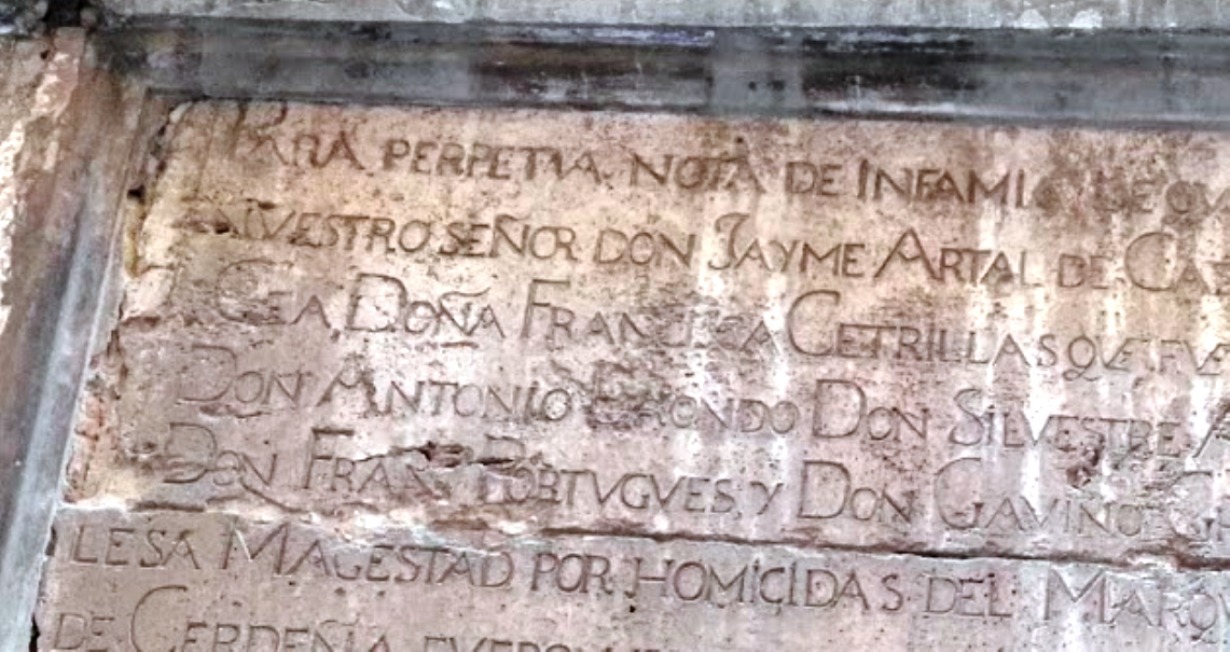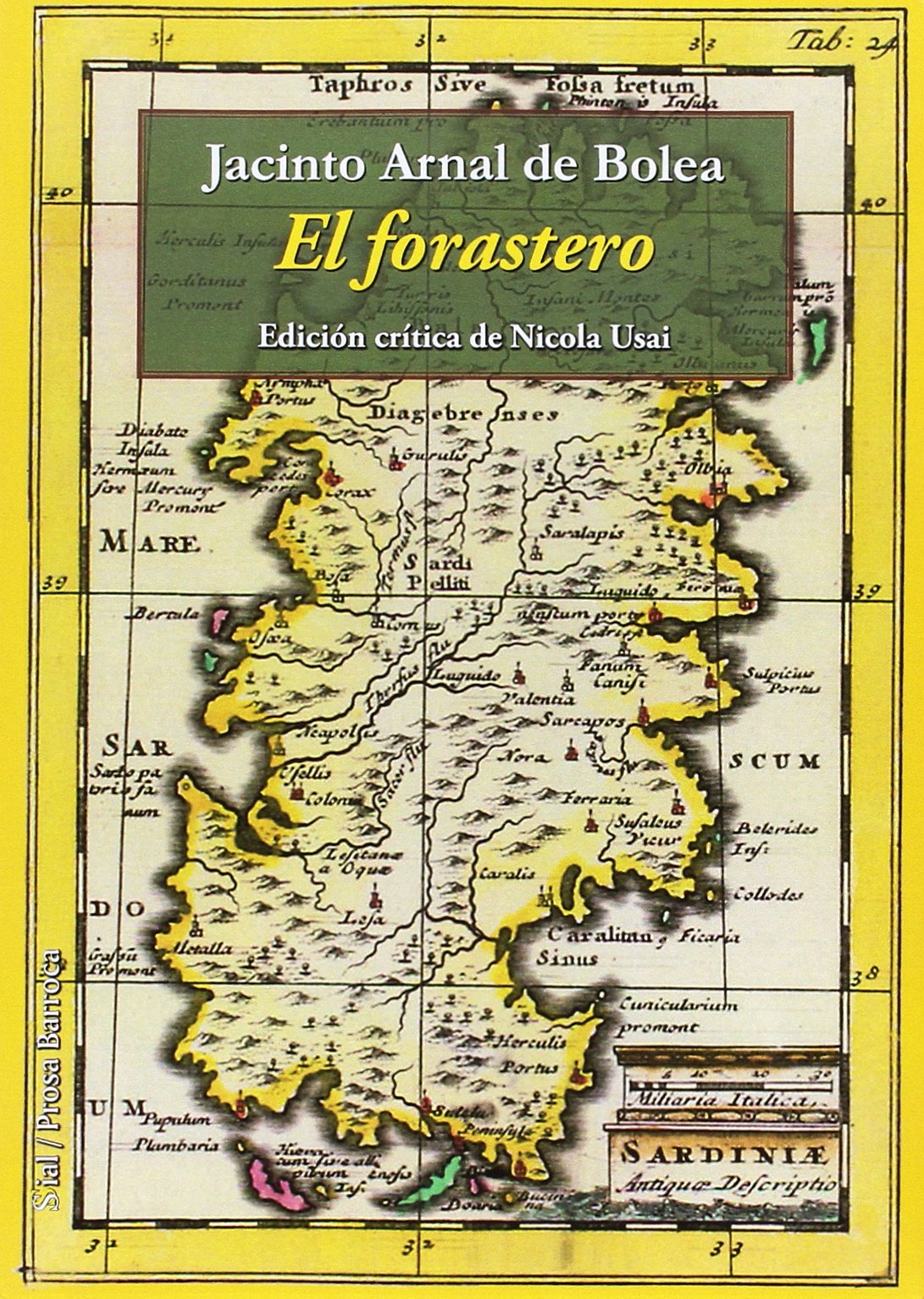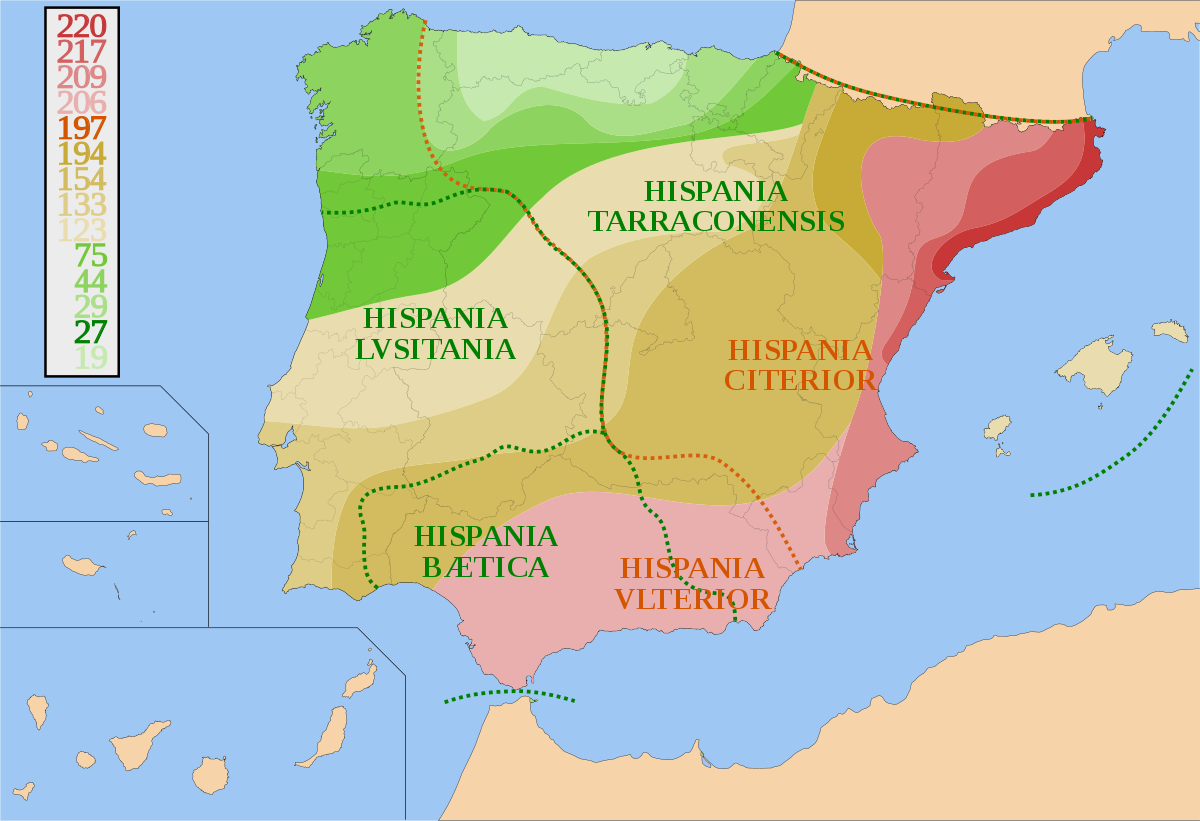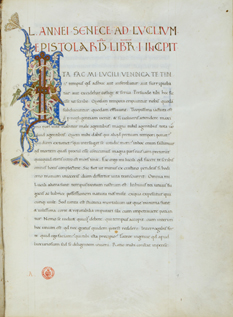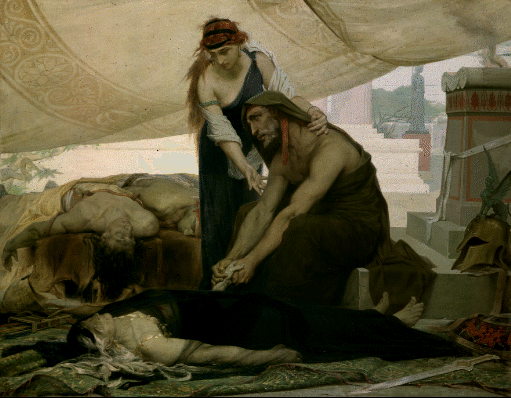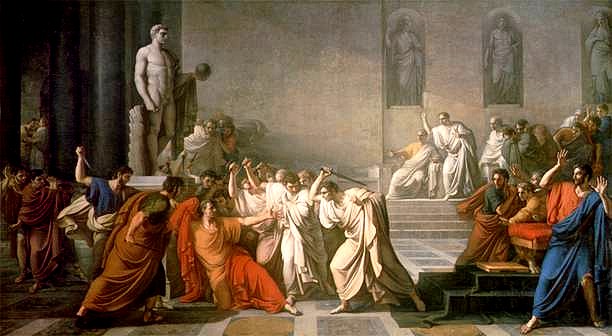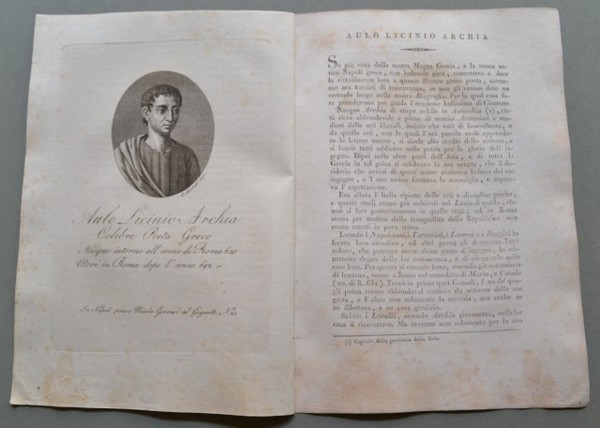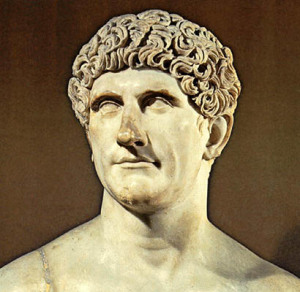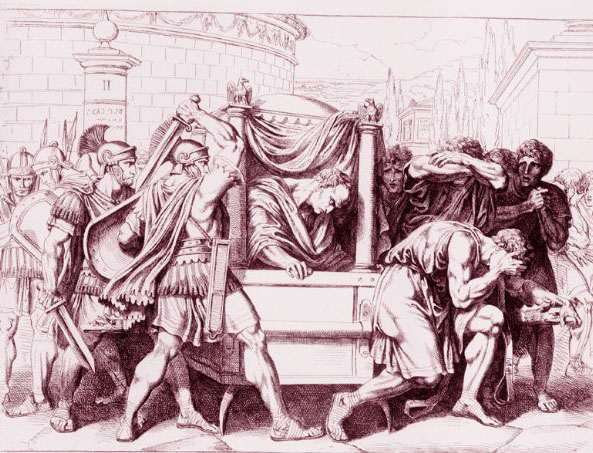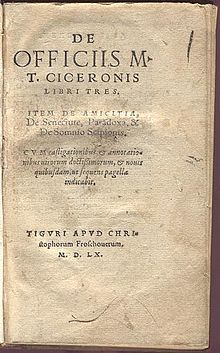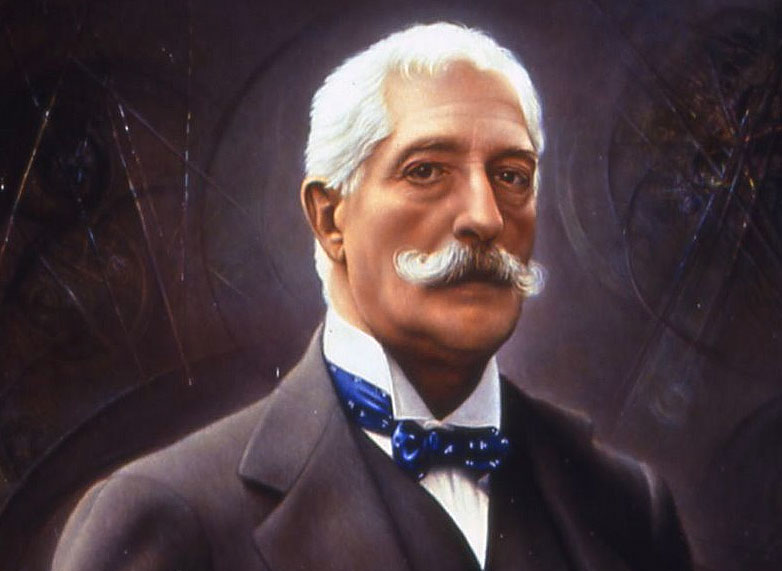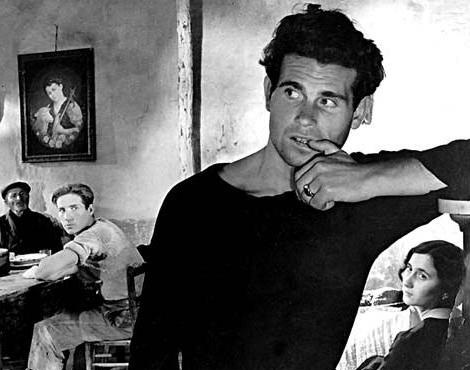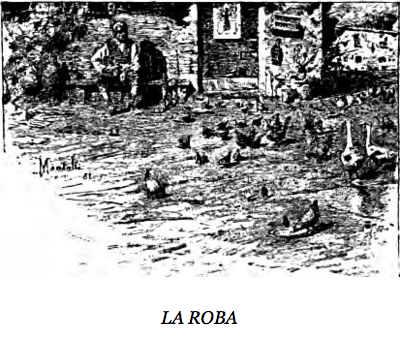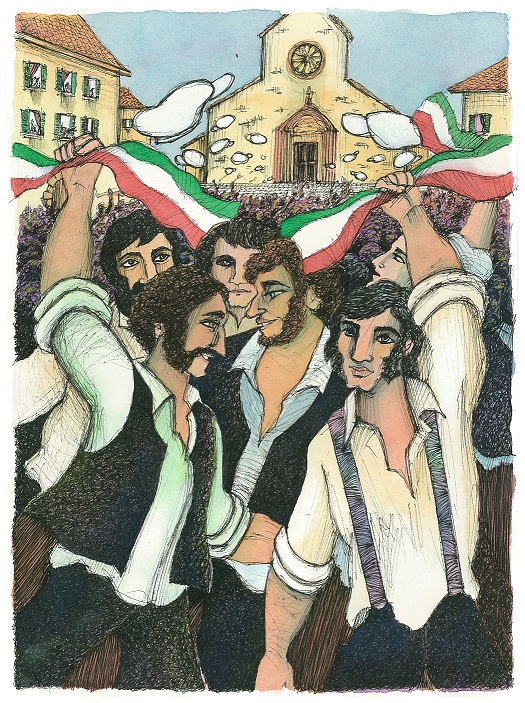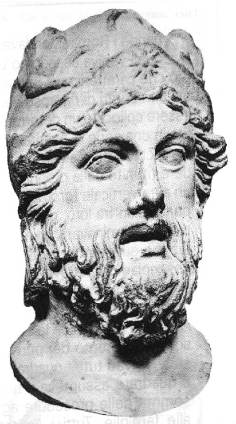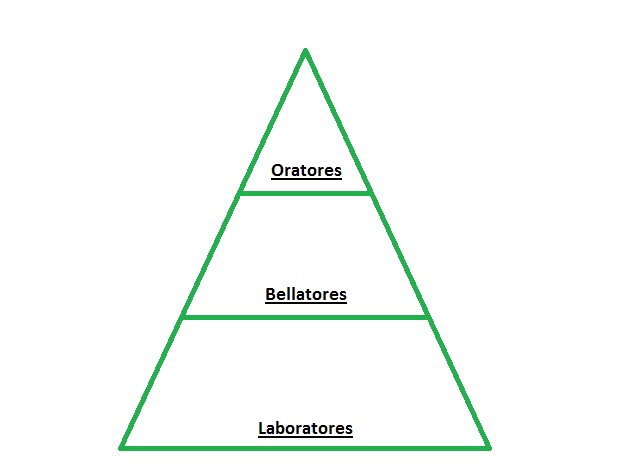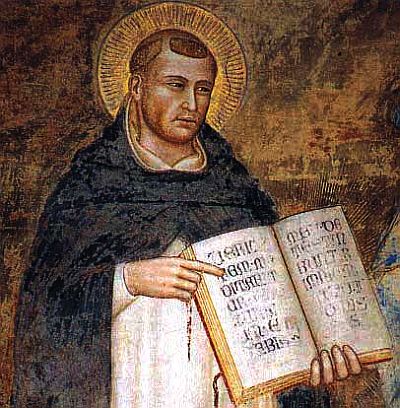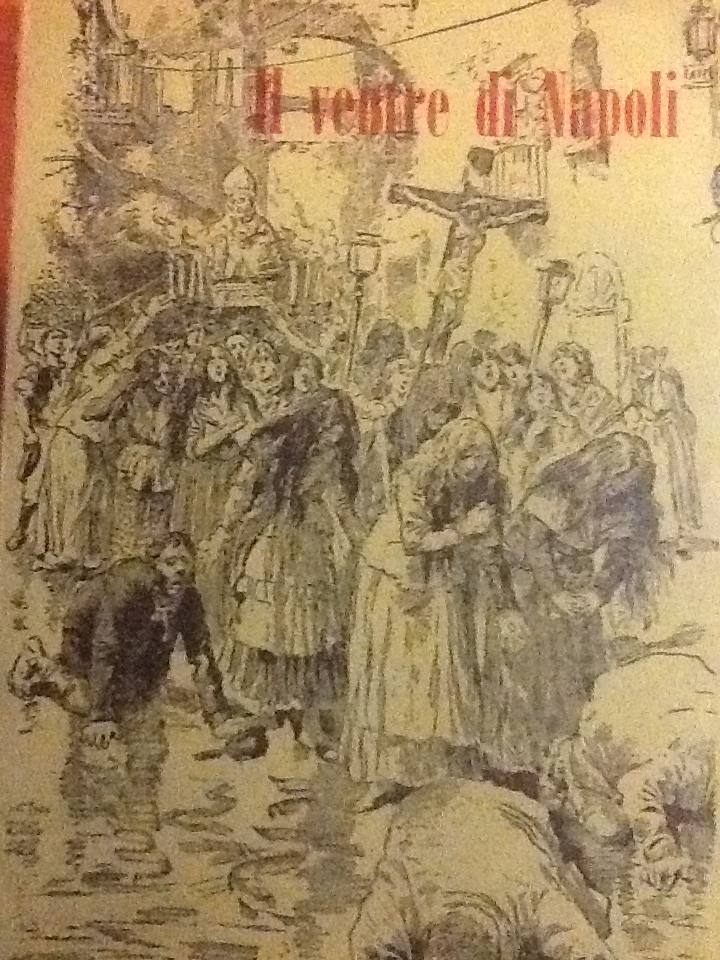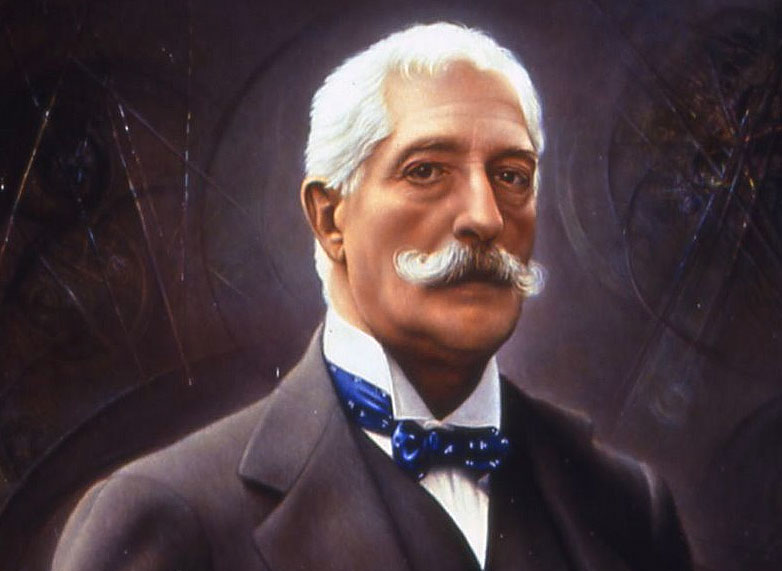
Giovanni Verga
Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840, da Giovan Battista, nobile e agiato proprietario agrario di cultura liberale e da Caterina di Mauro, di famiglia borghese. La sua prima formazione avviene nella scuola privata di Antonino Abate che lo avvicina ai valori patriottici rafforzati in parte da letture sulla poesia risorgimentale e dal valore civile. Non ottiene una forte formazione filologica, quanto piuttosto sulla letteratura contemporanea: tra queste predilige quella francese diventando un appassionato lettore di Eugéne Sue e di Alexander Dumas père e fils (tutti riconducibili al romanzo storico e popolare). Questa cultura viene riportata nei suoi primi tentativi letterati come Amore e patria (scritto tra i 16 e i 17 anni, rimasto inedito), I carbonari della montagna pubblicato a proprie spese nel 1861; Sulle lagune, pubblicato in rivista nel 1863. Più che opere minori si potrebbe parlare di una prima esperienza verghiana, che quasi nulla ci dice dell’autore futuro, ma che mostra sin da giovane la voglia d’esprimersi, pur richiamandosi ad autori dei feuilletons francesi, e da altri facenti parte di un romanticismo minore mescolato a tentativi di letteratura popolare (ci viene in mente Francesco Domenico Guerrazzi, prolifico autori di racconti e romanzi apparsi sia in volume che nei giornali dell’epoca). Nel 1858 si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, che poi abbandona per far parte della Guardia Nazionale, sorta per evitare disordini dopo l’arrivo di Garibaldi in città. Sempre a Catania, fonda, insieme ad alcuni amici, la rivista “Roma degli italiani”.
Nel 1865 decide di trasferirsi a Firenze, allora capitale d’Italia: di questa città sente l’attrazione per la vita mondana che vi si conduce, per gli intellettuali che vi risiedono e che comincia a frequentare, tra i quali ci piace ricordare l’eccentrico Vittorio Imbriani e, amicizia più determinante, Luigi Capuana. Scrive Una peccatrice (1866), in cui, dietro la storia di Pietro Brusio si nasconde in realtà Verga stesso, e Storia di una capinera, uscito dapprima a puntate su una rivista e poi definitivamente in volume nel 1871, che ottiene un clamoroso successo e gli apre le porte a prospettive più ampie.

Romanzo epistolare in cui la protagonista scrive ad una amica. All’inizio Maria accetta senza reticenze la scelta della matrigna di entrare in convento; ma un’epidemia di colera la costringe ad uscire e a tornare, per un certo periodo di tempo, in famiglia. Qui assapora le gioie della casa, la libertà e il sentimento d’amore per un giovane che frequenta la sua casa. Passato il colera, Maria deve rientrare in convento. Qui verrà a sapere che l’uomo di cui era innamorata sposerà la sorella. Ciò la getta in indicibile strazio e dolore che non riesce a reprimere e che la porterà in breve alla morte.
IL VOTO MONACALE
M’avevano abbigliata da sposa, col velo, la corona, i fiori; m’avevano detto ch’ero bella. Dio mel perdoni!… io ne fui contenta soltanto per lui che mi avrebbe veduta così!… M’affacciarono alla grata della chiesa. Tu mi vedesti; io non vidi nessuno; vidi una nube di incenso, un brulichìo, molte torce che ardevano; udii l’organo che suonava. Poi chiusero la cortina, mi spogliarono di quei begli abiti, mi tolsero il velo, i fiori, mi vestirono della tonaca senza che me ne avvedessi. Io non udivo, non vedevo nulla… lasciavo fare, ma tremavo talmente che i miei denti scricchiolavano gli uni contro gli altri. Pensavo alla bella veste da sposa di mia sorella, alla cerimonia cui ella aveva dovuto assistere senza provare lo sgomento che allora m’invadeva. La cortina fu riaperta. Tutta quella gente era ancora lì, guardava, ascoltava, con un’avida curiosità che mi agghiacciava di inesplicabile terrore. Mi sciolsero i capelli e me li sentii cadere fin sulle mani che tenevo giunte; li raccolsero tutti in pugno… e allora si udì uno stridere d’acciario… mi parve che mi cogliesse il ribrezzo della febbre, ma era quella sensazione di fresco che provai sul collo allorché quella cosa fredda s’introdusse fra il volume delle mie chiome; del resto non aveva che un’idea confusa di quanto accadeva. Vidi mio padre che piangeva. Perché piangeva? Vidi mia madre, Giuditta, Gigi… Accanto a Giuditta c’era un’altra persona ch’era pallida pallida e mi guardava cogli occhi spalancati. In quel punto lo stridere di quel a cosa agghiacciata mi parve che superasse il canto dei preti, il suono dell’organo, i singhiozzi di mio padre. I capelli mi cadevano da tutte le parti a ricci, a treccie intere… e le lagrime mi cadevano dagli occhi… Allora l’organo si fece mesto, le campane parvemi che piangessero. Mi stesero sul cataletto, mi coprirono colla coltre dei trapassati. Tutte quelle figure nere mi circondarono; mi guardavano, pallide, impassibili come spettri, salmodiando, colle torcie in mano. La cortina si rinchiuse. In chiesa si udì lo scalpiccìo di tutta quella gente che se ne andava… Tutti mi abbandonavano… anche mio padre… Gli spettri mi abbracciavano, mi baciavano, avevano le labbra fredde e sorridevano senza far rumore.
La lettera descrive all’amica Marianna il momento in cui Maria si veste della tonaca monacale. Ed è normale, per un lettore, richiamare alla memoria la figura di Gertrude, di manzoniana memoria. E’ evidente che se lo scrittore lombardo è interessato non solo al gesto riprovevole in sé, ma alla situazione politica e sociale del Seicento che lo avevano determinato, Verga rimanga ancorato a stilemi tardo romantici o per meglio dire scapigliati proprio nell’uso dell’io narrante. L’insistenza dei puntini di sospensione, la ricerca del patetico nella lentezza gestuale della protagonista, la turba che l’osserva che sembra costituire un’aurea sepolcrale e l’ultima frase che sembra ripresa da un romanzo di Tarchetti, pone Verga tra gli scrittori “popolari” al pubblico femminile, ma non sappiamo dire quanto consapevolmente. D’altra parte è lui stesso che non vuole dare una lettura sociologica al suo romanzo.
Il successo di Storia di una capinera, lo spinge a trasferirsi a Milano, dove frequenta gli ambienti della Scapigliatura. Testimonianza dell’adesione alla critica sociale del movimento milanese ce la offre l’introduzione al romanzo Eva, edito a Milano nel (1873):
Enrico Lanti è un giovane pittore che si innamora di Eva, una bellissima ballerina, ricca di fascino e di mistero, pur essendo consapevole che il suo sogno d’amore è irrealizzabile. Il sogno viceversa si avvera: Eva, conosciutolo, si innamora e abbandona il teatro per andare a vivere con lui. La monotona vita quotidiana, sulla quale pesano tra l’altro le difficoltà economiche, logora però l’iniziale passione: i due si separano ed Eva diventa l’amante del facoltoso conte Silvani. Enrico non si rassegna alla realtà e una sera, durante un veglione a teatro, abbraccia e bacia Eva. Nell’inevitabile duello che ne deriva il conte perde la vita. Enrico torna presso la famiglia in Sicilia e dopo pochi mesi, logorato da questo inestinguibile e fatale amore, muore.
INTRODUZIONE AD “EVA”
Eccovi una narrazione – sogno o storia poco importa – ma vera, com’è stata o come potrebbe essere, senza rettorica e senza ipocrisie. Voi ci troverete qualche cosa di voi che vi appartiene, ch’è il frutto delle vostre passioni, e se sentite di dover chiudere il libro allorché si avvicina vostra figlia – voi che non osate scoprirvi il seno dinanzi a lei se non alla presenza di duemila spettatori e alla luce del gas, o voi che, pur lacerando i guanti nell’applaudire le ballerine, avete il buon senso di supporre che ella non scorga scintillare l’ardore dei vostri desideri nelle lenti del vostro occhialetto tanto meglio per voi, che rispettate ancora qualche cosa. Però non maledite l’arte ch’è la manifestazione dei vostri gusti. I greci innamorati ci lasciarono la statua di Venere; noi lasceremo il cancan litografato sugli scatolini dei fiammiferi. Non discutiamo nemmeno sulle proporzioni; l’arte allora era una civiltà, oggi è un lusso: anzi un lusso da scioperati. La civiltà è il benessere, e in fondo ad esso, quand’è esclusivo come oggi, non ci troverete altro, se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il godimento materiale. In tutta la “serietà” di cui siamo invasi, e nell’antipatia per tutto ciò che non è positivo – mettiamo pure l’arte scioperata – non c’è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un’atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è l’esuberanza di tal vita. Non accusate l’arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che create, – voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l’onore là dove voi non lasciate che la borsa, – voi che fate scricchiolare allegramente i vostri stivalini inverniciati dove folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori sconosciuti, che l’arte raccoglie e che vi getta in faccia.

Toulouse Lautrec: Manifesto
Ma a tale Introduzione non succede il romanzo. Non sappiamo quali precise letture lo abbiano preceduto, ma sentiamo “spruzzati” qua e là riferimenti alla contemporanea letteratura francese (torna in mente la Nanà di Zola). Certo è che, come nel primo romanzo, anche qui il protagonista è un artista. Lì un romanziere, qui un pittore, il cui oggetto è sempre una donna “impossibile” che s’uccide per amore o fa morire per amore e chiudono ambedue con il ritorno in Sicilia, terra che non conosce la “corruzione” della civiltà e in cui rifugiarsi, scappare dalla “modernità”. Ma nel patetico racconto le Banche e di Imprese industriali dove sono? la febbre dei piaceri è l’esuberanza di tal vita più che criticata sembra agognata. Tuttavia qualcosa di nuovo nell’animo di Verga c’è e lo riprende proprio dallo spirito scapigliato: la ricerca della verità. Eccovi una narrazione – sogno o storia poco importa – ma vera, com’è stata o come potrebbe essere, senza rettorica e senza ipocrisie.
Gli altri due romanzi scritti nel periodo milanese sono Tigre reale ed Eros, ambedue del 1875. Il primo continua ad insistere su ambienti mondani e storie d’amore patetiche.
Nella prima un diplomatico e una contessa russa, cui sembra che il narratore, moralisticamente, prenda la distanza; nel secondo un marchese, di cui si racconta la fallimentare vita, fatta di amori e tradimenti (anche se in quest’ultimo percepiamo una maggiore capacità artistica, certamente non ancora matura, ma migliore rispetto alle opere precedenti).

Raccoglitrice di olive pittura di Roberto Rimini
Nedda del 1874 sembra rappresenti una “conversione” letteraria: racconta infatti la storia di una povera raccoglitrice di olive, che ha una madre gravemente malata e che s’innamora di Janu, un giovane del suo paese che è stato a lavorare a Catania. La madre muore e fra Nedda e Janu nasce un rapporto passionale e gioioso, ma che non porta alla felicità. La giovane infatti mostra presto i segni infamanti di una gravidanza prematrimoniale e, come se non bastasse, Janu si ammala di malaria e tuttavia, per affrettare le nozze, non rinuncia a lavorare. Cade però da un ulivo e muore tra le braccia di Nedda. La fanciulla rimane sola: abbandonata, disprezzata, sfruttata; presto le muore anche la figlioletta che ha avuto da Janu e in cui Nedda aveva riposto tutte le speranze per raggiungere una felicità che, ovviamente, non arriva.
NEDDA
Era una ragazza bruna, vestita miseramente; aveva quell’attitudine timida e ruvida che danno la miseria e l’isolamento. Forse sarebbe stata bella, se gli stenti e le fatiche non ne avessero alterato profondamente non solo le sembianze gentili della donna, ma direi anche la forma umana. I suoi capelli erano neri, folti, arruffati, appena annodati con dello spago; aveva denti bianchi come avorio, e una certa grossolana avvenenza di lineamenti che rendeva attraente il suo sorriso. Gli occhi erano neri, grandi, nuotanti in un fluido azzurrino, quali li avrebbe invidiati una regina a quella povera figliuola raggomitolata sull’ultimo gradino della scala umana, se non fossero stati offuscati dall’ombrosa timidezza della miseria, o non fossero sembrati stupidi per una triste e continua rassegnazione. Le sue membra schiacciate da pesi enormi, o sviluppate violentemente da sforzi penosi, erano diventate grossolane, senza esser robuste. Ella faceva da manovale, quando non aveva da trasportare sassi nei terreni che si andavano dissodando; o portava dei carichi in città per conto altrui, o faceva di quegli altri lavori più duri che da quelle parti stimansi inferiori al còmpito dell’uomo. La vendemmia, la messe, la raccolta delle olive per lei erano delle feste, dei giorni di baldoria, un passatempo, anziché una fatica. E’ vero bensì che fruttavano appena la metà di una buona giornata estiva da manovale, la quale dava bravi soldi! I cenci sovrapposti in forma di vesti rendevano grottesca quella che avrebbe dovuto essere la delicata bellezza muliebre. L’immaginazione più vivace non avrebbe potuto figurarsi che quelle mani costrette ad un’aspra fatica di tutti i giorni, a raspar fra il gelo, o la terra bruciante, o i rovi e i crepacci, che quei piedi abituati ad andar nudi nella neve e sulle rocce infuocate dal sole, a lacerarsi sulle spine, o ad indurirsi sui sassi, avrebbero potuto esser belli. Nessuno avrebbe potuto dire quanti anni avesse cotesta creatura umana; la miseria l’aveva schiacciata da bambina con tutti gli stenti che deformano e induriscono il corpo, l’anima e l’intelligenza. – Così era stato di sua madre, così di sua nonna, così sarebbe stato di sua figlia. – E dei suoi fratelli in Eva bastava che le rimanesse quel tanto che occorreva per comprenderne gli ordini, e per prestar loro i più umili, i più duri servigi.
Se il racconto mostra una realtà non più alto borghese, non cambia lo stile. La descrizione della protagonista ce ne offre un piccolo esempio: la narrazione è di uno scrittore onnisciente che osserva la figura e l’autore emerge nella scelta dello sguardo: si osservi il commento Forse sarebbe stata bella, se gli stenti e le fatiche non ne avessero alterato profondamente non solo le sembianze gentili della donna, ma direi anche la forma umana, dove si sottolinea il giudizio “morale” dello sfruttamento; Gli occhi erano neri, grandi, nuotanti in un fluido azzurrino, descrizione ancora abituata alle fattezze di una femme fatale, più che di una raccoglitrice d’olive. Tuttavia non bisogna tralasciare il nuovo interesse di Verga per il motivo economico dello sfruttamento, per il reale stato di abbandono delle classi povere del sud, e per l’affacciarsi del tema “positivistico” dell’ereditarietà Così era stato di sua madre, così di sua nonna, così sarebbe stato di sua figlia.
Nedda fa parte di una raccolta Primavera del 1877, in cui sono inserite novelle che ondeggiano tra temi antichi di amori impossibili, motivi etnografici, come in La coda del diavolo, e storie patetiche, come nel caso, appunto della povera ragazza siciliana.
Ma la vera svolta verghiana avviene nel 1880 con la raccolta di novelle Vita dei campi. Quest’opera presenta otto racconti, tutti d’ambiente siciliano, nel quale Verga s’immerge nel mondo contadino, non attraverso i singoli personaggi, ma in una più generale “contadinità”, cioè nel carattere “elementare” dei sentimenti che assume valore archetipico in una società preindustriale. Il sentimento che vi domina è l’amore come sentimento universale, che cancella ogni forma di sovrastruttura o patetismo, come era presentato, appunto, nei cosiddetti “romanzi mondani”. Si veda Fantasticheria, in cui all’amore patetico di una gentildonna della nobiltà si contrappone l’amore per la terra dei poveri marinai siciliani:
FANTASTICHERIA
Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, esclamaste: «Vorrei starci un mese laggiù!»
Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott’ore; i terrazzani che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un par d’anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell’azzurro, e di contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non spuntava mai. In quelle quarantott’ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Aci-Trezza: passeggiammo nella polvere della strada, e ci arrampicammo sugli scogli; col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci; passammo sul mare una notte romanticissima, gettando le reti tanto per far qualche cosa che a’ barcaiuoli potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi, e l’alba ci sorprese in cima al fariglione – un’alba modesta e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi violetti, sul mare di un verde cupo, raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce che dormivano quasi raggomitolate sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo trasparente e limpido, si stampava netta la vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra sarta, e il profilo fine ed elegante che ci mettevate voi. – Avevate un vestitino grigio che sembrava fatto apposta per intonare coi colori dell’alba. – Un bel quadretto davvero! e si indovinava che lo sapeste anche voi, dal modo in cui vi modellaste nel vostro scialletto, e sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo, e a quell’altra stranezza di trovarvici anche voi presente. Che cosa avveniva nella vostra testolina allora, di faccia al sole nascente? Gli domandaste forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un mese? Diceste soltanto ingenuamente: «Non capisco come si possa vivere qui tutta la vita».
Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non possedere centomila lire di entrata, prima di tutto; e in compenso patire un po’ di tutti gli stenti fra quegli scogli giganteschi, incastonati nell’azzurro, che vi facevano batter le mani per ammirazione. Così poco basta, perché quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro casipole sgangherate e pittoresche, che viste da lontano vi sembravano avessero il mal di mare anch’esse, tutto ciò che vi affannate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli.
E’ una cosa singolare; ma forse non è male che sia così – per voi, e per tutti gli altri come voi. Quel mucchio di casipole è abitato da pescatori, “gente di mare”, dicono essi, come altri direbbe “gente di toga”, i quali hanno la pelle più dura del pane che mangiano – quando ne mangiano – giacché il mare non è sempre gentile, come allora che baciava i vostri guanti… Nelle sue giornate nere, in cui brontola e sbuffa, bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, o sdraiati bocconi, il che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni c’è folla sull’uscio dell’osteria, ma suonano pochi soldoni sulla latta del banco, e i monelli che pullulano nel paese, come se la miseria fosse un buon ingrasso, strillano e si graffiano quasi abbiano il diavolo in corpo.
Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona spazzata in quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come, né perché.
Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di formiche, tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. Voi non ci tornereste davvero, e nemmen io; ma per poter comprendere siffatta caparbietà, che è per certi aspetti eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l’orizzonte fra due zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori. Volete metterci un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che guardate la vita dall’altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà.
Noi siamo stati amicissimi, ve ne rammentate? e mi avete chiesto di dedicarvi qualche pagina. Perché? à quoi bon? come dite voi. Che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi conosce? e per chi non vi conosce che cosa siete voi? Tant’è, mi son rammentato del vostro capriccio, un giorno che ho rivisto quella povera donna cui solevate far l’elemosina col pretesto di comperar le sue arance messe in fila sul panchettino dinanzi all’uscio. Ora il panchettino non c’è più; hanno tagliato il nespolo del cortile, e la casa ha una finestra nuova. La donna sola non aveva mutato, stava un po’ più in là a stender la mano ai carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano il vecchio Posto della guardia nazionale; ed io, girellando, col sigaro in bocca, ho pensato che anche lei, così povera com’è, vi aveva vista passare, bianca e superba.
Non andate in collera se mi son rammentato di voi in tal modo, e a questo proposito. Oltre i lieti ricordi che mi avete lasciati, ne ho cento altri, vaghi, confusi, disparati, raccolti qua e là, non so più dove; -forse alcuni son ricordi di sogni fatti ad occhi aperti; e nel guazzabuglio che facevano nella mia mente, mentre io passava per quella viuzza dove son passate tante cose liete e dolorose, la mantellina di quella donnicciola freddolosa, accoccolata, poneva un non so che di triste, e mi faceva pensare a voi, sazia di tutto, perfino dell’adulazione che getta ai vostri piedi il giornale di moda, citandovi spesso in capo alla cronaca elegante – sazia così, da inventare il capriccio di vedere il vostro nome sulle pagine di un libro.
Quando scriverò il libro, forse non ci penserete più; intanto i ricordi che vi mando, così lontani da voi, in ogni senso, da voi inebbriata di feste e di fiori, vi faranno l’effetto di una brezza deliziosa, in mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno carnevale. Il giorno in cui ritornerete laggiù, se pur vi ritornerete, e siederemo accanto un’altra volta, a spinger sassi col piede, e fantasie col pensiero, parleremo forse di quelle altre ebbrezze che ha la vita altrove. Potete anche immaginare che il mio pensiero siasi raccolto in quel cantuccio ignorato del mondo, perché il vostro piede vi si è posato, – o per distogliere i miei occhi dal luccichìo che vi segue dappertutto, sia di gemme o di febbri – oppure perché vi ho cercata inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti. Vedete quindi che siete sempre al primo posto, qui come al teatro!
Vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca? Voi gli dovete questo tributo di riconoscenza, perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le vostre belle calze azzurre. Ora è morto laggiù, all’ospedale della città, il povero diavolo, in una gran corsìa tutta bianca, fra dei lenzuoli bianchi, masticando del pane bianco, servito dalle bianche mani delle suore di carità, le quali non avevano altro difetto che di non saper capire i meschini guai che il poveretto biascicava nel suo dialetto semibarbaro.
Ma se avesse potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero, vicino al focolare, dove tanti anni era stata la sua cuccia “sotto le sue tegole”, tanto che quando lo portarono via piangeva, guaiolando come fanno i vecchi. Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a quel mare bello e traditore, col quale dové lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da campare la vita e non lasciargli le ossa; eppure in quei momenti in cui si godeva cheto cheto la sua “occhiata di sole” accoccolato sulla pedagna della barca, coi ginocchi fra le braccia, non avrebbe voltato la testa per vedervi, ed avreste cercato invano in quelli occhi attoniti il riflesso più superbo della vostra bellezza; come quando tante fronti altere s’inchinano a farvi ala nei saloni splendenti, e vi specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche.
La vita è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà; e voi potete godervi senza scrupoli quella parte di ricchezza che è toccata a voi, a modo vostro. Quella ragazza, per esempio, che faceva capolino dietro i vasi di basilico, quando il fruscìo della vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza, se vedeva un altro viso notissimo alla finestra di faccia, sorrideva come se fosse stata vestita di seta anch’essa. Chi sa quali povere gioie sognava su quel davanzale, dietro quel basilico odoroso, cogli occhi intenti in quell’altra casa coronata di tralci di vite? E il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire in lagrime amare, là, nella città grande, lontana dai sassi che l’avevano vista nascere e la conoscevano, se il suo nonno non fosse morto all’ospedale, e suo padre non si fosse annegato, e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi aveva soffiato sopra – un colpo di vento funesto, che avea trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle carceri di Pantelleria – “nei guai!” come dicono laggiù.
Miglior sorte toccò a quelli che morirono; a Lissa l’uno, il più grande, quello che vi sembrava un David di rame, ritto colla sua fiocina in pugno, e illuminato bruscamente dalla fiamma dell’ellera. Grande e grosso com’era, si faceva di brace anch’esso quando gli fissaste in volto i vostri occhi arditi; nondimeno è morto da buon marinaio, sulla verga di trinchetto, fermo al sartiame, levando in alto il berretto, e salutando un’ultima volta la bandiera col suo maschio e selvaggio grido d’isolano; l’altro, quell’uomo che sull’isolotto non osava toccarvi il piede per liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli, nel quale v’eravate impigliata da stordita che siete, si perdé in una fosca notte d’inverno, solo, fra i cavalloni scatenati, quando fra la barca e il lido, dove stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua e di là come pazzi, c’erano sessanta miglia di tenebre e di tempesta. Voi non avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio fosse capace per lottare contro tal morte quell’uomo che lasciavasi intimidire dal capolavoro del vostro calzolaio.
Meglio per loro che son morti, e non “mangiano il pane del re”, come quel poveretto che è rimasto a Pantelleria, o quell’altro pane che mangia la sorella, e non vanno attorno come la donna delle arance, a viver della grazia di Dio – una grazia assai magra ad Aci-Trezza. Quelli almeno non hanno più bisogno di nulla! lo disse anche il ragazzo dell’ostessa, l’ultima volta che andò all’ospedale per chieder del vecchio e portargli di nascosto di quelle chiocciole stufate che son così buone a succiare per chi non ha più denti, e trovò il letto vuoto, colle coperte belle e distese, sicché sgattaiolando nella corte, andò a piantarsi dinanzi a una porta tutta brandelli di cartacce, sbirciando dal buco della chiave una gran sala vuota, sonora e fredda anche di estate, e l’estremità di una lunga tavola di marmo, su cui era buttato un lenzuolo, greve e rigido. E pensando che quelli là almeno non avevano più bisogno di nulla, si mise a succiare ad una ad una le chiocciole che non servivano più, per passare il tempo. Voi, stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra, vi rammenterete con piacere che gli avete dato cento lire, al povero vecchio.
Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance; rimangono a ronzare attorno alla mendica, e brancicarle le vesti come se ci avesse sotto del pane, a raccattar torsi di cavolo, bucce d’arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si lasciano cadere per via, ma che pure devono avere ancora qualche valore, poiché c’è della povera gente che ci campa su; ci campa anzi così bene, che quei pezzentelli paffuti e affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada, e si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno, e popoleranno Aci-Trezza di altri pezzentelli, i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno, come il vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando Iddio di chiudere gli occhi là dove li hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sull’asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va.
«Insomma l’ideale dell’ostrica!» direte voi. – Proprio l’ideale dell’ostrica! e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi. Per altro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano – forse pel quarto d’ora – cose serissime e rispettabilissime anch’esse. Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s’addormenterebbero dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in generazione. – Sembrami che potrei vedervi passare, al gran trotto dei vostri cavalli, col tintinnìo allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente.
Forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell’istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che qualche volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò: – che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui. – E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca d’interesse. Per le ostriche l’argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.
Eppure non è soltanto l’amore per la terra il centro ideologico della novella che, non a caso, è posta come prima dell’intera raccolta, acquisendo così il valore di racconto programmatico. In primo luogo, ancora non vi è la cancellazione dell’autore ed il personaggio della gentildonna è ripreso fortemente dalle opere precedenti. La contrapposizione, tuttavia, tra lei ed il mondo dei pescatori è netta e si struttura come incapacità di qualsiasi forma di dialogo, quasi a configurarsi come “pittoresco” per la dama e “quotidiano” per la popolazione. L’intervento economico è chiarito sin dall’inizio basta non possedere centomila lire di entrata, di contro alla miseria, che rende appetibile ciò che “normalmente” si getta per strada. Le spiegazioni che ci offre Verga sono:
- sociologica e potrebbe riassumersi nel concetto di ciclicità dell’esistenza;
- filosofica con il darwinismo, che fa sì che il più forte vinca sul più debole che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch’egli è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con lui;
- letteraria, coll’esigenza dell’immedesimazione che toglie la visione superiore dello scrittore onnisciente e si fa piccola fino a cancellarsi all’interno della comunità descritta.
L’elemento forte, quello che distingue ideologicamente l’intera novella, è l’“ideale dell’ostrica”, rafforzato dal darwinismo sopra accennato; questo concetto sembra tuttavia caratterizzare in Verga una visione pessimistica della realtà che, politicamente, andrà a strutturarsi in un conservatorismo politico. Qui sembra quasi dirci che qualsiasi cambiamento sociale porterà ad una sconfitta personale e questa ideologia sarà rafforzata soprattutto nei suoi due romanzi maggiori. Per ultimo Fantasticheria ci presenta, anche se in filigrana, i personaggi principali de I Malavoglia.
Un’altra pagina programmatica ne Vita dei campi la troviamo nella novella L’amante di Gramigna che presenta, in un quadretto siciliano, un innamoramento per fama; ma estremamente importante, per la poetica di Verga è l’Introduzione che l’autore stesso vi inserisce, indirizzata allo scrittore e amico Salvatore Farina:

Scena del film di Carlo Lizzani “L’amante di Gramigna”
INTRODUZIONE A “L’AMANTE DI GRAMIGNA”
A Salvatore Farina
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il merito di essere brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono oggi – interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l’efficacia dell’essere stato, delle lagrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditorî, costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di partenza e quello d’arrivo; e per te basterà, – e un giorno forse basterà per tutti.
Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti gloriosi, con metodo diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri l’effetto della catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti verso la catastrofe resa meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la dimostrazione di cotesto legame oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all’arte dell’avvenire. Si arriverà mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il proseguire in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno “i fatti diversi”?
Intanto io credo che il trionfo del romanzo, la più completa e la più umana delle opere d’arte, si raggiungerà allorché l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e che l’armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore; che essa non serbi nelle sue forme viventi alcuna impronta della mente in cui germogliò, alcuna ombra dell’occhio che la intravvide, alcuna traccia delle labbra che ne mormorarono le prime parole come il “fiat” creatore; ch’essa stia per ragion propria, pel solo fatto che è come dev’essere, ed è necessario che sia, palpitante di vita ed immutabile al pari di una statua di bronzo, di cui l’autore abbia avuto il coraggio divino di eclissarsi e sparire nella sua opera immortale.
Pagina fondamentale, in cui quello che emerge è l’ottica attraverso la quale l’autore deve sviluppare il racconto o, per dirla “positivisticamente”, il documento umano. Se bisogna fare del romanzo, la più completa e la più umana delle opere d’arte, è necessario che lo scrittore e l’elaborazione narrativa scompaiano creando una specie di fusione mimetica tra il processo creativo e le passioni raccontate. Ciò comporta un duplice processo che riguarda dapprima il lettore, che non deve rendersi conto della presenza dell’autore, quindi di quest’ultimo che, pur essendoci, deve far di tutto per scomparire.
Dall’intera introduzione possiamo isolare tre essenziali concetti:
- l’essenzialità del racconto che deve ritrarre avvenimenti e meccanismi psicologici all’interno di esso;
- abolizione dello scrittore onnisciente e affermazione del principio dell’impersonalità;
- consonanza tra stile e materia;
Tuttavia percepiamo anche una distanza dal naturalismo francese, infatti Verga parla ancora del mistero con cui le passioni umane si sviluppano. Compito del narratore è registrarle fedelmente, regredendo in esse (assumendo la mentalità, il linguaggio, la società che circonda il personaggio); non vi è l’intento, come quello dello scienziato/scrittore teorizzato da Zola, che descrive per elaborare una diagnosi e quindi dar la possibilità di guarigione, ma solo quella di riportare fedelmente il “fatto umano”.
Il capolavoro di Vita dei campi è Rosso Malpelo:

Lavoratori in miniera
ROSSO MALPELO
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo.
Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi; nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni.
Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro.
Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e lordo di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a rupulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano “la cava di Malpelo”, e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava.
Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell’ingrottato, e dacché non serviva più, e s’era calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l’asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com’era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: «Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre».
Invece nemmen suo padre ci morì nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l’avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d’altra parte tutto è pericoloso nelle cave, e se si sta a badare al pericolo, è meglio andare a fare l’avvocato.
Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l’avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n’erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c’era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: «Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata!» e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto – il cottimante!
Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio; ed il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! ohi anch’esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: «Tirati indietro» oppure: «Sta’ attento! Sta’ attento se cascano dall’alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa!» Tutt’a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un rumore sordo e soffocato, come fa la rena allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense.
L’ingegnere che dirigeva i lavori della cava si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo, che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch’era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti come avesse la terzana. L’ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell’e arrivato in Paradiso, andò quasi pewr scarico di coscienza con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana.
Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n’era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell’affare di mastro Bestia!
Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia e urlava, come una bestia davvero.
«To’!» – disse infine uno. «E’ Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? Se non fosse stato Malpelo non sarebbe passata liscia…»
Malpelo, non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà nella rena, dentro la buca, sicché nessuno s’era accorto di lui; e quando si accostarono col lume gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza.
Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrava negli orecchi, dall’altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, come se non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano la quale dà loro il pane e le botte, magari. Ma l’asino, povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: «Così creperai più presto!»
Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono coll’anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s’immaginava gli avessero fatto, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l’avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: «Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché ei non faceva così!» E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un’occhiata torva: «E’ stato lui, per trentacinque tarì! – E un’altra volta, dietro allo Sciancato: – E anche lui! e si metteva a ridere! Io l’ho udito, quella sera!»
Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che sembrava ballasse la tarantella, e aveva fatto ridere tutti quelli della cava, così che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava; e Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano.
Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: «To’, Bestia! Bestia sei! Se non ti senti l’animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello!»
O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: «Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu!» Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll’occhio spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n’era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: «L’asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi».
Oppure: «Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso».
Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo’ di uno che l’avesse con la rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. «La rena è traditora», diceva a Ranocchio sottovoce; «somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui».
Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: «Taci, pulcino!» e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: «Lasciami fare; io sono più forte di te». Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: «Io ci sono avvezzo».
Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel’aveva levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui; già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di scolparsi, ei ripeteva: «A che giova? Sono malpelo!» e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di bieco orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai.
Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa se si scoprendolo sull’uscio in quell’arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se avesse visto che razza di cognato gli toccava sorbirsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Adunque, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia a sassate alle povere lucertole, le quali non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano.
La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto e cencioso e lercio com’era, non lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d’ingresso è verticale, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana.
Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla schiena, – o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; – o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l’intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi all’infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n’erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente.
Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all’aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici asserissero che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall’altra.
Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto stentar molto a morire, perché il pilastro gli si era piegato in arco addosso, e l’aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt’ora che mastro Bestia avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte. «Proprio come suo figlio Malpelo!» ripeteva lo sciancato «ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là». Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo.
Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno e “di carne battezzata”. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta, e le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolirsi le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non ne aveva volute di scarpe del morto.
Malpelo se li lisciava sulle gambe quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo che solevano accarezzargli i capelli, così ruvidi e rossi com’erano. Quelle scarpe le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimugginando chi sa quali idee in quel cervellaccio.
Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no; suo padre li ha resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni.
In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l’asino grigio; e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. «Così si fa,» brontolava Malpelo; «gli arnesi che non servono più, si buttano lontano». Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l’avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. «Vedi quella cagna nera,» gli diceva, «che non ha paura delle tue sassate; non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole!» Adesso non soffriva più, l’asino grigio, e se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde e a spolpargli le ossa bianche e i denti che gli laceravano le viscere non gli avrebbero fatto piegar la schiena come il più semplice colpo di badile che solevano dargli onde mettergli in corpo un po’ di vigore quando saliva la ripida viuzza. Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche; anch’esso quando piegava sotto il peso e gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: “Non più! Non più!”. Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio.
La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che al di sotto era tutta scavata dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c’era entrato coi capelli neri, e n’era uscito coi capelli bianchi, e un altro cui s’era spenta la torcia aveva invano gridato aiuto ma nessuno poteva udirlo. «Egli solo ode le sue stesse grida!» diceva, e a quell’idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva.
«Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d’andare. Ma io sono Malpelo, e se io non torno più, nessuno mi cercherà».
Pure, durante le belle notti d’estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna circostante era nera anch’essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell’alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là vagamente – perché allora la sciara sembra più bella e desolata. “Per noi che siamo fatti per vivere sotterra,” pensava Malpelo, “dovrebbe essere buio sempre e dapertutto”. La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: “Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli”.
Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l’asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate.
«Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti» gli diceva «e allora era tutt’altra cosa. Ma adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti».
Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c’era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. «Chi te l’ha detto?» domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma.
Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga. «Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella».
E dopo averci pensato un po’: «Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io».
Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull’asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo “non ne avrebbe fatto osso duro” a quel mestiere, e che per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in quell’aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l’aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che l’operaio se ne fu andato, aggiunse: «Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro!»
Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre e alcune volte sembrava soffocasse, e la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati come se volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l’occhio spento, preciso come quello dell’asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: «E’ meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi!» E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo.
Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana.
Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta e sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui perché non aveva mai avuto timore di perderlo.
Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così, e sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo s’era asciugati i suoi dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un’altra volta, ed era andata a stare a Cifali; anche la sorella si era maritata e avevano chiusa la casa. D’ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla.
Verso quell’epoca venne a lavorare nella cava uno che non s’era mai visto, e si teneva nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per degli anni e degli anni. Malpelo seppe in quell’occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista.
Da quel momento provò una malsana curiosità per quell’uomo che aveva provata la prigione e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. «Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione?» domandò Malpelo.
«Perché non sono malpelo come te!» rispose lo Sciancato. «Ma non temere, che tu ci andrai! E ci lascerai le ossa!»
Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che si riteneva comunicasse col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d’opera nel cavar fuori la rena. Ma se non era vero, c’era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l’oro del mondo.
Ma Malpelo non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l’oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua pelle valeva tutto l’oro del mondo: sua madre si era rimaritata e se n’era andata a stare a Cifali, e sua sorella s’era maritata anch’essa. La porta di casa era chiusa, ed ei non aveva altro che le scarpe di suo padre appese al chiodo; perciò gli commettevano sempre i lavori più pericolosi, e le imprese più arrischiate, e s’ei non si aveva riguardo alcuno, gli altri non avevano certamente per lui. Quando lo mandarono per quella esplorazione si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo; ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui.
Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi.

Bimbo in miniera
L’analisi del racconto può procedere attraverso la divisione dello stesso in sequenze:
- Presentazione di Malpelo: il racconto inizia con la regressione dell’autore e la conseguente cancellazione dello scrittore onnisciente; la voce che ci presenta Malpelo è quella popolare così come popolare è il rapporto di causa effetto che si istituisce: Malpelo = colore dei capelli = cattiveria del personaggio; il fatto che egli sia conosciuto soltanto con il soprannome significa che egli è un isolato da se stesso e dalla stessa comunità che non ne conosce il vero nome. Tale isolamento è rafforzato dal fatto che anche la madre lo indichi col nome di Malpelo. D’altra parte il rapporto del ragazzo con la famiglia è inesistente; esce dalla miniera il sabato sera e, se lo aspettano, lo fanno per ricevere la paga settimanale. Di Malpelo ci viene detto che è sempre cencioso e sporco, ma anche l’aspetto ha un so che di zoomorfo (non per niente è figlio mastro Misciu Bestia); il fatto che abbia i capelli rossi, lo mette subito in relazione con la rena rossa della miniera. E’ talmente forte l’identificazione che la miniera prende il suo nome, a dispetto della rabbia del padrone.
- Morte del padre: come detto precedentemente Malpelo e mastro Misciu Bestia sono associati a immagini zoomorfe: il papà infatti è un buon asino da basto, che lavora per impiegare il denaro guadagnato per gli acquisti della famiglia; quando anche a Malpelo verrà affidato un lavoro straordinario lo farà per la ricerca. Importante in questa sequenza la figura del direttore: egli sta vedendo l’Amleto. L’episodio e la citazione sembrano marginali, ma così non sono; ambedue dopo la morte del padre cercano la loro identità. Malpelo, nell’uscire illeso e nello scavare a mani nude, sanguinolente, viene definito dalla pelle dura come i gatti, ed i gatti, nella tradizione popolare sono associati ai diavoli.
- Il ritorno nell’inferno della cava: qui Malpelo (il diavolo) si mette in contatto con l’inferno (la cava); è talmente spinto nella ricerca che rifiuta il cibo, gettandolo ai cani.
- Il rapporto con Ranocchio: il rapporto con il povero ragazzino, apprendista minatore, si profila subito come pedagogico; egli gli insegna che la natura e la storia rispondono solo alla legge del più forte, a tale scopo basti l’esempio dell’asino con gli uomini e della cava con suo padre. Ma tale rapporto pedagogico si configura anche come rapporto paterno: Malpelo offre protezione a Malocchio, si leva il pane dalla bocca per lui e lo chiama “bestia” (Bestia che non sei altro!) come il nome di suo padre.
- La vita fuori della cava: Malpelo esce dalla cava il sabato e trascorre il tempo fuori da essa fino a domenica sera. Ma questo periodo non è caratterizzato da un ritorno in famiglia. Il parallelismo che si instaura tra il cane cacciato a sassate dal paese e lui mandato via di casa ci fa capire il senso d’isolamento che caratterizza entrambi; nel rapporto zoomorfo che Malpelo instaura con altri animali il passo è illuminante: cane che sembra un lupo, occhi da gattaccio; ma all’interno della miniera è un asino, è la miniera rimane il solo suo ambiente.
- Il ritrovamento di Mastro Misciu: al ritrovamento del corpo il microcosmo minerario risponde in maniera opposta: i compagni di lavoro pensano alla sua sistemazione, Malpelo non vi partecipa perché non accetta la sua morte. Si concentra, simbolicamente, sugli oggetti che sono appartenuti al genitore, facendo dei pantaloni paterni, sentiti al tatto, una metafora delle carezze paterne. Il pensiero della morte si riaffaccia in lui quando muore il “grigio”: la vita è solo sopravvivenza, intorno alla quale ogni bisogno primario ruota; la morte come fatto positivo e cancellazione di ogni sofferenza (sembra riprendere Leopardi).
- La sciara: la sciara è la distesa di detriti lavici e quindi il magma sotterraneo riapparso sulla terra. Se è quindi il sotterraneo che riemerge, non ha alcuna differenza con quello che c’è sotto, la cava. Il suo essere nera, rimanda al colore infernale, vissuto come assoluto, cui fanno compagnia i pipistrelli, topi con le ali, come di Malpelo a Ranocchio. La vita nella sciara è una non vita, isolamento e morte, il corpo del grigio ed è la memoria di chi si è perso nelle gallerie e non è più tornato. La sequenza si chiude con una riflessione filosofica: il paradiso è non esiste, come dice Ranocchio; se raccoglie i buoni ed il padre, ch’era buono, non c’è, ma sta sotto terra, vuol dire negare qualsiasi forma d’esistenza dopo la morte ed una concezione meccanicistica della vita, sebbene totalmente inconsapevole.
- La malattia di Ranocchio: Quando muore Ranocchio cessa anche quella funzione paterna che Malpelo aveva assunto con lui. Viene pertanto richiamata la sua solitudine che lo porta alla considerazione che la vita e sofferenza, la morte lo scioglimento di essa. Considerazione già fatta, ma ora esplicitata dalla morte dell’amico e dalla visione del “grigio” nella sciara.
- Epilogo: la sequenza inizia con una prolessi, anticipando la morte di Malpelo nella cava; ma la sua morte è diversa da quella di Mastro Misciu: quest’ultima avviene per motivi economici, per Malpelo si struttura come esplorazione, che nel suo animo semplice sembra indicare ricerca della propria identità. Riprendendo l’episodio dell’Amleto, anche quest’ultimo sente la Danimarca come una prigione, anch’esso vuole ricercare se stesso, anche se questo potrebbe significare la morte. Questo fa sì che il personaggio esca dalla storia e tale uscita è testimoniata dalla presenza all’interno della cava “immaginata” dai minatori, che lo trasformano, da personaggio miserrimo, in un vero e proprio mito.
LA LUPA
Era alta, magra; aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano.
Al villaggio la chiamavano “la Lupa” perché non era sazia giammai – di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. – Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei.
Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio.
Una volta la Lupa si innamorò di un bel ragazzo che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro, ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma colui seguitava a mietere tranquillamente col naso sui manipoli, e le diceva: «O che avete, gnà Pina?»
Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: «Che volete, gnà Pina?»
Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell’aia, stanchi della lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna
nera: «Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te!»
«Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella, rispose Nanni ridendo». La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò, né più comparve nell’aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l’olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolìo del torchio non la faceva dormire tutta notte.
«Prendi il sacco delle ulive», disse alla figliuola, «e vieni con me».
Nanni spingeva colla pala le ulive sotto la macina, e gridava ohi! alla mula perché non si arrestasse. «La vuoi mia figlia Maricchia?» gli domandò la gnà Pina. «Cosa gli date a vostra figlia Maricchia?» rispose Nanni. «Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le dò la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po’ di pagliericcio». «Se è così se ne può parlare a Natale, disse Nanni» Nanni era tutto unto e sudicio dell’olio e delle ulive messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l’afferrò pe’ capelli, davanti al focolare, e le disse co’ denti stretti: «Se non lo pigli ti ammazzo!»
La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più in qua e in là; non si metteva più sull’uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l’abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni,
e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. “In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona”, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte.
«Svegliati!» disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra le braccia. «Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola».
Nanni spalancò gli occhi imbambolati, fra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani.
«No! non ne va in volta femmina buona nell’ora fra vespero e nona!» singhiozzava Nanni, ricacciando la faccia contro l’erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. «Andatevene! Andatevene! non ci venite più nell’aia!»
Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone.
Ma nell’aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla; e quando
tardava a venire, nell’ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in
cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte; – e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: «Andatevene! andatevene! Non ci tornate più nell’aia!»
Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una lupacchiotta anch’essa, quando la vedeva tornare da’ campi pallida e muta ogni volta. «Scellerata! le diceva. «Mamma scellerata!»
«Taci!»
«Ladra! ladra!»
«Taci!»
«Andrò dal brigadiere, andrò!»
«Vacci!»
E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una pazza, perché adesso l’amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio dalle ulive messe a fermentare.
Il brigadiere fece chiamare Nanni, e lo minacciò della galera, e della forca. Nanni si diede a singhiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò scolparsi. È la tentazione! diceva; è la tentazione dell’inferno! si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera.
«Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! fatemi ammazzare, mandatemi in prigione; non me la lasciate veder più, mai! mai!»
«No! rispose però la Lupa al brigadiere. Io mi son riserbato un cantuccio
della cucina per dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia. Non voglio andarmene!»
Poco dopo, Nanni s’ebbe nel petto un calcio dal mulo e fu per morire; ma il parroco ricusò di portargli il Signore se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel tempo, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell’anima e nel corpo quando fu guarito. «Lasciatemi stare!» diceva alla Lupa; «per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me…»
Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la Lupa tornava a tentarlo:
«Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi,
com’è vero Iddio, vi ammazzo!»
«Ammazzami», rispose la Lupa, «ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci».
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri.
«Ah! malanno all’anima vostra!» balbettò Nanni.

Scena del film di Alberto Lattuada “La lupa” con Anna Magnani e Osaldo Parenti
Anche la Lupa come Malpelo ha qualcosa di ferino e quindi è un’isolata all’interno del consorzio sociale; la sua animalità tuttavia è tutta nella sessualità, la quale viene vissuta al di là di qualsiasi convenzione, rispondendo solo ad un appetito che non conosce né regole né relazioni. Non solo ha rovinato molti uomini, tra cui quel santo del parroco, ma addirittura ruba il marito alla figlia, a cui l’aveva dato proprio per averlo vicino. E’ talmente assatanata da essere, come dice il nome stesso, associata al diavolo ed è per questo che intorno a lei girano superstizioni, a volte riferite con detti popolari (l’uso della lingua è più vicino al parlato di quanto fosse in Malpelo). A livello stilistico il ritmo narrativo si presenta veloce, ellittico. Anche questa storia ha qualcosa di mitico: in Malpelo si dà il mito nel non ritrovamento, nel perdersi all’interno della cava, in la Lupa nell’assenza di ambiente: terra, natura, ciclicità del raccolto, ma non vi è altro, non vi è paese, non vi sono persone. Ed è un mito che resiste anche nella morte: ad essere sconfitto è Nanni, che di fronte a lei non può che emettere un debole borbottio.
I Malavoglia
Ad un anno dalla pubblicazione delle novelle Vita dai campi, Verga dà vita al suo capolavoro:

Gente di Acitrezza
I Toscano, detti “Malavoglia”, pescatori di Aci Trezza, posseggono una casa e una barca, la “Provvidenza”. Padron ‘Ntoni, il vecchio capofamiglia, padre di Bastianazzo che a sua volta ha cinque figli, compra un carico di lupini da vendere altrove; ma la barca fa naufragio, Bastianazzo muore e i lupini vanno perduti; per i Malavoglia è l’inizio di una lunga serie di sventure. Per pagare il debito bisogna vendere la casa (“la casa del nespolo”); Luca, il secondo genito di Bastianazzo, cade nella battaglia di Lissa e anche la vedova, Maruzza, muore vittima del colera. Sotto i colpi della sorte avversa, i giovani non resistono: ‘Ntoni, il figlio maggiore di Bastianazzo, comincia a frequentare cattive compagnie, si da’ al contrabbando e finisce in galera, e anche la sorella più piccola, Lia, compromessa per le voci che circolano su una sua presunta relazione con don Michele, il brigadiere delle guardie doganali, fugge di casa e scompare (si saprà poi che è diventata una prostituta); mentre la sorella maggiore, Mena, a causa delle difficoltà economiche non potrà sposarsi con compare Alfio. Con la morte di padron ‘Ntoni la famiglia è smembrata; ‘Ntoni lascerà il paese per andare lontano. Resterà, per riscattare la casa del nespolo e continuare il mestiere del nonno, il più giovane dei fratelli, Alessi.
PREFAZIONE AI MALAVOGLIA
Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosìa dell’ignoto, l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio.
Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei “Malavoglia” non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, “Mastro-don Gesualdo”, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella “Duchessa de Leyra”; e ambizione nell’“Onorevole Scipioni”, per arrivare all’“Uomo di lusso”, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è consunto. A misura che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perché la riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla spiegazione dell’argomento generale.
Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorìo universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani.
“I Malavoglia”, “Mastro-don Gesualdo”, la “Duchessa de Leyra”, l’“Onorevole Scipioni”, l’ “Uomo di lusso”, sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione – dall’umile pescatore al nuovo arricchito – alla intrusa nelle alte classi – all’uomo dall’ingegno e dalle volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sé quella parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare la legge, lui nato fuori della legge – all’artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un’altra forma dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere.
Milano, 19 gennaio, 1881
Il passo rivela un elemento non toccato dalle novelle: potremo dire che la riflessione verghiana in questo progetto narrativo, è concentrata sul divenire storico, su quel “progresso”, perno su cui ruota la filosofia positivista; qui egli definisce il “progresso” come una “fiumana”, termine che indica una forza che travolge ogni cosa, contro la quale non ci si può opporre. E’ per questo che il suo impeto abbatte ogni forma umana, dalla più semplice alla più elevata. Anzi, il nostro sembra quasi dirci che pur nella disperazione, forse la condizione più felice sia quella miserrima dei pescatori di Aci Trezza. Potremo dire, come in Fantasticheria, che essi, come l’ostrica, hanno avuto ancora la possibilità di starsene attaccati sullo scoglio, come farà Alessi, ma non appena gli si offre la possibilità di superare il limite loro concesso dalla “storia”, si perdono; non per niente estremamente più tragico è l’esito del Mastro, dove domina la più nera solitudine e lo scherno.
Non è da tacere il tentativo da parte di Verga di fare un ciclo, secondo la moda dapprima balzacchiana poi confermata da Zola; il titolo che voleva dare ad esso era I Vinti, a confermare che non c’era, nel suo disegno, alcuno che potesse scampare al determinismo della storia e a rafforzare la sua idea sul progresso antitetica rispetto al naturalismo francese.
LA FAMIGLIA MALAVOGLIA
(cap. 1)
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ‘Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo.
E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria della città; e così grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: ‘Ntoni il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant’Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. – Alla domenica, quando entravano in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione. Padron ‘Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perché il motto degli antichi mai mentì»: – «Senza pilota barca non cammina» – «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» – oppure – «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» – «Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose.
Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron ‘Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria.
Padron ‘Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto».

Mena e Lia
Sin dall’inizio Verga ci immerge all’interno della storia narrata attraverso la scomparsa dello scrittore onnisciente. I Malavoglia si presentano da sé senza bisogno di alcuna introduzione. La “veridicità” del racconto viene poi amplificata dal parlare formulario di Padron ‘Ntoni: l’uso ripetuto dei proverbi, che rappresentano per lui la saggezza popolare, ci rimandano ad un tempo mitico, immutabile, come immutabile è il perno attorno al quale ruota l’intera famiglia: “la casa del nespolo” che viene a simboleggiare l’unità familiare, sottolineata dalla metafora delle dita della mano. Si affaccia in questa pagina, inoltre, l’uso dell’indiretto libero: quando nell’ultimo periodo l’autore fa proprio il pensiero del personaggio. Tale circolarità mitica verrà interrotta dall’arrivo della storia: il servizio militare all’indomani dell’unità d’Italia.
MENA
(cap. 2)
Maruzza udendo suonare un’ora di notte era rientrata in casa lesta lesta, per stendere la tovaglia sul deschetto; le comari a poco a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava addormentandosi, si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto. Soltanto laggiù all’osteria, dove si vedeva il lumicino rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu il quale faceva festa tutti i giorni.
«Compare Rocco ha il cuore contento», disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno.
«Oh siete ancora là, compare Alfio!» rispose Mena, la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno.
«Sì, sono qua, comare Mena; sto qua a mangiarmi la minestra; perché quando vi vedo tutti a tavola, col lume, mi pare di non esser tanto solo, che va via anche l’appetito».
«Non ce l’avete il cuore contento voi?»
«Eh! ci vogliono tante cose per avere il cuore contento!»
Mena non rispose nulla, e dopo un altro po’ di silenzio compare Alfio soggiunse: «Domani vado alla città per un carico di sale».
«Che ci andate poi per i Morti?» domandò Mena.
«Dio lo sa, quest’anno quelle quattro noci son tutte fradicie.
«Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città», rispose la Nunziata dall’uscio dirimpetto.
«Che è vero?» domandò Mena.
«Eh, comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n’è delle ragazze come dico io, senza andare a cercarle lontano»
«Guardate quante stelle che ammiccano lassù!» rispose Mena dopo un pezzetto. «Ei dicono che sono le anime del Purgatorio che se ne vanno in Paradiso».
«Sentite», le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui; «voi che siete sant’Agata, se vi sognate un terno buono, ditelo a me, che ci giuocherò la camicia, e allora potrò pensarci a prender moglie…»
«Buona sera!» rispose Mena.
Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i tre re scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant’Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c’era pure della gente che andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti; – così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno.
Nel II capitolo del romanzo vengono presentati i vari componenti del paese, i piccoli proprietari, che si riuniscono in piazza sui gradini della chiesa, i notabili, che si ritrovano nella farmacia, dove discutono di politica, e quello dei paesani e degli uomini, il cui punto di ritrovo è l’osteria. Le donne sono in strada. Il capitolo si chiude col momento lirico di Mena ed Alfio. Quest’ultimo fa capire a Mena che al ritorno dal paese la vorrebbe sposare, ma Mena lo invita a contemplare il paesaggio. Tutto viene antropomorfizzato: le stelle ammiccano, il mare russa. Il divagare di Mena è figlio dell’ansia per il padre in mare: sembra quasi presagire la forza della natura sulla piccolezza dell’uomo e sul suo agire e quindi sulla storia; e sarà proprio la natura a sopraffare l’azione di Bastianazzo:
LA TRAGEDIA
(cap. 3)
Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di sant’Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell’anima di Giuda. Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia, e bene ammarrate alle grosse pietre sotto il lavatoio; perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in poppa; le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la povera gente che vi era dentro.
Maruzza la Longa non diceva nulla, com’era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava sempre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l’uovo. Gli uomini erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder piovere, col naso in aria. Sulla riva c’era soltanto padron ‘Ntoni, per quel carico di lupini che vi aveva in mare colla Provvidenza e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba, nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della Locca, colla Provvidenza e il carico dei lupini.
«Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire!» diceva stringendosi nelle spalle; «e poi quando hanno perso la mula vanno cercando la cavezza.»
Nella bottega di suor Mariangela la Santuzza c’era folla: quell’ubbriacone di Rocco Spatu, il quale vociava e sputava per dieci; compare Tino Piedipapera, mastro Turi Zuppiddu, compare Mangiacarrubbe, don Michele il brigadiere delle guardie doganali, coi calzoni dentro gli stivali, e la pistola appesa sul ventre, quasi dovesse andare a caccia di contrabbandieri con quel tempaccio, e compare Mariano Cinghialenta. Quell’elefante di mastro Turi Zuppiddu andava distribuendo per ischerzo agli amici dei pugni che avrebbero accoppato un bue, come se ci avesse ancora in mano la malabestia di calafato, e allora compare Cinghialenta si metteva a gridare e bestemmiare, per far vedere che era uomo di fegato e carrettiere.
Lo zio Santoro, raggomitolato sotto quel po’ di tettoia, davanti all’uscio, aspettava colla mano stesa che passasse qualcheduno per chiedere la carità. «Tra tutte e due, padre e figlia», disse compare Turi Zuppiddu, «devono buscarne dei bei soldi, con una giornata come questa, e tanta gente che viene all’osteria.»
«Bastianazzo Malavoglia sta peggio di lui, a quest’ora», rispose Piedipapera, «e mastro Cirino ha un bel suonare la messa; ma i Malavoglia non ci vanno oggi in chiesa; sono in collera con Domeneddio, per quel carico di lupini che ci hanno in mare.»
Il vento faceva volare le gonnelle e le foglie secche, sicché Vanni Pizzuto col rasoio in aria, teneva pel naso quelli a cui faceva la barba, per voltarsi a guardare chi passava, e si metteva il pugno sul fianco, coi capelli arricciati e lustri come la seta; e lo speziale se ne stava sull’uscio della sua bottega, sotto quel cappellaccio che sembrava avesse il paracqua in testa, fingendo aver discorsi grossi con don Silvestro il segretario, perché sua moglie non lo mandasse in chiesa per forza; e rideva del sotterfugio, fra i peli della barbona, ammiccando alle ragazze che sgambettavano nelle pozzanghere.
(…)
Ciascuno non poteva a meno di pensare che quell’acqua e quel vento erano tutt’oro per i Cipolla; così vanno le cose di questo mondo, che i Cipolla, adesso che avevano la paranza bene ammarrata, si fregavano le mani vedendo la burrasca; mentre i Malavoglia diventavano bianchi e si strappavano i capelli, per quel carico di lupini che avevano preso a credenza dallo zio Crocifisso Campana di legno.
«Volete che ve la dica?» saltò su la Vespa; «la vera disgrazia è toccata allo zio Crocifisso che ha dato i lupini a credenza. “Chi fa credenza senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno”.
Lo zio Crocifisso se ne stava ginocchioni a piè dell’altare dell’Addolorata, con tanto di rosario in mano, e intuonava le strofette con una voce di naso che avrebbe toccato il cuore a satanasso in persona. Fra un’avemaria e l’altra si parlava del negozio dei lupini, e della Provvidenza che era in mare, e della Longa che rimaneva con cinque figliuoli. «Al giorno d’oggi», disse padron Cipolla, stringendosi nelle spalle, «nessuno è contento del suo stato e vuol pigliare il cielo a pugni.»
«Il fatto è», conchiuse compare Zuppiddu, «che sarà una brutta giornata pei Malavoglia».
(…)
Sull’imbrunire comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla sciara, d’onde si scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciara, a quell’ora, parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera donna, le sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per tranquillarla, e le cantava le canzonette colla voce tremola che sapeva di lagrime anche essa. Le comari, mentre tornavano dall’osteria coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare qualche parola con la Longa senza aver l’aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla, per esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciara per dare un’occhiata verso il mare, e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a comare la Longa di suo marito, e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro. La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva al petto la bimba, come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre, e badava a ripetere: «Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria!» I figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi all’osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa.
«Requiem eternam», biascicava sottovoce lo zio Santoro, quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la carità, quando padron ‘Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca.
La poveretta che non sapeva di essere vedova, balbettava: «Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria!» Dinanzi al ballatoio della sua casa c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa.
«Che disgrazia!» dicevano sulla via. «E la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini!»
In questi passi del terzo capitolo si coglie la dinamica che intercorre il mondo dei Malavoglia e quello del paese. Il primo appare un mondo legato ai valori antichi dell’onestà e della dedizione al lavoro; il secondo, i paesani, vedono il mondo solo solo l’ottica del profitto: si percepisce, grazie anche al discorso indiretto libero, che per loro la disgrazia è nel “naufragio” dell’affare: sia per frate Cipolla, che ha prestato ad usura il carico di lupini, sia per padron ’Ntoni che aveva fatto un investimento a questo punto fallimentare. Il problema è che i mondi non si incontrano e, da parte dei più, c’è fraintendimento, per cui ogni azione dei Malavoglia, fosse questa legata alla loro concezione della vita, viene travisata e vista con l’unica ottica che il paese conosce. Circonda l’intero passo il concetto di fatalità, tipico, come già visto, della cultura siciliana. Il paese sembra guardare con estremo distacco all’evento in sé, quello che accade è destino che accada, l’uomo non ha la forza d’opporsi, ci dicono i personaggi del paese; ma lo stesso diceva Mena alla fine del capitolo precedente.

Mena e Lia sugli scogli scrutano il mare
RITRATTO DELLO ZIO CROCIFISSO
(cap. 4)
Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza, e lo zio Crocifisso non si contentava di “buone parole e mele fradicie”, per questo lo chiamavano Campana di legno, perché non ci sentiva di quell’orecchio, quando lo volevano pagare con delle chiacchiere, e’ diceva che “alla credenza ci si pensa”.
Egli era un buon diavolaccio, e viveva imprestando agli amici, non faceva altro mestiere, che per questo stava in piazza tutto il giorno, colle mani nelle tasche, o addossato al muro della chiesa, con quel giubbone tutto lacero che non gli avreste dato un baiocco; ma aveva denari sin che ne volevano, e se qualcheduno andava a chiedergli dodici tarì glieli prestava subito, col pegno, perché “chi fa credenza senza pegno, perde l’amico, la roba e l’ingegno” a patto di averli restituiti la domenica, d’argento e colle colonne, che ci era un carlino dippiù, com’era giusto, perché “coll’interesse non c’è amicizia”. Comprava anche la pesca tutta in una volta, con ribasso, e quando il povero diavolo che l’aveva fatta aveva bisogno subito di denari, ma dovevano pesargliela colle sue bilancie, le quali erano false come Giuda, dicevano quelli che non erano mai contenti, ed hanno un braccio lungo e l’altro corto, come san Francesco; e anticipava anche la spesa per la ciurma, se volevano, e prendeva soltanto il denaro anticipato, e un rotolo di pane a testa, e mezzo quartuccio di vino, e non voleva altro, ché era cristiano e di quel che faceva in questo mondo avrebbe dovuto dar conto a Dio. Insomma era la provvidenza per quelli che erano in angustie, e aveva anche inventato cento modi di render servigio al prossimo, e senza essere uomo di mare aveva barche, e attrezzi, e ogni cosa, per quelli che non ne avevano, e li prestava, contentandosi di prendere un terzo della pesca, più la parte della barca, che contava come un uomo della ciurma, e quella degli attrezzi, se volevano prestati anche gli attrezzi, e finiva che la barca si mangiava tutto il guadagno, tanto che la chiamavano la barca del diavolo – e quando gli dicevano perché non ci andasse lui a rischiare la pelle come tutti gli altri, che si pappava il meglio della pesca senza pericolo, rispondeva: «Bravo! e se in mare mi capita una disgrazia, Dio liberi, che ci lascio le ossa, chi me li fa gli affari miei?» Egli badava agli affari suoi, ed avrebbe prestato anche la camicia; ma poi voleva esser pagato, senza tanti cristi; ed era inutile stargli a contare ragioni, perché era sordo, e per di più era scarso di cervello, e non sapeva dir altro che “Quel che è di patto non è d’inganno”, oppure “Al giorno che promise si conosce il buon pagatore”.
Ora i suoi nemici gli ridevano sotto il naso, a motivo di quei lupini che se l’era mangiati il diavolo; e gli toccava anche recitare il deprofundis per l’anima di Bastianazzo, quando si facevano le esequie, insieme con gli altri confratelli della Buona Morte, colla testa nel sacco.
I vetri della chiesetta scintillavano, e il mare era liscio e lucente, talché non pareva più quello che gli aveva rubato il marito alla Longa; perciò i confratelli avevano fretta di spicciarsi, e di andarsene ognuno pei propri affari, ora che il tempo s’era rimesso al buono.
Stavolta i Malavoglia erano là, seduti sulle calcagna, davanti al cataletto, e lavavano il pavimento dal gran piangere, come se il morto fosse davvero fra quelle quattro tavole, coi suoi lupini al collo, che lo zio Crocifisso gli aveva dati a credenza, perché aveva sempre conosciuto padron ‘Ntoni per galantuomo; ma se volevano truffargli la sua roba, col pretesto che Bastianazzo s’era annegato, la truffavano a Cristo, com’è vero Dio! ché quello era un credito sacrosanto come l’ostia consacrata, e quelle cinquecento lire ei l’appendeva ai piedi di Gesù crocifisso; ma santo diavolone! padron ‘Ntoni sarebbe andato in galera! La legge c’era anche a Trezza!
La descrizione della figura dell’usuraio rappresenta un chiaro atteggiamento verghiano di “eclissi dell’autore”: a leggerlo è la concezione del paese; nel giro di un paragrafo dapprima lo chiama “campana di legno” perché non vuol sentirci per quanto riguarda il riscatto dei debiti; dall’altro “buon diavolaccio, viveva imprestando agli amici”; mano mano che la descrizione va avanti tali contraddizioni continuano ad emergere notiamo che da una parte il paese sottolinea la sua avidità nel commercio marino, dall’altra ne testimonia la necessità per chi vive in angustie. E’, come già detto, tutto ridotto all’economicità. Ce ne rendiamo conto anche all’interno della chiesa durante le esequie di Bastianazzo: il pensiero di un possibile rifiuto di resa del credito da parte dei Malavoglia viene visto come una bestemmia fatta al Signore, non rendendosi conto che a bestemmiare è proprio lui che “sacralizza” l’usura . Il suo nome, poi, cos’ legato al messaggio cristiano è, come spesso in Verga, usato in antifrasi: Crocifisso allo stesso modo in cui lui crocifigge i suoi creditori.
L’ABBANDONO DELLA CASA DEL NESPOLO
(cap. 9)
Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene colle buone dalla casa del nespolo, dopo tanto tempo che ci erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese, espatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare, e non erano tornati più, che ancora c’era lì il letto di Luca, e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie, e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dov’era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. La roba la trasportarono di notte, nella casuccia del beccaio che avevano presa in affitto, come se non si sapesse in paese che la casa del nespolo oramai era di Piedipapera, e loro dovevano sgomberarla, ma almeno nessuno li vedeva colla roba in collo. Quando il vecchio staccava un chiodo, o toglieva da un cantuccio un deschetto che soleva star lì di casa, faceva una scrollatina di capo. Poi si misero a sedere sui pagliericci ch’erano ammonticchiati nel mezzo della camera, per riposarsi un po’, e guardavano di qua e di là se avessero dimenticato qualche cosa; però il nonno si alzò tosto ed uscì nel cortile, all’aria aperta. Ma anche lì c’era della paglia sparsa per ogni dove, dei cocci di stoviglie, delle nasse sfasciate, e in un canto il nespolo, e la vite in pampini sull’uscio. «Andiamo via! diceva egli. Andiamo via, ragazzi. Tanto, oggi o domani!…» e non si muoveva. Maruzza guardava la porta del cortile dalla quale erano usciti Luca e Bastianazzo, e la stradicciuola per la quale il figlio suo se ne era andato coi calzoni rimboccati, mentre pioveva, e non l’aveva visto più sotto il paracqua d’incerata. Anche la finestra di compare Alfio Mosca era chiusa, e la vite pendeva dal muro del cortile che ognuno passando ci dava una strappata. Ciascuno aveva qualche cosa da guardare in quella casa, e il vecchio, nell’andarsene posò di nascosto la mano sulla porta sconquassata, dove lo zio Crocifisso aveva detto che ci sarebbero voluti due chiodi e un bel pezzo di legno.

La casa del nespolo
Lo zio Crocifisso era venuto a dare un’occhiata insieme a Piedipapera, e parlavano a voce alta nelle stanze vuote, dove le parole si udivano come se fossero in chiesa. Compare Tino non aveva potuto durarla a campare d’aria sino a quel giorno, e aveva dovuto rivendere ogni cosa allo zio Crocifisso, per riavere i suoi denari.
«Che volete, compare Malavoglia?» gli diceva passandogli il braccio attorno al collo. «Lo sapete che sono un povero diavolo, e cinquecento lire mi fanno! Se voi foste stato ricco ve l’avrei venduta a voi». Ma padron ‘Ntoni non poteva soffrire di andare così per la casa, col braccio di Piedipapera al collo. Ora lo zio Crocifisso ci era venuto col falegname e col muratore, e ogni sorta di gente che scorrazzavano di qua e di là per le stanze come fossero in piazza, e dicevano: «Qui ci vogliono dei mattoni, qui ci vuole un travicello nuovo, qui c’è da rifare l’imposta», come se fossero i padroni; e dicevano anche che si doveva imbiancarla per farla sembrare tutt’altra.
Lo zio Crocifisso andava scopando coi piedi la paglia e i cocci, e raccolse anche da terra un pezzo di cappello che era stato di Bastianazzo, e lo buttò nell’orto, dove avrebbe servito all’ingrasso. Il nespolo intanto stormiva ancora, adagio adagio, e le ghirlande di margherite, ormai vizze, erano tuttora appese all’uscio e le finestre, come ce le avevano messe a Pasqua delle Rose.
La Vespa era venuta a vedere anche lei, colla calzetta al collo, e frugava per ogni dove, ora che era roba di suo zio. Il “sangue non è acqua” andava dicendo forte, perché udisse anche il sordo. A me mi sta nel cuore la roba di mio zio, come a lui deve stare a cuore la mia chiusa. Lo zio Crocifisso lasciava dire e non udiva, ora che dirimpetto si vedeva la porta di compare Alfio con tanto di catenaccio. «Adesso che alla porta di compare Alfio c’è il catenaccio, vi metterete il cuore in pace, e lo crederete che non penso a lui!» diceva la Vespa all’orecchio dello zio Crocifisso. «Io ci ho il cuore in pace! rispondeva lui: sta tranquilla».
D’allora in poi i Malavoglia non osarono mostrarsi per le strade né in chiesa la domenica, e andavano sino ad Aci Castello per la messa, e nessuno li salutava più, nemmeno padron Cipolla, il quale andava dicendo: «Questa partaccia a me non la doveva fare padron ‘Ntoni. Questo si chiama gabbare il prossimo, se ci aveva fatto mettere la mano di sua nuora nel debito dei lupini!» «Tale e quale come dice mia moglie!» aggiungeva mastro Zuppiddu. «Dice che dei Malavoglia adesso non ne vogliono nemmeno i cani»
L’abbandono della casa del nespolo viene vissuta dai Malavoglia come fatto vergognoso, di notte senza che li veda nessuno. I gesti del vecchio, che ad ogni atto di sgombero scrolla il capo e infine, come se il peso della “sventura” gli pesasse all’improvviso, ordina, quasi, di andarsene via al più presto è l’unico momento lirico, incastonato così ad una vera profanazione di ciò che per padron ’Ntoni era un luogo sacro. La legge dell’economia pervade ancora, in modo prepotente, le azioni. Zio Crocifisso vi entra da padrone, la desacralizza letteralmente (parlavano a voce alta nelle stanze vuote, dove le parole si udivano come se fossero in chiesa), e cancella la storia, i ricordi, i sentimenti con un gesto brutale, definitivo (raccolse anche da terra un pezzo di cappello che era stato di Bastianazzo, e lo buttò nell’orto, dove avrebbe servito all’ingrasso).
IL VECCHIO ED IL NUOVO
(cap. 11)
Ma d’allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull’uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari dell’asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena aspettando che lo bardassero! «Carne d’asino!» borbottava; «ecco cosa siamo! Carne da lavoro!» E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l’accarezzava sulle spalle, e l’accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse, e chiamò il nipote fuori dell’uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse.
«Orsù, che c’è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo!»
‘Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si grattava il capo cercando le parole.
«Sì, sì, qualcosa ce l’hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c’era prima. “Chi va coi zoppi, all’anno zoppica”.
«C’è che sono un povero diavolo! ecco cosa c’è!»
«Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch’è stato tuo nonno! “Più ricco è in terra chi meno desidera”. “Meglio contentarsi che lamentarsi”.
«Bella consolazione!»
Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra: «Almeno non lo dire davanti a tua madre»
«Mia madre… Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre!»
«Sì», accennava padron ‘Ntoni, «sì! meglio che non t’avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal modo».
‘Ntoni per un po’ non seppe che dire: «Ebbene!» esclamò poi, «lo faccio per lei, per voi, e per tutti. Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po’ che le annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti». Padron ‘Ntoni spalancò tanto d’occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar giù. «Ricchi!» diceva, «ricchi! e che faremo quando saremo ricchi?»
‘Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. «Faremo quel che fanno gli altri… Non faremo nulla, non faremo!… Andremo a stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni».
«Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato»; e pensando alla casa dove era nato, e che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto.
«Tu sei un ragazzo, e non lo sai!… non lo sai!… Vedrai cos’è quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!… Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio!» Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: «“Ad ogni uccello, suo nido è bello”. Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene».
«Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro!» rispondeva ‘Ntoni. «Io non voglio vivere come un cane alla catena, come l’asino di compare Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girar la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani».
«Ringrazia Dio piuttosto, che t’ha fatto nascer qui; e guardati dall’andare a morire lontano dai sassi che ti conoscono. Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova”. Tu hai paura del lavoro, hai paura della povertà; ed io che non ho più né le tue braccia né la tua salute non ho paura, vedi! “Il buon pilota si prova alle burrasche”. Tu hai paura di dover guadagnare il pane che mangi; ecco cos’hai! Quando la buon’anima di tuo nonno mi lasciò la Provvidenza e cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non aveva paura; ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e prego Iddio di aiutarmi a farlo sempre sinché ci avrò gli occhi aperti, come l’ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca, benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua madre l’ha fatto anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai quante lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose che ti vengono in mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei; non ha fatto altro, tutta la sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la tentazione di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno zingaro».
In conclusione ‘Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il cuore ce l’aveva buono come il pane; ma il giorno dopo tornò da capo. La mattina si lasciava caricare svogliatamente degli arnesi, e se ne andava al mare brontolando: «Tale e quale l’asino di compare Alfio! come fa giorno allungo il collo per vedere se vengono a mettermi il basto».
Fino adesso nel romanzo abbiamo incontrato due tipologie romanzesche: da un lato i paesani, legati al profitto, umanamente disinteressati alle vicende altrui, gretti e meschini; dall’altra l’onestà di padron ‘Ntoni. Ora, nella narrazione, appare in modo ancor più violento del primo la storia. Essa dapprima aveva portato ‘Ntoni fuori dal paese, nella grande città, a Napoli, a fare il soldato, e, nel bene o nel male, aveva installato in lui, la “malattia” del cambiamento; poi Luca, che invece la storia se l’è preso, morendo per una guerra per lui lontana e senza senso. Ora la “malattia” di ‘Ntoni esplode, come una metastasi impazzita: è bastato l’arrivo in paese di due contrabbandieri, soldi facili si direbbe, per gravare su di lui l’insopportabilità di una vita sempre uguale e la voglia di fuggire. Ecco allora che si mettono in campo due visioni del mondo antitetiche: il conservatorismo del nonno e il ribellismo del nipote, il mondo statico di padron ‘Ntoni e il mondo dinamico di ‘Ntoni.
Se ci fossimo trovati di fronte ad un romanzo zoliano, molto probabilmente l’idea di uno sviluppo positivo, il tentativo di uscire da una condizione per migliorare la propria vita, sarebbe stato positivo. Per il conservatore Verga no: il ribellismo di ‘Ntoni non ha prospettive; la ricchezza è uguale alla scioperatezza, ad una condizione malata di essa; si è che Verga non vede prospettive, la sua storia è storia di fallimenti, non di progresso. Ma ciò non vuol dire che sia possibile ripristinare il passato:
IL RITORNO DI ALFIO
(cap. 15)
Alfio Mosca, mentre guidava il mulo, andava raccontando alla Nunziata come e dove avesse vista la Lia, ch’era tutta Sant’Agata, e ancora non gli pareva vero a lui stesso che l’avesse vista coi suoi occhi, tanto che la voce gli mancava nella gola, mentre ne parlava per ingannare la noia, lungo la strada polverosa. – Ah Nunziata! chi l’avrebbe detto, quando stavamo a chiacchierare da un uscio all’altro, e c’era la luna, e i vicini discorrevano lì davanti, e si udiva colpettare tutto il giorno quel telaio di Sant’Agata, e quelle galline che la conoscevano soltanto all’aprire che faceva il rastrello, e la Longa che la chiamava pel cortile, che ogni cosa si udiva da casa mia come se fosse stato proprio là dentro! Povera Longa! Adesso, vedi, che ci ho il mulo, e ogni cosa come desideravo, che se fosse venuto a dirmelo l’angelo del cielo non ci avrei creduto, adesso penso sempre a quelle sere là, quando udivo la voce di voialtre, mentre governavo l’asino, e vedevo il lume nella casa del nespolo, che ora è chiusa, e quando son tornato non ho trovato più niente di quel che avevo lasciato, e comare Mena non mi è parsa più quella. Uno che se ne va dal paese è meglio non ci torni più. Vedi, ora penso pure a quel povero asino che ha lavorato con me tanto tempo, e andava sempre, sole o pioggia, col capo basso e le orecchie larghe. Adesso chissà dove lo cacciano, e con quali carichi, e per quali strade, colle orecchie più basse ancora, ché anch’egli fiuta col naso la terra che deve raccoglierlo, come si fa vecchio, povera bestia! Padron ‘Ntoni, disteso sulla materassa, non udiva nulla, e ci avevano messo sul carro una coperta colle canne, sicché sembrava che portassero un morto. «Per lui è meglio che non oda più nulla», seguitava compare Alfio. «L’angustia di ‘Ntoni già l’ha sentita, e un giorno o l’altro gli toccherebbe anche di sentire come è andata a finire la Lia.»
(…)
Giacché tutti si maritavano, Alfio Mosca avrebbe voluto prendersi comare Mena, che nessuno la voleva più, dacché la casa dei Malavoglia s’era sfasciata, e compar Alfio avrebbe potuto dirsi un bel partito per lei, col mulo che ci aveva; così la domenica ruminava fra di sé tutte le ragioni per farsi animo, mentre stava accanto a lei, seduto davanti alla casa, colle spalle al muro, a sminuzzare gli sterpolini della siepe per ingannare il tempo. Anche lei guardava la gente che passava, e così facevano festa la domenica: «Se voi mi volete ancora, comare Mena», disse finalmente, «io per me son qua.»
La povera Mena non si fece neppur rossa, sentendo che compare Alfio aveva indovinato che ella lo voleva, quando stavano per darla a Brasi Cipolla, tanto le pareva che quel tempo fosse lontano, ed ella stessa non si sentiva più quella.«Ora sono vecchia, compare Alfio», rispose, «e non mi marito più.»
«Se voi siete vecchia, anch’io sono vecchio, ché avevo degli anni più di voi, quando stavamo a chiacchierare dalla finestra, e mi pare che sia stato ieri, tanto m’è rimasto in cuore. Ma devono esser passati più di otto anni. E ora quando si sarà maritato vostro fratello Alessi, voi restate in mezzo alla strada.»
Mena si strinse nelle spalle, perché era avvezza a fare la volontà di Dio, come la cugina Anna; e compare Alfio, vedendo così, riprese: «Allora vuol dire che non mi volete bene, comare Mena, e scusatemi se vi ho detto che vi avrei sposata. Lo so che voi siete nata meglio di me, e siete figlia di padroni; ma ora non avete più nulla, e se si marita vostro fratello Alessi, rimarrete in mezzo alla strada. Io ci ho il mulo e il mio carro, e il pane non ve lo farei mancare giammai, comare Mena. Ora perdonatemi la libertà!»
«Non mi avete offesa, no, compare Alfio; e vi avrei detto di sì anche quando avevamo la Provvidenza e la casa del nespolo, se i miei parenti avessero voluto, che Dio sa quel che ci avevo in cuore quando ve ne siete andato alla Bicocca col carro dell’asino, e mi pare ancora di vedere quel lume nella stalla, e voi che mettevate tutta la vostra roba sul carretto, nel cortile; vi rammentate?»
«Sì, che mi rammento! Allora perché non mi dite di sì, ora che non avete più nulla, e ci ho il mulo invece dell’asino al carretto, e i vostri parenti non potrebbero dir di no?»
«Ora non son più da maritare;» tornava a dire Mena col viso basso, e sminuzzando gli sterpolini della siepe anche lei. «Ho 26 anni, ed è passato il tempo di maritarmi.»
«No, che non è questo il motivo per cui non volete dirmi di sì!» ripeteva compar Alfio col viso basso come lei. «Il motivo non volete dirmelo!»
E così rimanevano in silenzio a sminuzzare sterpolini senza guardarsi in faccia. Dopo egli si alzava per andarsene, colle spalle grosse e il mento sul petto. Mena lo accompagnava cogli occhi finché poteva vederlo, e poi guardava al muro dirimpetto e sospirava. Come aveva detto Alfio Mosca, Alessi s’era tolta in moglie la Nunziata, e aveva riscattata la casa del nespolo.
«Io non son da maritare», aveva tornato a dire la Mena; «maritati tu che sei da maritare ancora;» e così ella era salita nella soffitta della casa del nespolo, come le casseruole vecchie, e s’era messo il cuore in pace, aspettando i figliuoli della Nunziata per far la mamma. Ci avevano pure le galline nel pollaio, e il vitello nella stalla, e la legna e il mangime sotto la tettoia, e le reti e ogni sorta di attrezzi appesi, il tutto come aveva detto padron ‘Ntoni; e la Nunziata aveva ripiantato nell’orto i broccoli ed i cavoli, con quelle braccia delicate che non si sapeva come ci fosse passata tanta tela da imbiancare, e come avesse fatti quei marmocchi grassi e rossi che la Mena si portava in collo pel vicinato, quasi li avesse messi al mondo lei, quando faceva la mamma. Compare Mosca scrollava il capo, mentre la vedeva passare, e si voltava dall’altra parte, colle spalle grosse. «A me non mi avete creduto degno di quest’onore!» le disse alfine quando non ne poté più, col cuore più grosso delle spalle. «Io non ero degno di sentirmi dir di sì!»
«No, compar Alfio!» rispose Mena la quale si sentiva spuntare le lagrime. «Per quest’anima pura che tengo sulle braccia! Non è per questo motivo. Ma io non son più da maritare.»
«Perché non siete più da maritare, comare Mena?»
«No! no!» – ripeteva comare Mena, che quasi piangeva. «Non me lo fate dire, compar Alfio! Non mi fate parlare! Ora se io mi maritassi, la gente tornerebbe a parlare di mia sorella Lia, giacché nessuno oserebbe prendersela una Malavoglia, dopo quello che è successo. Voi pel primo ve ne pentireste. Lasciatemi stare, che non sono da maritare, e mettetevi il cuore in pace.
«Avete ragione, comare Mena!» rispose compare Mosca; «a questo non ci avevo mai pensato. Maledetta la sorte che ha fatto nascere tanti guai! Così compare Alfio si mise il cuore in pace, e Mena seguitò a portare in braccio i suoi nipoti, quasi ci avesse il cuore in pace anche lei, e a spazzare la soffitta, per quando fossero tornati gli altri, che c’erano nati anche loro, – come se fossero stati in viaggio per tornare! – diceva Piedipapera.
Il ritorno di Alfio è giocato sul ricordo: il piano del ricordo che vuole rimettere in gioco nel presente, la Mena di ieri e la Mena di oggi. Anche qui, come nel passo precedente, le loro figure rimandano ad una sorte di pudore sentimentale, che può diventare “sfacciataggine” di compare Alfio, una “sfacciataggine” tuttavia che non offende, determinata dal sentimento che non è mai cambiato nei confronti della nipote di padron ‘Ntoni. Ma il passato non può tornare. Uno che se ne va dal paese è meglio che non torni più, dice Alfio; le cose cambiano ed anche i sentimenti escono sconfitti. La storia ha cambiato le situazioni, non esiste più circolarità.
IL RITORNO DI ‘NTONI
(cap. 15)
Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l’uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non riconobbe ‘Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato, e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ei non sembrava più quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il cane gli abbaiava, ché non l’aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi ‘Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. Alessi non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si sentì balzare il cuore dal petto, e Mena gli disse tutta smarrita: «Te ne vai?»
«Sì!» rispose ‘Ntoni.
«E dove vai?» chiese Alessi.
«Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacché son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui non posso starci, ché tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono.»
Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa, e capivano che egli faceva bene a dir così. ‘Ntoni continuava a guardare dappertutto, e stava sulla porta, e non sapeva risolversi ad andarsene.
«Ve lo farò sapere dove sarò;» disse infine, e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era scuro, disse anche: «E il nonno?»
Alessi non rispose; ‘Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto: «E la Lia che non l’ho vista?»
E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse colla voce tremante, quasi avesse freddo: «E’ morta anche lei?» Alessi non rispose nemmeno; allora ‘Ntoni che era sotto il nespolo, colla sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando: «Addio addio! Lo vedete che devo andarmene?»
Prima d’andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto come prima; ma adesso, a lui che gli era bastato l’animo di lasciarla, e di dare una coltellata a don Michele, e di starsene nei guai, non gli bastava l’animo di passare da una camera all’altra se non glielo dicevano. Alessi che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla, col pretesto del vitello che aveva comperato la Nunziata, ed era grasso e lucente; e in un canto c’era pure la chioccia coi pulcini; poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la Mena coi bambini della Nunziata, e pareva che li avesse fatti lei. ‘Ntoni guardava ogni cosa, e approvava col capo, e diceva: «Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello; qui c’erano le chioccie, e qui dormivano le ragazze, quando c’era anche quell’altra…»
Ma allora non aggiunse altro, e stette zitto a guardare intorno, cogli occhi lustri. In quel momento passava la Mangiacarrubbe, che andava sgridando Brasi Cipolla per la strada, e ‘Ntoni disse: «Questa qui l’ha trovato il marito; ed ora, quando avranno finito di quistionare, andranno a dormire nella loro casa.»
Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: «Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te.»
«No!» rispose ‘Ntoni. «Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene.»
In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. «Addio,» ripeté ‘Ntoni. «Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti.»
E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico. Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filippo. Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero, e ascoltando il mare che gli brontolava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la Puddara che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. «Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta, pensò ‘Ntoni, e si accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua giornata anche lui.» Tornò a guardare il mare, che s’era fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta e disse: «Ora è tempo d’andarmene, perché fra poco comincierà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco Spatu.»
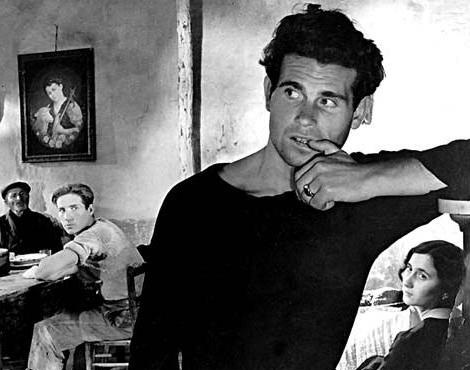
‘Ntoni
Dopo il ritorno di Alfio, il ritorno di ‘Ntoni. Poche righe separano le due azioni: poche righe lo stesso concetto. C’è sconfitta, ma questa volta non è sentimentale, e di un’intera vita. Se per Alfio la sconfitta è un dire addio a Mena, ma è un ritorno diverso, in cui lui è più ricco, sia dentro che fuori e comprende le leggi che sovrintendono alla comunità, ‘Ntoni è totalmente sconfitto. La galera lo ha escluso definitivamente, lo ha reso “inaccettabile” soprattutto a lui stesso, gli ha fatto capire l’errore di un sogno e il duro prezzo che è costretto a pagare. Il ricordo non lo aiuta, anzi esacerba il suo rimpianto e lo porta alla considerazione della vanità delle cose. Solo la natura, sempre uguale a se stessa, sembra resistere agli effetti della storia: il mare che brontola, l’alba, i Tre Re; gli altri, come Rocco Spatu che è il primo a svegliarsi, ricominceranno a lavorare e a arrabbattarsi, comunque inutilmente. Quanta tristezza nell’addio di ‘Ntoni, quanta verità, e quanta poesia nella scarsezza lessicale verghiana!
I Malavoglia, come detto, è un romanzo pubblicato nel 1881, ad un anno di distanza dalle novelle di Vita dei campi. La genesi ci porta nel 1874, dove al suo editore Treves prospetta un “bozzetto marinaresco” dal titolo Padron ‘Ntoni. Tuttavia bisogna aspettare ancora sei anni, con il passaggio al mondo rurale in Nedda, perché Verga trovasse infine l’intero materiale per dar vita al romanzo.
Non c’è differenza stilistica, né diversità ideologica tra le novelle ed I Malavoglia: ne è testimonianza Fantasticheria, che apre Vita dei campi: vengono qui descritti personaggi che faranno parte del romanzo. Ciò vuol dire che la composizione delle due opere avviene contemporaneamente.
Per l’analisi dell’opera partiamo dalla presentazione dei personaggi: questa non è mai analitica e descrittiva, ma statica, dettata dalle stesse azioni degli stessi e registrata da un narratore interno.
I personaggi vengono distribuiti in due categorie in modo parallelo ed antitetico:
- i Malavoglia ed il paese: i primi legati ai valori della laboriosità ed onestà; i secondi rappresentano invece un mondo dominato dal denaro e l’affermazione sociale; Verga nella descrizione dei due non prende alcuna parte. La grettezza rimane tale, dall’inizio alla fine. Ma anche padron ‘Ntoni non è salvato, con la sua cocciutaggine per la “religione della famiglia” porta quest’ultima alla rovina;
- All’interno della famiglia: padron ‘Ntoni con Mena e Alessi e, dall’altra parte ‘Ntoni e Lia. I primi agiscono all’interno di un conflitto tra loro ed il destino e ciò che esso prepara loro (tempeste, morte); i secondi un conflitto con se stessi che si esplica attraverso l’insofferenza e i limiti imposti dalla famiglia e la voglia di scappare di realizzare se stessi in un futuro nebuloso dai contorni indefiniti. Anche qui Verga non si schiera; ancora padron ‘Ntoni che non sa che opporre al nipote stanco proverbi “immobili”, che non riesce a capire il movimento storico e rimane abbrancato a qualcosa che non esiste più. Ma anche ‘Ntoni ci offre soltanto la sua negatività: non è “progresso sociale” il suo, vuole portare l’idea del paese nel mondo col mito del denaro, per diventar ricco e non fare niente.
In Verga nulla si muove ed il suo pessimismo è totale.
Lo spazio dei Malavoglia è uno spazio limitato: i gradini della chiesa, la bottega, la farmacia e l’osteria; per le donne la strada. dove s’incontrano per pettegolare. Al di là di questo tutto è lontano, fosse Lissa, Napoli, oppure Catania. Più che lontano è più esatto dire che sia esterno. Qui Verga pone un’altra volta l’antinomia: l’interno il paese è il luogo dove i meccanismi sono conosciuti e quindi sicuri; l’esterno rappresenta invece il pericolo, l’ignoto (dove appunto finiscono sia ‘Ntoni che Lia).
Un ultimo discorso lo merita lo stile e la lingua usata per I Malavoglia: si è già parlato della scomparsa dello scrittore onnisciente, ora si tratta di sottolineare la distanza che vi è tra il purismo linguistico manzoniano e la scelta verghiana: si tratta infatti di una scelta nuova, quella di un italiano parlato dai siciliani colti con influenze del parlato (si può citare ad esempio l’uso del che subordinante che traduce il ca siciliano).
Per quanto attiene al discorso indiretto libero si tratta di una tecnica in cui spariscono i verba dicendi con l’infinitiva e si assume, nella narrazione, senza soluzione di continuità, il pensiero del personaggio che si assimila a quello dell’autore.
Ancora l’uso insistito dei proverbi, che vogliono rendere una saggezza popolare, mitica e senza tempo (ricordiamo la ricerca scrupolosa su di essi fatto su testi di studio di folclore siciliano).
*le immagini poste per “I Malavoglia” sono tratte dal film di Luchino Visconti La terra trema del 1948 ispirato al romanzo verghiano.
Anche il secondo romanzo verghiano viene preceduta da una raccolta di 12 racconti, a cui l’autore siciliano dà il titolo di Novelle rusticane (1883): in questa si fa più cupo il suo pessimismo. I protagonisti, infatti, non sono più i miseri pescatori o icontadini di Vita dei campi, ma reverendi, proprietari terrieri amministratori, chi, in qualche modo, stava arrancando attraverso la scala sociale. Qualcuno di essi, pur diventando ricchissimo, non muta affatto pelle, come Mazzarò:
LA ROBA
Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: «Qui di chi è?» sentiva rispondersi: «Di Mazzarò.» E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembravano chiese, e le galline a stormi accoccolate all’ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: «E qui?» «Di Mazzarò.» E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all’improvviso l’abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo6 , accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: «Di Mazzarò.» Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l’erba non spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell’acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandrie di Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. «Tutta roba di Mazzarò». Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell’assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. – Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane; e sì ch’era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch’era un brillante, quell’uomo. Infatti, colla testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere; col sole, coll’acqua, col vento; senza scarpe ai piedi, e senza uno straccio di cappotto; che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell’eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori; e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore; ma egli portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera, la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga – dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di cinquemila bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di tutte, e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, all’impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, che non ci si vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o colla testa dentro un corbello, nelle calde giornate della mèsse. Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, colle foglie larghe ed alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del giuoco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare al camposanto.
Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua, ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata, nel mese di luglio, a star colla schiena curva quattordici ore, col soprastante a cavallo dietro, che vi piglia a nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba; e adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivano in novembre; e altre file di muli, che non finivano più, portavano le sementi; le donne che stavano accoccolate nel fango, da ottobre a marzo, per raccogliere le sue olive, non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle; e al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare, nella campagna, era per la vendemmia di Mazzarò. Alla mèsse poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati, che per mantenere tutta quella gente, col biscotto alla mattina e il pane e l’arancia amara a colazione, e la merenda, e le lasagne alla sera, ci volevano dei denari a manate, e le lasagne si scodellavano nelle madie come tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d’occhio uno solo, e badava a ripetere: «Curviamoci, ragazzi!» Egli era tutto l’anno colle mani in tasca a spendere, e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre ogni volta.
Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto; e ogni volta che Mazzarò vendeva il vino, ci voleva più di un giorno per contare il danaro tutto di 12 tarì d’argento, ché lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re, o gli altri; e alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo, e ingombravano le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare, e il santo, colla banda, alle volte doveva mutar strada, e cedere il passo.
Tutta quella roba se l’era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll’affaticarsi dall’alba a sera, e andare in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule – egli solo non si logorava, pensando alla sua roba, ch’era tutto quello ch’ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né nipoti né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba.
Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò, e l’aveva raccolto per carità nudo e crudo ne’ suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati, e di tutti quei boschi, e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri, pareva il re, e gli preparavano anche l’alloggio e il pranzo, al minchione, sicché ognuno sapeva l’ora e il momento in cui doveva arrivare, e non si faceva sorprendere colle mani nel sacco. “Costui vuol essere rubato per forza!” diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro, e si fregava la schiena colle mani, borbottando: “Chi è minchione, se ne stia a casa”; – “la roba non è di chi l’ha, ma di chi la sa fare”. Invece egli, dopo che ebbe fatta la sua roba, non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la mèsse, o la vendemmia, e quando, e come; ma capitava all’improvviso, a piedi o a cavallo alla mula, senza campieri, con un pezzo di pane in tasca; e dormiva accanto ai suoi covoni, cogli occhi aperti, e lo schioppo fra le gambe.
In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne padrone di tutta la roba del barone; e costui uscì prima dall’uliveto, e poi dalle vigne, e poi dai pascoli, e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo istesso, che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate, e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce. Al barone non rimase altro che lo scudo di pietra ch’era prima sul portone, ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazzarò: «Questo solo, di tutta la mia roba, non fa per te».
Ed era vero; Mazzarò non sapeva che farsene, e non l’avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più i calci nel di dietro.
«Questa è una bella cosa, d’avere la fortuna che ha Mazzarò!» diceva la gente; e non sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna: quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera, e come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina di mulino, per fare la roba; e se il proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela, o voleva prendere pel collo Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere, e farcelo cascare, malgrado la diffidenza contadinesca. Ei gli andava a vantare, per esempio, la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini41, e arrivava a fargliela credere una terra promessa, sicché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto, per specularci sopra, e ci perdeva poi il fitto, la casa e la chiusa, che Mazzarò se la chiappava – per un pezzo di pane. – E quante seccature Mazzarò doveva sopportare! – I mezzadri che venivano a lagnarsi delle malannate, i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo e l’asinello, che non avevano da mangiare.
«Lo vedete, quel che mangio io?» rispondeva lui, «pane e cipolla! e sì che ho i magazzini pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba.» E se gli domandavano un pugno di fave, di tutta quella roba, ei diceva: «Che, vi pare che l’abbia rubata? Non sapete quanto costano per seminarle, e zapparle, e raccoglierle?» E se gli domandavano un soldo rispondeva che non l’aveva. E non l’aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene importava del denaro, diceva che non era roba, e appena metteva insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed essere meglio del re, ché il re non può né venderla, né dire ch’è sua.
Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov’era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, con il mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: “Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente!” Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all’anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: «Roba mia, vientene con me!»
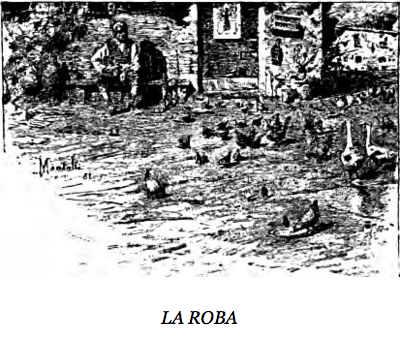
Illustrazione della novella “La roba”
La novella si struttura intorno al dato economico: è la roba, nuova dea cui Mazzarò è devoto sacerdote. Sembra che tale novella esemplifichi un po’ il personaggio descritto nei Malavoglia, quello di Zio Crocefisso (non è un caso che essa appaia in rivista nel 1880); ma è altrettanto indice della volontà dello scrittore nel descrivere una tipologia umana realmente esistente. Si tratta di rendere visibile il concetto del possesso, e qui Verga lo renda esplicito attraverso non solo la descrizione di Mazzarò, la sua pancia e il suo cappello, ma nei lenti gesti che scandiscono un lavorio tutto teso all’accumulo, tanto da diventare compulsivo. E’ per questo che la novella da “tragedia” umana, alla fine vira sul grottesco; Mazzarò per rincorrere la roba, diventa pazzo.
LIBERTA’
Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a gridare in piazza: «Viva la libertà!»
Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei “galantuomini”, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola.
«A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri!» Innanzi a tutti gli altri una strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. «A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato l’anima!» «A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero!» «A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente!» «A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno!»
E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! «Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli!»
Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia insanguinata contro il marciapiede. «Perché? perché mi ammazzate?» «Anche tu! al diavolo!» Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. «Abbasso i cappelli! Viva la libertà!» «Te’! tu pure!» Al reverendo che predicava l’inferno per chi rubava il pane. Egli tornava dal dir messa, coll’ostia consacrata nel pancione. «Non mi ammazzate, ché sono in peccato mortale!» La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l’inverno della fame, e riempiva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure. Anche il lupo allorché capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla rabbia. – Il figliuolo della Signora, che era accorso per vedere cosa fosse – lo speziale, nel mentre chiudeva in fretta e in furia – don Paolo, il quale tornava dalla vigna a cavallo del somarello, colle bisacce magre in groppa. Pure teneva in capo un berrettino vecchio che la sua ragazza gli aveva ricamato tempo fa, quando il male non aveva ancora colpito la vigna. Sua moglie lo vide cadere dinanzi al portone, mentre aspettava coi cinque figliuoli la scarsa minestra che era nelle bisacce del marito. «Paolo! Paolo!» Il primo lo colse nella spalla con un colpo di scure. Un altro gli fu addosso colla falce, e lo sventrò mentre si attaccava col braccio sanguinante al martello. Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio, un ragazzo di undici anni, biondo come l’oro, non si sa come, travolto nella folla. Suo padre si era rialzato due o tre volte prima di strascinarsi a finire nel mondezzaio, gridandogli: «Neddu! Neddu!» Neddu fuggiva, dal terrore, cogli occhi e la bocca spalancati senza poter gridare. Lo rovesciarono; si rizzò anch’esso su di un ginocchio come suo padre; il torrente gli passò di sopra; uno gli aveva messo lo scarpone sulla guancia e glie l’aveva sfracellata; nonostante il ragazzo chiedeva ancora grazia colle mani. – Non voleva morire, no, come aveva visto ammazzare suo padre; – strappava il cuore! – Il taglialegna, dalla pietà, gli menò un gran colpo di scure colle due mani, quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant’anni – e tremava come una foglia. – Un altro gridò: «Bah! egli sarebbe stato notaio, anche lui!»
Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! tutti i cappelli! – Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente. Le donne più feroci ancora, agitando le braccia scarne, strillando l’ira in falsetto, colle carni tenere sotto i brindelli delle vesti. – «Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta!» «Tu che avevi a schifo d’inginocchiarti accanto alla povera gente!» «Te’! Te’!» Nelle case, su per le scale, dentro le alcove, lacerando la seta e la tela fine. Quanti orecchini su delle facce insanguinate! e quanti anelli d’oro nelle mani che cercavano di parare i colpi di scure! La baronessa aveva fatto barricare il portone: travi, carri di campagna, botti piene, dietro; e i campieri che sparavano dalle finestre per vender cara la pelle. La folla chinava il capo alle schiopettate, perché non aveva armi da rispondere. Prima c’era la pena di morte chi tenesse armi da fuoco. «Viva la libertà!» E sfondarono il portone. Poi nella corte, sulla gradinata, scavalcando i feriti. Lasciarono stare i campieri. «I campieri dopo!» «I campieri dopo!» Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono. Ella correva di stanza in stanza col lattante al seno, scarmigliata – e le stanze erano molte. Si udiva la folla urlare per quegli andirivieni, avvicinandosi come la piena di un fiume. Il figlio maggiore, di 16 anni, ancora colle carni bianche anch’esso, puntellava l’uscio colle sue mani tremanti, gridando: «Mamà! mamà!» Al primo urto gli rovesciarono l’uscio addosso. Egli si afferrava alle gambe che lo capestavano. Non gridava più. Sua madre s’era rifugiata nel balcone, tenendo avvinghiato il bambino, chiudendogli la bocca colla mano perché non gridasse, pazza. L’altro figliolo voleva difenderla col suo corpo, stralunato, quasi avesse avuto cento mani, afferrando pel taglio tutte quelle scuri. Li separarono in un lampo. Uno abbrancò lei pei capelli, un altro per i fianchi, un altro per le vesti, sollevandola al di sopra della ringhiera. Il carbonaio le strappò dalle braccia il bambino lattante. L’altro fratello non vide niente; non vedeva altro che nero e rosso. Lo calpestavano, gli macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati; egli aveva addentato una mano che lo stringeva alla gola e non la lasciava più. Le scuri non potevano colpire nel mucchio e luccicavano in aria.
E in quel carnevale furibondo del mese di luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di turchi.
Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati i portoni e le finestre delle case deserte.
Aggiornava; una domenica senza gente in piazza né messa che suonasse. Il sagrestano s’era rintanato; di preti non se ne trovavano più. I primi che cominciarono a far capannello sul sagrato si guardavano in faccia sospettosi; ciascuno ripensando a quel che doveva avere sulla coscienza il vicino. Poi, quando furono in molti, si diedero a mormorare. – Senza messa non potevano starci, un giorno di domenica, come i cani! – Il casino dei galantuomini era sbarrato, e non si sapeva dove andare a prendere gli ordini dei padroni per la settimana. Dal campanile penzolava sempre il fazzoletto tricolore, floscio, nella caldura gialla di luglio.
E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi giallastri nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il vicino. – Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti! – Quel Nino Bestia, e quel Ramurazzo, avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli! – Se non c’era più il perito per misurare la terra, e il notaio per metterla sulla carta, ognuno avrebbe fatto a riffa e a raffa! – E se tu ti mangi la tua parte all’osteria, dopo bisogna tornare a spartire da capo? – Ladro tu e ladro io -. Ora che c’era la libertà, chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini! – Il taglialegna brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure.
Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; sarebbe bastato rotolare dall’alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse. Le donne strillavano e si strappavano i capelli. Ormai gli uomini, neri e colle barbe lunghe, stavano sul monte, colle mani fra le cosce, a vedere arrivare quei giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito, e quel generale piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo.
Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina, prima dell’alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l’uomo. E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono. Il taglialegna, mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie lo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate in fila come i mortaletti della festa.
Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati sulle mule, disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del convento, seduti di fianco sulla scranna, e dicendo «ahi!» ogni volta che mutavano lato. Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro donne li seguivano correndo per le lunghe strade di campagna, in mezzo ai solchi, in mezzo ai fichidindia, in mezzo alle vigne, in mezzo alle biade color d’oro, trafelate, zoppicando, chiamandoli a nome ogni volta che la strada faceva gomito, e si potevano vedere in faccia i prigionieri. Alla città li chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate; e se le donne volevano vedere i loro uomini, soltanto il lunedì, in presenza dei guardiani, dietro il cancello di ferro. E i poveretti divenivano sempre più gialli in quell’ombra perenne, senza scorgere mai il sole. Ogni lunedì erano più taciturni, rispondevano appena, si lagnavano meno. Gli altri giorni, se le donne ronzavano per la piazza attorno alla prigione, le sentinelle minacciavano col fucile. Poi non sapere che fare, dove trovare lavoro nella città, né come buscarsi il pane. Il letto nello stallazzo costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco; se si accoccolavano a passare una notte sull’uscio di una chiesa, le guardie le arrestavano. A poco a poco rimpatriarono, prima le mogli, poi le mamme. Un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla. Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non potevano lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i galantuomini. Fecero la pace. L’orfano dello speziale rubò la moglie a Neli Pirru, e gli parve una bella cosa, per vendicarsi di lui che gli aveva ammazzato il padre. Alla donna che aveva di tanto in tanto certe ubbie, e temeva che suo marito le tagliasse la faccia, all’uscire dal carcere, egli ripeteva: «Sta tranquilla che non ne esce più». Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchiarello, se gli correvano gli occhi verso la pianura, dove era la città, o la domenica, al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all’aria ci vanno i cenci.
Il processo durò tre anni, nientemeno! tre anni di prigione e senza vedere il sole. Sicché quegli accusati parevano tanti morti della sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribunale. Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per vedere i compaesani, dopo tanto tempo, stipati nella capponaia – ché capponi davvero si diventava là dentro! e Neli Pirru doveva vedersi sul mostaccio quello dello speziale, che s’era imparentato a tradimento con lui! Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. «Voi come vi chiamate?» E ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano, fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnecchiavano, dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore. Di faccia erano seduti in fila dodici galantuomini, stanchi, annoiati, che sbadigliavano, si grattavano la barba, o ciangottavano fra di loro. Certo si dicevano che l’avevano scappata bella a non essere stati dei galantuomini di quel paesetto lassù, quando avevano fatto la libertà. E quei poveretti cercavano di leggere nelle loro facce. Poi se ne andarono a confabulare fra di loro, e gli imputati aspettavano pallidi, e cogli occhi fissi su quell’uscio chiuso. Come rientrarono, il loro capo, quello che parlava colla mano sulla pancia, era quasi pallido al pari degli accusati, e disse: «Sul mio onore e sulla mia coscienza!…»
Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: «Dove mi conducete? In galera? O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la liberta!…»
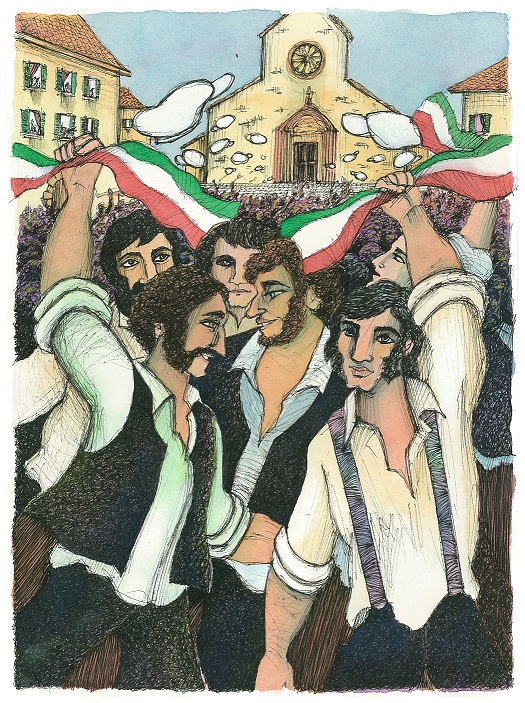
Illustrazione per la novella “Libertà”
I fatti raccontati in questa novella sono veri e si riferiscono alle vicende risorgimentali accadute dopo l’arrivo di Garibaldi in Sicilia. Ci troviamo, nella realtà storica a Bronte, paese sull’Etna, dove il generale, appena sbarcato, fece promessa ai contadini di una divisione delle terre demaniali e di un generale miglioramento della condizione di vita dei contadini. Nella realtà tale miglioramento non si ebbe e scoppiarono delle rivolte in varie località, ma soprattutto a Bronte, dove vi era riconosciuto un avvocato socialista, Niccolò Lombardini. Tuttavia la rivolta sfuggì di mano ai vari partiti politici, trasformandosi in un eccidio. Nino Bixio, comandato dallo stesso Garibaldi, intervenne, riportando l’ordine in modo cruento: fece fucilare, tra cui lo stesso Lombardo, i più “facinorosi”, negando loro qualsiasi forma di regolare processo.
La novella si riferisce a questo episodio, ma ci dice anche qualcosa di più: l’eliminazione di una qualsiasi guida nel racconto verghiano, induce lo stesso a raccontarci una folla irrazionale, che uccide, quasi, per il solo gusto d’ammazzare. A descrivere il sommossa popolare, Verga indugia in una lunga macrosequenza, isolando le azioni più efferate. Diverso l’atteggiamento dello scrittore verso Ninio Bixio, a disegnarci quasi un buon padre, che rimbocca le coperte ai suoi soldati, ma che si rivela, anche un determinato, nonché spietato esecutore di morte. E’ che in Verga non c’è pietà per nessuno, la storia stritola, al di là della voglia di cambiarla.
D’altra parte tutto nasce da un’incomprensione: la libertà garibaldina era una libertà politica; quella contadina una libertà da millenni di soprusi: i due linguaggi non si parlano, così come ci viene chiarito dall’ultima riga del racconto.
Mastro-don Gesualdo è il secondo romanzo “verista” verghiano, cui il nostro lavorò dal 1882 al 1889.
L’azione si svolge a Vizzini, centro agricolo del catanese, tra il 1820 e il 1848, un periodo segnato da rivolte politiche e sociali. Il manovale “Mastro” Gesualdo è diventato “don” a forza di lavoro e sacrifici. Dopo la ricchezza, la sua promozione sociale dovrebbe essere sancita dal matrimonio che lo imparenta a una famiglia nobile seppure economicamente rovinata: sposa Bianca Trao, ma non per questo è accolto nel suo mondo. La moglie, del resto, non lo ama e quando lo ha sposato era già incinta, i seguito a una relazione col ricco cugino Ninì Rubiera, che la madre di questi aveva impedito si concludesse il matrimonio. Nasce Isabella, che da grande si vergognerà delle umili origini del padre putativo e sposerà, anche lei come la madre, per “riparare”, un duca squattrinato e dissipatore della dote e dei beni del suocero. Il romanzo si conclude con la scena della morte in solitudine del protagonista, relegato in una stanza del palazzo ducale a Palermo, abbandonato dalla figlia e irriso dai servitori.

Immagine di Copertina per il “Mastro don Gesualdo”
L’INCENDIO
(I, 1)
Suonava la messa dell’alba a San Giovanni; ma il paesetto dormiva ancora della grossa, perché era piovuto da tre giorni, e nei seminati ci si affondava fino a mezza gamba. Tutt’a un tratto, nel silenzio, s’udì un rovinìo, la campanella squillante di Sant’Agata che chiamava aiuto, usci e finestre che sbattevano, la gente che scappava fuori in camicia, gridando:
«Terremoto! San Gregorio Magno!»
Era ancora buio. Lontano, nell’ampia distesa nera dell’Alìa, ammiccava soltanto un lume di carbonai, e più a sinistra la stella del mattino, sopra un nuvolone basso che tagliava l’alba nel lungo altipiano del Paradiso. Per tutta la campagna diffondevasi un uggiolare lugubre di cani. E subito, dal quartiere basso, giunse il suono grave del campanone di San Giovanni che dava l’allarme anch’esso; poi la campana fessa di San Vito; l’altra della chiesa madre, più lontano; quella di Sant’Agata che parve addirittura cascar sul capo agli abitanti della piazzetta. Una dopo l’altra s’erano svegliate pure le campanelle dei monasteri, il Collegio, Santa Maria, San Sebastiano, Santa Teresa: uno scampanìo generale che correva sui tetti spaventato, nelle tenebre.
«No! no! È il fuoco!… Fuoco in casa Trao!… San Giovanni Battista!»
Gli uomini accorrevano vociando, colle brache in mano. Le donne mettevano il lume alla finestra: tutto il paese, sulla collina, che formicolava di lumi, come fosse il giovedì sera, quando suonano le due ore di notte: una cosa da far rizzare i capelli in testa, chi avesse visto da lontano.
«Don Diego! Don Ferdinando!» si udiva chiamare in fondo alla piazzetta; e uno che bussava al portone con un sasso.
Dalla salita verso la Piazza Grande, e dagli altri vicoletti, arrivava sempre gente: un calpestìo continuo di scarponi grossi sull’acciottolato; di tanto in tanto un nome gridato da lontano; e insieme quel bussare insistente al portone in fondo alla piazzetta di Sant’Agata, e quella voce che chiamava:
«Don Diego! Don Ferdinando! Che siete tutti morti?»
Dal palazzo dei Trao, al di sopra del cornicione sdentato, si vedevano salire infatti, nell’alba che cominciava a schiarire, globi di fumo denso, a ondate, sparsi di faville. E pioveva dall’alto un riverbero rossastro, che accendeva le facce ansiose dei vicini raccolti dinanzi al portone sconquassato, col naso in aria. Tutt’a un tratto si udì sbatacchiare una finestra, e una vocetta stridula che gridava di lassù:
«Aiuto!… ladri!… Cristiani, aiuto!»
«Il fuoco! Avete il fuoco in casa! Aprite, don Ferdinando!»
«Diego! Diego!»
Dietro alla faccia stralunata di don Ferdinando Trao apparve allora alla finestra il berretto da notte sudicio e i capelli grigi svolazzanti di don Diego. Si udì la voce rauca del tisico che strillava anch’esso:
«Aiuto!… Abbiamo i ladri in casa! Aiuto!»
«Ma che ladri!… Cosa verrebbero a fare lassù?» sghignazzò uno nella folla.
«Bianca! Bianca! Aiuto! aiuto!»
Giunse in quel punto trafelato Nanni l’Orbo, giurando d’averli visti lui i ladri, in casa Trao.
«Con questi occhi!… Uno che voleva scappare dalla finestra di donna Bianca, e s’è cacciato dentro un’altra volta, al vedere accorrer gente!…»
«Brucia il palazzo, capite? Se ne va in fiamme tutto il quartiere! Ci ho accanto la mia casa, perdio!» Si mise a vociare mastro-don Gesualdo Motta. Gli altri intanto, spingendo, facendo leva al portone, riuscirono a penetrare nel cortile, ad uno ad uno, coll’erba sino a mezza gamba, vociando, schiamazzando, armati di secchie, di brocche piene d’acqua; compare Cosimo colla scure da far legna; don Luca il sagrestano che voleva dar di mano alle campane un’altra volta, per chiamare all’armi; Pelagatti così com’era corso, al primo allarme, col pistolone arrugginito ch’era andato a scavar di sotto allo strame.
Dal cortile non si vedeva ancora il fuoco. Soltanto, di tratto in tratto, come spirava il maestrale, passavano al di sopra delle gronde ondate di fumo, che si sperdevano dietro il muro a secco del giardinetto, fra i rami dei mandorli in fiore. Sotto la tettoia cadente erano accatastate delle fascine; e in fondo, ritta contro la casa del vicino Motta, dell’altra legna grossa: assi d’impalcati, correntoni fradici, una trave di palmento che non si era mai potuta vendere.
«Peggio dell’esca, vedete!» sbraitava mastro-don Gesualdo.» «Roba da fare andare in aria tutto il quartiere!… santo e santissimo!… E me la mettono poi contro il mio muro; perché loro non hanno nulla da perdere, santo e santissimo!…»
In cima alla scala, don Ferdinando, infagottato in una vecchia palandrana, con un fazzolettaccio legato in testa, la barba lunga di otto giorni, gli occhi grigiastri e stralunati, che sembravano quelli di un pazzo in quella faccia incartapecorita di asmatico, ripeteva come un’anatra:
«Di qua! di qua!»
Ma nessuno osava avventurarsi su per la scala che traballava. Una vera bicocca quella casa: i muri rotti, scalcinati, corrosi; delle fenditure che scendevano dal cornicione sino a terra; le finestre sgangherate e senza vetri; lo stemma logoro, scantonato, appeso ad un uncino arrugginito, al di sopra della porta. Mastro-don Gesualdo voleva prima buttar fuori sulla piazza tutta quella legna accatastata nel cortile.
«Ci vorrà un mese!» rispose Pelagatti il quale stava a guardare sbadigliando, col pistolone in mano.
«Santo e santissimo! Contro il mio muro è accatastata!… Volete sentirla, sì o no?»
Giacalone diceva piuttosto di abbattere la tettoia; don Luca il sagrestano assicurò che pel momento non c’era pericolo: una torre di Babele!
Erano accorsi anche altri vicini. Santo Motta colle mani in tasca, il faccione gioviale e la barzelletta sempre pronta. Speranza, sua sorella, verde dalla bile, strizzando il seno vizzo in bocca al lattante, sputando veleno contro i Trao: «Signori miei… guardate un po’!… Ci abbiamo i magazzini qui accanto!» E se la prendeva anche con suo marito Burgio, ch’era lì in maniche di camicia: «Voi non dite nulla! State lì come un allocco! Cosa siete venuto a fare dunque?»
Mastro-don Gesualdo si slanciò il primo urlando su per la scala. Gli altri dietro come tanti leoni per gli stanzoni scuri e vuoti. A ogni passo un esercito di topi che spaventavano la gente. «Badate! badate! Ora sta per rovinare il solaio!» Nanni l’Orbo che ce l’aveva sempre con quello della finestra, vociando ogni volta: «Eccolo! eccolo!» E nella biblioteca, la quale cascava a pezzi, fu a un pelo d’ammazzare il sagrestano col pistolone di Pelagatti. Si udiva sempre nel buio la voce chioccia di don Ferdinando il quale chiamava: «Bianca! Bianca!» E don Diego che bussava e tempestava dietro un uscio, fermando pel vestito ognuno che passava strillando anche lui: «Bianca! mia sorella!..»
«Che scherzate?» rispose mastro-don Gesualdo rosso come un pomodoro, liberandosi con una strappata. «Ci ho la mia casa accanto, capite: Se ne va in fiamme tutto il quartiere!»
Era un correre a precipizio nel palazzo smantellato; donne che portavano acqua; ragazzi che si rincorrevano schiamazzando in mezzo a quella confusione, come fosse una festa; curiosi che girandolavano a bocca aperta, strappando i brandelli di stoffa che pendevano ancora dalle pareti, toccando gli intagli degli stipiti, vociando per udir l’eco degli stanzoni vuoti, levando il naso in aria ad osservare le dorature degli stucchi, e i ritratti di famiglia: tutti quei Trao affumicati che sembravano sgranare gli occhi al vedere tanta marmaglia in casa loro. Un va e vieni che faceva ballare il pavimento.

Casa di Mastro don Gesualdo a Vizzini
Anche questo romanzo, come I Malavoglia, comincia in medias res: un incendio in casa Trao, due vecchi nobili, morti di fame, cui è scoppiato un incendio dentro casa, un’inesistente Bianca, (nel balcone con l’amante, che viene scambiato per ladro) e soprattutto Gesualdo, citato con nome e cognome. In pochi tratti, con un’ottima costruzione narrativa, ci viene detto l’essenziale: soprattutto riguardo Gesualdo: il sottolineare la sua “proprietà” a rischio incendio ci fa intravedere come stia attento alle sua “roba” e come al contempo, già appaiano ben delinate le figure di contorno, Sante e Speranza, fratelli di Gesualdo.
GESUALDO E DIODATA
(I,4)
Allorché finalmente Gesualdo arrivò alla Canziria, erano circa due ore di notte. La porta della fattoria era aperta. Diodata aspettava dormicchiando sulla soglia. Massaro Carmine, il camparo, era steso bocconi sull’aia, collo schioppo fra le gambe; Brasi Camauro e Nanni l’Orbo erano spulezzati di qua e di là, come fanno i cani la notte, quando sentono la femmina nelle vicinanze; e i cani soltanto davano il benvenuto al padrone, abbaiando intorno alla fattoria.
«Ehi? non c’è nessuno? Roba senza padrone, quando manco io!»
Diodata, svegliata all’improvviso, andava cercando il lume tastoni, ancora assonnata. Lo zio Carmine, fregandosi gli occhi, colla bocca contratta dai sbadigli, cercava delle scuse.
«Ah!… sia lodato Dio! Voi ve la dormite da un canto, Diodata dall’altro, al buio!… Cosa facevi al buio?… aspettavi qualcheduno?… Brasi Camauro oppure Nanni l’Orbo?…»
La ragazza ricevette la sfuriata a capo chino, e intanto accendeva lesta lesta il fuoco, mentre il suo padrone continuava a sfogarsi, lì fuori, all’oscuro, e passava in rivista i buoi legati ai pioli intorno all’aia. Il camparo mogio mogio gli andava dietro per rispondere al caso: «Gnorsì, Pelorosso sta un po’ meglio; gli ho dato la gramigna per rinfrescarlo. La Bianchetta ora mi fa la svogliata anch’essa… Bisognerebbe mutar di pascolo… tutto il bestiame… Il mal d’occhio, sissignore! Io dico ch’è passato di qui qualcheduno che portava il malocchio!… Ho seminato perfino i pani di San Giovanni nel pascolo… Le pecore stanno bene, grazie a Dio… e il raccolto pure… Nanni l’Orbo? Laggiù a Passanitello, dietro le gonnelle di quella strega… Un giorno o l’altro se ne torna a casa colle gambe rotte, com’è vero Dio!… e Brasi Camauro anch’esso, per amor di quattro spighe… »
Diodata gridò dall’uscio ch’era pronto. «Se non avete altro da comandarmi, vossignoria, vado a buttarmi giù un momento…»
Come Dio volle finalmente, dopo un digiuno di ventiquattr’ore, don Gesualdo poté mettersi a tavola, seduto di faccia all’uscio, in maniche di camicia, le maniche rimboccate al disopra dei gomiti, coi piedi indolenziti nelle vecchie ciabatte ch’erano anch’esse una grazia di Dio. La ragazza gli aveva apparecchiata una minestra di fave novelle, con una cipolla in mezzo, quattr’ova fresche, e due pomidori ch’era andata a cogliere tastoni dietro la casa. Le ova friggevano nel tegame, il fiasco pieno davanti; dall’uscio entrava un venticello fresco ch’era un piacere, insieme al trillare dei grilli, e all’odore dei covoni nell’aia: – il suo raccolto lì, sotto gli occhi, la mula che abboccava anch’essa avidamente nella bica dell’orzo, povera bestia – un manipolo ogni strappata! Giù per la china, di tanto in tanto, si udiva nel chiuso il campanaccio della mandra; e i buoi accovacciati attorno all’aia, legati ai cestoni colmi di fieno, sollevavano allora il capo pigro, soffiando, e si vedeva correre nel buio il luccichìo dei loro occhi sonnolenti, come una processione di lucciole che dileguava.Gesualdo posando il fiasco mise un sospirone, e appoggiò i gomiti sul deschetto:
«Tu non mangi?… Cos’hai?»
Diodata stava zitta in un cantuccio, seduta su di un barile, e le passò negli occhi, a quelle parole, un sorriso di cane accarezzato.
«Devi aver fame anche tu. Mangia! mangia!»
Essa mise la scodella sulle ginocchia, e si fece il segno della croce prima di cominciare, poi disse: «Benedicite a vossignoria!»
Mangiava adagio adagio, colla persona curva e il capo chino. Aveva una massa di capelli morbidi e fini, malgrado le brinate ed il vento aspro della montagna: dei capelli di gente ricca, e degli occhi castagni, al pari dei capelli, timidi e dolci: de’ begli occhi di cane carezzevoli e pazienti, che si ostinavano a farsi voler bene, come tutto il viso supplichevole anch’esso. Un viso su cui erano passati gli stenti, la fame, le percosse, le carezze brutali; limandolo, solcandolo, rodendolo; lasciandovi l’arsura del solleone, le rughe precoci dei giorni senza pane, il lividore delle notti stanche – gli occhi soli ancora giovani, in fondo a quelle occhiaie livide. Così raggomitolata sembrava proprio una ragazzetta, al busto esile e svelto, alla nuca che mostrava la pelle bianca dove il sole non aveva bruciato. Le mani, annerite, erano piccole e scarne: delle povere mani pel suo duro mestiere!…
«Mangia, mangia. Devi essere stanca tu pure!…»
Ella sorrise, tutta contenta, senza alzare gli occhi. Il padrone le porse anche il fiasco: «Te’, bevi! non aver suggezione!»
Diodata, ancora un po’ esitante, si pulì la bocca col dorso della mano, e s’attaccò al fiasco arrovesciando il capo all’indietro. Il vino, generoso e caldo, le si vedeva scendere quasi a ogni sorso nella gola color d’ambra; il seno ancora giovane e fermo sembrava gonfiarsi. Il padrone allora si mise a ridere.
«Brava, brava! Come suoni bene la trombetta!…»
Sorrise anch’essa, pulendosi la bocca un’altra volta col dorso della mano, tutta rossa.
«Tanta salute a vossignoria!»
Egli uscì fuori a prendere il fresco. Si mise a sedere su di un covone, accanto all’uscio, colle spalle al muro, le mani penzoloni fra le gambe. La luna doveva essere già alta, dietro il monte, verso Francofonte. Tutta la pianura di Passanitello, allo sbocco della valle, era illuminata da un chiarore d’alba. A poco a poco, al dilagar di quel chiarore, anche nella costa cominciarono a spuntare i covoni raccolti in mucchi, come tanti sassi posti in fila. Degli altri punti neri si movevano per la china, e a seconda del vento giungeva il suono grave e lontano dei campanacci che portava il bestiame grosso, mentre scendeva passo passo verso il torrente. Di tratto in tratto soffiava pure qualche folata di venticello più fresco dalla parte di ponente, e per tutta la lunghezza della valle udivasi lo stormire delle messi ancora in piedi. Nell’aia la bica alta e ancora scura sembrava coronata d’argento, e nell’ombra si accennavano confusamente altri covoni in mucchi; ruminava altro bestiame; un’altra striscia d’argento lunga si posava in cima al tetto del magazzino, che diventava immenso nel buio.
«Eh? Diodata? Dormi, marmotta?…»
«Nossignore, no!…»
Essa comparve tutta arruffata e spalancando a forza gli occhi assonnati. Si mise a scopare colle mani dinanzi all’uscio, buttando via le frasche, carponi, fregandosi gli occhi di tanto in tanto per non lasciarsi vincere dal sonno, col mento rilassato, le gambe fiacche.
«Dormivi!… Se te l’ho detto che dormivi!…»
E le assestò uno scapaccione come carezza.
Egli invece non aveva sonno. Si sentiva allargare il cuore. Gli venivano tanti ricordi piacevoli. Ne aveva portate delle pietre sulle spalle, prima di fabbricare quel magazzino! E ne aveva passati dei giorni senza pane, prima di possedere tutta quella roba! Ragazzetto… gli sembrava di tornarci ancora, quando portava il gesso dalla fornace di suo padre, a Donferrante! Quante volte l’aveva fatta quella strada di Licodia, dietro gli asinelli che cascavano per via e morivano alle volte sotto il carico! Quanto piangere e chiamar santi e cristiani in aiuto! Mastro Nunzio allora suonava il deprofundis sulla schiena del figliuolo, con la funicella stessa della soma… Erano dieci o dodici tarì che gli cascavano di tasca ogni asino morto al poveruomo! – Carico di famiglia! Santo che gli faceva mangiare i gomiti sin d’allora; Speranza che cominciava a voler marito; la mamma con le febbri, tredici mesi dell’anno!… – Più colpi di funicella che pane! – Poi quando il Mascalise, suo zio, lo condusse seco manovale, a cercar fortuna… Il padre non voleva, perché aveva la sua superbia anche lui, come uno che era stato sempre padrone, alla fornace, e gli cuoceva di vedere il sangue suo al comando altrui. – Ci vollero sette anni prima che gli perdonasse, e fu quando finalmente Gesualdo arrivò a pigliare il primo appalto per conto suo… la fabbrica del Molinazzo… Circa duecento salme di gesso che andarono via dalla fornace al prezzo che volle mastro Nunzio… e la dote di Speranza anche, perché la ragazza non poteva più stare in casa… – E le dispute allorché cominciò a speculare sulla campagna!… – Mastro Nunzio non voleva saperne… Diceva che non era il mestiere in cui erano nati. “Fa l’arte che sai!” – Ma poi, quando il figliuolo lo condusse a veder le terre che aveva comprato, lì proprio, alla Canziria, non finiva di misurarle in lungo e in largo, povero vecchio, a gran passi, come avesse nelle gambe la canna dell’agrimensore… E ordinava “bisogna far questo e quest’altro” per usare del suo diritto, e non confessare che suo figlio potesse aver la testa più fine della sua. – La madre non ci arrivò a provare quella consolazione, poveretta. Morì raccomandando a tutti Santo, che era stato sempre il suo prediletto e Speranza carica di famiglia com’era stata lei… – un figliuolo ogni anno… – Tutti sulle spalle di Gesualdo, giacché lui guadagnava per tutti. Ne aveva guadagnati dei denari! Ne aveva fatta della roba! Ne aveva passate delle giornate dure e delle notti senza chiuder occhio! Vent’anni che non andava a letto una sola volta senza prima guardare il cielo per vedere come si mettesse. – Quante avemarie, e di quelle proprio che devono andar lassù, per la pioggia e pel bel tempo! – Tanta carne al fuoco! tanti pensieri, tante inquietudini, tante fatiche!… La coltura dei fondi, il commercio delle derrate, il rischio delle terre prese in affitto, le speculazioni del cognato Burgio che non ne indovinava una e rovesciava tutto il danno sulle spalle di lui!… – Mastro Nunzio che si ostinava ad arrischiare cogli appalti il denaro del figliuolo, per provare che era il padrone in casa sua!… – Sempre in moto, sempre affaticato, sempre in piedi, di qua e di là, al vento, al sole, alla pioggia; colla testa grave di pensieri, il cuore grosso d’inquietudini, le ossa rotte di stanchezza; dormendo due ore quando capitava, come capitava, in un cantuccio della stalla, dietro una siepe, nell’aia, coi sassi sotto la schiena; mangiando un pezzo di pane nero e duro dove si trovava, sul basto della mula, all’ombra di un ulivo, lungo il margine di un fosso, nella malaria, in mezzo a un nugolo di zanzare. – Non feste, non domeniche, mai una risata allegra, tutti che volevano da lui qualche cosa, il suo tempo, il suo lavoro, o il suo denaro; mai un’ora come quelle che suo fratello Santo regalavasi in barba sua all’osteria! – trovando a casa poi ogni volta il viso arcigno di Speranza, o le querimonie del cognato, o il piagnucolìo dei ragazzi – le liti fra tutti loro quando gli affari non andavano bene. – Costretto a difendere la sua roba contro tutti, per fare il suo interesse. – Nel paese non un solo che non gli fosse nemico, o alleato pericoloso e temuto. – Dover celare sempre la febbre dei guadagni, la botta di una mala notizia, l’impeto di una contentezza; e aver sempre la faccia chiusa, l’occhio vigilante, la bocca seria! Le astuzie di ogni giorno; le ambagi per dire soltanto “vi saluto”; le strette di mano inquiete, coll’orecchio teso; la lotta coi sorrisi falsi, o coi visi arrossati dall’ira, spumanti bava e minacce – la notte sempre inquieta, il domani sempre grave di speranza o di timore…
«Ci hai lavorato, anche tu, nella roba del tuo padrone!… Hai le spalle grosse anche tu… povera Diodata!…»
Essa, vedendosi rivolta la parola, si accostò tutta contenta e gli si accovacciò ai piedi, su di un sasso, col viso bianco di luna, il mento sui ginocchi, in un gomitolo. Passava il tintinnìo dei campanacci, il calpestìo greve e lento per la distesa del bestiame che scendeva al torrente, dei muggiti gravi e come sonnolenti, le voci dei guardiani che lo guidavano e si spandevano lontane, nell’aria sonora. La luna ora discesa sino all’aia, stampava delle ombre nere in un albore freddo; disegnava l’ombra vagante dei cani di guardia che avevano fiutato il bestiame; la massa inerte del camparo, steso bocconi «Nanni l’Orbo, eh?… o Brasi Camauro? Chi dei due ti sta dietro la gonnella?» riprese don Gesualdo che era in vena di scherzare.
Diodata sorrise: «Nossignore!… nessuno!…»
Ma il padrone ci si divertiva: «Sì, sì!… l’uno o l’altro… o tutti e due insieme!… Lo saprò!… Ti sorprenderò con loro nel vallone, qualche volta!…»
Essa sorrideva sempre allo stesso modo, di quel sorriso dolce e contento, allo scherzo del padrone che sembrava le illuminasse il viso, affinato dal chiarore molle: gli occhi come due stelle; le belle trecce allentate sul collo; la bocca un po’ larga e tumida, ma giovane e fresca.
Il padrone stette un momento a guardarla così, sorridendo anch’esso, e le diede un altro scapaccione affettuoso.
«Questa non è roba per quel briccone di Brasi, o per Nanni l’Orbo! no!…»
«Oh, gesummaria!…» esclamò essa facendosi la croce.
«Lo so, lo so. Dico per ischerzo, bestia!…»
Tacque un altro po’ ancora, e poi soggiunse: «Sei una buona ragazza!… buona e fedele! vigilante sugli interessi del padrone, sei stata sempre…
«Il padrone mi ha dato il pane», rispose essa semplicemente. «Sarei una birbona…»
«Lo so! lo so!… poveretta!… per questo t’ho voluto bene!»
A poco a poco, seduto al fresco, dopo cena, con quel bel chiaro di luna, si lasciava andare alla tenerezza dei ricordi. «Povera Diodata! Ci hai lavorato anche tu!… Ne abbiamo passati dei brutti giorni!… Sempre all’erta, come il tuo padrone! Sempre colle mani attorno… a far qualche cosa! Sempre l’occhio attento sulla mia roba!… Fedele come un cane!… Ce n’è voluto, sì, a far questa roba!..».
Tacque un momento intenerito. Poi riprese, dopo un pezzetto, cambiando tono:
«Sai? Vogliono che prenda moglie.»
La ragazza non rispose; egli non badandoci, seguitò:
«Per avere un appoggio… Per far lega coi pezzi grossi del paese… Senza di loro non si fa nulla!… Vogliono farmi imparentare con loro… per l’appoggio del parentado, capisci?… Per non averli tutti contro, all’occasione… Eh? che te ne pare?»
Ella tacque ancora un momento col viso nelle mani. Poi rispose, con un tono di voce che andò a rimescolargli il sangue a lui pure:
«Vossignoria siete il padrone…»
«Lo so, lo so… Ne discorro adesso per chiacchierare… perché mi sei affezionata… Ancora non ci penso… ma un giorno o l’altro bisogna pure andarci a cascare… Per chi ho lavorato infine?… Non ho figliuoli…»
Allora le vide il viso, rivolto a terra, pallido pallido e tutto bagnato.
«Perché piangi, bestia?»
«Niente, vossignoria!… Così!… Non ci badate…»
«Cosa t’eri messa in capo, di’?»
«Niente, niente, don Gesualdo…»
«Santo e santissimo! Santo e santissimo!» prese a gridare lui sbuffando per l’aia. Il camparo al rumore levò il capo sonnacchioso e domandò:
«Che c’è?… S’è slegata la mula? Devo alzarmi?…»
«No, no, dormite, zio Carmine.»
Diodata gli andava dietro passo passo, con voce umile e sottomessa:
«Perché v’arrabbiate, vossignoria?… Cosa vi ho detto?..».
«M’arrabbio colla mia sorte!… Guai e seccature da per tutto… dove vado!… Anche tu, adesso!… col piagnisteo!… Bestia!… Credi che, se mai, ti lascerei in mezzo a una strada… senza soccorsi?…»
«Nossignore… non è per me… Pensavo a quei poveri innocenti…»
«Anche quest’altra?… Che ci vuoi fare! Così va il mondo!… Poiché v’è il comune che ci pensa!… Deve mantenerli il comune a spese sue… coi denari di tutti!… Pago anch’io!… So io ogni volta che vo dall’esattore!…»
Si grattò il capo un istante, e riprese:
«Vedi, ciascuno viene al mondo colla sua stella… Tu stessa hai forse avuto il padre o la madre ad aiutarti? Sei venuta al mondo da te, come Dio manda l’erba e le piante che nessuno ha seminato. Sei venuta al mondo come dice il tuo nome… Diodata! Vuol dire di nessuno!… E magari sei forse figlia di barone, e i tuoi fratelli adesso mangiano galline e piccioni! Il Signore c’è per tutti! Hai trovato da vivere anche tu!… E la mia roba?… me l’hanno data i genitori forse? Non mi son fatto da me quello che sono? Ciascuno porta il suo destino!… Io ho il fatto mio, grazie a Dio, e mio fratello non ha nulla…»
In tal modo seguitava a brontolare, passeggiando per l’aia, su e giù dinanzi la porta. Poscia vedendo che la ragazza piangeva ancora, cheta cheta per non infastidirlo, le tornò a sedere allato di nuovo, rabbonito.
«Che vuoi? Non si può far sempre quel che si desidera. Non sono più padrone… come quando ero un povero diavolo senza nulla… Ora ci ho tanta roba da lasciare… Non posso andare a cercar gli eredi di qua e di là, per la strada… o negli ospizi dei trovatelli. Vuol dire che i figliuoli che avrò poi, se Dio m’aiuta, saranno nati sotto la buona stella!…»
«Vossignoria siete il padrone…»
Egli ci pensò un po’ su, perché quel discorso lo punzecchiava ancora peggio di una vespa, e tornò a dire:
«Anche tu… non hai avuto né padre né madre… Eppure cosa t’è mancato, di’?»
«Nulla, grazie a Dio!»
«Il Signore c’è per tutti… Non ti lascerei in mezzo a una strada, ti dico!… La coscienza mi dice di no… Ti cercherei un marito..».
«Oh… quanto a me… don Gesualdo!..».
«Sì, sì, bisogna maritarti!… Sei giovane, non puoi rimaner così… Non ti lascerei senza un appoggio… Ti troverei un buon giovane, un galantuomo… Nanni l’Orbo, guarda! Ti darei la dote…»
«Il Signore ve lo renda…»
«Son cristiano! son galantuomo! Poi te lo meriti. Dove andresti a finire altrimenti?… Penserò a tutto io. Ho tanti pensieri pel capo!… e questo cogli altri!… Sai che ti voglio bene. Il marito si trova subito. Sei giovane… una bella giovane… Sì, sì, bella!… lascia dire a me che lo so! Roba fine!… sangue di barone sei, di certo!…»
Ora la pigliava su di un altro tono, col risolino furbo e le mani che gli pizzicavano. Le stringeva con due dita il ganascino. Le sollevava a forza il capo, che ella si ostinava a tener basso per nascondere le lagrime.
«Già per ora son discorsi in aria… Il bene che voglio a te non lo voglio a nessuno, guarda!… Su quel capo adesso, sciocca!… sciocca che sei!…»
Come vide che seguitava a piangere, testarda, scappò a bestemmiare di nuovo, simile a un vitello infuriato.
«Santo e santissimo! Sorte maledetta!… Sempre guai e piagnistei!…»

Riduzione teatrale del Mastro don-Gesualdo: qui una scena tra il protagonista e Diodata
Il passo si può dividere in tre sequenze:
- Gesualdo in fattoria: dopo una faticosa giornata, Gesualdo torna al suo nido, dove vi è un vecchio, che gli controlla la roba e una contadina, la sua serva-amante. Sin dall’inizio si comprende come solo questo sia il “nido” degli affetti, in quel guardare, insieme al vecchio fattore, la quotidianità dello svolgersi della natura, che pure gli offre la “roba”, senza rabbia, senza ansia; così come lo sguardo pieno d’amore che le rivolge, sentendola vicina nel sentimento; la condivisione del pasto lo sancisce, la fatica condivisa per lui lo conferma;
- I ricordi di Gesualdo che lo disegnano come un “self made man”;: fiuto degli affari, accettazione del rischio, operosità, sopportazione dei disagi. Tutta questa è stata la vita di Gesualdo, scandita continuamente da una corsa affannosa, dal mettere toppe da una famiglia che dipendeva (vista l’insipienza del fratello e del cognato) da lui, la gelosia paterna e, per di più, il subire un amore di secondo grado da parte della povera madre, che stravedeva per il figlio piccolo. Interessante di questo passo è la tecnica: tutto viene visto attraverso una focalizzazione interna, un, potrebbe anche dirsi, discorso indiretto libero interiore o anticipazione del monologo interiore;
- Il rimpianto di non poter scegliersi la vita: anche qui si sancisce una sconfitta, sottolineata dalle lacrime di Diodata. Il pessimismo verghiano è all’origine della vita: si nasce dove vuole il destino e si cresce, chi più o chi meno fortunato, senza possibilità di scelta. Ma lui il destino se lo è costruito, contro tutti, ma è solo e sarà solo: il suo bestemmiare finale rassomiglia proprio a una non accettazione di ciò che è diventato.
L’ASTA
(II,1)
«Tre onze e quindici!… Uno!… due!…»
«Quattr’onze!» replicò don Gesualdo impassibile.
Il barone Zacco si alzò, rosso come se gli pigliasse un accidente. Annaspò alquanto per cercare il cappello, e fece per andarsene. Ma giunto sulla soglia tornò indietro a precipizio, colla schiuma alla bocca, quasi fuori di sé, gridando:
«Quattro e quindici!…»
E si fermò ansante dinanzi alla scrivania dei giurati, fulminando il suo contradittore cogli occhi accesi. Don Filippo Margarone, Peperito e gli altri del Municipio che presiedevano all’asta delle terre comunali, si parlarono all’orecchio fra di loro. Don Gesualdo tirò su una presa, seguitando a fare tranquillamente i suoi conti nel taccuino che teneva aperto sulle ginocchia. Indi alzò il capo, e ribatté con voce calma:
«Cinque onze!»
Il barone diventò a un tratto come un cencio lavato. Si soffiò il naso; calcò il cappello in testa, e poi infilò l’uscio, sbraitando:
«Ah!… quand’è così!… giacch’è un puntiglio!… una personalità!… Buon giorno a chi resta!»
I giurati si agitavano sulle loro sedie quasi avessero la colica. Il canonico Lupi si alzò di botto, e corse a dire una parola all’orecchio di don Gesualdo, passandogli un braccio al collo.
«Nossignore», rispose ad alta voce costui. «Non ho di queste sciocchezze… Fo i miei interessi, e nulla più.»
Nel pubblico che assisteva all’asta corse un mormorìo. Tutti gli altri concorrenti si erano tirati indietro, sgomenti, cacciando fuori tanto di lingua. Allora si alzò in piedi il baronello Rubiera, pettoruto, lisciandosi la barba scarsa, senza badare ai segni che gli faceva da lontano don Filippo, e lasciò cadere la sua offerta, coll’aria addormentata di uno che non gliene importa nulla del denaro:
«Cinque onze e sei!… Dico io!…»
«Per l’amor di Dio», gli soffiò nelle orecchie il notaro Neri tirandolo per la falda. «Signor barone, non facciamo pazzie!…»
«Cinque onze e sei!» replicò il baronello senza dar retta, guardando in giro trionfante.
«Cinque e quindici.»
Don Ninì si fece rosso, e aprì la bocca per replicare; ma il notaro gliela chiuse con la mano. Margarone stimò giunto il momento di assumere l’aria presidenziale.
«Don Gesualdo!… Qui non stiamo per scherzare!… Avrete denari… non dico di no… ma è una bella somma… per uno che sino a ieri l’altro portava i sassi sulle spalle… sia detto senza offendervi… Onestamente… “Guardami quel che sono, e non quello che fui” dice il proverbio… Ma il comune vuole la sua garanzia. Pensateci bene!… Sono circa cinquecento salme… Fanno… fanno…» E si mise gli occhiali, scrivendo cifre sopra cifre.
«So quello che fanno», rispose ridendo mastro-don Gesualdo. «Ci ho pensato portando i sassi sulle spalle… Ah! signor don Filippo, non sapete che soddisfazione, essere arrivato sin qui, faccia a faccia con vossignoria e con tutti questi altri padroni miei, a dire ciascuno le sue ragioni, e fare il suo interesse!»
Don Filippo posò gli occhiali sullo scartafaccio; volse un’occhiata stupefatta ai suoi colleghi a destra e a sinistra, e tacque rimminchionito. Nella folla che pigiavasi all’uscio nacque un tafferuglio. Mastro Nunzio Motta voleva entrare a ogni costo, e andare a mettere le mani addosso al suo figliuolo che buttava così i denari. Burgio stentava a frenarlo. Margarone suonò il campanello per intimar silenzio.
«Va bene!… va benissimo!… Ma intanto la legge dice…»
Come seguitava a tartagliare, quella faccia gialla di Canali gli suggerì la risposta, fingendo di soffiarsi il naso.
«Sicuro!… Chi garantisce per voi?… La legge dice…»
«Mi garantisco da me», rispose don Gesualdo posando sulla scrivania un sacco di doppie che cavò fuori dalla cacciatora.
A quel suono tutti spalancarono gli occhi. Don Filippo ammutolì.
«Signori miei!…» strillò il barone Zacco rientrando infuriato. «Signori miei!… guardate un po’! a che siam giunti!…»
«Cinque e quindici!» replicò don Gesualdo tirando un’altra presa. «Offro cinque onze e quindici tarì a salma per la gabella delle terre comunali. Continuate l’asta, signor don Filippo.»
Il baronello Rubiera scattò su come una molla, con tutto il sangue al viso. Non l’avrebbero tenuto neppure le catene.
«A sei onze!» balbettò fuori di sé. «Fo l’offerta di sei onze a salma.»
«Portatelo fuori! Portatelo via!» strillò don Filippo alzandosi a metà. Alcuni battevano le mani. Ma don Ninì ostinavasi, pallido come la sua camicia adesso.
«Sissignore! a sei onze la salma! Scrivete la mia offerta, segretario!»
«Alto!» gridò il notaro levando tutte e due le mani in aria. «Per la legalità dell’offerta!… fo le mie riserve!…»
E si precipitò sul baronello, come s’accapigliassero. Lì, nel vano del balcone, faccia a faccia, cogli occhi fuori dell’orbita, soffiandogli in viso l’alito infuocato:
«Signor barone!… quando volete buttare il denaro dalla finestra!… andate a giuocare a carte!… giuocatevi il denaro di tasca vostra soltanto!…»
L’accaparramento delle terre comunali da parte dei notabili, con la complicità dei funzionari, era una prassi che si svolgeva da tempi immemorabili: il loro possesso voleva poi dire poi subaffittarle e quindi guadagnarci. Gesualdo vuole acquistarle tutte ed imporre invece un vero e proprio monopolio. E’ certo che tale mossa risponde a fini economici, ma nell’economia del romanzo essa va inserirsi in un episodio fondamentale: precedentemente i notabili avevano palesemente snobbato il suo matrimonio con Bianca Trao; vincerli sul piano economico, buttando loro in faccia la sua ricchezza diventa una vera e propria rivalsa e sottolineare che, d’ora in poi, dovranno fare i conti con lui. Tutto ciò e anche sottolineato dal ritmo narrativo con cui Verga descrive la scena: da una parte gli atteggiamenti sconnessi della nobiltà, che si vede sfidata, ma non sembra possedere un’efficace risposta, dall’altra, la calma serafica di Gesualdo, che col suo atteggiamento distaccato, sembra li irrida profondamente.

Mastro don Gesualdo in una vecchia riduzione televisiva (1964)
LA MORTE DI GESUALDO
(IV,5)
Un giorno venne a fargli visita l’amministratore del duca, officioso, tutto gentilezze come il suo padrone quando apparecchiavasi a dare la botta. S’informò della salute; gli fece le condoglianze per la malattia che tirava in lungo. Capiva bene, lui, un uomo d’affari come don Gesualdo… che dissesto… quanti danni… le conseguenze… un’azienda così vasta… senza nessuno che potesse occuparsene sul serio… Infine offrì d’incaricarsene lui… per l’interesse che portava alla casa… alla signora duchessa… Del signor duca era buon servo da tanti anni… Sicché prendeva a cuore anche gli interessi di don Gesualdo. Proponeva d’alleggerirlo d’ogni carico… finché si sarebbe guarito… se credeva… investendolo per procura…
A misura che colui sputava fuori il veleno, don Gesualdo andava scomponendosi in viso. Non fiatava, stava ad ascoltarlo, cogli occhi bene aperti, e intanto ruminava come trarsi d’impiccio. A un tratto si mise a urlare e ad agitarsi quasi fosse colto di nuovo dalla colica, quasi fosse giunta l’ultima sua ora, e non udisse e non potesse più parlare. Balbettò solo, smaniando:
«Chiamatemi mia figlia! Voglio veder mia figlia!»
Ma appena accorse lei, spaventata egli non aggiunse altro. Si chiuse in sé stesso a pensare come uscire dal malo passo, torvo, diffidente, voltandosi in là per non lasciarsi scappare qualche occhiata che lo tradisse. Soltanto ne piantò una lunga lunga addosso a quel galantuomo che se ne andava rimminchionito. Infine, a poco a poco, finse di calmarsi. Bisognava giuocar d’astuzia per uscire da quelle grinfie. Cominciò a far segno di sì e di sì col capo, fissando gli occhi amorevoli in volto alla figliuola allibbita, col sorriso paterno, il fare bonario;
«Sì… voglio darvi in mano tutto il fatto mio… per alleggerirmi il carico… Mi farete piacere anzi… nello stato in cui sono… Voglio spogliarmi di tutto… Già ho poco da vivere… Rimandatemi a casa mia per fare la procura… la donazione… tutto ciò che vorrete… Lì conosco il notaro… so dove metter le mani… Ma prima rimandatemi a casa mia… Tutto quello che vorrete, poi!…»
«Ah, babbo, babbo!» esclamò Isabella colle lagrime agli occhi.
Ma egli sentivasi morire di giorno in giorno. Non poteva più muoversi. Sembravagli che gli mancassero le forze d’alzarsi dal letto e andarsene via perché gli toglievano il denaro, il sangue delle vene, per tenerlo sottomano, prigioniero. Sbuffava, smaniava, urlava di dolore e di collera. E poi ricadeva sfinito, minaccioso, colla schiuma alla bocca, sospettando di tutto, spiando prima le mani del cameriere se beveva un bicchiere d’acqua, guardando ciascuno negli occhi per scoprire la verità, per leggervi la sua sentenza, costretto a ricorrere agli artifizii per sapere qualcosa di quel che gli premeva.
«Chiamatemi quell’uomo dell’altra volta… Portatemi le carte da firmare… E’ giusto, ci ho pensato su. Bisogna incaricare qualcuno dei miei interessi, finchè guarisco…»
Ma adesso coloro non avevano fretta; gli promettevano sempre, dall’oggi al domani. Lo stesso duca si strinse nelle spalle: come a dire che non serviva più. Un terrore più grande, più vicino, della morte lo colse a quell’indifferenza. Insisteva, voleva disporre della sua roba, come per attaccarsi alla vita, per far atto d’energia e di volontà. Voleva far testamento, per dimostrare a sé stesso ch’era tuttora il padrone. Il duca finalmente, per chetarlo, gli disse che non occorreva, poiché non c’erano altri eredi… Isabella era figlia unica…
«Ah?…» rispose lui. «Non occorre… è figlia unica?…»
E tornò a ricoricarsi, lugubre. Avrebbe voluto rispondergli che ce n’erano ancora, degli eredi nati prima di lei, sangue suo stesso. Gli nascevano dei rimorsi, colla bile. Faceva dei brutti sogni, delle brutte facce pallide e irose gli apparivano la notte; delle voci, degli scossoni lo facevano svegliare di soprassalto, in un mare di sudore, col cuore che martellava forte. Tanti pensieri gli venivano adesso, tanti ricordi, tante persone gli sfilavano dinanzi: Bianca, Diodata, degli altri ancora: quelli non l’avrebbero lasciato morire senza aiuto! Volle un altro consulto, i migliori medici. Ci dovevano essere dei medici pel suo male, a saperli trovare, a pagarli bene. Il denaro l’aveva guadagnato apposta, lui! Al suo paese gli avevano fatto credere che rassegnandosi a lasciarsi aprire il ventre… Ebbene, sì, sì!
Aspettava il consulto, il giorno fissato, sin dalla mattina, raso e pettinato, seduto nel letto, colla faccia color di terra, ma fermo e risoluto. Ora voleva vederci chiaro nei fatti suoi. «Parlate liberamente, signori miei. Tutto ciò che si deve fare si farà!»
Gli batteva un po’ il cuore. Sentiva un formicolìo come di spasimo anticipato tra i capelli. Ma era pronto a tutto; quasi scoprivasi il ventre, perchè si servissero pure. Se un albero ha la cancrena addosso, cos’è infine? Si taglia il ramo! Adesso invece i medici non volevano neppure operarlo. Avevano degli scrupoli, dei ma e dei se. Si guardavano fra di loro e biasciavano mezze parole. Uno temeva la responsabilità; un altro osservò che non era più il caso… oramai… Il più vecchio, una faccia di malaugurio che vi faceva morire prima del tempo, com’è vero Dio, s’era messo già a confortare la famiglia, dicendo che sarebbe stato inutile anche prima, con un male di quella sorta…
«Ah…» rispose don Gesualdo, fattosi rauco a un tratto. «Ah… Ho inteso…»
E si lasciò scivolare pian piano giù disteso nel letto, trafelato. Non aggiunse altro, per allora. Stette zitto a lasciarli finire di discorrere. Soltanto voleva sapere s’era venuto il momento di pensare ai casi suoi. Non c’era più da scherzare adesso! Aveva tanti interessi gravi da lasciare sistemati… «Taci! taci!» borbottò rivolto alla figliuola che gli piangeva allato. Colla faccia cadaverica, cogli occhi simili a due chiodi in fondo alle orbite livide, aspettava la risposta che gli dovevano, infine. Non c’era da scherzare!
«No, no… C’è tempo. Simili malattie durano anni e anni… Però… certo… premunirsi… sistemare gli affari a tempo… non sarebbe male…»
«Ho inteso», ripeté don Gesualdo col naso fra le coperte. «Vi ringrazio, signori miei.»
Un nuvolo gli calò sulla faccia e vi rimase. Una specie di rancore, qualcosa che gli faceva tremare le mani e la voce, e trapelava dagli occhi socchiusi. Fece segno al genero di fermarsi; lo chiamò dinanzi al letto, a quattr’occhi, da solo a solo.
«Finalmente… questo notaro… verrà, sì o no? Devo far testamento… Ho degli scrupoli di coscienza… Sissignore!… Sono il padrone, sì o no?… Ah… ah… stai ad ascoltare anche tu?…»
Isabella andò a buttarsi ginocchioni ai piedi del letto, col viso fra le materasse, singhiozzando e disperandosi. Il genero lo chetava dall’altra parte. «Ma sì, ma sì, quando vorrete, come vorrete. Non c’è bisogno di far delle scene… Ecco in che stato avete messo la vostra figliuola!…»
«Va bene!» seguitò a borbottare lui. «Va bene! Ho capito!»
E volse le spalle, tal quale suo padre, buon’anima. Appena fu solo cominciò a muggire come un bue, col naso al muro. Ma poi se veniva gente, stava zitto. Covava dentro di sé il male e l’amarezza. Lasciava passare i giorni. Pensava ad allungarseli piuttosto, a guadagnare almeno quelli, uno dopo l’altro, così come venivano, pazienza! Finché c’è fiato c’è vita. A misura che il fiato gli andava mancando, a poco a poco, acconciavasi pure ai suoi guai; ci faceva il callo. Lui aveva le spalle grosse, e avrebbe tirato in lungo, mercé la sua pelle dura. Alle volte provava anche una certa soddisfazione, fra sé e sé, sotto il lenzuolo, pensando al viso che avrebbero fatto il signor duca e tutti quanti, al vedere che lui aveva la pelle dura. Era arrivato ad affezionarsi ai suoi malanni, li ascoltava, li accarezzava, voleva sentirseli lì, con lui, per tirare innanzi. I parenti ci avevano fatto il callo anch’essi; avevano saputo che quella malattia durava anni ed anni, e s’erano acchetati. Così va il mondo, pur troppo, che passato il primo bollore, ciascuno tira innanzi per la sua via e bada agli affari propri. Non si lamentava neppure; non diceva nulla, da villano malizioso, per non sprecare il fiato, per non lasciarsi sfuggire quel che non voleva dire; solamente gli scappavano di tanto in tanto delle occhiate che significavano assai, al veder la figliuola che gli veniva dinanzi con quella faccia desolata, e poi teneva il sacco al marito, e lo incarcerava lì, sotto i suoi occhi, col pretesto dell’affezione, per covarselo, pel timore che non gli giuocasse qualche tiro nel testamento. Indovinava che teneva degli altri guai nascosti, lei, e alle volte aveva la testa altrove, mentre suo padre stava colla morte sul capo. Si rodeva dentro, a misura che peggiorava; il sangue era diventato tutto un veleno; ostinavasi sempre più, taciturno, implacabile, col viso al muro, rispondendo solo coi grugniti, come una bestia.
Finalmente si persuase ch’era giunta l’ora, e s’apparecchiò a morire da buon cristiano. Isabella era venuta subito a tenergli compagnia. Egli fece forza coi gomiti, e si rizzò a sedere sul letto. «Senti», le disse, «ascolta…»
Era turbato in viso, ma parlava calmo. Teneva gli occhi fissi sulla figliuola, e accennava col capo. Essa gli prese la mano e scoppiò a singhiozzare.
«Taci», riprese, finiscila. Se cominciamo così non si fa nulla.
Ansimava perchè aveva il fiato corto, ed anche per l’emozione. Guardava intorno, sospettoso, e seguitava ad accennare del capo, in silenzio, col respiro affannato. Ella pure volse verso l’uscio gli occhi pieni di lagrime. Don Gesualdo alzò la mano scarna, e trinciò una croce in aria, per significare ch’era finita, e perdonava a tutti, prima d’andarsene.
«Senti… Ho da parlarti… intanto che siamo soli…»
Ella gli si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, di no, colle mani erranti che l’accarezzavano. L’accarezzò anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una parola. Di lì a un po’ riprese:
«Ti dico di sì. Non sono un ragazzo… Non perdiamo tempo inutilmente.» Poi gli venne una tenerezza. «Ti dispiace, eh?… ti dispiace a te pure?…»
La voce gli si era intenerita anch’essa, gli occhi, tristi, s’erano fatti più dolci, e qualcosa gli tremava sulle labbra. «Ti ho voluto bene… anch’io… quanto ho potuto… come ho potuto… Quando uno fa quello che può…»
Allora l’attirò a sé lentamente, quasi esitando, guardandola fissa per vedere se voleva lei pure, e l’abbracciò stretta stretta, posando la guancia ispida su quei bei capelli fini.
«Non ti fo male, di’?… come quand’eri bambina?…»
Gli vennero insieme delle altre cose sulle labbra, delle ondate di amarezza e di passione, quei sospetti odiosi che dei bricconi, nelle questioni d’interessi, avevano cercato di mettergli in capo. Si passò la mano sulla fronte, per ricacciarli indietro, e cambiò discorso.
«Parliamo dei nostri affari. Non ci perdiamo in chiacchiere, adesso…»
Essa non voleva, smaniava per la stanza, si cacciava le mani nei capelli, diceva che gli lacerava il cuore, che gli pareva un malaugurio, quasi suo padre stesse per chiudere gli occhi.
«Ma no, parliamone!» insisteva lui. «Sono discorsi serii. Non ho tempo da perdere adesso». Il viso gli si andava oscurando, il rancore antico gli corruscava negli occhi. «Allora vuol dire che non te ne importa nulla… come a tuo marito…»
Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti… Le raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla: «Piuttosto farti tagliare la mano, vedi!… quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte!… Lui non sa cosa vuol dire!» Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, l’Alìa, la Canziria, li passava tutti in rassegna amorosamente; rammentava come erano venuti a lui, uno dopo l’altro, a poco a poco, le terre seminative, i pascoli, le vigne; li descriveva minutamente, zolla per zolla, colle qualità buone o cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso, gli spuntavano le lagrime agli occhi:
«Mangalavite, sai… la conosci anche tu… ci sei stata con tua madre… Quaranta salme di terreni, tutti alberati!… ti rammenti… i belli aranci?… anche tua madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca, negli ultimi giorni!… 300 migliaia l’anno, ne davano! Circa 300 onze! E la Salonia… dei seminati d’oro… della terra che fa miracoli… benedetto sia tuo nonno che vi lasciò le ossa!…»
Infine, per la tenerezza, si mise a piangere come un bambino.
«Basta», – disse poi. «Ho da dirti un’altra cosa… Senti…»
La guardò fissamente negli occhi pieni di lagrime per vedere l’effetto che avrebbe fatto la sua volontà. Le fece segno di accostarsi ancora, di chinarsi su lui supino che esitava e cercava le parole.
«Senti!… Ho degli scrupoli di coscienza… Vorrei lasciare qualche legato a delle persone verso cui ho degli obblighi… Poca cosa… Non sarà molto per te che sei ricca… Farai conto di essere una regalìa che tuo padre ti domanda… in punto di morte… se ho fatto qualcosa anch’io per te…»
«Ah, babbo, babbo!… che parole!» singhiozzò Isabella.
«Lo farai, eh? lo farai?… anche se tuo marito non volesse…»
Le prese le tempie fra le mani, e le sollevò il viso per leggerle negli occhi se l’avrebbe ubbidito, per farle intendere che gli premeva proprio, e che ci aveva quel segreto in cuore. E mentre la guardava, a quel modo, gli parve di scorgere anche lui quell’altro segreto, quell’altro cruccio nascosto, in fondo agli occhi della figliuola. E voleva dirle delle altre cose, voleva farle altre domande, in quel punto, aprirle il cuore come al confessore, e leggere nel suo. Ma ella chinava il capo, quasi avesse indovinato, colla ruga ostinata dei Trao fra le ciglia, tirandosi indietro, chiudendosi in sè, superba, coi suoi guai e il suo segreto. E lui allora sentì di tornare Motta, com’essa era Trao, diffidente, ostile, di un’altra pasta. Allentò le braccia, e non aggiunse altro.
«Ora fammi chiamare un prete», terminò con un altro tono di voce. «Voglio fare i miei conti con Domeneddio.»
Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l’udì agitarsi e smaniare prima dell’alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall’altra parte, fingendo di non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c’era.
«Mia figlia!» borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. «Chiamatemi mia figlia!»
«Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla», rispose il domestico, e tornò a coricarsi.
Ma non lo lasciava dormire quell’accidente! Un po’ erano sibili, e un po’ faceva peggio di un contrabbasso, nel russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle. Tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce.
«Cos’è? Gli è venuto l’uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca?»
Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per vederlo in faccia. Allora si fregò bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto.
«Ohi! ohi! Che facciamo adesso?» balbettò grattandosi il capo.
Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po’, o scendere subito a svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra. Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli, e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi, e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s’affacciò a prendere una boccata d’aria, fumando.
Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra.
«Mattinata, eh, don Leopoldo?»
«E nottata pure!» rispose il cameriere sbadigliando. «M’è toccato a me questo regalo!»
L’altro scosse il capo, come a chiedere che c’era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n’era andato, grazie a Dio.
«Ah… così… alla chetichella?…» osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l’androne.
Degli altri domestici s’erano affacciati intanto, e vollero andare a vedere. Di lì a un po’ la camera del morto si riempì di gente in manica di camicia e colla pipa in bocca. La guardarobiera vedendo tutti quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche lei a far capolino nella stanza accanto.
«Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non vi mangiamo mica… E neanche lui… non vi mette più le mani addosso di sicuro…»
«Zitto, scomunicato!… No, ho paura, poveretto…» Ha cessato di penare.
«Ed io pure», soggiunse don Leopoldo.
Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano – uno che faceva della notte giorno, e non si sapeva come pigliarlo, e non era contento mai. – Pazienza servire quelli che realmente son nati meglio di noi… Basta, dei morti non si parla.
«Si vede com’era nato…» osservò gravemente il cocchiere maggiore. «Guardate che mani!»
«Già, son le mani che hanno fatto la pappa!… Vedete cos’è nascer fortunati… Intanto vi muore nella battista come un principe!…»
«Allora», disse il portinaio, «devo andare a chiudere il portone?»
«Sicuro, eh! E’ roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa.»
Abbiamo già parlato della similarità tra Mazzarò e Gesualdo: per ambedue esiste solo la “religione della roba” e la separazione da essa è qualcosa che prima o poi i due personaggi dovevano affrontare; il primo lo fa in modo grottesco, nel secondo, invece, Verga utilizza un vero e proprio stile tragico. Gesualdo è estraneo in casa della figlia, come è estraneo alla figlia stessa. Il genero vuole soltanto profittare dei suoi beni. L’accumulo della “roba” gli ha estraniato qualsiasi affetto e da vecchio, sul punto di morte, questo senso di colpa sembra quasi voglia espiarlo. Ma è un attimo: il pensiero torna alla roba e alla paura ce il genero gliela porti via per pagare i suoi immensi debiti. E’ che la roba è lui, in questo processo d’identificazione vedere la figlia non difendere la roba paterna è come voler dire non difendere il padre stesso. Ma è abbastanza palese, dagli atteggiamenti di Isabella, quanta difficoltà abbia nel riuscire ad amare un padre che era stato odiato dalla madre e quindi da lei.
Muore tra la servitù, solo, regredendo da dove è partito e sancendo una sconfitta totale, simile nella loro diversità: Mazzarò la distrugge perché non può portarla con sé, Gesualdo la vede distruggere. Per Verga non esiste alcuna possibilità per evitare la sconfitta.
Il Mastro-don Gesualdo, rappresenta il secondo romanzo del ciclo de I Vinti ed è diviso in quattro parti: ascesa, successo, declino e sconfitta. Tutta la vicenda, quindi, ruota intorno a Gesualdo, facendo così sparire la coralità che era stata invece tipica de I Malavoglia. Cambia anche il tempo storico, a cavallo delle grandi rivoluzioni del ’48 e quindi anche in questa vicenda la storia entra a turbare il destino del personaggio: l’ascesa della borghesia e il conseguente degradare della nobiltà.
Il personaggio di Gesualdo è dominato dal “demone” della roba, da lui si fa trasportare e per lui rinuncia ad ogni forma di accettazione sociale: è odiato perché è diventato ricco; è odiato dalla moglie, perché è stata costretta a sposarlo proprio per la sua ricchezza e che lui ha a sua volta sposato per scalare la scala sociale; è odiato dalla figlia perché non gli ha permesso un matrimonio d’amore. Gesualdo è condannato alla solitudine. Tale condizione della vita non può che ricrearsi nella morte.
La storia di un personaggio e non di un intero paese spinge Verga a mutare la tecnica narrativa: non più una “regressione” quanto una presa di distanza critica sull’oggetto narrato, che non elude, talvolta, una presa di posizione da parte del narratore che spesso coincide con quella popolare; una maggiore “verità” la ottiene anche attraverso un numero piuttosto alto di dialoghi.
In altre parole potremo dire che il Mastro-don Gesualdo è un romanzo più tradizionale de I Malavoglia, ma dalla stessa capacità d’impatto per la cultura italiana ed europea, tanto da poter degnamente figurare tra i grandi romanzi della seconda metà dell’Ottocento.
Opere tarde
Oltre i quattro capolavori, che potremo definire “rusticani” Verga continuerà a scrivere, ma tutte le ultime opere sono considerate dalla critica inferiori al periodo maggiormente creativo dell’artista siciliano. Tali opere sono i racconti riuniti nelle seguenti raccolte:
- Per le vie (1883)
- Drammi intimi (1884)
- Vagabondaggio (1887)
- I ricordi del Capitano d’Arce (1891)
- Don Candeloro & C. (1894)
In tutte queste novelle Verga mescola ambienti ancora siciliani con quelli milanesi (soprattutto nella prima di esse, in cui si sofferma sui diseredati urbani), ma già dalla seconda ricominciano ad apparire storie mondane psicologiche che ci riportano ai soliti difetti dei primi romanzi.
Così è anche il romanzo Il marito di Elena (1882), dove il nostro non prosegue affatto il ciclo dei Vinti (abbiamo solo un capitolo e mezzo de La Duchessa di Leyra), ma crea un opera assolutamente involutiva rispetto ai romanzi maggiori, ripetendo schemi e situazioni già toccati nei cosiddetti romanzi mondani.


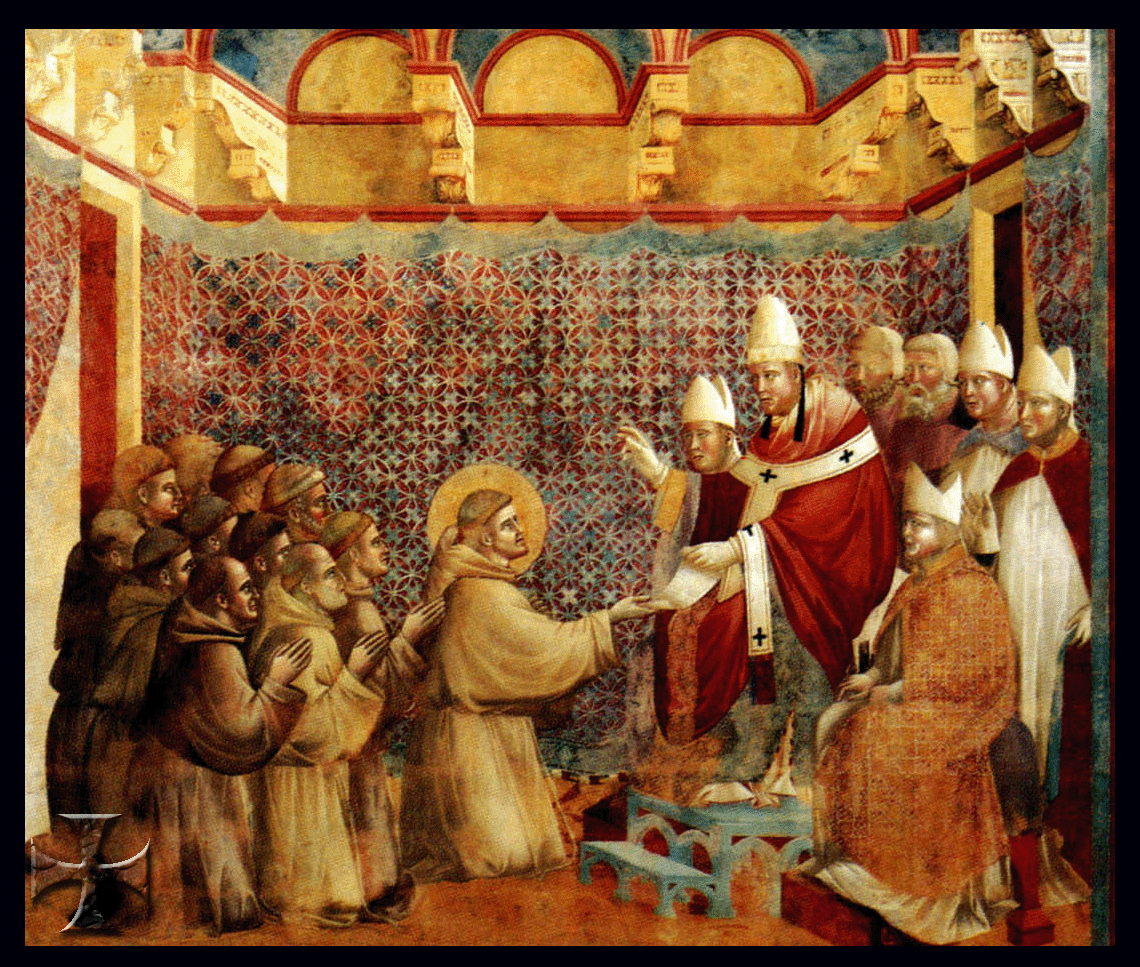


















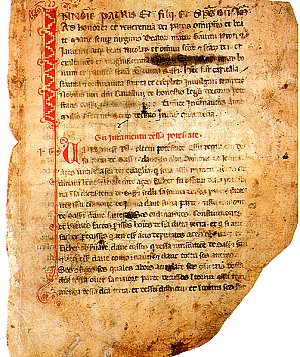




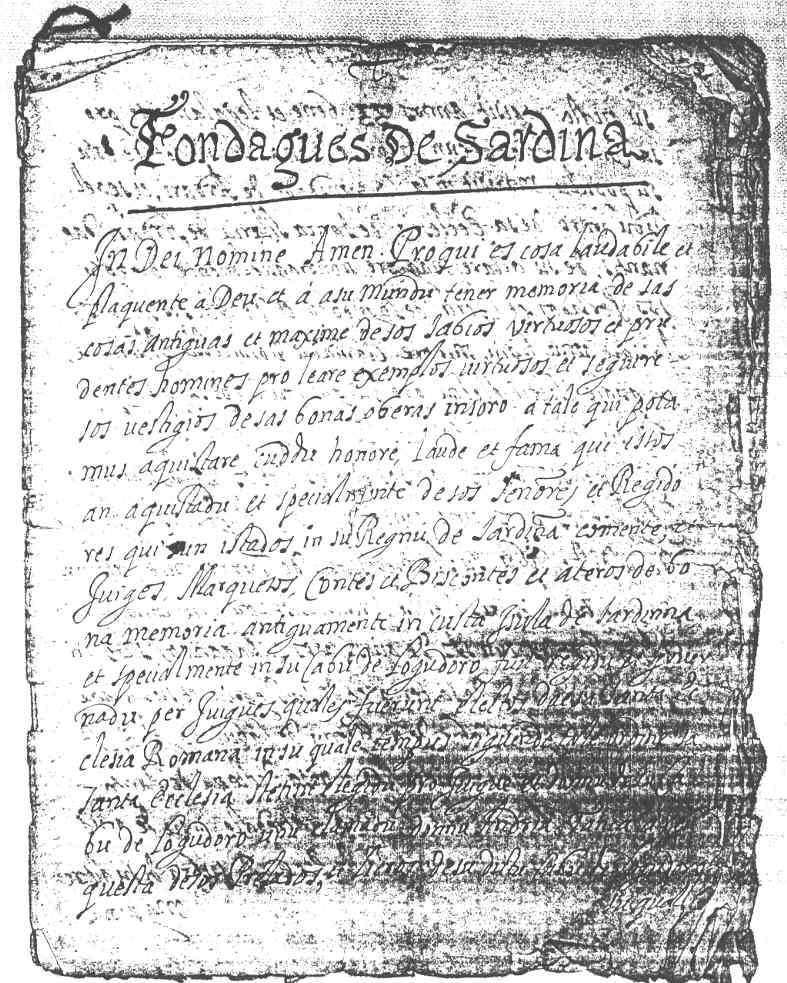



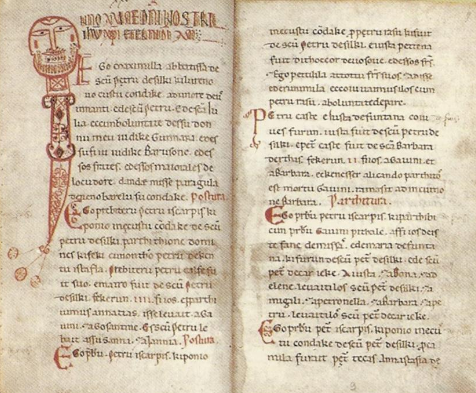




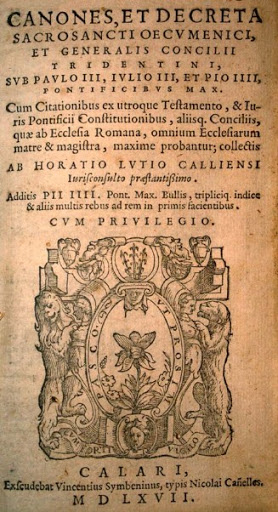
 Il trilinguismo
Il trilinguismo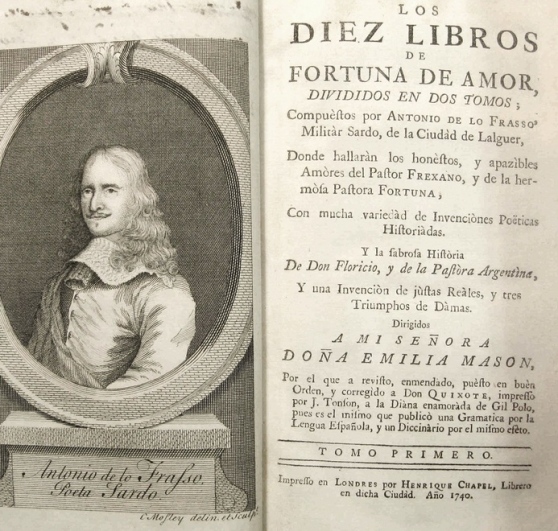
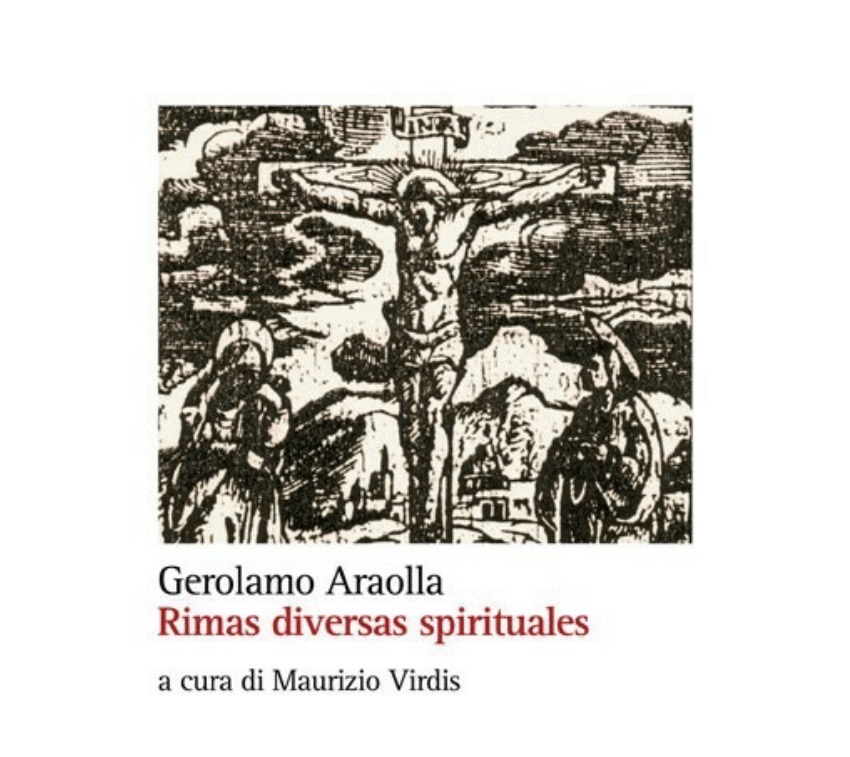

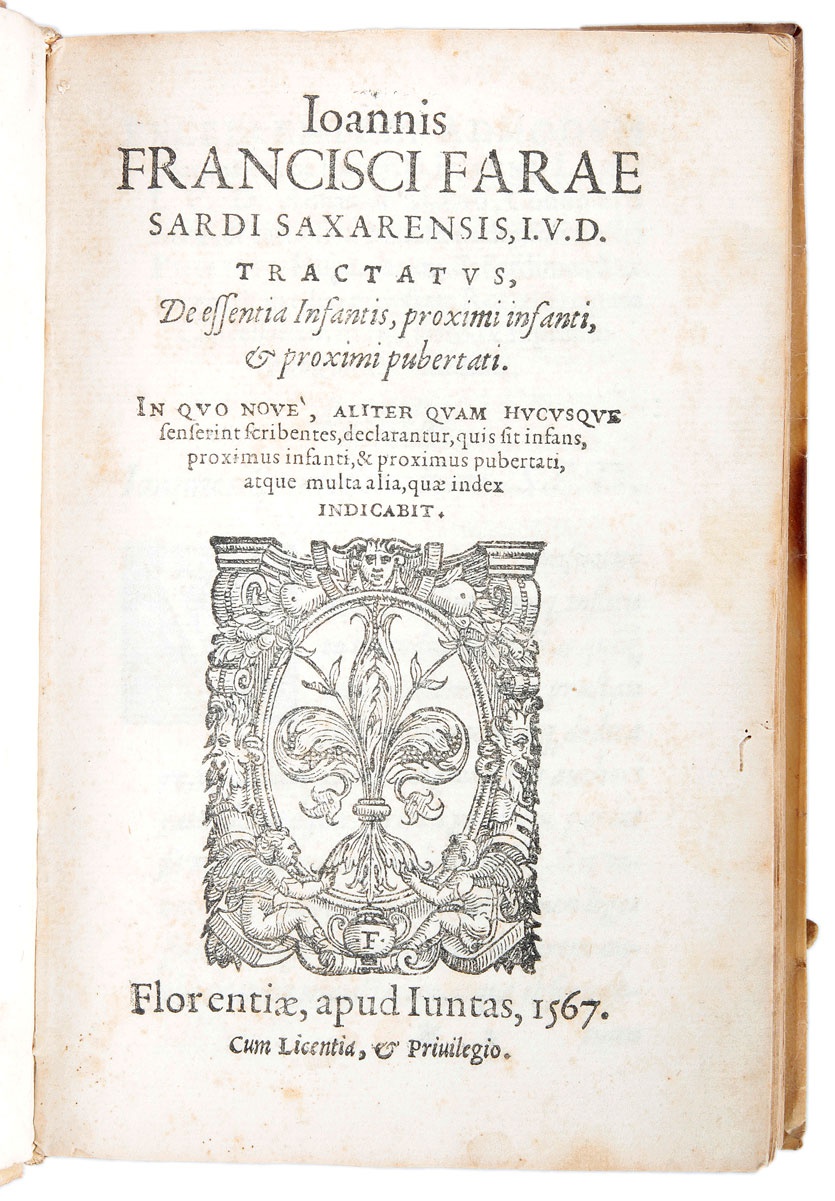
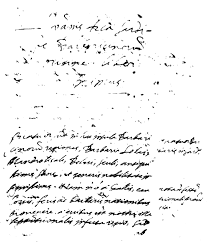

 Forse il più integrato nel clima culturale italiano fu Pietro Delitala (1550 -1592 circa). Nato a Bosa, durante il suo lungo esilio in Italia, entra in contatto con gli ambienti letterari e, probabilmente, anche col Tasso, la cui opera, comunque, conosce e considera quale indispensabile punto di riferimento. E’ autore di un canzoniere in lingua italiana, Rime diverse, di chiara ispirazione petrarchesca, pubblicato a Cagliari nel 1596. Nell’opera Delitala si dimostra inserito negli sviluppi manieristici della tradizione lirica italiana, la materia delle poesie è ricca di interessanti riferimenti autobiografici e alla realtà sarda. E’ stata messa in dubbio la conoscenza personale del Tasso da parte del Delitala, ma il sonetto indirizzato all’autore della Gerusalemme liberata, sembra confermare questo rapporto. Nell’introduzione alla sua raccolta si scusa per avere scelto l’italiano al posto dello spagnolo o del sardo e chiede clementia per la sua prova poetica. La sua opera rappresenta al meglio la tendenza, da parte degli intellettuali sardi, a mantenere i tre filoni della sua tradizione letteraria: quello italiano, quello spagnolo e quello sardo.
Forse il più integrato nel clima culturale italiano fu Pietro Delitala (1550 -1592 circa). Nato a Bosa, durante il suo lungo esilio in Italia, entra in contatto con gli ambienti letterari e, probabilmente, anche col Tasso, la cui opera, comunque, conosce e considera quale indispensabile punto di riferimento. E’ autore di un canzoniere in lingua italiana, Rime diverse, di chiara ispirazione petrarchesca, pubblicato a Cagliari nel 1596. Nell’opera Delitala si dimostra inserito negli sviluppi manieristici della tradizione lirica italiana, la materia delle poesie è ricca di interessanti riferimenti autobiografici e alla realtà sarda. E’ stata messa in dubbio la conoscenza personale del Tasso da parte del Delitala, ma il sonetto indirizzato all’autore della Gerusalemme liberata, sembra confermare questo rapporto. Nell’introduzione alla sua raccolta si scusa per avere scelto l’italiano al posto dello spagnolo o del sardo e chiede clementia per la sua prova poetica. La sua opera rappresenta al meglio la tendenza, da parte degli intellettuali sardi, a mantenere i tre filoni della sua tradizione letteraria: quello italiano, quello spagnolo e quello sardo.