
Pelizza da Volpedo: Il quarto stato (1901)
In Italia il naturalismo viene importato da Luigi Capuana, narratore siciliano ed assumerà caratteristiche proprie inserito in una realtà differente da quella dei paesi già industrializzati. E lo fa con una recensione nel Fanfulla della Domenica ai Malavoglia, l’opera maggiore di Verga:

Luigi Capuana
RECENSIONE AI MALAVOGLIA
Il Balzac, il gran padre del romanzo moderno, ha i suoi predecessori ai quali sta, forse, meno attaccato che i suoi successori non stiano a lui. Il Flaubert, i De Goncourt, lo Zola che hanno fatto e che fanno altro se non svolger meglio, ridurre a maggior perfezione quelle parti della forma del romanzo rimaste nella Comédie humaine in uno stato incipiente o imperfetto? Il naturalismo, i famosi documenti umani non sono una trovata dello Zola. Bisogna non aver letto la prefazione del Balzac al suo immenso monumento per credere che il trasportare nel romanzo il metodo della storia naturale sia una novità strana e pericolosa. Senza dubbio l’elemento scientifico s’infiltra nel romanzo contemporaneo e lo trasforma più pesantemente, con più coscienza, nei lavori del Flaubert, dei De Goncourt e dello Zola; ma la vera novità non istà in questo. Né stà nella pretesa di un romanzo sperimentale, bandiera che lo Zola inalbera arditamente, a sonori colpi di grancassa, per attirar la folla che altrimenti passerebbe via, senza fermarsi, com’egli confessava francamente al De Amicis. Un’opera d’arte non può assimilarsi un concetto scientifico che alla propria maniera, secondo la sua natura d’opera d’arte. Se il romanzo non dovesse far altro che della fisiologia o della patologia, o della psicologia comparata in azione, […] il guadagno non sarebbe né grande né bello. Il positivismo, il naturalismo esercitano una vera e radicale influenza nel romanzo contemporaneo, ma soltanto nella forma e tal influenza si traduce nella perfetta impersonalità di quest’opera d’arte. Tutto il resto, per l’arte, è una cosa molto secondaria, e dovrebbe esser tale anche nei giudizii che si pronunziano intorno ai lavori rappresentanti, più o meno efficaci, della nuova formula artistica. (…)
Nei romanzi del Balzac, questo sparire dell’autore avviene ad intervalli. Egli si mescola ogni po’ all’azione, spiega, descrive, torna addietro, fa delle lunghe divagazioni prima di lasciar i suoi personaggi a dibattersi soli soli colle loro passioni, col loro carattere, colle potenti influenze del lor tempo e dei luoghi; e l’onnipotenza del suo genio non si mostra mai così intera come quando le sue creature rimangon libere, abbandonate ai loro istinti, alla loro tragica fatalità. I suoi successori intervengono assai meno di lui nell’azione o non intervengono affatto. Si può dire che la loro opera d’arte si faccia da sé, piuttosto che la faccian loro. E questo semplicissimo cambiamento ha già prodotto una rivoluzione che il volgo dei lettori difficilmente sarà nel caso d’apprezzare nel suo giusto valore.
I Malavoglia si rannodano agli ultimissimi anelli di questa catena dell’arte. L’evoluzione del Verga è completa. Egli è uscito dalla vaporosità della sua prima maniera e si è afferrato alla realtà, solidamente. Questi Malavoglia e la sua Vita dei campi saranno un terribile e salutare corrosivo nella nostra bislacca letteratura. Lasciateli fare e vedrete. Se avranno poi la consacrazione (e se la meritano) d’una traduzione francese, eserciteranno un’influenza anche in una sfera più larga e conteranno per qualche cosa nella storia generale dell’arte. Giacché finora nemmeno lo Zola ha toccato una cima così alta in quell’impersonalità ch’è l’ideale dell’opera d’arte moderna. C’è voluto, senza dubbio, un’immensa dose di coraggio, per rinunziare così arditamente ad ogni più piccolo artificio, ad ogni minimo orpello rettorico e in faccia a questa nostra Italia che la rettorica allaga nelle arti, nella politica, nella religione, dappertutto. Ma non c’è voluto meno talento per rendere vive quelle povere creature di pescatori, quegli uomini elementari attaccati, come le ostriche, ai neri scogli di lava della riva di Trezza. Padron ‘Ntoni, Mena, la Santuzza, lo zio Crocifisso, lo zio Santoro, Piedipapera, ecc., sono creazioni che debbono essere un po’ sbalordite di trovarsi a vivere dentro la morta atmosfera della nostra stalattitica letteratura. (…)
Un romanzo come questo non si riassume. È un congegno di piccoli particolari, allo stesso modo della vita, organicamente innestati insieme. L’interesse che ispira non è quello volgare, triviale del come finira? ma un interesse concentrato che vi prende a poco a poco, con un’emozione di tristezza dinanzi a tanta miseria, dinanzi a quella lotta per la vita, qui osservata nel suo primo stadio quasi animale, e che l’autore s’accinge a studiare nelle classi superiori con una serie di romanzi legati insieme dal titolo complessivo: I Vinti. L’originalità il Verga l’ha trovata dapprima nel suo soggetto, poi nel metodo impersonale portato fino alle sue estreme conseguenze. Quei pescatori sono dei veri pescatori siciliani, anzi di Trezza, e non rassomigliano a nessuno dei personaggi d’altri romanzi. Non è improbabile che il Verga si possa sentir accusare di minore originalità quando il suo soggetto lo condurrà fra la borghesia e le alte classi delle grandi città, perché allora le differenze dei caratteri e delle passioni appariranno meno spiccate; ed è bene notarlo fin da ora.
La pagina è interessante perché ci offre la distanza che Capuana istituisce tra la produzione positivistica letteraria francese e la letteratura verista italiana. Innanzitutto egli intuisce come la produzione di Zola abbia radici sin da Balzac; quasi a dire che l’unica novità portata dall’autore di Germinal sia solo quello di rendere più “oggettiva” l’opera d’arte. Quindi sottolinea sin da subito che non è l’ideologia a fare dell’opera d’arte un’opera innovativa, ma il modo in cui è scritta. Insomma la novità della nuova cultura dev’essere soprattutto estetica e quindi non può riguardare il contenuto (a cui dev’essere data la liceità di descrivere il deforme) ma il grado dell’impersonalità raggiunta di modo che l’“opera d’arte si faccia da sé”.
Ciò è dovuto dal fatto che i romanzi europei si situano laddove l’industrializzazione è forte, e quindi la rappresentazione del reale è soprattutto urbana, dove avvengono i cambiamenti e le tensioni sociali. Per questo i protagonisti dei romanzi inglesi e francesi di questo periodo saranno operai o minatori (Germinale, L’Assomoir di Zola; Oliver Twist, Tempi difficili di Dickens).
Necessariamente diversa è la situazione italiana dove il paesaggio agrario è ancora dominante e le grandi città del Nord non possono competere con le capitali europee.
Quando la cultura positivista s’affaccia in Italia assume, per ciò che riguarda la letteratura, il nome di Verismo. Se per ottenere come dice Capuana il massimo dell’impersonalità devo osservare la realtà, essa non potrà essere che frammentata nelle varie situazioni regionali, dove maggiore è il disagio della unificazione (si pensi all’episodio del brigantaggio) né potrà essere urbana dal momento che le nostre città, a livello d’industrializzazione sono in netto ritardo rispetto alle varie capitali europee.
I nostri maggiori scrittori veristi sono meridionali. Fra questi bisogna citare il fondatore di tale movimento, Luigi Capuana (1839-1915), che si dimostra anche eccellente scrittore. Scrive varie novelle, i romanzi Giacinta (1879) e Il marchese di Roccaverdina, ritenuto il suo capolavoro (pubblicato nel 1901, ma frutto di una ventennale elaborazione):

1° edizione originale de “Il marchese di Roccaverdina”
La vicenda, ambientata nella campagna siciliana, ruota intorno all’aristocratico proprietario terriero che vive solitario nella casa avita, accudito dalla vecchia governante che gli fa da madre. Il marchese è tormentato da complessi problemi psicologici in seguito a un lunga, cruciale esperienza amorosa con una donna del popolo, Agrippina Solmo. Per uscire da una situazione insostenibile il marchese aveva allontanato l’amante, ingiungendole di sposare il suo factotum Rocco Criscione, ma obbligando anche entrambi, con un giuramento, a restare sposi solo di nome. Il romanzo inizia con le indagini sull’assassinio di Rocco, trovato ucciso da una fucilata, e si sviluppa in un crescendo di rivelazioni che costituiscono a poco a poco gli antefatti della storia. Il momento culminante di questo processo giunge con la confessione del marchese a don Silvio la Ciura, prete in fama di santità, di essere lui stesso il responsabile del delitto. La confessione non porta tuttavia al marchese la pace sperata, sia perché continuerà a temere fino alla morte del prete che questi si lasci sfuggire il segreto, sia perché non ha ottenuto l’assoluzione rifiutando di costituirsi per scagionare l’innocente cacciatore Neli Casaccio, messo in prigione come colpevole del delitto. Di qui inizia la caduta del protagonista in sempre più frequenti crisi di paura e di rimorso. Sul già precario equilibrio del marchese, infine, esercitano una deleteria risonanza anche le vicende di altri personaggi di contorno, come il suicidio di un piccolo proprietario costretto a vendergli il suo fondo o le disgrazie della famiglia di Neli Casaccio, ormai morto in carcere. Non riuscendo più a reggere il peso dei laceranti conflitti interiori il marchese cede alla follia.
I TORMENTI DEL MARCHESE
Quantunque, il giorno dopo, mamma Grazia lo avesse avvertito ch’ella aveva già dato aria al mezzanino, lasciando la chiave nella serratura dell’uscio perché dalla scala interna nessuno passava, il marchese non era disceso a ricercare le vecchie scritture. Fatte attaccare le mule alla carrozza, era partito per Margitello. Titta, il cocchiere, si meravigliava di vedere il padrone rannicchiato in fondo alla carrozza chiusa, e insolitamente silenzioso. Aveva tentato, ma inutilmente, di fargli dire qualcosa. «Ci vuole la pioggia! Guardi, voscenza; non un filo d’erba.» La pianura si estendeva da ogni lato, con terreni riarsi dal sole e screpolati, con aride piante di spino irte sui margini dello stradone… E si era alla fine di ottobre! Qua e là, un paio di buoi attaccati all’aratro si sforzavano di rompere le zolle indurite, procedendo lenti per la resistenza che incontravano. Qualche asino, un mulo, una cavalla col puledro dietro, pascolavano, legati a una lunga fune, o con pastoie ai piedi davanti, tra le poche stoppie non ancora abbruciate. «Quest’anno la paglia rincarirà. Non vi sarà altro per le povere bestie!» La carrozza, lasciato lo stradone provinciale, aveva infilato, a sinistra, la carraia di Margitello, tra due siepi di fichi d’India contorti, polverosi, coi fiori appassiti su le spinose foglie magre e quasi gialle per mancanza di umore. Le mule trottavano, sollevando nembi di polvere e facendo sobbalzare la carrozza su le ineguaglianze del suolo. A un certo punto, le ruote avevano urtato in un mucchio di sassi che ingombrava metà della carraia. «Qui accadde la disgrazia!», disse Titta. Quel mucchio di sassi indicava il posto dove era stato trovato il cadavere di Rocco Criscione, con la testa fracassata dalla palla tiratagli quasi a bruciapelo dalla siepe accanto. Chi era passato di là in quei giorni vi avea buttato un sasso, recitando un requiem, perché tutti si rammentassero del cristiano colà ammazzato e dicessero una preghiera in suffragio di quell’anima andata all’altro mondo senza confessione e senza sacramenti. Così il mucchio era diventato alto e largo in forma di piccola piramide. Ma neppure questa volta Titta sentì rispondersi niente; e frustò le mule, pensando a quel che sarebbe avvenuto a Margitello dove nessuno si attendeva l’arrivo del padrone. Stormi di piccioni domestici, usciti alla pastura, si levavano a volo dai lati della carraia al rumore dei sonagli delle mule e delle ruote della carrozza, che ora correva su la ghiaia sparsa sul terreno a poca distanza dalla casina. Si scorgevano il recinto della corte e le finestre chiuse, a traverso gli alberi di eucalipti che la circondavano da ogni parte. Contrariamente alle previsioni di Titta, il massaio e i garzoni l’avevano passata liscia. Il marchese avea visitato la dispensa, le stalle delle vacche, il fieno, la pagliera; aveva ispezionato minutamente gli aratri di nuovo modello fatti venire da Milano l’anno avanti, la cantina, le stanze di abitazione dei contadini, seguito dal massaio che gli andava dietro, timoroso di qualche lavata di capo; e non aveva fiatato neppure quando allo stesso massaio era parso opportuno scusarsi per un oggetto fuori posto, per un ingombro che avrebbe dovuto essere evitato, per qualche arnese buttato là trascuratamente, guasto e non riparato. Poi il marchese era salito, solo, nelle stanze superiori; e il massaio, dalla corte, gli vedeva spalancare le finestre, lo sentiva passare da una stanza all’altra, aprire e chiudere cassetti di tavolini e di cassettoni, armadii, spostare seggiole e sbattere usci. Due o tre volte, il marchese si era affacciato ora da una ora da un’altra finestra, quasi volesse chiamare qualcuno. Invece, avea dato lunghe occhiate lontano e attorno, per la campagna, o al cielo che sembrava di bronzo, limpido, senza un fiocco di nuvole da dieci mesi, infocato dal sole che bruciava come di piena estate. Tre ore dopo, egli era disceso giù aveva ordinato a Titta di riattaccare le mule, ed era ripartito senza dare nessuna disposizione, senza mostrarsi scontento né soddisfatto. A mezza strada della carraia di Margitello, là dove era il pezzo di terreno di compare Santi Dimauro, che aveva dovuto venderlo per forza, per evitarsi guai, il marchese, scorgendo dallo sportello il vecchio contadino seduto su un sasso rasente la siepe dei fichi d’India, coi gomiti appuntati su le ginocchia e il mento tra le mani, avea ordinato a Titta di fermare le mule. Compare Santi rizzò la testa, e salutò il marchese sollevando con una mano la parte anteriore del berretto bianco, di cotone. «Voscenza benedica!» «Che fate qui?», gli domandò il marchese. «Niente, eccellenza. Trovandomi al mulino, ho voluto dare uno sguardo…» «Rimpiangete ancora questi quattro sassi?» «Il mio cuore è sempre qua! Verrò a morirvi un giorno o l’altro.» «E avete faccia di lagnarvi, dopo che ve li ho pagati settant’onze?» Il vecchio si strinse nelle spalle, e riprese la sua positura. «Montate in serpe con Titta», soggiunse il marchese. «Grazie, voscenza. Ho lasciato l’asino al mulino; vo’ a riprenderlo, con la farina.» Titta si era voltato per convincersi se il padrone avesse parlato sul serio invitando compare Santi a montare in serpe, tanto gli era parsa straordinaria la cosa; ma la sua curiosità rimase insoddisfatta. Il marchese gli accennò con la mano di tirar via, e le mule si rimisero al trotto al primo schiocco di frusta. Lungo la ripida salita, Titta avea risparmiato le povere bestie. Alla svoltata della Cappelletta però, da dove lo stradone comincia a salire dolcemente, egli faceva riprendere il trotto; e pel movimento a sbalzi, i sonagli delle testiere squillavano all’ombra degli ulivi e dei mandorli che sporgevano dietro i ciglioni le chiome grige e verdognole tra cui stridevano alcune cicale ritardatarie, illuse forse dal persistente caldo che l’estate durasse ancora. «Che c’è?», domandò il marchese all’improvviso arrestarsi della carrozza. E, affacciatosi allo sportello, vide l’avvocato don Aquilante, con le lunghe gambe penzoloni dal parapetto di un ponticello, il cappellone di feltro nero, a larghe falde, che gli riparava dal sole, come un ombrello, la faccia sbarbata, con la grossa canna d’India tenuta ferma da una mano sul paracarro sottostante. Don Aquilante socchiuse gli occhi, scosse la testa con l’abituale movimento, portò l’altra mano allo stomaco, quasi volesse reggere la cintura rilasciata dei calzoni, e scese dal parapetto, aggrottando le sopracciglia, stringendo le labbra con l’aria di un uomo importunatamente disturbato. «Qui, con questo sole?», disse il marchese aprendo lo sportello della carrozza. Don Aquilante fece soltanto una mossa che voleva significare: se sapeste! e, accettando l’invito espressogli con un gesto, montò accanto al marchese. Le mule ripartirono al trotto. «Qui, con questo sole?», tornò quegli a domandare. «Voi siete scettico… Non importa!… Vi convincerete un giorno o l’altro!», rispose don Aquilante. Il marchese sentì corrersi un brivido per tutta la persona. Pure fece il bravo, sorrise; e quantunque avesse pregato don Aquilante di non più riparlargli di quelle cose, ed ora ne sentisse più che mai invincibile terrore, provò un impeto di sfida per vincere la sensazione che gli sembrava puerile in quel punto, all’aria aperta e con tutta quella luce. «Ah! Venite a cercare gli Spiriti fin qui?» «L’ho seguito a dieci passi di distanza, senza potere raggiungerlo. Ora è agitato; comincia ad aver coscienza della sua nuova condizione… Voi non potete intendere; siete fuori della verità, tra la caligine dei pregiudizi religiosi.» «Ebbene?», balbettò il marchese. «Un giorno vi persuaderete, finalmente, che io non sono un allucinato, né un pazzo. Vi sono persone», soggiunse con severo accento, «che posseggono facoltà speciali per vedere quel che gli altri non vedono, per udire quel che gli altri non odono. Per esse, il mondo degli uomini e quello degli Spiriti non sono due mondi distinti e diversi. Tutti i santi hanno avuto questa gran facoltà. Non occorre, però, di essere un santo
per ottenerla. Particolari circostanze possono accordarla a un meschino avvocato come me…» «E non vi è riuscito a raggiungerlo!», disse il marchese, con accento che avrebbe voluto essere ironico e tradiva intanto l’ansia da cui era turbato. «Si è fermato presso il ponticello ed è rimasto un istante in ascolto; poi, tutt’a un tratto, udito lo strepito dei sonagli delle mule e il rumore delle ruote della vostra carrozza che saliva per la rampa sottostante, si è precipitato giù pel ciglione dirimpetto. Evidentemente, ha voluto evitare d’incontrarsi con voi.» «Perché?» «Ve l’ho detto. Egli comincia ad aver coscienza della nuova condizione. In questo caso, tutto quel che rammenta la vita ispira orrore. E’ il più penoso dell’altra esistenza. Rocco che già si accorge di non essere più vivo…» Il marchese non osava d’interromperlo, né osava di domandarsi se colui che gli parlava in quel modo avesse smarrito il senno o fosse ancora in pieno possesso della ragione. A furia di udirlo discorrere di queste stramberie, come il marchese soleva chiamarle, si sentiva attratto da esse, non ostante che da qualche tempo in qua gli ispirassero una gran paura del misterioso ignoto, a dispetto del suo scetticismo e delle sue credenze religiose. E l’Inferno? E il Paradiso? E il Purgatorio? Don Aquilante li spiegava a modo suo; ma la Chiesa non dice che si tratta di cose diaboliche? Titta aveva spinte le mule al gran trotto, per fare una bella entrata in paese con schiocchi di frusta, gran tintinnio di sonagli e rumore di ruote; e questo distrasse il marchese dal torbido rimescolio di riflessioni e di terrori che gli passava per la mente mentre don Aquilante parlava. Rimescolio di riflessioni e di terrori che lo riprendeva però appena posto il piede in quelle stanze deserte dove non si udiva altro di vivente all’infuori dello strasciar delle ciabatte di mamma Grazia e del borbottio dei suoi rosarii, quando essa non aveva niente da fare. «Ho lasciato la chiave nella serratura dell’uscio», gli rammentò mamma Grazia. E il marchese, per occuparsi di qualche cosa, quantunque veramente non avesse nessuna vecchia scrittura da ricercare, scendeva giù nel mezzanino. Mamma Grazia aveva dato aria a quei due stanzoni, ma il tanfo di rinchiuso prendeva alla gola ciò non ostante. Larghe amache di ragnateli pendevano dagli angoli del soffitto. Un denso strato di polvere copriva i pochi vecchi mobili sfasciati, le casse, le tavole rotte che ingombravano la prima stanza e vi si distinguevano appena, perché essa prendeva luce da l’altra che rispondeva su la via. Entrato quasi diffidente, arricciando il naso pel forte puzzo di muffa, strizzando gli occhi per vedervi, il marchese si era fermato più volte a fine di raccapezzarsi. Tutta roba da buttar via! Era là fin da quando viveva il marchese grande. Nessuno aveva mai pensato di fare un bel repulisti; lo avrebbe fatto fare lui e subito. Ma pur pensando a questo, tornavano a frullargli nella testa le parole di don Aquilante, quasi qualcuno gliele ripetesse sommessamente dall’angolo più riposto del cervello: «Ha voluto evitare di scontrarsi con voi! Comincia ad aver coscienza della sua condizione!». Ormai! Che doveva importargli delle stramberie dell’avvocato?… Ma se fosse vero? Eh, via!… Ma, infine, se fosse vero?… E si arrestò con un senso di puerile paura, appena passata la soglia dell’altra stanza. La stessa angosciosa impressione di una volta, di molti e molti anni addietro! Allora aveva otto o nove anni. Ma allora il lenzuolo che avvolgeva il corpo di Cristo in croce, di grandezza naturale, appeso alla parete di sinistra, non era ridotto a brandelli dalle tignuole; e non si affacciavano dagli strappi quasi intera la testa coronata di spine e inchinata su una spalla, né le mani rattrappite, né i ginocchi piegati e sanguinolenti, né i piedi sovrapposti e squarciati dal grosso chiodo che li configgeva nel legno. La vista di quel corpo umano, che il lenzuolo modellava avvolgendolo, lo aveva talmente impaurito da bambino, ch’egli si era aggrappato al nonno, al marchese grande, da cui era stato condotto là, ora non si rammentava più perché; e i suoi strilli avevano fatto accorrere mamma Grazia e la marchesa nuova non ancora assalita dalla paralisi. Il nonno aveva tentato di convincerlo che quello era Gesù Crocifisso, e che non ne doveva aver paura; ed era salito sulla cassapanca sottostante per togliere gli spilli dal lenzuolo e fargli vedere il Signore messo in croce dai Giudei, del quale la mamma gli aveva raccontato la storia della passione e morte, un venerdì santo, prima di farlo assistere nella chiesa di Sant’Isidoro alla sacra cerimonia della Deposizione. Anche quella volta egli aveva strillato dalla paura, come altri bimbi suoi pari; e mamma Grazia era stata costretta a portarlo via in collo facendosi largo a stento tra la folla delle donne accalcate nella chiesa quasi buia, e singhiozzanti e piangenti, mentre un prete picchiava con un martello sul legno della croce per sconficcare i chiodi del Crocifisso, e una tromba squillava così malinconicamente che sembrava piangesse anch’essa. Questi ricordi gli eran passati, come un baleno, davanti agli occhi della mente; e intanto la paura di bambino si riproduceva in lui ugualmente intensa, anzi raddoppiata dalla circostanza che il vecchio lenzuolo, ridotto in brandelli, rendeva più terrificante quella figura di grandezza naturale, che sembrava lo guardasse con gli occhi semispenti e volesse muovere le livide labbra contratte dalla suprema convulsione dell’agonia. Quanti minuti non aveva avuto forza e coraggio d’inoltrarsi né di tornare addietro? Quando poté vincersi e dominarsi, aveva le mani diacce e il cuore che gli batteva forte. E non riusciva a formarsi un’esatta idea del tempo trascorso. S’impose però, facendosi violenza, di fissare il Crocifisso, anzi di accostarsi ad esso. E soltanto dopo che si sentì un po’ tranquillo, uscì dallo stanzone, indugiò un istante nell’altro, e chiuse l’uscio a chiave. Ma nel salire le scale gli sembrava che quegli occhi semispenti continuassero a guardarlo a traverso la spessezza dei muri, e che quelle livide labbra contratte dalla suprema convulsione dell’agonia si agitassero, forse, per gridargli dietro qualche terribile parola!
Il passo riportato ci presenta l’inizio del tormento del marchese e per coglierne la piena valenza narrativa è necessario ricordare che il lettore non sa ancora nulla. Ciò permette allo stesso di cogliere quegli indizi che condurranno poi, nel capitolo successivo, alla piena confessione dell’omicidio da parte del marchese. Tutto il brano è costruito con grande sapienza narrativa:
- il marchese vaga per la sua proprietà mostrandosi, innaturalmente, indifferente a tutto ciò che gli accade intorno. Si inizia a percepire che qualcosa non va;
- l’attraversamento del luogo in cui è avvenuto l’assassinio acuisce il senso di disagio del marchese che sente il peso della sua coscienza gravargli sempre di più, come le pietre che ricoprono quel corpo senza requie.
- L’incontro con l’avvocato Aquilante, che gli svela di essere in contatto con le persone morte: l’incredulità “razionale” del marchese di frange difronte all’immenso senso di colpa che lo attanaglia.
- Ritorno a casa, la crisi diventa “palpabile”: potrebbe sciogliersi, ma ancora non lo fa; il suo stato sociale gli dà quasi la garanzia dell’impunibilità.
Ma perché tale romanzo può essere iscritto nella narrativa verista? Capuana, per il suo secondo romanzo, riprende il tema della follia e lo fa derivare da quello che potremo definire l’ambiente. Ma non riesce ad evitare elementi che potremo definire ulteriori, come alcune simbologie (si pensi alle pietre e al peso sulla coscienza o al ricordo del Cristo). Il suo verismo allora è tutto nella “sparizione” dell’autore; il suo narrare è frutto dell’osservazione sia del paesaggio che dell’animo del protagonista che parlano all’autore senza alcuna mediazione.

Federico De Roberto
L’altro grande autore è Federico De Roberto (1861-1927); nato a Napoli, ma vissuto sin dalla fanciullezza a Catania dove morì. Si avvicinò, durante una sua permanenza a Milano a Capuana e Verga con i quali condivise la teoria dell’impersonalità per l’arte. Si mostra da subito interessato alla fisiologia dei sentimenti, soprattutto quello amoroso, determinando un notevole interesse per la psicologia dei personaggi. Questo gli sarà fortemente utile quando, tornato a Catania decise di dar vita ad un ciclo di romanzi per descrivere le vicende di una potente famiglia siciliana gli Uzeda. Tale ciclo vedrà la realizzazione del suo capolavoro I Viceré (1894) cui seguirà L’imperio, pubblicato postumo nel 1929.
Il Monastero dei Benedettini e il Palazzo Biscari
IL RITRATTO DI UNA FAMIGLIA
Se fosse stato più accorto, avrebbe preso con le buone la vecchia, senza rinunziare, beninteso, a nessuna delle proprie ambizioni. L’ostinazione, la durezza di cui aveva dato prova anche con lei erano sciocche, degne d’un Uzeda stravagante, non dell’onorevole di Francalanza, dell’uomo nuovo che egli voleva essere. E arrivando in casa della vecchia, in quella casa dov’era venuto tante volte bambino, a veder gli stemmi, a udire le storie dei Viceré, ad abbeverarsi d’albagia aristocratica, un muto sorriso gli spuntò sulle labbra. Se gli elettori avessero saputo?
«Come sta la zia?» chiese alla cameriera, una faccia nuova.
«Così così…» rispose la donna, guardando curiosamente quel signore sconosciuto.
«Ditele che il principe suo nipote vorrebbe vederla.»
La vecchia era capace di non riceverlo; egli aspettava la risposta con una certa ansietà. Donna Ferdinanda, udendo che c’era di là Consalvo, rispose alla cameriera, con voce arrochita dal raffreddore: «Lascialo entrare.» Ella aveva saputo gli ultimi vituperi commessi dal nipote, la parlata in pubblico come un cavadenti, i princìpi di casta sconfessati, l’inno alla libertà e alla democrazia, il palazzo Francalanza invaso dalla folla dei mascalzoni, Baldassarre ammesso alla tavola del principe che prima aveva servito: Lucrezia le aveva narrato ogni cosa, per vendicarsi, per rovinare Consalvo, per portargli via l’eredità. E donna Ferdinanda aveva sentito rimescolarsi il vecchio sangue degli Uzeda, dallo sdegno, dall’ira; ma adesso era ammalata, l’egoismo della vecchiaia e dell’infermità temperava i suoi bollori. E Consalvo veniva a trovarla; dunque s’umiliava, le dava questa soddisfazione negatale per tanto tempo. Poi, nonostante le apostasie e i vituperi, egli era tuttavia il principe di Francalanza… Il capo della casa, il suo protetto d’una volta… «Lascialo entrare…»
Egli le andò incontro premurosamente, si chinò sul lettuccio di ferro, quello di tant’anni addietro, e domandò: «Zia, come sta?»
Ella fece solo un gesto ambiguo col capo.
«Ha febbre? Mi lasci sentire il polso… No, soltanto un po’ di calore. Che cosa ha preso? Ha chiamato un dottore?»
«I dottori sono altrettanti asini,» gli rispose brevemente, voltandosi con la faccia contro il muro.
«Vostra Eccellenza ha ragione… sanno ben poco… ma qualcosa più di noi sanno pure… Perché non curarsi in principio?»
La vecchia rispose con uno scoppio di tosse cavernosa che finì con uno scaracchio giallastro. «Ha la tosse e non prende nulla! Le porterò io certe pastiglie che sono davvero miracolose. Mi promette di prenderle?»
Donna Ferdinanda fece il solito cenno col capo.
«Io non sapevo nulla, altrimenti sarei venuto prima. M’hanno detto che Vostra Eccellenza stava poco bene a momenti, in casa Radalì… Sa che mia sorella è andata oggi a vedere la Serva di Dio, quella di cui si narrano tante cose? E’ andata col Vicario, lei solamente ha avuto il permesso. Pare che sia un favore insigne… Vostra Eccellenza crede a tutto ciò che si narra?»
Non ebbe risposta. Pur continuò a parlare, comprendendo che alla vecchia doveva far piacere udir chiacchiere e notizie, vedersi qualcuno vicino.
«Io, col rispetto dovuto, non ne credo niente. E’ forse peccato? Lo stesso San Tommaso volle vedere e toccare, prima di credere… ed era santo!… Ma francamente, certe storie!… Teresa adesso è infatuata… Basta, ciascuno ha da vedersela con la propria coscienza… E la zia Lucrezia che l’ha con me? Che cosa voleva che io facessi?… Mi va sparlando per ogni dove, quasi fossi l’ultimo degli uomini…»
La vecchia non fiatava, gli voltava le spalle.
«Tutto pel grande amore del marito improvvisamente divampatole in petto!… Prima dichiarava ridicoli gli atteggiamenti di Giulente,» non lo chiamava zio sapendo di farle piacere, «adesso sono tutti infami coloro che non l’hanno sostenuto!»
Un nuovo scoppio di tosse fece soffiare la vecchia come un mantice. Quando calmossi, ella disse con voce affannata, ma con accento di amaro disprezzo: «Tempi obbrobriosi!… Razza degenere!»
La botta era diretta anche a lui. Consalvo tacque un poco, a capo chino, ma con un sorriso di beffa sulle labbra, poiché la vecchia non poteva vederlo. Poi, fiocamente, con tono d’umiltà, riprese: «Forse Vostra Eccellenza l’ha anche con me… Se ho fatto qualcosa che le è dispiaciuta, gliene chiedo perdono… Ma la mia coscienza non mi rimprovera nulla… Vostra Eccellenza non può dolersi che uno del suo nome sia di nuovo tra i primi del paese… Forse le duole il mezzo col quale questo risultato s’è raggiunto… Creda che duole a me prima che a lei… Ma noi non scegliamo il tempo nel quale veniamo al mondo; lo troviamo com’è, e com’è dobbiamo accettarlo. Del resto, se è vero che oggi non si sta molto bene, forse che prima si stava d’incanto?»
Non una sillaba di risposta.
«Vostra Eccellenza giudica obbrobriosa l’età nostra, né io le dirò che tutto vada per il meglio; ma è certo che il passato par molte volte bello solo perché è passato… L’importante è non lasciarsi sopraffare… Io mi rammento che nel Sessantuno, quando lo zio duca fu eletto la prima volta deputato, mio padre mi disse: “Vedi? Quando c’erano i Viceré, gli Uzeda erano Viceré; ora che abbiamo i deputati, lo zio siede in Parlamento.” Vostra Eccellenza sa che io non andai molto d’accordo con la felice memoria; ma egli disse allora una cosa che m’è parsa e mi pare molto giusta… Un tempo la potenza della nostra famiglia veniva dai Re; ora viene dal popolo… La differenza è più di nome che di fatto… Certo, dipendere dalla canaglia non è piacevole; ma neppure molti di quei sovrani erano stinchi di santo. E un uomo solo che tiene nelle proprie mani le redini del mondo e si considera investito d’un potere divino e d’ogni suo capriccio fa legge è più difficile da guadagnare e da serbar propizio che non il gregge umano, numeroso ma per natura servile… E poi, e poi il mutamento è più apparente che reale. Anche i Viceré d’un tempo dovevano propiziarsi la folla; se no, erano ambasciatori che andavano a reclamare a Madrid, che ne ottenevano dalla Corte il richiamo… o anche la testa!… Le avranno forse detto che un’elezione adesso costa quattrini; ma si rammenti quel che dice il Mugnòs del Viceré Lopez Ximenes, che dovette offrire trentamila scudi al Re Ferdinando per restare al proprio posto… e ci rimise i quattrini! In verità, aveva ragione Salomone quando diceva che non c’è niente di nuovo sotto il sole! Tutti si lagnano della corruzione presente e negano fiducia al sistema elettorale, perché i voti si comprano. Ma sa Vostra Eccellenza che cosa narra Svetonio, celebre scrittore dell’antichità? Narra che Augusto, nei giorni dei comizi, distribuiva mille sesterzi a testa alle tribù di cui faceva parte, perché non prendessero nulla dai candidati!…» Egli diceva queste cose anche per se stesso, per affermarsi nella giustezza delle proprie vedute; ma, poiché la vecchia non si muoveva, pensò che forse s’era assopita e che egli parlava al muro. S’alzò, quindi, per vedere: donna Ferdinanda aveva gli occhi spalancati. Egli continuò, passeggiando per la camera: «La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia di prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d’oggi pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale non è né un popolano, né un borghese, né un democratico: sono io, perché mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della nobiltà non è e non può essere spento. Ora che tutti parlano di democrazia, sa qual è il libro più cercato alla biblioteca dell’Università, dove io mi reco qualche volta per i miei studi? L’Araldo sicolo dello zio don Eugenio, felice memoria. Dal tanto maneggiarlo, ne hanno sciupato tre volte la legatura! E consideri un poco: prima, ad esser nobile, uno godeva grandi prerogative, privilegi, immunità, esenzioni di molta importanza. Adesso, se tutto ciò è finito, se la nobiltà è una cosa puramente ideale e nondimeno tutti la cercano, non vuol forse dire che il suo valore e il suo prestigio sono cresciuti?… In politica, Vostra Eccellenza ha serbato fede ai Borboni, e questo suo sentimento è certo rispettabilissimo, considerandoli come i sovrani legittimi… Ma la legittimità loro da che dipende? Dal fatto che sono stati sul trono per più di cento anni… Di qui a ottant’anni Vostra Eccellenza riconoscerebbe dunque come legittimi anche i Savoia… Certo, la monarchia assoluta tutelava meglio gl’interessi della nostra casta; ma una forza superiore, una corrente irresistibile l’ha travolta… Dobbiamo farci mettere il piede sul collo anche noi? il nostro dovere, invece di sprezzare le nuove leggi, mi pare quello di servircene!…»
Travolto dalla foga oratoria, nel tripudio del recente trionfo, col bisogno di giustificarsi agli occhi propri, di rimettersi nelle buone grazie della vecchia, egli improvvisava un altro discorso, il vero, la confutazione di quello tenuto dinanzi alla canaglia, e la vecchia stava ad ascoltarlo, senza più tossire, soggiogata all’eloquenza del nipote, divertita e quasi cullata da quella recitazione enfatica e teatrale.
«Si rammenta Vostra Eccellenza le letture del Mugnòs?…» continuava Consalvo. «Orbene, imaginiamo che quello storico sia ancora in vita e voglia mettere a giorno il suo Teatro genologico al capitolo: Della famiglia Uzeda. Che cosa direbbe? Direbbe press’a poco: “Don Gafpare Vzeda”,» egli pronunziò f la s e v la u, «”fu promosso ai maggiori carichi, in quel travolgimento del nostro Regno che passò dal Re don Francesco II di Borbone al Re don Vittorio Emanuele II di Savoia. Fu egli deputato al Nazional Parlamento di Torino, Fiorenza e Roma, et ultimamente dal Re don Umberto have stato sublimato con singolar dispaccio al carico di senatore. Don Consalvo de Uzeda, VIII prencipe di Francalanza, tenne poter di sindaco della sua città nativa, indi deputato al Parlamento di Roma et in prosieguo…”»
Tacque un poco, chiudendo gli occhi: si vedeva già al banco dei ministri, a Montecitorio; poi riprese: «Questo direbbe il Mugnòs redivivo; questo diranno con altre parole i futuri storici della nostra casa. Gli antichi Uzeda erano commendatori di San Giacomo, ora hanno la commenda della Corona d’Italia. E’ una cosa diversa, ma non per colpa loro! E Vostra Eccellenza li giudica degeneri! Scusi, perché?»
La vecchia non rispose.
«Fisicamente, sì; il nostro sangue è impoverito; eppure ciò non impedisce a molti dei nostri di arrivare sani e vegeti all’invidiabile età di Vostra Eccellenza!… Al morale, essi sono spesso cocciuti, stravaganti, bislacchi, talvolta…» voleva aggiungere «pazzi» ma passò oltre. «Non stanno in pace tra loro, si dilaniano continuamente. Ma Vostra Eccellenza pensi al passato! Si rammenti quel Blasco Uzeda, “cognominato nella lingua siciliana Sciarra, che nel tosco idioma Rissa diremmo”; si rammenti di quell’altro Artale Uzeda, cognominato Sconza, cioè Guasta!… Io e mio padre non siamo andati d’accordo, ed egli mi diseredò; ma il Viceré Ximenes imprigionò suo figlio, lo fece condannare a morte… Vostra Eccellenza vede che sotto qualche aspetto è bene che i tempi siano mutati!… E rammenti la fellonia dei figli di Artale ; rammenti tutte le liti tra parenti, pei beni confiscati, per le doti delle femmine… Con questo, non intendo giustificare ciò che accade ora. Noi siamo troppo volubili e troppo cocciuti ad un tempo. Guardiamo la zia Chiara, prima capace di morire piuttosto che di sposare il marchese, poi un’anima in due corpi con lui, poi in guerra ad oltranza. Guardiamo la zia Lucrezia che, viceversa, fece pazzie per sposare Giulente, poi lo disprezzò come un servo, e adesso è tutta una cosa con lui, fino al punto di far la guerra a me e di spingerlo al ridicolo del fiasco elettorale! Guardiamo, in un altro senso, la stessa Teresa. Per obbedienza filiale, per farsi dar della santa, sposò chi non amava, affrettò la pazzia ed il suicidio del povero Giovannino; e adesso va ad inginocchiarsi tutti i giorni nella cappella della Beata Ximena, dove arde la lampada accesa per la salute del povero cugino! E la Beata Ximena che cosa fu se non una divina cocciuta? Io stesso, il giorno che mi proposi di mutar vita, non vissi se non per prepararmi alla nuova. Ma la storia della nostra famiglia è piena di simili conversioni repentine, di simili ostinazioni nel bene e nel male… Io farei veramente divertire Vostra Eccellenza, scrivendole tutta la cronaca contemporanea con lo stile degli antichi autori: Vostra Eccellenza riconoscerebbe subito che il suo giudizio non è esatto. No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa.»
Pagina straordinaria, questa, di cui si ricorderà con altrettanta capacità, un altro grande siciliano, Tomasi di Lampedusa, quando scriverà Il gattopardo (1958). Il brano si presenta sin da subito come un gran pezzo di oratoria, in cui Consalvo illustra alla vecchia malata (quasi rappresentasse il vecchio mondo in dissoluzione) la nuova realtà parlamentare, sottolineando come essa, al di là della forma liberal democratica, sia “scatola vuota” in cui inserire i poteri che sempre lo hanno esercitato. La famiglia, la razza è sempre la stessa. E ciò che dice Consalvo alla vecchia zia è lo stesso che direbbe in un’orazione politica. Perché di una vera è propria orazione si tratta a cui assiste dapprima diffidente ma poi divertita la rappresentante più eminente della famiglia Uzeda.

Matilde Serao
La terza scrittrice meridionale è Matilde Serao (1856-1927), la cui figura di romanziera, a ragione associata al feuilleton (Le virtù di Cecchina, Fior di passione), non ci fa dimenticare che fu una tra le più influenti firme del giornalismo italiano del secondo Ottocento, e che fu la prima donna ad essere fondatrice e direttrice di un giornale, Il mattino di Napoli (1888), in cui riuscì a portare le prestigiose firme di Carducci e D’Annunzio.

Una delle prime copie de “Il Mattino”
Ed è proprio la “verve” giornalistica e di denuncia quella che caratterizza la prosa della Serao, come si può vedere nel romanzo Il ventre di Napoli, che riecheggia, nel titolo, l’opera di enorme successo del francese Eugene Sue Il ventre di Parigi.
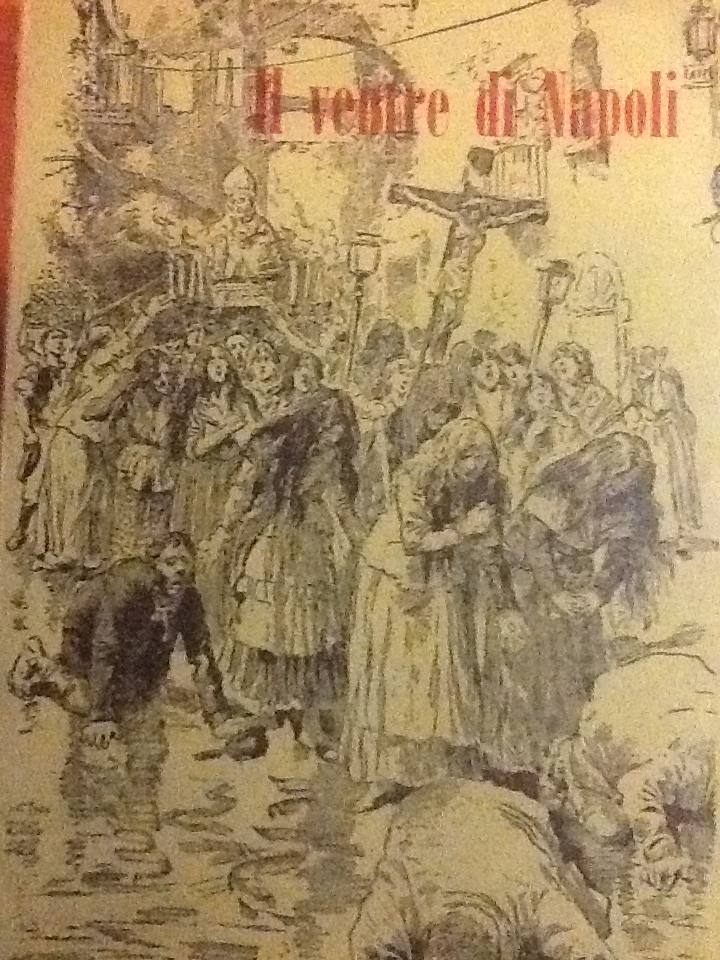
Una vecchia copia de “Il ventre di Napoli”
BISOGNA SVENTRARE NAPOLI
Efficace la frase, Voi non lo conoscevate, onorevole Depretis, il ventre di Napoli. Avevate torto, perché voi siete il Governo e il Governo deve saper tutto. Non sono fatte pel Governo, certamente, le descrizioncelle colorite di cronisti con intenzioni letterarie, che parlano della via Caracciolo, del mare glauco, del cielo di cobalto, delle signore incantevoli e dei vapori violetti del tramonto: tutta questa rettorichetta a base di golfo e di colline fiorite, di cui noi abbiamo già fatto e oggi continuiamo a fare ammenda onorevole, inginocchiati umilmente innanzi alla patria che soffre; tutta questa minuta e facile letteratura frammentaria, serve per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata per racconti di miserie. Ma il governo doveva sapere l’altra parte; il governo a cui arriva la statistica della mortalità e quella dei delitti; il governo a cui arrivano i rapporti dei prefetti, dei questori, degli ispettori di polizia, dei delegati; il governo a cui arrivano i rapporti dei direttori delle carceri; il governo che sa tutto: quanta carne si consuma in un giorno e quanto vino si beve in un anno, in un paese; quante femmine disgraziate, diciamo così, vi esistano, e quanti ammoniti siano i loro amanti di cuore, quanti mendichi non possano entrare nelle opere pie e quanti vagabondi dormano in istrada, la notte; quanti nullatenenti e quanti commercianti vi sieno; quanto renda il dazio consumo, quanto la fondiaria, per quanto s’impegni al Monte di Pietà e quanto renda il lotto. Quest’altra parte, questo ventre di Napoli, se non lo conosce il Governo, chi lo deve conoscere? E se non servono a dirvi tutto, a che sono buoni tutti questi impiegati alti e bassi, a che questo immenso ingranaggio burocratico che ci costa tanto? E, se voi non siete la intelligenza suprema del paese che tutto conosce e a tutto provvede, perché siete ministro?
* * *
Vi avranno fatto vedere una, due, tre strade dei quartieri bassi e ne avrete avuto orrore. Ma non avete visto tutto; i napoletani istessi che vi conducevano, non conoscono tutti i quartieri bassi. La via dei Mercanti, l’avete percorsa tutta? Sarà larga quattro metri, tanto che le carrozze non vi possono passare, ed è sinuosa, si torce come un budello: le case altissime la immergono, durante le più belle giornate, in una luce scialba e morta: nel mezzo della via il ruscello è nero, fetido, non si muove, impantanato, è fatto di liscivia e di saponata lurida, di acqua di maccheroni e di acqua di minestra, una miscela fetente che imputridisce. In questa strada dei Mercanti, che è una delle principali del quartiere Porto, v’è di tutto: botteghe oscure, dove si agitano delle ombre, a vendere di tutto, agenzie di pegni, banchi lotto; e ogni tanto un portoncino nero, ogni tanto un angiporto fangoso, ogni tanto un friggitore, da cui esce il fetore dell’olio cattivo, ogni tanto un salumaio, dalla cui bottega esce un puzzo di formaggio che fermenta e di lardo fradicio. Da questa via partono tante altre viottole, che portano i nomi delle arti: la Zabatteria, i Coltellai, gli Spadari, i Taffettanari, i Materassari, e via di seguito. Sono, queste viottole – questa è la sola differenza – molto più strette dei Mercanti, ma egualmente sporche e oscure; e ognuna puzza in modo diverso: di cuoio vecchio, di piombo fuso, di acido nitrico, di acido solforico. Varie strade conducono dall’alto al quartiere di Porto: sono ripidissime, strette, mal selciate. La via di Mezzocannone è popolata tutta di tintori: in fondo a ogni bottega bruna, arde un fuoco vivo sotto una grossa caldaia nera, dove gli uomini seminudi agitano una miscela fumante; sulla porta si asciugano dei cenci rossi e violetti; sulle selci disgiunte, cola sempre una feccia di tintura multicolore. Un’altra strada, le così dette Gradelle di Santa Barbara, ha anche la sua originalità: da una parte e dall’altra abitano femmine disgraziate, che ne hanno fatto un loro dominio, e, per ozio di infelici disoccupate, nel giorno, e per cupo odio contro l’uomo, buttano dalla finestra, su chi passa, buccie di fichi, di cocomero, spazzatura, torsoli di spighe. e tutto resta, su questi gradini, così che la gente pulita non osa passarvi più. Vi è un’altra strada, che dietro l’educandato di San Marcellino, conduce a Portanova, dove i Mercanti finiscono e cominciano i Lanzieri: veramente non è una strada, è un angiporto, una specie di canale nero, che passa sotto due archi e dove pare raccolta tutta la immondizia di un villaggio africano. Ivi, a un certo punto, non si può procedere oltre: il terreno è lubrico e lo stomaco spasima.
* * *
In sezione Vicaria, vi siete stato? Sopra tutte le strade che la traversano, una sola è pulita, la via del Duomo: tutte le altre sono rappresentazioni della vecchia Napoli, affogate, brune, con le case puntellate, che cadono per vecchiaia. Vi è un vicolo del Sole, detto così perché il sole non vi entra mai; vi è un vicolo del Settimo Cielo, appunto per l’altitudine di una strisciolina di cielo, che apparisce fra le altissime e antiche case. Attorno alla piazzetta dei SS. Apostoli vi sono tre o quattro stradette; Grotta della Marra, Santa Maria a Vertecœli, vicolo della Campana, dove vive una popolazione magra e pallida, appestata dalla fabbrica di tabacco che è lì, appestata dalla propria sudiceria; e tutti i dintorni di Castelcapuano, di questa grande e storica Vicaria, sembrano proprio il suo ambiente, vale a dire putridume materiale e morale, su cui sorge l’estremo portato di questa società povera e necessariamente corrotta: la galera. La sezione Mercato? Ah, già: quella storica, dove Masaniello ha fatto la rivoluzione, dove hanno tagliato il capo a Corradino di Svevia; sì, sì, ne hanno parlato drammaturghi e poeti. Se ne traversa un lembo, venendo in carrozza, dalla Ferrovia, ma si esce subito alla Marina. Al diavolo la poesia e il dramma! In sezione Mercato, niuna strada è pulita; pare che da anni non ci passi mai lo spazzino; ed è forse la sporcizia di un giorno. Ivi è il Lavinaio, la grande fonte, dove si lavano i cenci luridi della vecchia e povera Napoli: il Lavinaio, che è il grande ruscello, dove il luridume viene a detergersi superficialmente; tanto che per insultare bonariamente un napoletano, sul proprio napoletanesimo, gli si dice. – Sei proprio del Lavinaio. Nella sezione Mercato, vi sono i sette vicoli della Duchesca, in uno dei quali, ho letto un dispaccio, vi sono stati in un’ora trenta casi; vi è il vicolo del Cavalcatoio; vi è il vicolo di Sant’Arcangelo a Baiano. Io sono una donna e non posso dirvi che sieno queste strade, poichè ivi l’abbiezione diventa così profonda, così miseranda, la natura umana si degrada talmente, che vengono alla faccia le fiamme della vergogna.
* * *
Sventrare Napoli? Credete che basterà? Vi lusingate che basteranno tre, quattro strade, attraverso i quartieri popolari, per salvarli? Vedrete, vedrete, quando gli studi, per questa santa opera di redenzione, saranno compiuti, quale verità fulgidissima risulterà: bisogna rifare. Voi non potrete sicuramente lasciare in piedi le case che sono lesionate dalla umidità, dove al pianterreno vi è il fango e all’ultimo piano si brucia nell’estate e si gela nell’inverno; dove le scale sono ricettacoli d’immondizie; nei cui pozzi, da cui si attinge acqua così penosamente, vanno a cadere tutti i rifiuti umani e tutti gli animali morti; e che hanno tutto un pot-bouille, una cosidettavinella, una corticina interna in cui le serve buttano tutto; il cui sistema di latrine, quando ci sono, resiste a qualunque disinfezione. Voi non potrete lasciare in piedi le case, nelle cui piccole stanze sono agglomerate mai meno di quattro persone, dove vi sono galline e piccioni, gatti sfiancati e cani lebbrosi; case in cui si cucina in uno stambugio, si mangia nella stanza da letto e si muore nella medesima stanza, dove altri dormono e mangiano, case, i cui sottoscala, pure abitati da gente umana, rassomigliano agli antichi, ora aboliti, carceri criminali della Vicaria, sotto il livello del suolo. Voi non potrete sicuramente lasciare in piedi i cavalcavia che congiungono le case; nè quelle ignobili costruzioni di legno che si sospendono a certe muraglie di case, nè quei portoncini angusti, nè vicoli ciechi, nè quegli angiporti, nè quei supportici; voi non potrete lasciare in piedi i fondaci. Voi non potrete lasciare in piedi certe case dove al primo piano è un’agenzia di pegni, al secondo si affittano camere a studenti, al terzo si fabbricano i fuochi artificiali: certe altre dove al pianterreno vi è un bigliardo, al primo piano un albergo dove si pagano tre soldi per notte, al secondo una raccolta di poverette, al terzo un deposito di cenci. Per distruggere la corruzione materiale e quella morale, per rifare la salute e la coscienza a quella povera gente, per insegnare loro come si vive – essi sanno morire, come avete visto! – per dir loro che essi sono fratelli nostri, che noi li amiamo efficacemente, che vogliamo salvarli, non basta sventrare Napoli: bisogna quasi tutta rifarla.
Il ventre di Napoli è costituito da una serie di “reportage” che la scrittrice napoletano pubblicò in nove puntate sulla rivista Capitan Fracassa a partire dal 1884. L’aspetto che vi domina è quello dell’articolo di denuncia a seguito dell’infelice espressione di Depretis “Bisogna sventrare Napoli” in quel tempo preda di un’epidemia di colera determinata soprattutto dalla scarsità d’igiene nei quartieri popolari.
La denuncia non lesina, tuttavia, dalla descrizione “oggettiva” delle strade napoletane dove emergono figure di vecchie povertà, dove non entra il sole e dove femmine disgraziate, sfruttate dai tenutari delle case chiuse, imparano come sia duro e caro il prezzo da pagare per vivere.
Tutto questo viene reso attraverso uno stile in cui predomina il nome e l’aggettivo piuttosto che l’azione, come fosse un accumulo di roba che fermenta e suscita un odore insopportabile. E’ il cibo marcio a diventare il fulcro “ideologico” della Serao, il ventre di Napoli che lei scrive con piglio di denuncia. E che denuncia sia è scritto a chiare lettere sin dall’incipit: il governo ha il dovere di sapere e, sapendo, conoscendo, toccando con mano, porre dei rimedi per il miglioramento delle condizioni popolari.