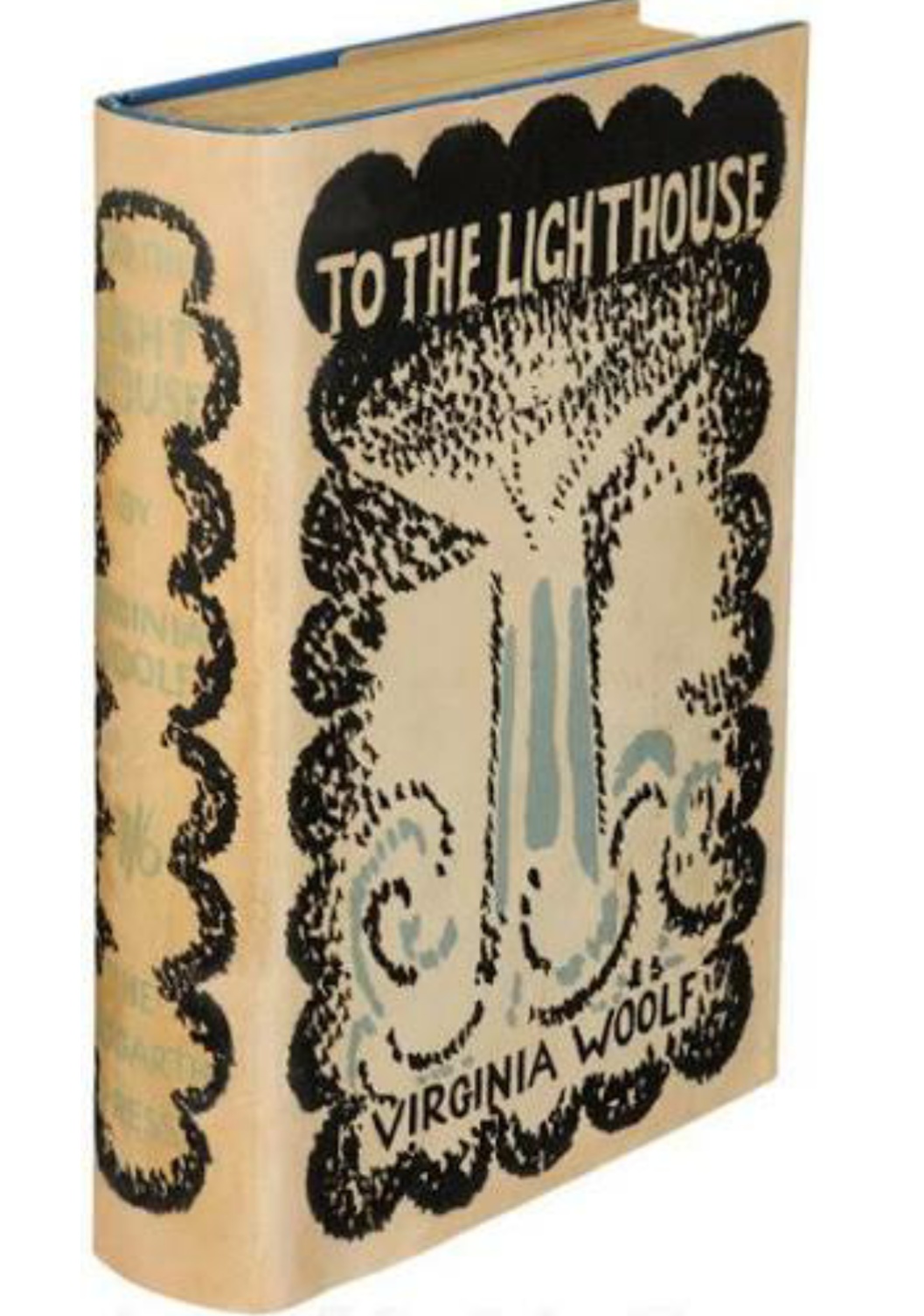Le opere narrative di Pirandello e di Svevo s’inseriscono a buon diritto all’interno di una grande stagione letteraria che “ridisegna” il “raccontare” tipico ottocentesco e dà vita a soluzioni nuove, diversificate, ma tutte tese a ritrarre la crisi dell’uomo novecentesco. Per meglio dire, se tutti gli scrittori europei che qui menzioneremo si faranno interpreti delle nuove istanze che la storia offre (seconda industrializzazione, società di massa, perdita delle coordinate scientifiche fino ad allora imperanti, nascita del relativismo e della psicoanalisi) ognuno di loro le guarderà con occhio diverso, da un’angolazione propria e personale.
Opere in lingua tedesca

Thomas Mann
Thomas Mann (1875 – 1955), insignito dal premio Nobel nel 1929, è uno dei più grandi interpreti del decadentismo; tale capacità deriva non soltanto dalla sua lunga attività, che va ben oltre la fine della seconda guerra mondiale, ma anche dal fatto che, fuggito dalla Germania hitleriana e rifugiatosi negli Stati Uniti, egli divenne il più attento critico verso ogni forma di violenza e di barbarie culturale. Egli lo fece mettendo al centro della sua produzione la decadenza della borghesia, del suo disfarsi e quindi arroccarsi su posizioni irrazionali e quindi aggressive o difensive (si pensi al nostro D’Annunzio o all’inglese Wilde). Questi temi saranno già presenti nella sua prima opera I Buddenbrook (1901) dove egli disegna la conflittualità presente tra i vecchi e i nuovi valori.
E’ la storia dell’ascesa e del declino di una famiglia della borghesia mercantile del sec. XIX, titolare a Lubecca di una ditta di cereali fondata nel 1768. Attorno ai primogeniti di quattro generazioni, Johann “senior”, Johann-Jean “junior”, Thomas ed Hanno, si annoda la complessa vicenda di una folla di personaggi rappresentativi di diverso strati sociali. il romanzo si apre con un pranzo del vecchio Johann per inaugurare la nuova sede, uno splendido palazzo già appartenuto ai Ratenkamp. Le fortune della famiglia aumentano, Johann “junior” diventa console dei Paesi Bassi, Thomas senatore. Lo stesso Thomas acquista una nuova sede ancora più prestigiosa. Ma i germi della decadenza, dapprima presenti come inespresso male oscuro, diventano via via più evidenti. Il fratello minore di Thomas, Christian, che rappresenta l’irregolare della famiglia, finisce i suoi tormentati giorni in un sanatorio. La sorella maggiore, Tony, passa senza fortuna da un matrimonio all’altro. L’ultimo erede, Hanno, muore di tifo e con lui i Buddenbrook si estinguono.
Come appare già nella trama il romanzo può essere diviso in due parti: nella prima che narra l’ascesa, vengono disegnati gli atteggiamenti vincenti, propositivi, ma tutti inseriti nel quadro di una limitatezza intellettuale, di un angustia dei principi, che non permette all’autore di aderire con simpatia verso i suoi personaggi. Nella seconda parte, quella dedicata alla decadenza, Thomas Mann disegna il groviglio delle nuove istanze (artistiche, edonistiche, irrazionali) che incarnano i nuovi Buddenbrook, che li rendono “estranei”, “diversi”, incapaci di reggere le sorti della famiglia.
Una delle pagine in cui meglio appare la parabola discendente è nella figura di Thomas Buddenbook, così come la leggiamo nel capitolo IV dell’ottavo libro:
LA CRISI DI THOMAS BUDDENBROOK
Rimasto solo, il senatore aveva ripreso il suo posto alla tavola, aveva tirato fuori il pince-nez e voluto proseguire nella lettura del suo giornale. Ma già dopo due minuti i suoi occhi s’erano sollevati dal foglio stampato, e senza mutare posizione egli era rimasto a fissare lungamente, dritto dinanzi a sé, tra le portiere, nel buio del salotto. Come si trasformava il suo viso, fino a divenire irriconoscibile, quando egli era solo! I muscoli della bocca e delle guance, altrimenti disciplinati e costretti all’obbedienza, al servizio di un’incessante sforzo di volontà, si allentavano, si afflosciavano; cadeva come una maschera da quel volto l’espressione vigile, avveduta, amabile ed energica che da lungo tempo era conservata solo artificiosamente, e lasciava il posto ai segni di una tormentosa stanchezza; gli occhi, rivolti con uno sguardo torbido e opaco su un oggetto senza vederlo, si arrossavano, cominciavano a lacrimare – e senza avere il coraggio per tentare d’ingannare ancora anche se stesso, egli, fra tutti i pensieri che pesanti, confusi e irrequieti gli riempivano la testa, riusciva a fermarne uno solo, disperato: che Thomas Buddenbrook a quarantadue anni era un uomo sfinito.
Lentamente, con un profondo sospiro, si passò la mano sulla fronte e sugli occhi, accese macchinalmente un’altra sigaretta, pur sapendo che gli faceva male, e attraverso il fumo continuò a guardare nel buio… Che contrasto fra il torpore dolente dei suoi lineamenti e la toilette elegante, quasi marziale, riserbata a quella testa – ai baffi profumati, lunghi e appuntiti, alla pelle perfettamente rasata del mento e delle guance, all’accurata pettinatura che nascondeva il più possibile l’incipiente calvizie alla sommità del capo e scopriva le tempie delicate in due rientranze piuttosto lunghe, con una scriminatura sottile, mentre sulle orecchie i capelli non erano più lunghi e arricciati come una volta, bensì tenuti cortissimi, affinché non si vedesse che là cominciavano a ingrigire… Egli stesso lo avvertiva, questo contrasto, e sapeva bene che fuori, in città, a nessuno poteva sfuggire la contraddizione fra la sua mobile, versatile attività, e lo spossato pallore della sua faccia.
Non che, là fuori, egli fosse minimamente divenuto una personalità non importante e indispensabile come in passato. Gli amici ripetevano, e gli avversari non potevano negare, che il borgomastro dottor Langhals aveva confermato a voce ancora più alta la dichiarazione del suo predecessore Oeverdieck: il senatore Buddenbrook era il braccio destro del borgomastro. Che però la ditta «Johann Buddenbrook» non fosse più quella di una volta, eh, questa sembrava una verità così nota a tutti che il signor Stuht della Glockengiesserstrasse poteva raccontarla a sua moglie, quando a mezzogiorno mangiavano insieme la zuppa di lardo… E Thomas Buddenbrook ne gemeva dentro.
Tuttavia era proprio lui che aveva soprattutto contribuito a far sorgere quell’opinione. Era ricco, e nessuna perdita subita, non esclusa quella pesante del ‘66, aveva potuto mettere seriamente in questione l’esistenza della ditta. Ma sebbene egli, ovviamente, continuasse a mettersi all’altezza dei doveri di rappresentanza e ad offrire dîners con il numero di portate che gli ospiti si aspettavano da lui, la convinzione che fortuna e successo per lui fossero finiti: convinzione che era più una verità interiore di quanto risultasse fondata sui fatti esterni, e che l’aveva gettato in uno stato di così sospettosa trepidazione da indurlo a cominciare come non mai a tener stretto il suo denaro e a risparmiare nella vita privata in modo quasi meschino.
Cento volte aveva maledetto la costosa costruzione della nuova casa che, egli sentiva, gli aveva portato soltanto disgrazie. I viaggi estivi furono aboliti, e il piccolo giardino di città dovette sostituire le villeggiature al mare o in montagna. I pasti che faceva con sua moglie e con il piccolo Hanno furono, per suo ripetuto e severo ordine, di una semplicità che risultava comica in contrasto con l’ampia sala da pranzo a parquet, con il suo alto e lussuoso soffitto e con gli splendidi mobili di quercia. Per parecchio tempo il dessert fu permesso solo alla domenica…
L’eleganza del suo abbigliamento rimase la stessa; ma Anton, il domestico da lunga data, sapeva e raccontava in cucina che adesso il senatore si cambiava solo ogni due giorni la camicia bianca, perché il bucato rovinava troppo la fine tela di lino… Sapeva anche dell’altro. Sapeva che sarebbe stato licenziato. Gerda protestò. Tre persone di servizio erano appena sufficienti per una casa così grande. Non servì a nulla: con una liquidazione adeguata, Anton, che per tanto tempo era stato seduto a cassetta quando Thomas Buddenbrook andava in senato, fu congedato.
A queste misure corrispondeva il ritmo sconsolato che avevano assunto gli affari. Non c’era più traccia dello spirito nuovo e vivace con cui un tempo il giovane Thomas Buddenbrook aveva animato l’azienda, – e il suo socio, il signor Friedrich Wilhelm Marcus, che, partecipando solo con un modesto capitale, non avrebbe mai avuto comunque influenza determinante, era per natura e temperamento privo di qualsiasi iniziativa. Col passare degli anni la sua pedanteria era aumentata ed era divenuta autentica stravaganza. Aveva bisogno di un quarto d’ora per spuntare il sigaro e riporne la punta nel borsellino, lisciandosi i baffi, raschiandosi la gola e lanciando circospette occhiate di sbieco. Di sera, quando le lampade a gas illuminavano a giorno ogni angolo dell’ufficio, egli non trascurava mai di mettere sulla sua scrivania anche una candela accesa. Ogni mezz’ora si alzava per andarsi a rinfrescare la testa sotto il rubinetto dell’acqua. Una mattina, per sbaglio, era rimasto sotto la sua scrivania un sacco di granaglie vuoto, che egli prese per un gatto e, con gran gaudio di tutto il personale, cercò di scacciare imprecando…
No, non era uomo che potesse intervenire energicamente nell’andamento degli affari a contrastare l’attuale spossatezza del suo socio; e spesso il senatore era afferrato, come ora mentre fissava lo sguardo spossato nella tenebra del salotto, dalla vergogna e da una disperata impazienza al pensiero del piccolo commercio senza importanza, degli affari da pochi soldi, cui si era abbassata negli ultimi tempi la ditta «Johann Buddenbrook».
Ma non era bene che fosse così? Anche la sfortuna, egli pensò, deve avere il suo tempo. Non è saggio restare tranquilli finché essa regna su di noi, non agitarsi, stare ad aspettare e, nella calma, raccogliere forze interiori? Perché dovevano venire da lui proprio allora con questa proposta, a disturbarlo prima del tempo nella sua savia rassegnazione ed a riempirlo di dubbi e di scrupoli! Era già arrivato il momento? Era un cenno del destino? Doveva sentirsi rianimato, tirarsi su e fare il colpo? Con tutta la risolutezza che era capace di conferire alla propria voce, egli aveva respinto quella richiesta spiacevole; ma da quando Tony era uscita, la cosa era davvero liquidata? Pareva di no, se egli restava ancora lì a rimuginare. «Una proposta agita e manda in collera solo quando non ci si sente ben sicuri di sapervi resistere…» Furba come il diavolo, la piccola Tony!
Che cosa le aveva obiettato? Per quanto si ricordava, aveva parlato molto bene, stringente. «Maneggio poco pulito… Pescare nel torbido… Brutale sfruttamento… Depredare uno che non può difendersi… Profitto da usuraio…,» magnifico! Bisognava però chiedersi se era il caso di mettere in campo parole così sonore. Il console Hermann Hagenström non le avrebbe cercate e non le avrebbe trovate. Thomas Buddenbrook era un uomo d’affari, un uomo d’azione spregiudicato – o un cogitabondo pieno di scrupoli? Oh sì, questo era il problema; questo era stato il suo problema di sempre, da quando riusciva a ricordare! La vita era dura, e la vita dell’uomo d’affari nel suo andamento privo di scrupoli e di concessioni ai sentimenti era una copia della vita intera. Thomas Buddenbrook stava solidamente piantato con tutt’e due i piedi, come i suoi padri, in questa vita dura e pratica? Abbastanza spesso, da sempre, aveva avuto ragione di dubitarne! Abbastanza spesso, fin dall’adolescenza, aveva dovuto correggere dinanzi a questa vita il suo modo di sentire… Usare durezza, subire durezza, e sentirla non come durezza, ma come qualcosa di ovvio – l’avrebbe mai veramente imparato?
Ricordò l’impressione che gli aveva fatto la catastrofe del ‘66, e richiamò alla mente le sensazioni indicibilmente dolorose che allora l’avevano sopraffatto. Aveva perso una grossa somma… oh, non era stata questa la cosa più insopportabile! Ma per la prima volta aveva dovuto sperimentare nella sua pienezza e sul proprio corpo la crudele brutalità della vita degli affari, in cui ogni sentire buono, dolce, amabile va a rimpiattarsi dinanzi ad un rozzo, nudo e imperioso istinto di conservazione, e in cui una sfortuna patita suscita negli amici, nei migliori amici, non partecipazione, non simpatia, ma – «diffidenza», fredda, scostante diffidenza. Ma lui non lo sapeva? Aveva il diritto di stupirne? Più tardi, nelle ore migliori e più ricche di forze, quanto si era vergognato d’essersi indignato in quelle notti insonni, d’essersi rivoltato, pieno di schifo e inguaribilmente ferito, contro la durezza odiosa e vergognosa della vita!
Come era stato stupido! Come erano stati ridicoli quegli impulsi ogni volta che li aveva provati! Come era possibile che sorgessero in lui? Di nuovo lo stesso problema: era una persona pratica o un delicato sognatore?
Oh, mille volte s’era posto questa domanda; e nelle ore di forza e di fiducia vi aveva risposto in un modo, in quelle di stanchezza in un altro. Ma egli era troppo perspicace e onesto per non confessarsi alla fine la verità: che i due aspetti si mescolavano in lui.
Per tutta la vita s’era mostrato alla gente come un uomo d’azione; ma, nella misura in cui lo si poteva ritenere giustamente tale, egli non lo era forse stato per ben consapevole riflessione – secondo il motto (e il verdetto) goethiano che citava spesso -? A suo tempo aveva riportato successi… ma non erano forse stati provocati soltanto dall’entusiasmo, dallo slancio che egli doveva alla riflessione? E ora che era abbattuto, che le sue forze sembravano esaurite – seppure, volesse Dio!, non per sempre -: non era questo la conseguenza necessaria di una situazione insostenibile, di quel contrasto innaturale e logorante dentro di lui?… Suo padre, suo nonno, il suo bisnonno, avrebbero comperato in erba il raccolto di Pöppenrade? Ma che importava!… che importava!… Erano stati uomini pratici, lo erano stati in modo più completo, più assoluto, più forte, più spregiudicato, più naturale di quanto egli lo fosse: questo era il fatto!…
Una grande inquietudine lo prese, un bisogno di moto, di spazio e di luce. Spinse indietro la sedia, andò nel salotto e accese parecchie fiamme a gas del lampadario sulla tavola centrale. Rimase lì, fermo, torcendosi a lungo e spasmodicamente la punta dei lunghi baffi, e senza veder nulla si guardò intorno nella stanza lussuosa.
Traduzione di Furio Jesi e Silvana Speciale Scalia
 Un’immagine della riduzione filmica dei Buddenbrook del 2008
Un’immagine della riduzione filmica dei Buddenbrook del 2008
Il personaggio di Thomas Buddenbrook sembra quasi saper incarnare quella figura tipica tra Ottocento e Novecento che è l’industriale, colui che “produce” e rende ricchi una nazione e se stesso, fiducioso nel domani e nelle possibilità di un futuro meraviglioso. Eppure è lo stesso Thomas a farci capire che non è proprio così, riflettendo tra economicità e morale egli si rende conto non solo della loro inconciliabilità ma della sua estraneità in quanto non essendo più l’uomo pragmatico come suo nonno e suo padre, egli non sa più chi essere; nonostante la sua enorme ricchezza, comincia a percepire la sua labilità, quasi presagisse il disastro cui andava incontro, su cui aleggia un inconscia vocazione verso la morte.
Il tema della “diversità” sarà presente anche in due brevi romanzi: Tonio Kröger (1903) e La morte a Venezia (1912).
Nel primo la coscienza della sua “diversità”, e quindi della sua “estraneità” porta il protagonista a voler recuperare i valori “normalizzanti” borghesi; ma non ci riesce:
Tonio Kröger, ritratto dell’artista da giovane, è uno scrittore di successo, impegnato a realizzare una dimensione della letteratura in perenne contrasto con la morale borghese. Durante l’infanzia e l’adolescenza, trascorse a Lubecca, e gli anni della giovinezza, trascorsi a Monaco e in viaggi frequenti, egli confida le sue contraddizioni all’amico Hans Hansen, alla giovane Ingeborg Holm, di cui s’innamora, ma che andrà sposa ad Hans, e alla pittrice russa Lisaveta Ivanovna.
TONIO KRÖGER O DELL’ESTRAINEITA’
Alcune coppie giravano in cerchio dondolandosi, altre tenendosi il braccio se n’andavano in giro per la sala. Le persone non erano vestite appositamente per il ballo, ma come per una qualsiasi domenica d’estate da trascorrere all’aperto. I cavalieri indossavano abiti dal taglio un po’ provinciale, che, si vedeva, erano stati preparati con cura per tutta la settimana, le ragazze vestivano invece abiti chiari e leggeri e guarnivano il corsetto con mazzetti di fiori di campo. Cerano anche un paio di bambini che ballavano fra loro, per così dire, anche quando la musica era finita. Un uomo dalle gambe lunghe e la giacchetta a coda di rondine, un tipo provinciale con il monocolo ed i capelli arricciati, aggiunto postale o qualcosa del genere, somigliante a una qualche comica figura di un personaggio di un romanzo danese, s’atteggiava a soprintendente della festa e direttore del ballo. Premuroso, sudato, votato con tutta l’anima alla buona riuscita della festa, era presente quasi ovunque nel medesimo istante; indaffaratissimo si occupava della sala: si trovava ovunque in qualsiasi momento, muoveva con maestria le punte dei piedi infilate in stivaletti ristretti e lisci a punta, incrociandoli l’un l’altro in maniera ingarbugliata, agitava le braccia in aria,… impartiva ordini, reclamava la musica, batteva le mani, e mentre faceva tutto questo i nastri della sua grande variopinta coccarda, i segni distintivi della carica che teneva ben ancorati alle spalle e verso i quali ogni tanto volgeva compiacente il capo, svolazzavano festosi dietro di lui di qua e di là.
E c’erano anche loro, i due che erano passati dinanzi a Tonio nello sfondo della luce del primo mattino. Li rivide, e nello scorgerli quasi contemporaneamente provò un brivido di gioia. Vicino a lui, poggiato alla porta, c’era Hans Hansen a gambe divaricate ed un poco piegato in avanti: intento a mangiare una gran fetta di torta teneva la mano raccolta sotto il mento per trattenere le briciole. Laggiù, poggiata alla parete, stava Ingeborg Holm, la bionda Inge, e nei suoi pressi s’indaffarava l’aggiunto postale per invitarla con un inchino prezioso a ballare, e in questa cerimonia poneva una mano dietro la schiena mentre l’altra la portava graziosamente al petto. Lei fece un cenno di diniego col capo mostrando di essere esausta e di volersi riposare un poco; e l’aggiunto postale allora le si sedette a fianco.
Tonio Kröger si soffermò a guardare i due per i quali un tempo aveva provato i tormenti d’amore. . . Hans ed Ingeborg. Erano proprio loro, e non tanto in virtù di caratteristiche o di una simiglianza del vestire che ancora riscontrava, quanto piuttosto in forza d’una certa identità di razza e specie, quella specie chiara dagli occhi azzurro-acciaio e dai capelli biondi che presentava per lui un’idea di purezza, serenità e di ritrosia intangibile ad un tempo semplice e fiera di sè. Egli li guardò. Guardò Hans Hansen pieno di sé e completamente formato, con le spalle larghe e i fianchi snelli, e addosso il solito vestito alla marinara; vide Ingeborg portare sorridendo in maniera spavalda la testa a lato, notò la sua mano, una mano ancora da ragazzina non particolarmente affusolata e non particolarmente graziosa andare carezzevole alla nuca, così che il velo bianco della manica scivolò lungo il gomito,. . . e d’improvviso la nostalgia d’emozioni perdute lo scosse così violentemente nel petto, che pur nell’oscurità indietreggiò perché nessuno potesse accorgersi delle contrazioni sul suo volto.
Vi avevo dimenticati? si chiese. No, mai! Né te Hans, né tantomeno te bionda Inge! Inge! Ed eravate proprio voi coloro per i quali nell’ombra io lavoravo, e quando talvolta veniva a me un applauso io cominciavo furtivo a guardarmi attorno per vedere se voi foste presenti. . . Lo hai letto poi il Don Carlos, Hans Hansen, come mi avevi promesso sulla soglia del tuo cancello di casa? Non farlo, non lo esigo più da te! Che può importare a te del re che piange perché è solo? Non velare i tuoi occhi chiari col turbamento e con l’ansia di vitrei versi velati di malinconia. Poter essere come te! Ricominciare tutto da capo e crescere come te, leale, allegro, semplice,. . . normale, in completa armonia con Dio ed il mondo, poter essere amato dai puri e dai felici, e prendere in moglie te, Ingeborg Holm, ed avere un figlio come te Hans Hansen,. . . e libero dalla maledizione della conoscenza, della sofferenza del creare, poter amare, vivere, lodare, esaltarsi in una beata mediocrità!. . . Ricominciare da capo? Sarebbe completamente inutile. Avverrebbe tutto ancora una volta, com’è avvenuto e come doveva andare: alcuni sono predestinati a perdersi perché per essi una via diritta non è stata tracciata.
Ora la musica taceva, c’era un poco di pausa e fu offerto un rinfresco. L’aggiunto postale s’indaffarava in giro con un vassoio colmo d’insalata d’aringhe e s’occupava personalmente delle signore. Ma come giunse dinanzi ad Ingeborg Holm s’inginocchiò persino nel porgerle la coppetta, e lei ne arrossì di gioia.
Dalla sala s’iniziava a volgere attenzione alla persona che se ne stava presso la porta a vetri ed alcuni visi graziosi, accaldati, estranei ma incuriositi, posarono fugacemente lo sguardo su di lui, ma nonostante questo spettatore se ne restò al suo posto. Anche Ingeborg ed Hans gli posarono per un istante lo sguardo sopra, in modo così indifferente e trascurato che sembrava avere l’apparenza del disprezzo. All’improvviso però egli si rese conto che da qualche parte c’era uno sguardo che lo scrutava in modo del tutto particolare, volse il capo ed i suoi occhi s’incrociarono con quelli di cui aveva avvertito il contatto. Non molto lontano c’era una ragazza dal viso pallido, magro e gentile di cui già s’era accorto. Non aveva ballato ed i cavalieri attorno a lei non s’erano particolarmente affannati, e l’aveva notata esser rimasta a lungo oziosa presso la parete con le labbra amaramente contratte. Ed anche ora era sola. Come le altre indossava un abito chiaro e vaporoso, ma sotto la stoffa diafana del suo vestito s’intravedevano le spalle nude gracili e ossute, e il collo magro affondava così tanto in quelle povere spalle che nell’insieme la silente fanciulla dava anche un poco l’idea della deformità. Teneva le mani ricoperte da sottili mezziguanti sul seno piatto, e le dita si sfioravano. Guardava Tonio Kröger dal basso verso l’alto con i suoi occhi cupi e offuscati, tenendo il capo reclinato. E questi si voltò. . .
Qui, assai vicino, sedevano Hans ed Inge Ingeborg. Lui le era accanto con modi fra l’affettuoso ed il protettivo, e assieme ad altri giovani dalle guance accaldate mangiavano, bevevano, chiacchieravano, si divertivano, si canzonavano, con voci allegre e sempre ridenti. Non poteva almeno un poco avvicinarsi a loro, rivolgere a lui o a lei la prima parola scherzosa che gli fosse venuta in mente ed a cui avrebbero certo risposto con un sorriso? Questo l’avrebbe reso felice, e in fondo lo desiderava; poi, con la consapevolezza di aver ristabilito con i due un tenue legame, si sarebbe potuto ritirare contento in camera sua. Pensò anche alle parole da dire, ma il coraggio di pronunciarle gli mancò.
Ed anche ora era tutto come sempre: loro non avrebbero potuto comprenderlo, le sue parole sarebbe risuonate estranee, la sua lingua non era la loro. Sembrava che il ballo dovesse di nuovo riprendere. L’aggiunto era indaffaratissimo. Si muoveva incessantemente da destra a sinistra, invitava tutti ad impegnarsi, toglieva di mezzo con l’aiuto dei camerieri sedie e bicchieri, impartiva ordini ai musicisti, allontanava spingendoli via per le spalle quelli impacciati che non sapevano dove mettersi. Che s’intendeva fare? Ogni quattro coppie si formava un quadrato. . . Un ricordo terribile fece arrossire Tonio Kröger: si sarebbe ballata la quadriglia. La musica attaccò, e fra inchini le coppie cominciarono a incrociarsi. L’aggiunto comandava e, gran Dio!, per di più comandava in francese con suoni nasali in modo incomparabilmente distinto. Ingeborg Holm ballava dinanzi a Tonio Kröger, nel quadrato immediatamente vicino alla porta a vetri. Lei volteggiava dinanzi a lui su e giù, avanti e dietro, ed ogni tanto lo sfiorava il profumo dei suoi capelli o della bianca e delicata stoffa dell’abito, ed egli chiudeva gli occhi e provava un’antica sensazione che ben conosceva, il cui aroma, il cui aspro fascino egli aveva vagamente avvertito in tutti quei giorni, e che ora in un dolce tormento lo sovrastava ancora. Ma cos’era dunque alla fine? Nostalgia? Tenerezza? Invidia? Disprezzo di se stesso?. . . Moulinet des dames! Ridesti tu bionda Inge, ridesti tu di me quando io ballai moulinet rendendomi così miserevolmente ridicolo? E rideresti di me anche oggi; adesso che sono diventato un po’ celebre? Sì, certo che rideresti, ed avresti un’infinità di ragioni per farlo! Perché se anche io, proprio io e tutto da solo, avessi composto le nove sinfonie, concepito Il mondo come volontà e rappresentazione, raffigurato il Giudizio universale, tu avresti ancora buone ragioni per ridere. . . La guardò e si sovvenne di un verso che da tempo aveva dimenticato e che gli era stato tanto familiare ed affine: “Dormir vorrei, ma tu vuoi danzare. . .” La conosceva bene quella sensazione d’indolenza malinconica nordica, mesta, intima, impacciata che gli sussurrava da dentro. Dormire. . . Anelare d’amare, semplicemente e pienamente, in tutto e per tutto seguendo il sentimento che pigramente sognante se ne sta racchiuso in se stesso senza avvertire la necessità di trasformarsi in azione e in danza,. . . e nondimeno esser costretti a danzare, dover eseguire sempre lesti, sempre pronti in spirito, la difficile e pericolosa danza sulla lama dell’arte, senza mai riuscire a dimenticare, a scacciare l’umiliante assurdità che c’è nel pretendere di ballare mentre si ama. . .
(…)
 Vilhelm Hammershøi: Interno con uomo che legge (1896)
Vilhelm Hammershøi: Interno con uomo che legge (1896)
Si sentiva come ubriacato da quella festa che si era limitato ad osservare da lontano, e stanco per la gelosia sofferta. Ed ancora una volta era successo tutto come un tempo, tutto come un tempo. . . Con il volto accalorato se n’era restato in un angolo buio soffrendo per voi, per voi biondi, per voi felici, per voi fortunati, e poi, da solo, si era ritirato. Ma qualcuno doveva venire! Ingefort doveva pur venire, accorgersi che era là fuori, seguirlo furtivamente, posargli una mano sulla spalla, dirgli: Vieni dentro da noi! Sii felice! Io ti amo! Ma essa non venne. Cose simili non accadono.
Siamo nelle ultime pagine del romanzo breve con l’eroe eponimo: Kröger è diventato un grande scrittore, un intellettuale. Dopo tanti anni, ad una festa da ballo incontra i suoi vecchi amici; Hans ed Ingeborg. I partecipanti sembrano essere tutti descritti come dei piccoli borghesi che si lasciano trasportare dagli eventi divertenti e sani del clima festoso, ad esserne distaccato è proprio lui, che rivive la stessa sensazione di estraneità che aveva caratterizzato la sua vita da adolescente. Tonio non è mai riuscito ad integrarsi, l’avrebbe voluto con tutta la sua forza, ma altrettanto forte è il richiamo della mente del pensiero, che lo allontana dal flusso vitale.
Il ballo è il simbolo della sana naturalezza, della vitalità, del sentirsi in accordo con Dio e il mondo, la cultura è estraneità. Thomas Mann svela il contrasto tra arte e vita, malattia dell’artista e sanità della normalità: all’artista non resta che creare ciò che la vita gli offre.
Ancora un contrasto nel secondo breve famoso romanzo di Thomas Mann, La morte a Venezia (1912), dove il musicista von Aschenbach non può fare a meno di sentirsi attratto dall’efebico Tazio, simbolo dell’irrazionale e del torbido fascino che travolge il borghese decoro del musicista.
Gustav von Aschenbach, scrittore celebre, teso a una costante ricerca estetica, spossato dal lavoro, fa un viaggio a Venezia, dove spera di rigenerarsi come uomo e come scrittore. Nel lussuoso albergo dove ha preso alloggio è colpito dalla bellezza di un ragazzo polacco, Tadzio, per il quale prova un’immediata, irresistibile attrazione. Senza che i due si scambino mai una parola, si crea tra loro una sorta di ambigua intimità: Aschenbach vive la sua passione estenuandosi in una lunga e voluttuosa ricerca del giovane per le calli di Venezia. Mentre corre voce che si siano verificati casi di colera in città, Aschenbach insegue il suo sogno, riducendosi a fingere una equivoca giovinezza fatta di tinture e cosmetici. Cerca invano di fuggire da Venezia e, mentre contempla ancora una volta sulla spiaggia Tadzio, il colera, nel frattempo esploso, lo uccide.
LA CONFUSIONE DI GUSTAV
Così dunque lo sviato innamorato non sapeva né voleva più altro che perseguire senza requie l’oggetto che lo infiammava, di lui sognare quand’era assente, e, alla maniera degli innamorati, rivolgere tenere parole alla sua mera ombra. Solitudine, estraneità e la felicità di un’ebbrezza tardiva e profonda lo incoraggiavano e persuadevano ad abbandonarsi senza vergogna e rossori alle situazioni più strane, com’era accaduto una sera che, rientrando sul tardi da Venezia, al primo piano dell’albergo si era arrestato all’uscio del bellissimo, in piena estasi aveva appoggiato la fronte allo stipite della porta e a lungo non era stato capace di staccarsene, a rischio di venir sorpreso, colto sul fatto in un atteggiamento così folle.
Eppure non gli mancavano i momenti di tregua e di semilucidità. «Su che strada mi sono messo!» pensava allora costernato. «Su che strada!» Come ogni uomo cui meriti naturali ispirino un aristocratico interesse per il proprio lignaggio! egli era abituato, nelle fatiche e nei successi dell’esistenza, a rivolgere il pensiero agli antenati, onde assicurarsi in spirito la loro approvazione, la loro soddisfazione, il loro indispensabile rispetto. A essi pensava anche qui, ora, irretito in un’esperienza così inammissibile, coinvolto in così esotiche dissolutezze di sentimento, ne rammentava la dignitosa severità, l’onesta virilità dei costumi, e sorrideva malinconicamente. Che cosa avrebbero detto? E d’altra parte, che cosa avrebbero detto della sua vita tutt’intera, che si era scostata da loro fino alla degenerazione, di questa vita in balìa dall’arte, di cui egli stesso un tempo, nello spirito borghese dei padri, aveva dato giovanili giudizi così sarcastici e che tuttavia in fondo era stato così simile a loro!
(…)
In questa direzione dunque procedevano i pensieri del sedotto, così egli cercava di puntellarsi, di salvare la propria dignità. In pari tempo, però, egli prestava un’attenzione indagatrice e pertinace ai sordidi avvenimenti di cui era teatro Venezia, a quell’avventura del mondo esterno che oscuramente confluiva con quella del suo cuore e alimentava la sua passione di vaghe e illegittime speranze. Incaponito a conoscere fatti nuovi e certi sullo stato e il progresso dell’epidemia, sfogliava nei caffè della città i giornali tedeschi, spariti già da parecchi giorni erano dal tavolo di lettura nell’atrio dell’albergo. Vi si alternavano affermazioni e smentite. Il numero dei casi di malattia e di decesso ascendeva a venti, a quaranta, forse a cento e più, e, poche righe più sotto, la stessa apparizione del morbo era, se non recisamente negata, per lo meno ridotta a pochi casi isolati, di provenienza esterna.
 Gustav e Tadzio nel film di Luchino Visconti (1971)
Gustav e Tadzio nel film di Luchino Visconti (1971)
Vi è qui, come anche nell’altro breve romanzo, la riflessione di come l’arte possa destabilizzare la vita; in questo brano tale potere è segnalato dal dialogo fittizio con gli antenati, ovvero con quella classe borghese già così efficacemente descritta ne I Buddenbrook, alla quale l’autore confessa la sua eccentricità, qui illustrata dall’insana passione verso Tadzio. Thomas amplifica la “malattia morale” in una decadente Venezia, malata essa stessa, in piena epidemia di colera. Ma se l’estetismo irrazionale di von Aschenbach simboleggia l’arte e Tadzio la purezza irragiungibile, la Venezia non può che rappresentare l’Europa malata, che sente già rullare i tamburi di una guerra imminente.
Lo scontro tra l’istanza malata, diversa e recupero della ragione avviene anche nell’altro grande romanzo di Mann La montagna incantata, in cui, come un maitre à penser l’autore vuole condurre il lettore ad abbandonare quelle spinte irrazionalistiche che avevano portato alla strage della prima guerra mondiale (siamo nel ’24):
Hans Castorp, un giovane borghese, recatosi a trovare il cugino Gioacchino malato di tisi nel sanatorio di Davos, finisce, ammalandosi a sua volta, col restarvi sette anni, affascinato da quel piccolo mondo che è in sé un universo simbolico ma completo. Si innamora di un’ospite del sanatorio, Madame Chauchat, e passa lunghe ore conversando con due intellettuali: l’italiano Settembrini erede della tradizione illuminista, e il gesuita Naphta, più tardi suscita, esponente del mondo romantico e decadente. Un altro singolare personaggio, l’olandese Pepperkon, rappresenta l’istinto irrazionale, il predominio dei sensi e della natura. Lo scoppio della guerra del 1914 strappa Castorp da questa atmosfera stregata e lo conduce sui campi di battaglia, dove si troverà coinvolto nella carneficina: la sua sorte resta incerta, anche se immersa in un clima di morte.
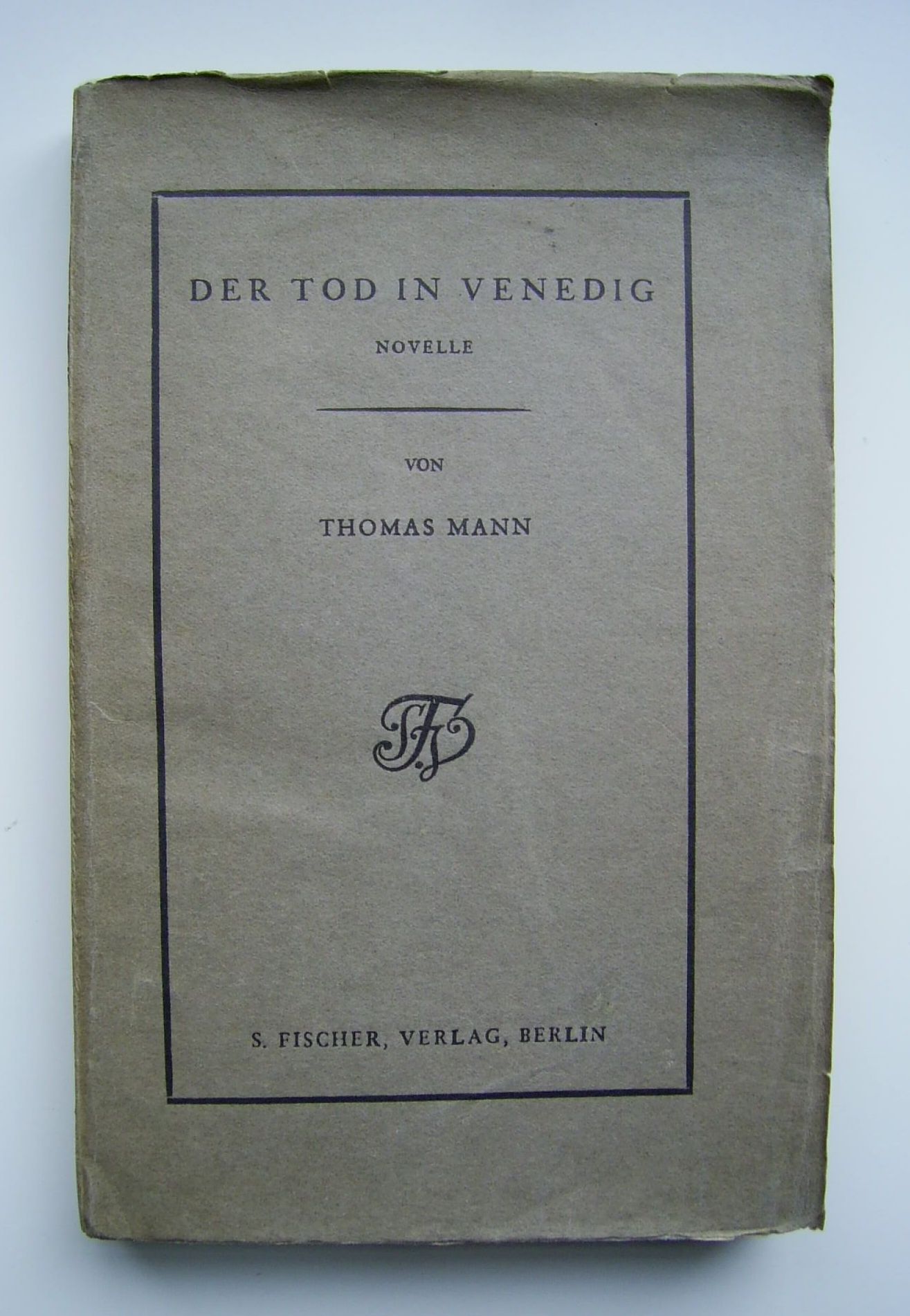 Edizione originale del 1913
Edizione originale del 1913
CONSERVAZIONE BORGHESE E IDEALITA’ DEMOCRATICHE
Coi due cugini, Ludovico Settembrini parlava anche di sé, e della sua provenienza, sia durante le passeggiate, sia durante la conversazione serale, oppure dopo il pranzo, quando la maggior parte dei pazienti avevano lasciato la sala ed egli rimaneva ancora un poco seduto vicino a Castorp e Ziemssen, alla loro tavola. Intanto le cameriere sparecchiavano, e Castorp fumava il suo “Maria Mancini” che alla terza settimana pareva voler fargli gustare ancora qualche poco dei suoi aromi reconditi. con attenzione critica, alquanto scandalizzato, ma propenso a lasciarsi influenzare, egli ascoltava le narrazioni dell’italiano, che gli aprivano un mondo strano, completamente nuovo a lui.
Settembrini parlava di suo nonno, un avvocato che aveva risieduto a Milano, grande patriota, agitatore politico, oratore, collaboratore di parecchi giornali, anche lui uomo dell’opposizione come il nipote, certo in più grande stile e più ardito assai. Poiché mentre Ludovico, come egli stesso osservava con accento di amarezza, doveva limitarsi a sforbiciare nella vita e negli avvenimenti del Sanatorio Internazionale Berghof, esercitandovi la sua critica beffarda e protestando contro di esso in nome di una umanità bella e giocondamente operosa, quegli invece aveva dato da fare ai governi, aveva cospirato contro l’Austria e la Santa Alleanza che allora teneva la sua patria sotto il giogo della schiavitù, ed era stato membro attivo di certe società segrete. “Un Carbonaro”, come Settembrini pronunciò d’un tratto a bassa voce, quasi fosse ancora pericoloso parlarne. A farla breve, questo Luigi Settembrini apparve agli occhi dei due ascoltatori, a dedurne dai racconti del nipote, come un’esistenza misteriosa e passionale di demagogo, come un caporione cospiratore; e quantunque i due giovanotti si sforzassero di concepire il rispetto, non riusciva loro di cancellare dal viso un’espressione di antipatia diffidente. Certo le cose stavano in modo speciale: quello che giungeva alle loro orecchie era passato da molto tempo, quasi da cento anni, era la storia, e dalla storia l’uomo che venivano a conoscere riceveva un aspetto, diremo così, teorico di disperato amore per la libertà e di odio contro i tiranni, quantunque i due cugini non avessero mai pensato di venir con lui ad un contatto così umanamente diretto. Non solo, ma all’attività di cospiratore e di agitatore di questo avo, andava congiunto, come i due apprendevano da ciò che narrava Settembrini, un grande amore per la sua patria, che egli voleva libera e unita. Anzi, la sua attività sovversiva era appunto frutto di tale rispettabile unione e per quanto questo insieme di sovversivismo e di patriottismo apparisse strano ai due cugini abituati a considerare invece l’amor patrio allo stesso livello dell’amore per l’ordine, tuttavia essi dovevano ammettere nel loro intimo che, come s’erano svolte le cose in quei tempi e in quei luoghi , la ribellione e la virtù cittadina dovevano essere un tutt’uno, come un tutt’uno erano la obbedienza legale e la pigra indifferenza verso la cosa pubblica. Il nonno di Settembrini non era stato soltanto un grande patriota italiano, sibbene anche un compagno di fede e di battaglia di tutti i popoli anelanti la libertà, poiché dopo il naufragio di un certo colpo di Stato tentato a Torino, sfuggito per miracolo agli sgherri di Metternich, aveva utilizzato il tempo del suo esilio combattendo in Spagna a pro della Costituzione, in Grecia per l’indipendenza di quel popolo. Là, era venuto alo mondo il padre di Settembrini – anche perciò quest’ultimo era diventato un grande umanista e un amante appassionato dell’antichità classica – nato, d’altronde, da madre di sangue tedesco, poiché Luigi aveva sposato una ragazza svizzera conducendola poi sempre con sé nella sua vita avventurosa. Più tardi, dopo dieci anni di esilio, aveva potuto tornare in patria, ed esercitato l’avvocatura a Milano non tralasciando però mai di incitare la Nazione con la parola parlata e scritta, in versi e prosa, alla libertà e alla costituzione della Repubblica unitaria, non cessando di compilare programmi sovversivi con appassionata enfasi di agitatore e dal proclamare l’unione dei popoli liberati per l’instaurazione di una comune felicità.
Un particolare che Settembrini citò, fece specialmente impressione sul giovane Castorp. Il nonno Luigi s’era sempre mostrato fra i suoi concittadini in abito nero, poiché egli asseriva di dimostrare in quel modo il lutto per la miseria e la schiavitù in cui era tenuta l’Italia, la patria sua. Udendo tale particolare, Castorp fu costretto, come d’altronde aveva fatto più volte, a pensare al suo proprio nonno; questi pure aveva sempre portato, per quanto il nipote potesse ricordarsene, vestiti neri, ma per motivi molto diversi da quelli del nonno di Settembrini. Hans Lorenz Castorp, essere appartenente ad un’altra epoca, s’era adattato per ripiego al suo tempo cui non apparteneva affatto, e ne aveva portato il costume, finché in morte era rientrato solennemente (col collare a pieghe) nel suo vero e giusto aspetto. Due nonni ben diversi erano stati quelli! Hans Castorp ci pensava mentre i suoi occhi fissavano un punto nel vuoto ed egli andava scuotendo il capo, cosa che poteva essere un segno d’ammirazione per Luigi Settembrini, o anche un’espressione di diniego e di disapprovazione. Si guardava anche onestamente dal giudicare ciò che non poteva in coscienza conoscere, si accontentava invece di constatare e di paragonare. Vedeva la testa sottile del vecchio Hans Lorenz chinarsi pensosa sull’orlo stinto della tazza battesimale – immobile e peregrinante eredità – a bocca stretta poiché le sue labbra pronunciavano sillabe cupe e pie che ricordavano il luogo dove si procede camminando chini in avanti in segno di profondo rispetto. E vedeva Luigi Settembrini che, reggendo il tricolore, sguainava la spada e, con lo sguardo dei neri occhi rivolto al cielo per un sacro giuramento, marciava in capo a una schiera di volontari per irrompere contro la falange del dispotismo. Ambedue avevano la loro bellezza e la loro nobiltà, pensava, sforzandosi di essere equo, tanto più che si sentiva personalmente o quasi in causa. Poiché il nonno di Settembrini aveva combattuto per diritti politici, mentre alò suo proprio nonno o agli avi di lui erano appartenuti in origine tutti i diritti che la plebaglia nel corso di quattro secoli aveva loro strappato con la violenza e con la retorica… Ed ambedue erano sempre vestiti di nero, il nonno del nord e quello del sud, e ambedue allo scopo di porre una severa distanza fra sé e l’epoca in cui vivevano. L’uno l’aveva fatto per un senso di religiosità, per il rispetto al passato e alla orte cui il suo essere apparteneva; l’altro, al contrario, per ribellione e in omaggio al progresso nemico della pietà. Sì, essi rappresentavano due mondi, due punti cardinali, così pensava Hans Castorp e gli pareva essersi trovato altra volta tra essi, gettando uno sguardo scrutatore ora all’uno ora all’altro, facendo precisamente come faceva in quel momento mentre il signor Settembrini continuava a narrare.
(…)
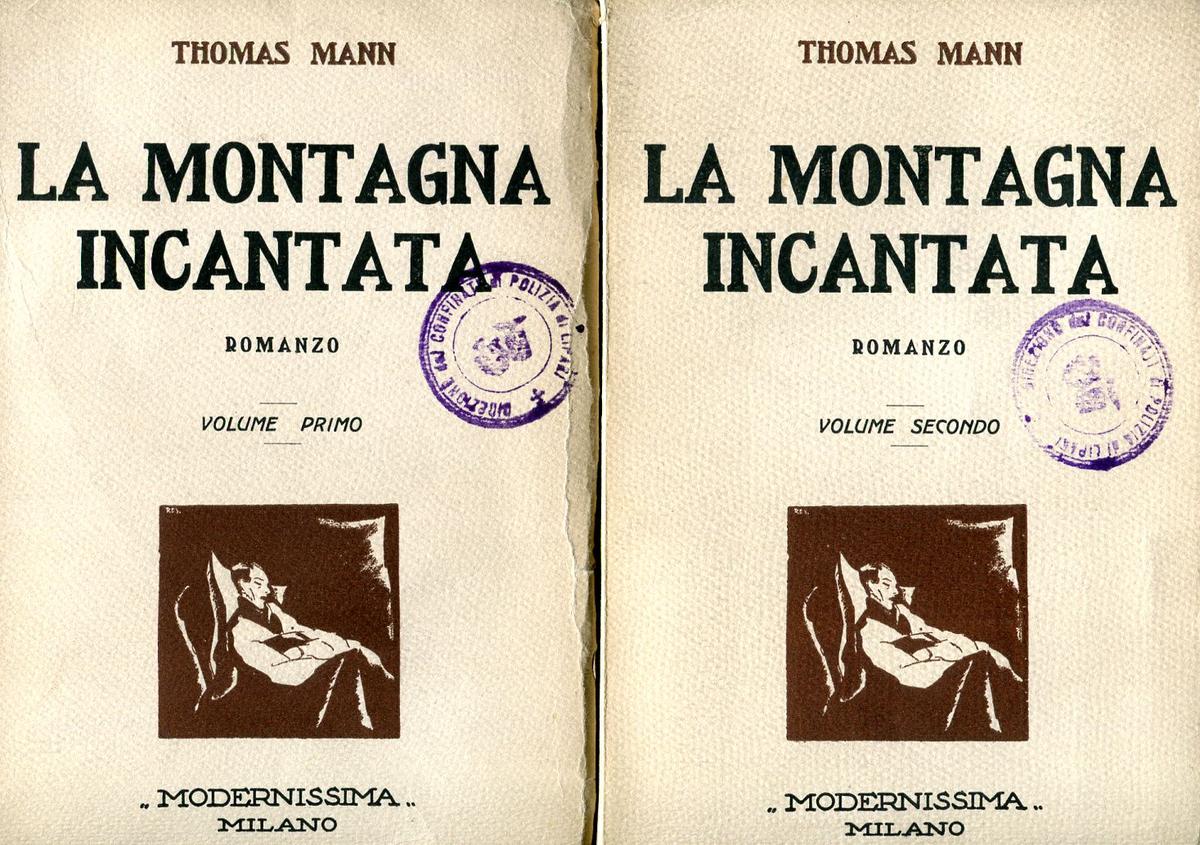 Edizione italiana del 1932
Edizione italiana del 1932
…L’Italiano rendeva onore alla patria dei suoi ascoltatori perché là erano state inventate l’arte della stampa e la polvere da sparo, perché essa aveva spazzato la corazza del feudalesimo, rendendo possibile il propagarsi delle idee democratiche. Lodava dunque la Germania sotto tale punto di vista e per quanto riguardava il passato, ma credeva di dover dare la palma alla sua propria patria perché, mentre le altre nazioni giacevano ancora nell’oscurantismo e nella schiavitù, essa aveva inalberato la bandiera del progresso intellettuale, della cultura, della libertà. Tuttavia l’omaggio che rendeva alla tecnica ed alle comunicazioni, campo di lavoro di Hans Castorp, non era diretto precisamente alle potenze in sé, ma a tali potenze solo perché da quelle risultava un perfezionamento morale dell’individuo. la tecnica – diceva – sottomettendo sempre più la natura con mezzi di comunicazione, con lo sviluppo delle reti stradali e telegrafiche, vincendo le differenze di clima, si dimostra il mezzo maggiormente atto ad avvicinare l’un l’altro i popoli, a favorirne la vicendevole conoscenza, a iniziare fra essi un equilibrio umano, a distruggere i loro preconcetti e finalmente ad instaurare una unione generale. La razza umana proviene dal buio, dalla paura, dall’odio ma essa procede e s’innalza sopra una via luminosa, verso uno stato finale di simpatia, di intima chiarezza, di bontà e di felicità, e la tecnica è il miglior veicolo per procedere su tale via.
Così parlando, Settembrini univa i campi che Hans Castorp era sempre abituato a pensare divisi, anzi ben lontani uno dall’altro. Tecnica e morale! disse. E poi parlò del Cristianesimo e del Redentore che, primo, rivelò il principio di uguaglianza e di fratellanza, principio divulgato poi dalla stampa e che la Rivoluzione Francese aveva innalzato a legge. A Hans Castorp, sia pure per motivi per cui non si rendeva ben conto, tale opinione sembrava decisamente confusa, quantunque Settembrini la esponesse in parole chiare, levigate e sonanti. Una volta – così narrava – una volta in vita sua e precisamente all’inizio degli anni migliori della maturità, suo nonno s’era sentito profondamente felice, cioè al tempo della Rivoluzione Parigina di Luglio. Allora egli aveva detto chiaro e forte in pubblico che tutti gli uomini in un tempo non lontano avrebbero posto i tre giorni di Parigi accanto a sei della Creazione. A questo punto Hans Castorp non poté fare a meno di battere la mano sul tavolo e di meravigliarsi nel più profondo dell’anima sua. Gli sembrava un po’ forte che accanto a sei giorni in cui il Signore Iddio aveva separato la terra dall’acqua e aveva creato le eterne luci del firmamento, i fiori, gli alberi, gli uccelli, i pesci ed ogni cosa che ha vita, si ponessero i tre giorni della Rivoluzione di Luglio dell’anno 1830, ed anche dopo, quando rimase solo col cugino, si espresse in questo senso.
Tuttavia, siccome era assolutamente disposto a lasciarsi influenzare, pose freno alla protesta che la sua pietà ed il suo gusto elevavano contro l’ordinamento delle cose “alla Settembrini”. Forse ciò che a lui pareva sacrilegio si poteva invece considerare coraggio e nobile slancio, almeno in quel luogo e a quella epoca. Nel luogo e nell’epoca, per esempio, in cui il nonno di Settembrini chiamava le barricate: “trono del popolo” e aveva dichiarato che bisognava “consacrare la picca del cittadino sull’altare dell’umanità”.
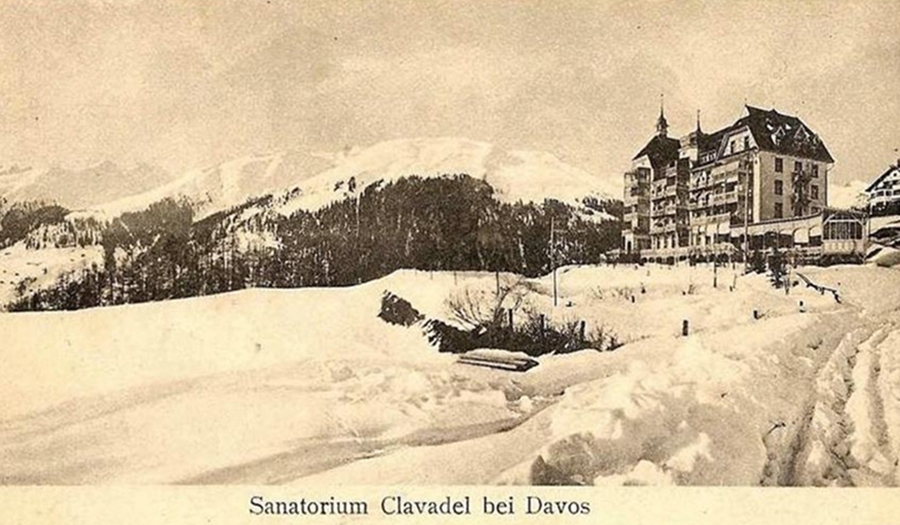
Come si vede il corposo romanzo presenta anche un’aspetto che potremo definire saggistico. A non renderlo tuttavia tale è il personaggio di Hans Castorp che Thomas Mann definisce Hans Castorp un quester ovvero “colui che cerca e interroga, che percorre il cielo e l’inferno, che tiene testa al cielo e all’inferno e stringe un patto col mistero, con la malattia, col male, con la morte con l’altro mondo, con l’occulto, con quel mondo che nella Montagna incantata è detto “problematico”… alla ricerca del Graal, cioè del supremo, del sapere, di conoscenza e iniziazione, della pietra filosofale, dell’aurum potabile, della bevanda di vita.”
Qui lo vediamo alle prese con Settembrini, discendente del famoso patriota italiano, entusiasta portavoce della Rivoluzione del 1789 e del razionalismo liberale del XIX secolo. A lui si contrappone Naphta (non presente nella parte riportata), allievo dei gesuiti e portavoce dell’assolutismo e dell’inquisizione. Quello che caratterizza il protagonista è quasi una specie di vuotezza interiore che man mano cerca di fortificarsi nell’ascolto attento, a volte ricevuto con perplessità, ma pronto a lasciarsi influenzare e ad arricchirsi.
L’attività di Thomas Mann continua con il Doctor Faustus, in cui al successo e all’incredibile creatività che il musicista Adrian Leverkühn ottiene grazie al patto col diavolo risponde la rinuncia agli affetti e l’aridità umana: la sua oltraggiosa coscienza di sé e la violazione di ogni limite rappresentano un’esplicita metafora del regime hitleriano.
“Abbiamo accennato solo alle più significative tappe di una produzione che sia sul piano specificatamente letterario che su quello saggistico ha, per varietà e mole, del prodigioso: nessun autore del Novecento può vantare come Mann un così approfondito e ossessivo esame (durato un cinquantennio) delle componenti della civiltà contemporanea, dei tanti ambigui miti che nel penultimo secolo essa ha elaborato: nessuno, forse, come lui ha contribuito – appunto perché li ha vissuti problematicamente dentro di sé – a esorcizzarli attraverso il faticoso recupero della ragione”. (Salvatore Guglielmino)
Heinrich Mann
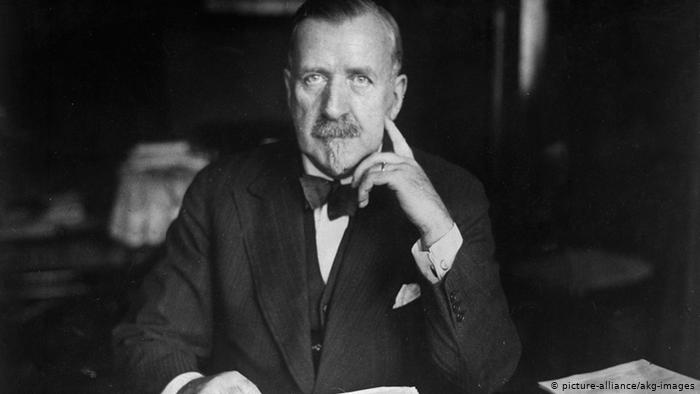
Meno famoso del fratello minore Thomas, Heinrich Mann, autore de Il professor Unrat, deve la sua fortuna al film Angelo azzurro del 1930 che ne fu tratto e che lanciò nel mondo, facendone un’intramontabile diva, Marlene Dietrich.
Nasce a Lubecca nel 1871. Per la sua opposizione al nazismo si trasferì dapprima in Cecoslovacchia, quindi in Francia ed infine negli Stati Uniti. Scrisse vari romanzi, fra i quali ricordiamo Il paese di Cuccagna (1900), Le dee (1903), Il professor Unrat (1905) e Tra le razze ( 1907). Giornalista e saggista si legò al socialismo umanitario e democratico (in polemica col fratello Thomas) e la sua opera può essere letta come una critica alla società tedesca che va dall’età guglielmina sino al nazismo attraverso una satira lucida e precisa.
Professor Unrat narra la storia di un insegnante vedovo cinquantenne, soprannominato dagli alunni Unrat, cioè “immondezza”. Un giorno s’inoltra nei quartieri malfamati della città, non grande ma rispettabilre, per cogliere in fallo tre dei suoi alunni più riottosi (Kieselack, von Ertzum, Lohmann) che egli sospetta di cattivi costumi. Conosce così nel locale “Angelo azzurro”, la cabarettista vicina quasi alla prostituzione Rosa Frölich e ne diventa un assiduo frequentatore, se ne invaghisca, spenda i suoi risparmi e infine se la sposi. Unrat viene licenziato dalla scuola, vive con lei tra i debiti, e la sua casa è frequentata dagli uomini più in vista della città, attirati dal fascino licenzioso della sposa. Sarà proprio lo studente Lohmann che lo denuncerà per il furto di un portafoglio e la coppia finisce arrestata e dileggiata.
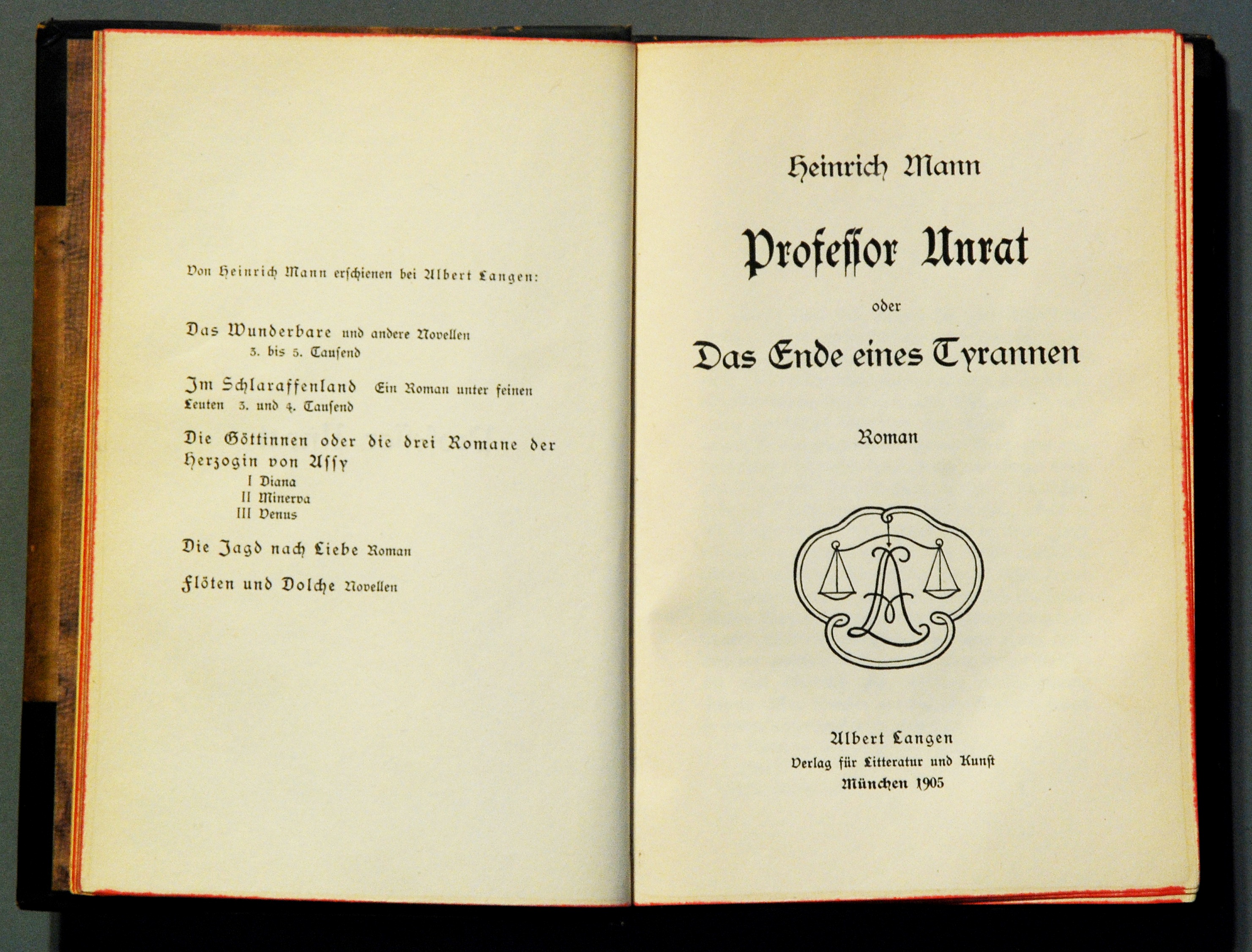 Edizione del 1905
Edizione del 1905
Dal questo romanzo prendiamo l’incipit:
IL PROFESSOR UNRAT
Poiché il suo nome era Raat, tutta la città lo chiamava Unrat, Sporcizia. Veniva così spontaneo, naturale. Ogni tanto capitava che questo o quel professore cambiasse soprannome: un nuovo scaglione di alunni entrava a far parte della classe, prendeva di mira con voluttà omicida un certo lato comico del professore che non era stato messo abbastanza in rilievo dai compagni dell’anno prima, e ne sbandierava il nome senza pietà. Unrat, invece il suo lo portava da molte generazioni, tutta la città ne era al corrente, i suoi colleghi lo usavano fuori dal liceo e anche dentro, appena lui voltava le spalle. Le persone che ospitavano in casa propria gli scolari e ne sorvegliavano gli studi, parlavano in presenza dei loro pensionanti del professor Unrat. E il bell’ingegno che avesse cercato di studiare con occhio nuovo e di battezzare in altro modo l’ordinario della prima liceo non sarebbe mai riuscito a spuntarla: se non altro perché l’appellativo suscitava ancora nel vecchio insegnante la stessa reazione di ventisei anni prima. Bastava che nel cortile della scuola, non appena lo vedeva venire, uno gridasse: «Non sentite odor di sporcizia?» Oppure: «Ehi, che odore di sporcizia!»
E subito il vecchio scrollava convulsamente la spalla, sempre la destra, che era più alta, e da dietro gli occhiali lanciava di sbieco un’occhiata piena di bile che gli studenti definivano perfida, e che era invece pavida e vendicativa: l’occhiata di un tiranno dalla coscienza poco tranquilla, che cerca di scoprire i pugnali tra le pieghe dei mantelli. Il suo mento spigoloso, a cui si attaccava una barbetta rada tra il giallo e il grigio, tremava con violenza. Contro l’alunno che aveva urlato la frase “non aveva prove” e non gli restava che tirar lungo sulle gambe magre dalle ginocchia curve, sotto il suo bisunto cappellaccio da muratore.
L’anno prima, per il suo giubileo, la scuola gli aveva organizzato una fiaccolata. Era uscito sul balcone e aveva fatto un discorso. E all’improvviso, mentre tutte le teste, appoggiate alla nuca, erano rivolte verso di lui, si era levata una sgradevole voce fessa: «Ehi, c’è sporcizia in aria!»
Altri avevano ripetuto: «Sporcizia in aria! Sporcizia in aria!»
Là in alto il professore, che pure aveva previsto l’incidente, cominciò a balbettare, fissato la bocca spalancata di ognuno dei suoi derisori. Gli altri signori stavano là, intorno a lui: egli si rese conto anche quella volta “non aveva prove”; tra sé prese nota, però di tutti i nomi. Non più tardi del giorno dopo quello dalla voce fessa, ignorando il villaggio natale della Pulzella d’Orléans, diede il modo al professore d’assicurargli che in futuro avrebbe fatto del suo meglio per rendergli la vita difficile. E a Pasqua infatti quel Kieselack non fu promosso. Assieme a lui dovette ripetere l’anno la maggior parte di quelli che avevano fatto gazzarra la sera del giubileo: tra questi von Ertzum. Lohmann se n’era stato zitto, però fu bocciato lo stesso: la sua indolenza, come l’ottusità dell’altro, aiutò Unrat nel suo intento. Ora accadde che un mattino del novembre successivo, durante l’intervallo delle undici che precedeva il compito in classe sulla Pulzella d’Orléans, von Ertzum, prevedendo un esito catastrofico del tema vista la sua scarsa confidenza con la Pulzella, spalancasse disperato la finestra e urlasse a casaccio nella nebbia: «Unrat!»
Non sapeva se il professore fosse nei paraggi, e non gliene importava nulla. Il povero corpacciuto nobile di campagna aveva semplicemente soddisfatto il bisogno tutto fisico di concedere ancora pochi attimi di libertà ai suoi polmoni prima di rannicchiarsi per due ore davanti a un foglio bianco, tutto vuoto, cercando di riempirlo con parole spremute dalla sua testa non meno vuota. Ma il caso volle che proprio in quel momento Unrat attraversasse il cortile. Quando l’urlo lanciato dalla finestra lo raggiunse ebbe un goffo sobbalzo. Lassù tra la nebbia distinse la sagoma pesante di von Ertzum. Di sotto non c’era un solo alunno, nessuno a cui von Ertzum potesse aver gridato quella parola. «Questa volta», pensò Unrat esultando «era me che intendeva. Questa volta ne ho le prove!»
 Marlene Dietrich ed Emil Jannings nelle parti di Rosa e del professor Rat
Marlene Dietrich ed Emil Jannings nelle parti di Rosa e del professor Rat
nel film del 1930
Quello che caratterizza il personaggio è una sua profonda ambiguità: egli è infatti vittima, con quel nomignolo che gli viene affibbiato sembra quasi dall’intera comunità, nomignolo che lo denigra e che lo squalifica; ma è anche carnefice, capace di vendicarsi in modo brutale, colpendo proprio chi non ha potere di difendersi, come i suoi studenti e soprattutto verso i più riottosi, i meno “inquadrati”. La ricerca del loro peccato, come poi verrà illustrato nel testo, si disegna tuttavia come la ricerca di un mondo che lo ha sempre affascinato ma che per convenzione non ha mai potuto frequentare. Potrebbe, detto così, sembrare un percorso che riscatta il personaggio, ma non è propriamente così: Unrat per ottenere ciò che vuole deve distruggere chi prima di lui ne era in possesso; la sua è una lotta senza quartiere, svolta tuttavia con armi che vanno dall’ossequio obliquo verso il potere e dalla più inaudita prepotenza verso chi è più debole di lui:
“…Unrat si voltò verso di lui. Intanto la Frölich se la filò: scappò gridando nella stanza vicina e si chiuse dentro sbattendo la porta. Per un attimo Unrat parve come stordito; poi si riprese e cominciò a fare dei gran salti intorno a Lohmann. Lohmann, che per darsi un contegno era indietreggiato fino al tavolo, prese il portafogli e si mise ad accarezzarlo. Pensò confusamente a qualcosa da dire. Che strano essere aveva davanti! Una via di mezzo tra un ragno e un gatto, con gli occhi da matto, col sudore che colava in gocce colorate da sopra gli occhi, e con la schiuma che gli usciva dai denti che battevano. Non era piacevole avercelo intorno con le braccia inarcate, pronte a scattare. E che farfugliava?”
“Unrat è, caricaturalmente deformato, il tipo del tiranno che vive tra furore e paura: nella scuola, se gli alunni non riconoscono il suo potere, tutto è perduto (come per il tiranno quando vede il palazzo invaso dalla plebe); fuori dalla scuola i rapporti con gli altri gli si configurano sempre come rapporti di autorità e di controllo (egli non sa immaginarne di diversi); l’intera città, sfuggendogli di mano, assume l’aspetto e la condotta di cinquantamila studenti indisciplinati e perciò meritevoli di punizione. Con vero piacere Unrat apre la sua casa a nobili e borghesi benestanti e assiste alla loro rovina: perduta l’autorità il tiranno è pronto a diventare anarchico, e si vanta del simbolismo implicito nell’odioso soprannome da cui un tempi si sentiva perseguitato” (Remo Ceserani)
Franz Kafka

Franz Kafka (1883 – 1924) è un autore che va inserito in quella cultura del vasto Impero asburgico nel periodo della sua decadenza, definito Mitteleuropa. Sarà importante al suo interno la componente ebraica e la lingua con cui espresse la sua cultura fu la lingua tedesca in cui descrisse la crisi epocale dell’Occidente, inserendola nel più lato discorso della crisi del personaggio-uomo nella cultura dei primi anni del Novecento.
Nacque a Praga ed ebbe nell’infanzia e nell’adolescenza difficili rapporti familiari, soprattutto con il padre, imponente nella figura e autoritario nell’educazione, che favorì in lui un senso d’inadeguatezza. Della complessità del loro rapporto abbiamo testimonianza nella famosa lettera al padre del 1919:
MIO CARO PAPA’
Mio caro papà, non è molto che mi hai chiesto perché affermo di aver paura di Te. Come al solito non ho saputo rispondere, un po’ per la paura che Tu m’incuti, un po’ perché, per motivare questa paura, occorrono troppi particolari che non saprei cucire in un discorso. E se ora mi provo a risponderTi per iscritto, anche questa risposta sarà incompletissima, poiché pur scrivendo mi sento impedito dalla paura e dalle sue conseguenze, e perché la vastità dell’argomento supera di molto la mia memoria e la mia intelligenza.
A Te la questione è sempre parsa molto semplice, almeno quando ne parlavi con me e, secondo i casi, con molti altri. La vedevi così: tutta la vita Tu hai lavorato duramente, hai sacrificato tutto per i Tuoi figli, specialmente per me, di modo che io son vissuto da signore, libero di studiare quel che volevo, senza crucci materiali, e cioé senza crucci affatto; in cambio Tu non chiedevi gratitudine – Tu conosci “la gratitudine dei figli” – ma almeno certi riguardi, qualche segno di comprensione, invece io Ti ho sempre evitato, rintanandomi in camera mia, fra i libri, fra amici esaltati, fra idee insane; mai Ti ho parlato a cuore aperto, al Tempio non ti sono mai stato accanto, mai sono venuto a trovarTi a Franzensbad*, d’altronde io non posseggo il senso della famiglia, non mi sono mai curato della ditta o degli altri Tuoi affari. La fabbrica Te l’ho caricata sulle spalle per piantarTi subito in asso, ho sostenuto Ottla* nei suoi capricci, e mentre per Te non muovo un dito (neppure un biglietto di teatro T’ho mai portato) per gli amici farei qualunque cosa. Se riassumi il Tuo giudizio su di me, ne vien fuori che Tu non mi rimproveri nulla di malvagio o di disonorevole (tranne forse il mio ultimo progetto matrimoniale) ma freddezza, estraneità, ingratitudine. E anzi me lo rimproveri come se fosse colpa mia, come se con un giro di timone avessi potuto cambiare tutto, mentre Tu non hai nulla da rimproverarTi, se non forse di essere stato troppo buono con me.
Questo tuo giudizio lo reputo esatto in quanto credo anch’io che Tu sia del tutto inconsapevole della nostra lontananza. Ma anch’io sono altrettanto innocente. Se fossi capaci di condurTi a riconoscerlo, sarebbe possibile non dico una nuova vita – siamo tutti e due troppo vecchi – ma una sorta di pace, non la fine ma un’attenuazione delle Tue incessanti rampogne.
Strano a dirsi, Tu hai una vaga percezione di quello che io intendo. Così ad esempio mi hai detto recentemente “Ti ho sempre voluto bene, anche se in apparenza il mio contegno non era quello degli altri padri, appunto perché non so fingere come gli altri”. In complesso, papà, io non ho mai dubitato della Tua bontà verso di me, ma questa affermazione non la credo giusta: E’ vero che tu non sai fingere, ma voler solo per questo sostenere che gli altri padri fingono è o pura protervia che non si può discutere oppure – e così è secondo il mio parere – la velata dimostrazione che fra noi due c’è qualcosa che non va, e che anche Tu ne sei causa, ma senza colpa. Se Tu lo ammetti, allora siamo d’accordo.
Non dico, naturalmente, di essere diventato quel che sono soltanto per il Tuo concorso. Questo sarebbe molto esagerato (e io inclino fin troppo a tale esagerazione). E’ assai probabile che, anche se fossi cresciuto libero dal Tuo influsso, non sarei diventato un uomo come volevi Tu. Sarei stato pur sempre una creatura debole, paurosa, dubbiosa, inquieta, certo non un Robert Kafka o un Karl Hermann*, certo però diverso da quello che sono, e avremmo potuto vivere in buona intesa. Sarei stato felice di averTi per amico, per principale, zio, nonno e perfino (sebbene con qualche esitazione) per suocero. Soltanto che come padre Tu eri troppo forte per me, tanto più che i miei fratelli morirono bambini, e le sorelle vennero molto più tardi, e io dovetti sopportare da solo il primo urto, per il quale ero di gran lunga troppo debole.
(…)
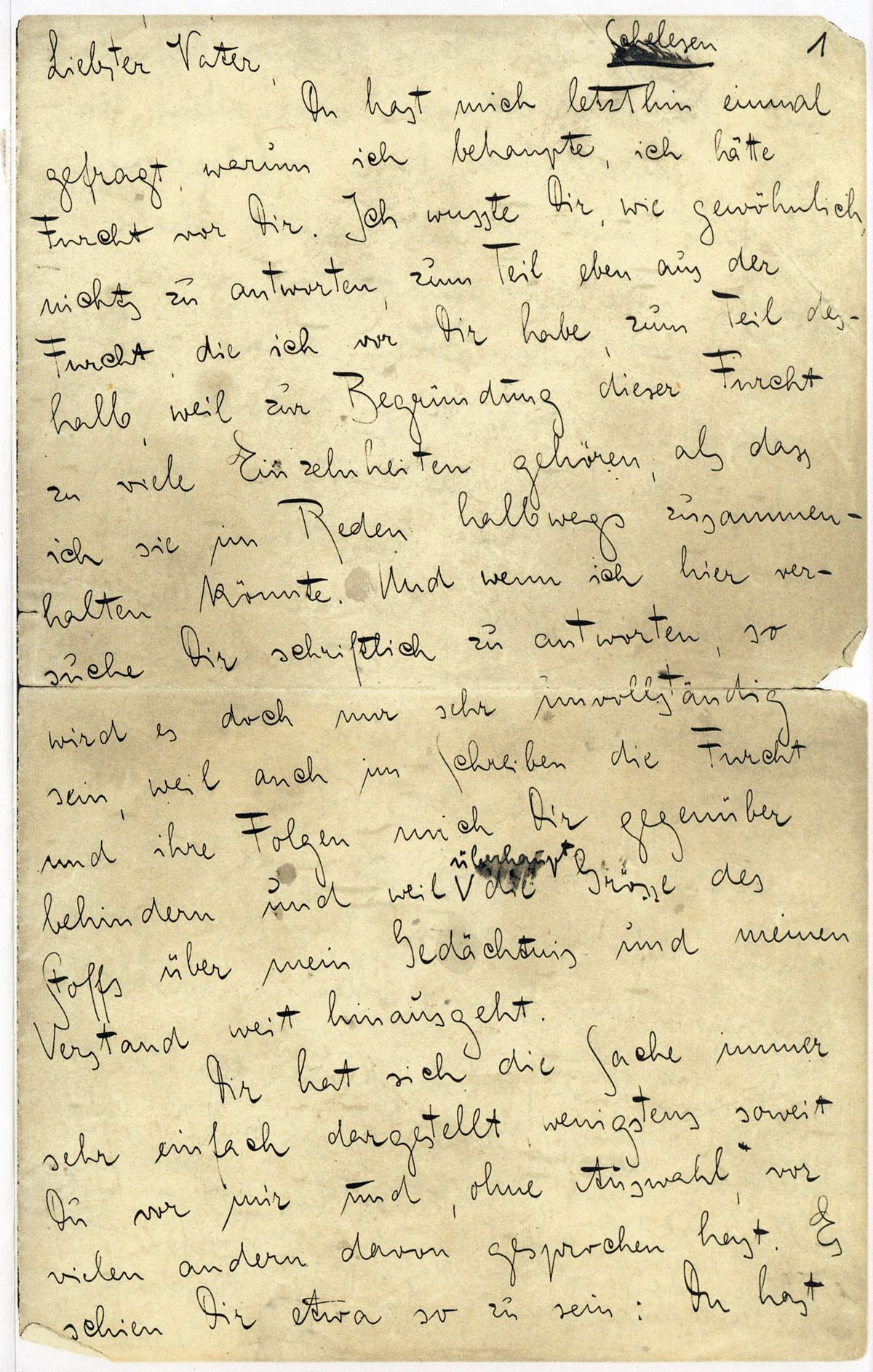
Alla Tua superiorità fisica faceva riscontro quella spirituale. Tu ti eri innalzato con le Tue sole forze, di conseguenza avevi una fiducia illimitata in Te stesso. Per il bambino ciò era meno evidente di quanto non lo fu per il giovane che si faceva adulto. Dalla Tua poltrona Tu governavi il mondo. La Tua opinione era giusta, ogni altra era assurda, stravagante, pazza, anormale. La Tua sicurezza era così grande che potevi anche essere incoerente e tuttavia non cessavi di avere ragione. Accadeva anche che su certe questioni Tu non avessi opinione alcuna, e allora tutte le opinioni possibili intorno a quel tema dovevano essere sbagliate senza eccezione. Per esempio prima insultavi i cechi, poi i tedeschi, poi ancora gli ebrei, e ciò non a proposito di alcunché di particolare, ma sotto tutti i riguardi, tanto che alla fine Tu solo rimanevi. AcquistasTi ai miei occhi un alone misterioso, come tutti i tiranni, il cui diritto si fonda sulla loro persona, non sul pensiero. A me, almeno, pareva così.
Nel 1919, all’età di trentasei anni, Franz Kafka scrisse questa lunghissima lettera al padre, che non fu mai consegnata e venne pubblicata solo in seguito, dopo la morte dell’autore e del destinatario. Tuttavia essa ci serve per chiarire non soltanto l’atteggiamento di un figlio nei confronti di un padre “forte”, ma come tale rapporto si segnasse fin da subito nella sensibilità eccitabile di Franz sotto il segno “psicoanalitico” della castrazione, per meglio dire l’impossibilità di diventare adulto perché tutto lo spazio era già occupato dal padre, che giustifica se stesso con il verbo essere, cioè è, come un tiranno, facendo in modo che gli altri non possano che essere dei sudditi. E’ un grido disperato ma lucido quello di Kafka, una testimonianza forte e decisa di quella figura di primo Novecento che troverà la sua definizione in colui che è incapace a vivere, con una sola parola, l’inetto.
 Egon Schiele: Padre con figlio
Egon Schiele: Padre con figlio
Laureatosi nel 1906 in giurisprudenza iniziò a lavorare in un istituto di assicurazioni, S’innamorò dapprima della titolare di una ditta, Felice Bauer, che rappresentava con la sua vivacità un perfetto alter ego, quindi con una scrittrice Milena Jesenska, ma solo con Dora Dymant riuscì a trovare un po’ di serenità. Fondamentale fu l’amicizia con lo scrittore Max Brod che divenne il suo confidente.
La voglia di scrivere è testimoniata dall’esigenza di narrarsi in un Diario, ma è del 1916 l’unica opera pubblicata in vita che rappresenta uno dei vertici della narrazione novecentesca, La metamorfosi:
Gregor Samsa, commesso viaggiatore, è, dopo il fallimento del padre, il sostegno della famiglia. Ma, svegliatosi il mattino dopo una notte di incubi, si trova trasformato in un enorme insetto. Accortosi della ripugnanza che desta nei familiari, si adatta a dormire sotto il letto e a non comparire più in pubblico. Si nutre soltanto di rifiuti, assistito da una vecchia serva, l’unica che sopporti la sua vista. Ma un giorno, attirato dal suono del violino della sorella Grete, compare fra i suoi. Il padre gli scaglia una mela, che lo ferisce. Ne muore poco dopo. La vecchia serva, pur commiserandolo, lo getta nella spazzatura.
IL RISVEGLIO DI GREGOR SAMSA
Quando Gregor Samsa di risvegliò una mattina da sogni tormentosi si ritrovò nel suo letto trasformato in un insetto gigantesco. Giaceva sulla schiena dura come una corazza e sollevando un poco il capo poteva vedere la sua pancia convessa, color marrone, suddivisa in grosse scaglie ricurve; sulla cima la coperta, pronta a scivolar via, si reggeva appena. Le sue numerose zampe, pietosamente esili se paragonate alle sue dimensioni, gli tremolavano disperate davanti agli occhi.
«Che cosa mi è successo?» pensò. Non era un sogno. La sua stanza, una vera stanza, – sia pure piccola – per esseri umani, era tranquillamente racchiusa fra le quattro pareti così familiari. Sopra al tavolo, sul quale era sparso un campionario di stoffe – Samsa era un commesso viaggiatore – era appesa la figura che aveva recentemente ritagliato da un giornale illustrato e sistemato in una bella cornice dorata. Rappresentava una signora seduta tutta impettita con un cappellino e un boa di pelliccia, che ostentava a chi la guardasse un ampio manicotto nel quale scomparivano i suoi avambracci.
Lo sguardo di Gregor si rivolse poi alla finestra e il cattivo tempo – si udiva la pioggia picchiettare sulle parti metalliche della finestra – lo rattristò completamente. «Che accadrebbe se continuassi a dormire un altro po’ dimenticando queste sciocchezze?», pensò, ma non era proprio fattibile perché era abituato a dormire sul fianco destro e nella condizione in cui si trovava non poteva assumere quella posizione. Per quanto si sforzasse di buttarsi verso destra ripiombava sempre nella posizione supina. Ci provò un centinaio di volte, chiuse gli occhi per non vedere le zampe annaspanti, e rinunciò solo quando cominciò a sentire sul fianco un dolorino sordo mai provato prima di allora.
«Oh Dio,» pensò, «che mestiere faticoso mi sono scelto! Sempre in giro, un giorno dopo l’altro. L’affanno per gli affari è molto maggiore che nell’azienda, inoltre devo sopportare anche questa piaga da viaggiatore, i crucci per le coincidenze, i pasti irregolari e cattivi, rapporti umani sempre mutevoli, mai costanti, mai cordiali. Che vada tutto al diavolo!» Provò un leggero prurito sulla pancia, ; si trascinò lentamente sul dorso verso la testata del letto per poter sollevare meglio il capo, localizzò la parte che gli prudeva e che era cosparsa di puntini bianchi, di cui non riusciva a spiegarsi la causa; volle toccare la parte con una zampa, ma la ritirò subito perché il contatto lo fece rabbrividire.
Scivolò nuovamente nella posizione di prima. «Queste continue levatacce», pensò, «finiscono per rincitrullire. Ogni essere umano ha bisogno delle sue giuste ore di sonno. Gli altri viaggiatori di commercio hanno una vita da pascià! Quante torno alla locanda nel corso della mattinata per trascrivere le ordinazioni ricevute, quei signori stanno appena consumando la prima colazione. Se facessi una cosa simile col principale che mi ritrovo, verrei cacciato su due piedi. Chi sa, però, se non sarebbe meglio per me. Se non cercassi di dominarmi per far piacere ai miei genitori avrei dato le dimissioni da lungo tempo, sarei andato dal principale e gli avrei detto chiaro e tondo come la penso. L’averi fatto cadere dalla cattedra! E’ anche una strana abitudine quella di mettersi in cattedra e di parlare dall’alto coi dipendenti, che oltre tutto devono venire assai vicino a causa della sordità del principale. Comunque non tutte le speranze sono perdute; quando avrò raggranellato abbastanza soldi per pagare il debito che i miei genitori hanno verso di lui – e non ci dovrei mettere più cinque o sei anni – mi licenzierò senz’altro. Sarà un taglio netto. Intanto, però, devo alzarmi: il mio treno parte alle cinque.»
E guardò la sveglia che ticchettava sul cassettone. «Santo Cielo!» esclamò tra sé. Erano le sei e mezza e le lancette proseguivano tranquillamente il loro cammino, anzi era ancor più tardi, mancava poco ai tre quarti. Forse la sveglia non aveva suonato? Si vedeva benissimo anche dal letto che era stata fissata sulle quattro: aveva suonato sicuramente. Sì, ma era mai possibile continuare a dormire pacificamente con quel frastuono che scuoteva i mobili? In verità, non aveva dormito proprio pacificamente però forse per questo il sonno era stato più pesante. Che cosa doveva fare ora? Il prossimo treno partiva alle sette: per prenderlo avrebbe dovuto sbrigarsi come un matto, il campionario non era ancora sistemato e lui stesso non si sentiva particolarmente sveglio e attivo. E anche se avesse preso quel treno una sfuriata del principale sarebbe stata inevitabile, perché l’usciere della ditta aveva atteso al treno delle cinque e aveva già riferito la sua mancanza. Era una creatura del padrone, senza spina dorsale né comprendonio. E si fosse dato per malato? E ciò sarebbe stato assai penoso e sospetto, perché durante i suoi cinque anni di servizio Gregor non era mai stato ammalato. Sicuramente il principale sarebbe venuto col medico della cassa malattia, avrebbe rimproverato i genitori per la pigrizia del loro figlio e avrebbe troncato qualsiasi obiezione rimettendosi al parere del medico della cassa malattia, per il quale esistono soltanto persone sanissime o pelandroni. E gli si poteva dare torto nel suo caso? Gregor, a parte il sopore eccessivo dovuto al lungo sonno, si sentiva veramente bene e aveva persino una gran fame.
Mentre questi pensieri gli turbinavano per la mente, e senza che si decidesse a lasciare il letto – proprio in quel momento la sveglia faceva le sei e tre quarti – venne bussato lievemente alla porta che si trovava vicino alla testata del letto.«Gregor,» mormorò una voce – era la mamma – «sono le sette meno un quarto. Non dovevi partire?» La dolce voce! Gregor sussultò udendo la propria voce mentre rispondeva che era indubbiamente ancora quella di prima, in cui si mescolava però, dal basso, un insopprimibile frinire fastidioso, che solo in un primissimo momento lasciava alle sue parole un suono integro, ma poi lo deformava al punto da far credere di aver udito male. Gregor avrebbe voluto rispondere fornendo tutti i particolari, ma in simili condizioni si limitò a dire: «Sì sì, grazie mamma, mi sto alzando.» La porta chiusa impediva che fuori si notasse il cambiamento della voce di Gregor, perciò la mamma rassicurata se ne andò strascicando i piedi. Ma il breve dialogo aveva rivelato agli altri membri della famiglia che, contro ogni aspettativa, Gregor si trovava ancora in casa; e il padre si era messo a bussare alla porta, debolmente ma col pugno. «Gregor, Gregor,» gridò, «che cosa c’è?» E dopo un breve intervallo tonò con voce più profonda: «Gregor! !Gregor!» Dietro l’altra porta la sorella bisbigliava: «Gregor! Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa?» Gregor rispose ad entrambi le direzioni «Sono già pronto» e si sforzò di eliminare ogni suono dalla sua voce scandendo le parole con molta cura e separandole con lunghe pause. Infatti il padre se tornò alla sua colazione, ma la sorella mormorò: «Gregor apri, te ne supplico.» Gregor non pensava proprio di aprire, anzi si compiaceva dell’abitudine presa nel corso dei suoi viaggi di chiudere a chiave le porte durante la notte anche quando si trovava in casa propria.

La prosa di Kafka ci descrive in modo mirabile l'”assurdo quotidiano”. Cosa intendiamo con questo? A ben guardare quello che colpisce è la normalità con cui, in questo caso, Gregor, proprio all’inizio del racconto, gestisce il suo svegliarsi scarafaggio. Non ci viene adombrata una causa. Gregor, senza motivo e senza alcuna percezione, se non quella di un profondo sonno, durante la notte si trasforma in un orrendo insetto. L’autore, rigorosamente eterodiegetico, ci informa soltanto della preoccupazione per il fare tardi al lavoro.
E’ evidente che pertanto la lettura che dobbiamo esercitare in un testo così inquietante non può prescindere dal concetto di alienazione che colpisce gran parte della narrativa di primo Novecento. Qui alienazione assume un carattere quasi etimologico, alius, altro, diverso: si tratta infatti di una regressione verso una forma lontanissima, invertebrata, e per di più considerata immonda dalla società, accentuata dall’essere dapprima chiusa, quindi nascosta in spazi angusti, ristretti, dove permangono oggetti altrettanto alienati (la foto di un’immagine femminile tratta da una rivista incastonata in una cornice dorata che lui cercherà di difendere con tutte le sue forze).
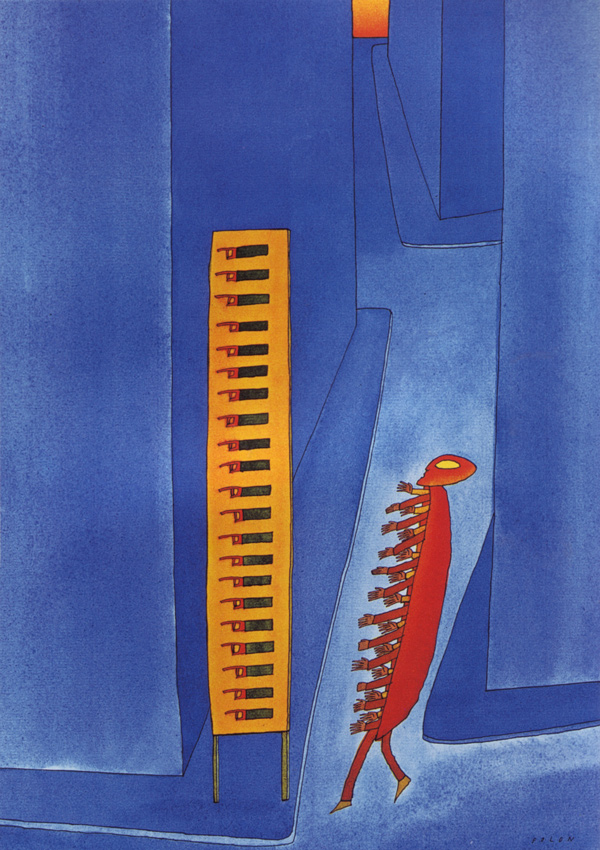 La Metamorfosi di Kafka illustrata da Jean Michel Folon
La Metamorfosi di Kafka illustrata da Jean Michel Folon
Si ricrea qui, sotto forma letteraria quel rapporto malato e ambiguo tra lui, essere privo di forza e l’autorità, che abbiamo già letto nella Lettera al padre: qui l’autorità è rappresentata dal padre di Gregor che “uccide” il figlio con una mela (nel brano riportato bussa preoccupato, ma con un pugno), ma anche dal principale da cui vorrebbe scappare ma non può – inconsciamente non vuole – che ci viene raccontato come in cattedra, autoritario nell’alto della sua potenza.
Dopo aver vissuto gli ultimi anni a casa della sorella Ottla, attraversò un periodo buio di crisi religiosa, determinata anche dalla visione straziante dei reduci di guerra. Morì piuttosto giovane, a quarantuno anni, di turbecolosi. Il suo amico Max Brod venne meno alla promessa fatta di bruciare tutto ciò che non fosse stato già pubblicato, e vennero così alla luce i romanzi incompiuti Il processo, Il castello e Amerika.
Ecco la trama de Il processo:
Josef K., trent’anni, impiegato di banca, è dichiarato in arresto da due persone. Un processo è stato istruito nei suoi confronti. Dapprima sicuro di sé, poi via via schiacciato da una macchina processuale di cui gli sfuggono i meccanismi, Josef K. finisce per trascurare il lavoro fino a lasciarsi assorbire completamente dalle esigenze del processo. Abbandonato da tutti, si rassegna alla fine ad accettare una condanna che lui stesso, senza saperne il motivo, ritiene irrevocabile. All’alba del giorno del suo trentunesimo compleanno, altri due signori vestiti di nero si presentano davanti a casa sua, lo prelevano e lo conducono ai margini della città dove verrà giustiziato.
L’ARRESTO DI JOSEF K.
Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché, senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato. La cuoca della signora Grubach, la sua affittacamere, che ogni giorno verso le otto gli portava la colazione, quella volta non venne. Non era mai successo prima. K. aspettò ancora un poco, guardò dal suo cuscino la vecchia che abitava di fronte e lo stava osservando con una curiosità del tutto insolita per lei, ma poi, stupito e affamato insieme, suonò il campanello. Subito bussarono e un uomo che K. non aveva mai visto prima in quella casa entrò. Era slanciato ma di solida corporatura, indossava un abito nero attillato che, come quelli da viaggio, era provvisto di varie pieghe, tasche, fibbie, bottoni e cintura, e dava quindi l’impressione, senza che si capisse bene a che cosa dovesse servire, di essere particolarmente pratico.
«Lei chi è?», chiese K. subito sollevandosi a metà nel letto. Ma l’uomo eluse la domanda, come se la sua comparsa fosse da accettare e si limitò a chiedere a sua volta: «Ha suonato?».
«Anna mi deve portare la colazione», disse K. e cercò, dapprima in silenzio, con l’osservazione e la riflessione, di stabilire chi mai fosse l’uomo. Ma questi non si espose troppo a lungo ai suoi sguardi, si volse verso la porta e l’aprì un poco per dire a qualcuno che stava evidentemente subito dietro: «Vuole che Anna gli porti la colazione».
Ci fu una risatina nella stanza accanto, dal suono non poteva essere sicuro che non venisse da più persone. Sebbene l’estraneo non potesse con questo aver appreso nulla che già non avesse saputo prima, disse a K. con il tono di una comunicazione: «È impossibile».
«Questa sarebbe nuova», disse K., saltò dal letto e s’infilò in fretta i pantaloni. «Voglio un po’ vedere che gente c’è nell’altra stanza e che giustificazione mi darà la signora Grubach per questa seccatura». Gli venne subito in mente che non avrebbe dovuto dire questo a voce alta, e che in tal modo riconosceva all’estraneo un qualche diritto di controllo, ma al momento la cosa non gli parve importante. L’estraneo, comunque, l’intese così, perché disse: «Non preferisce rimanere qui?».

«Non voglio rimanere qui né che lei mi rivolga la parola finché non si sarà presentato».
«L’intenzione era buona», disse l’estraneo e aprì ora spontaneamente la porta. Nella stanza accanto, dove K. entrò più lentamente di quanto volesse, a un primo sguardo tutto pareva quasi immutato dalla sera prima. Era il soggiorno della signora Grubach, forse nella stanza stracolma di mobili, tessuti, porcellane e fotografie, c’era un po’ più spazio del solito, non lo si vedeva subito, anche perché il cambiamento principale consisteva nella presenza di un uomo, seduto vicino alla finestra con un libro da cui ora alzò lo sguardo.
«Sarebbe dovuto rimanere nella sua stanza! Non glielo ha detto Franz?».
«Ma lei che cosa vuole?», disse K., e volse lo sguardo dalla nuova conoscenza all’uomo chiamato Franz, che era rimasto sulla porta, e poi ancora all’altro. Dalla finestra aperta si vedeva di nuovo la vecchia che, con una curiosità veramente senile, si era adesso spostata alla finestra dirimpetto per continuare a vedere ogni cosa.
«Insomma, voglio la signora Grubach…», disse K., e fece un movimento come per divincolarsi dai due uomini, che pure stavano distanti da lui, e andarsene.
«No», disse l’uomo vicino alla finestra, gettò il libro su un tavolino e si alzò. «Lei non può andarsene, è in arresto».
«Si direbbe proprio», disse K. «E perché?», chiese poi.
«Non siamo autorizzati a dirglielo. Vada in camera sua e aspetti. Il procedimento è appena avviato, e lei saprà tutto a tempo debito. Vado oltre il mio incarico parlandole così amichevolmente. Ma spero che non ci senta nessuno al di fuori di Franz, e anche lui è gentile con lei contro ogni regola. Se continua ad avere la fortuna che ha avuta con l’assegnazione delle sue guardie, può sperare in bene».
 Anthony Perkins nella parte di Josef K. nel film omonimo di Orson Welles del 1962
Anthony Perkins nella parte di Josef K. nel film omonimo di Orson Welles del 1962
Se Gregor vive nella trasformazione/degradazione di sé il senso della propria alienazione Josef K. (Kafka?) vive la stessa da un esterno inspiegabile, altrettanto assurdo. A ben pensare quello che definisce il protagonista della storia è un non essere: l’inizio ex abrupto ci dice cosa succede, non chi lui sia né come siano le sue fattezze. E’ un nome (neppure un cognome). Una cosa fa, probabilmente in modo inconsapevole, vive e vive in una reiterata quotidianità, tanto che questa, quando viene meno, diventa piccolo dramma. Egli pertanto è colpevole perché vive e, avendo una colpa/non colpa avrà di conseguenza una imputazione/non imputazione altrettanto determinata: il suo essere è già di per sé una colpa. Per questo il suo percorso, raccontato esemplarmente assumendo il punto di vista del protagonista, fa in modo che il lettore si identifichi con lui. Josef è vittima del suo argomentare in modo raziocinante, quindi naturale ma ciò che si trova di fronte è il contrario della normalità. Ma sarà quest’ultima, attraverso il processo dell’inversione, che sarà raccontata “come cosa normale” mentre le rimostranze di Josef saranno sempre meno convincenti per gli altri e quindi anche per sé. Questa capacità kafkiana oserei dire di straniamento provocherà un senso d’angosciante assurdità cui Joseph deve sottostare e che lo condurrà inevitabilmente ad una condanna che la Legge gli infliggerà.
Kafka è uno degli autori più problematici del Novecento, la cui interpretazione non è semplice. Egli tuttavia può essere considerato, nel complesso, come l’interprete della fragilità e dell’esilio dell’uomo contemporaneo. I protagonisti delle sue opere sono personaggi che non trovano spiegazione al loro agire, in quanto forniti d’inadeguatezza propositiva, ma soprattutto non trovano un senso non nel loro agire, ma nelle cose per le quali dovrebbero agire. La fragilità dell’uomo kafkiano non è nella sconfitta, cui è destinato, ma nell’impossibilità di comprenderla. Il gioco sta nel tentativo di comprendere logicamente le ragioni delle cose, ma quest’ultime sopraffanno l’uomo stesso, che si trova “invischiato” in un meccanismo più grande di lui. Tutto ciò è reso da Kafka con moduli narrativi e stilistici di grande originalità: egli infatti descrive le cose con estrema minuziosità, siano essi ambienti, o piccoli oggetti; tuttavia proprio questa attenzione fa sì che essi si carichino di implicazioni simboliche, di allusioni polisense. In un certo modo esasperando attraverso lo sguardo le cose, egli (come l’espressionismo) ce le fa apparire allucinate, con una fredda luce che ne toglie credibilità, illuminandole in un agghiacciante assurdo. Ladislao Mittner, studioso di letteratura tedesca, definisce il modo di scrittura kafkiano “realismo grottesco” e così spiega l’estraneità alla vita dell’autore praghese: “Chi vive fuori della realtà, trova assurda ed angosciante la realtà intera, e la trova tanto più assurda ed angosciante, quanto più perfettamente essa ubbidisce alla propria legge, quanto più è normale ed anche banale. Essendo impossibile ogni e qualsiasi possibilità reale, diventa per converso possibilissimo tutto quanto nella realtà concreta è impossibile. Assurdi sono gli eventi che colpiscono l’eroe kafkiano, ma la loro assurdità è narrata senza alcun pathos, in uno stile da relazione scientifica o addirittura da verbale giudiziario.”
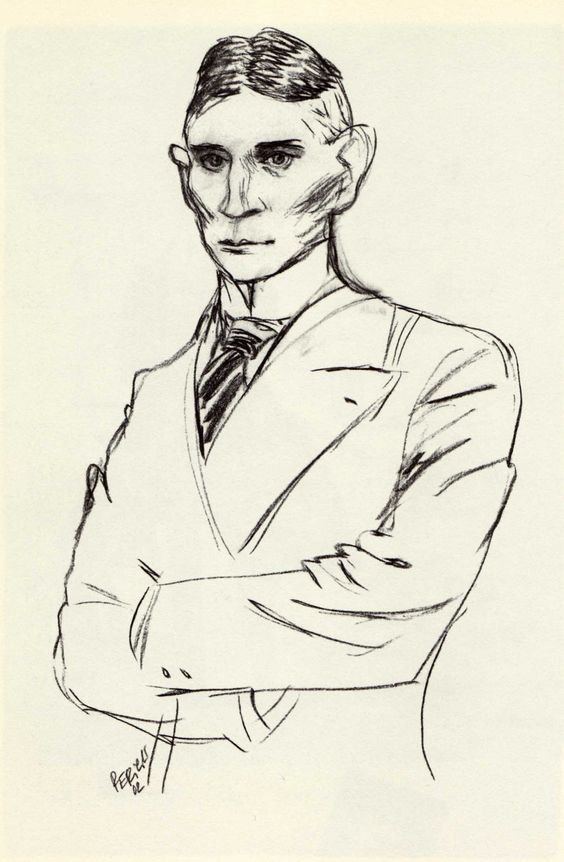
Kafka in un disegno di Tullio Pericoli
Robert Musil

Robert Musil è uno scrittore austriaco, nato nel 1880. Dopo il liceo si laurea in ingegneria meccanica, lavorando si da subito all’interno dell’università. Dopo pochi anni si trasferisce a Berlino, dove consegue una seconda laurea in Filosofia. Già precedentemente aveva dato alle stampe il suo primo romanzo I turbamenti del giovane Törless, a cui seguiranno un libro di racconti Incontri. Allo scoppio della prima guerra mondiale si arruola e viene spedito nel fronte italiano. Alla fine della guerra torna a Berlino, dove inizia la sua opera più importante L’uomo senza qualità. Tornato a Vienna nel 1935, l’abbandonerà a seguito dell’invasione tedesca. Contrario al nazismo si rifugiò in Svizzera, lavorando incessantemente al suo romanzo pur non riuscendo a terminarlo. Morirà a Ginevra nel 1942, dopo aver trascorso gli ultimi anni in forti ristrettezze economiche.
Come già detto il suo primo romanzo è I turbamenti del giovane Törless (1906), dettato dall’esperienza biografica di studio all’interno di un collegio militare (dove studierà anche Rilke)
La vita del giovane Törless, consegnato al collegio da una famiglia impeccabilmente borghese, scorre dapprima nella pigrizia e nell’inerzia. In questo stato di fragilità intellettuale Törless comincia a prendere coscienza degli enigmi incomprensibili, dei vuoti e delle contraddizioni che minano il compatto tessuto del reale. Con la vecchia prostituta Božena che, a servizio dai signori, ne ha conosciuto il mondo e la corruzione. Törless conosce la sessualità come degradazione ma anche come sfondamento dei limiti, e acquisisce la consapevolezza che il mondo dei propri genitori, apparentemente integro e casto, è anch’esso contaminato. Törless prende atto dell’esistenza di due mondi, uno chiaro e diurno, solitamente borghese in cui ogni cosa appare inserita in un ordine razionale, e un altro dissoluto, nudo e distruttivo, pieno di oscurità e sangue, come lo stanzino che due tra i peggiori allievi dell’istituto, Reiting e Beineberg, hanno scoperto e adibito a teatro della propria folle violenza. L’edificio della realtà appare a Törless instabile e sdrucciolevole, fondato sul nulla, e il pensiero gli si rileva un mezzo insufficiente, tanto che Törless, per indagare la vita, si affida non solo a una sensibile e acuta intelligenza, ma anche a un’ambigua e disponibile sessualità., la quale lo porta a sperimentare l’abiezione di un rapporto carnale con un debole compagno, già vittima di Reiting e Beineberg. Solo nella raggiunta consapevolezza che le cose vanno viste “ora con la ragione, ora altrimenti, senza confonderle, Törless, che abbandonerà il collegio, saprà dissociarsi dai suoi camerati ed emanciparsi dai propri turbamenti giovanili.
IL GIOVANE TÖRLESS IN COLLEGIO
Una piccola stazione, sulla linea ferroviaria che porta in Russia.
Dritte a perdita d’occhio quattro rotaie parallele correvano nelle due direzioni tra il pietrisco giallo dell’ampia massicciata; accanto a ciascuna, come un’ombra sporca, la striscia scura impressa sul terreno dai vapori di scarico.
Dietro il basso edificio della stazione pitturata a olio una strada larga, scavata dai solchi delle vetture, portava su fino alla rampa. I suoi bordi si perdevano nel terreno circostante, tutto calpestato, ed erano riconoscibili solo grazie a due filari di acacie che fiancheggiavano meste la strada con le foglie riarse e soffocate dalla polvere e dalla fuliggine.
Fosse l’effetto di questi tristi colori, fosse la luce debole e smorta del sole pomeridiano, illanguidita dalla foschia, le cose e le persone avevano un’aria apatica, fiacca e meccanica, quasi fossero uscite dallo scenario d’un teatro di burattini. Di tanto in tanto, a intervalli regolari, il capostazione usciva dal suo ufficio, risaliva con lo sguardo, girando sempre la testa nello stesso modo, la lunga linea ferroviaria e scrutava le cabine di segnalazione che ancora non si decidevano ad annunciare l’arrivo del diretto, in gran ritardo sin dal confine; poi, con un gesto sempre identico del braccio, toglieva l’orologio dal taschino, scuoteva la testa e scompariva di nuovo, come vengono e vanno le figure che allo scoccare dell’ora escono da certi antichi orologi delle torri.
Sulla larga striscia in terra battuta tra i binari e l’edificio una gaia compagnia di giovani passeggiava su e giù stringendosi attorno a una matura coppia di coniugi che formava il centro della conversazione piuttosto chiassosa. Ma anche l’allegria di questo gruppo non era proprio tale, il chiasso delle gioconde risate sembrava ammutolire due passi più in là e cadere a terra urtando contro un ostacolo invisibile e tenace.
La moglie del consigliere di corte Törless – era lei la signora sulla quarantina – nascondeva dietro la fitta veletta gli occhi tristi un po’ arrossati dal pianto. Era il momento dell’addio, e le pesava dover lasciare ancora una volta per tanto tempo il suo unico figlio tra gente estranea, senza la possibilità di vegliare lei sul suo beniamino.
La cittadina infatti, ben lontana dalla capitale, si trovava nella parte orientale dell’impero, in una regione agricola arida e non molto popolata.
La ragione per cui la signora Törless doveva rassegnarsi a sapere il suo ragazzo in un posto così lontano e inospitale era l’esistenza, in quella città, di un famoso collegio, che già dal secolo precedente, quand’era stato costruito sul terreno di un pio istituto, s’era deciso di tenere laggiù, certo per preservare i giovani, negli anni della loro maturazione, dagli influssi corruttori di una grande città. Là infatti i figli delle migliori famiglie del paese ricevevano la loro educazione, in attesa di entrare, una volta lasciato l’istituto, all’università o nella carriera militare o in quella burocratica, e in tutti questi casi, come pure per l’ammissione negli ambienti della buona società, l’esser cresciuti nel convitto di W. era un ottimo biglietto di presentazione.
Quattro anni prima ciò aveva indotto i signori Törless a cedere alle ambiziose insistenze del loro ragazzo e a ottenere la sua ammissione all’istituto.
Questa decisione, più tardi, era costata molte lacrime. Infatti, quasi a partire dal momento in cui il portone del collegio s’era irrevocabilmente chiuso dietro di lui, il piccolo Törless aveva cominciato a soffrire di una terribile, appassionata nostalgia. Né le lezioni, né i giochi sui grandi prati rigogliosi del parco, né le altre distrazioni che il convitto offriva ai suoi ospiti riuscivano a interessarlo. Vi partecipava appena, vedeva ogni cosa come attraverso un velo; anche di giorno durava spesso fatica a ricacciare in gola certi ostinati singhiozzi; di sera poi s’addormentava sempre tra le lacrime.
Scriveva lettere a casa quasi ogni giorno, e viveva solo in quelle lettere; tutte le sue altre occupazioni gli parevano solo fatti nebulosi e insignificanti, tappe del suo cammino indifferenti come le ore sul quadrante di un orologio. Invece quando scriveva sentiva in sé qualcosa di esclusivo che lo distingueva: come un’isola piena di soli e colori meravigliosi, in lui emergeva qualcosa dal mare di grigie sensazioni che giorno dopo giorno lo stringeva, freddo e indifferente. E quando, nel corso della giornata, durante i giochi o le lezioni, pensava che la sera avrebbe scritto la sua lettera, gli pareva di portare appesa a una catena invisibile una segreta chiave d’oro con cui, quando nessuno vedeva, avrebbe aperto la porta di meravigliosi giardini.
Il lato più singolare di tutto ciò era che quell’improvviso e divorante amore per i suoi genitori a lui per primo riusciva nuovo e sconcertante. Prima non ne aveva supposto l’esistenza, era entrato volentieri, spontaneamente in collegio, aveva addirittura riso quando al primo commiato sua madre non aveva saputo trattenere un gran pianto, e solo dopo, quand’era là ormai da vari giorni e s’era anche trovato abbastanza bene, gli era scoppiata dentro quella reazione improvvisa, elementare.
La credeva nostalgia, desiderio prepotente dei genitori. In realtà era qualcosa di assai più indefinito e composito. Perché l'”oggetto” di quello struggimento, l’immagine dei suoi genitori, a ben guardare non era più presente in esso. Intendo quel certo ricordo plastico di una persona amata che è fisico e non soltanto della memoria e che parla a tutti i sensi e viene custodito in ciascuno di essi, per cui non si può far niente senza sentirsi al fianco, invisibile e silenzioso, l’altro. Questo ricordo svanì presto, come un’eco che avesse vibrato solo per un breve tratto. In quel periodo, per esempio, Törless non riusciva più a evocare l’immagine dei suoi – così li chiamava per lo più tra sé – “cari, cari genitori”. Se ci si provava, invece di quella affiorava in lui, un dolore sconfinato, il cui anelito lo torturava e tuttavia lo teneva ostinatamente avvinto, perché le sue fiamme gli facevano male e l’estasiavano insieme. Il pensiero dei genitori divenne per lui sempre più un espediente per eccitare in sé quell’egoistica sofferenza che lo chiudeva nel suo orgoglio voluttuoso come nel segreto di una cappella dove da cento ceri accesi e da cento occhi di sacre immagini venisse sparso incenso tra gli spasimi dei flagellanti.
Quando, più tardi, la “nostalgia” divenne meno violenta e a poco a poco scomparve, questa sua natura si rivelò infatti abbastanza chiaramente. La sua scomparsa non portò una tranquillità a lungo attesa ma lasciò nell’animo del giovane Törless un vuoto. E da questo nulla, da questo vuoto che sentiva in sé egli capì che non gli veniva a mancare un semplice struggimento ma qualcosa di positivo, una forza interiore, qualcosa che col pretesto della sofferenza s’era sviluppato rigoglioso dentro di lui.
Ma ormai era tutto passato, e quella fonte di una prima eletta beatitudine gli s’era rivelata solo inaridendosi.
In questo periodo scomparvero di nuovo dalle sue lettere i segni appassionati del primo risveglio della sua anima; il loro posto fu preso da descrizioni particolareggiate della vita nell’istituto e dei nuovi amici. Lui, Törless, in questa situazione si sentiva impoverito e spoglio come un alberello che dopo una fioritura ancora senza frutto viva il suo primo inverno.
I genitori, invece, ne furono contenti. Lo amavano di una tenerezza forte, istintiva, animale. Ogni volta che lui tornava dal convitto per una vacanza, alla moglie del consigliere la casa appariva, dopo, di nuovo morta e vuota, e nei giorni che seguivano ognuna di quelle visite lei si aggirava per le stanze con le lacrime agli occhi, carezzando qua e là un oggetto che il suo ragazzo aveva tenuto tra le dita o su cui aveva posato l’occhio. Tutt’e due si sarebbero lasciati fare a pezzi per lui.
La goffa tenerezza e l’appassionata, caparbia afflizione delle sue lettere li impensierì e provocò in loro un’esaltazione sentimentale; la serena e soddisfatta superficialità che venne poi rallegrò anche loro; pensando che fosse il segno del superamento di una crisi la favorirono quanto più poterono. Né l’una né l’altra apparvero loro il sintomo di una precisa evoluzione psicologica: al contrario, essi accolsero sia la pena che l’acquietamento come una naturale conseguenza di quello stato di cose. Sfuggì loro che s’era trattato del primo, fallito tentativo dell’adolescente lasciato a se stesso di dispiegare le proprie energie interiori.
 Scena del film del 1966 tratto dal libro di Musil
Scena del film del 1966 tratto dal libro di Musil
E’ la parte iniziale del romanzo, ma che ci fa già capire quali saranno le linee entro le quali l’autore svilupperà la sua narrazione: dapprima ci si mostra un ragazzo alla fermata di un treno con una madre apprensiva che lo lascia partire per la prima volta in un collegio esclusivo e all’interno della stazione Törless nota che le cose e le persone avevano un’aria apatica, fiacca e meccanica, quasi fossero uscite dallo scenario d’un teatro di burattini (sembra quasi che la percezione del giovanissimo protagonista riesca a cogliere l’apatia alienante dei viaggiatori, scoprendo in lui una capacità d’osservazione critica); passa quindi a sottolineare l’esclusività del luogo, per far meglio risaltate, durante la lettura come esso sia un microcosmo pieno d’ipocrisia e violenza. La pagina continua con le sue prime “fanciullesche” impressioni, lette come nostalgia per le figure genitoriali per poi colpirci con la repentina mutabilità psicologica per cui Questo ricordo svanì presto, come un’eco che avesse vibrato solo per un breve tratto, per lasciare un vuoto, vuoto che Törless dovrà imparare a riempire e che gli permetterà di dispiegare le proprie energie interiori.
I turbamenti del giovane Törless (ci piace pensarlo come il fratello di Tonio Kröger di Mann) è un Bildungsroman (romanzo di formazione) il cui protagonista è un giovane della borghesia tedesca: egli svilupperà un forte rapporto conflittuale con i genitori (a dimostrazione di un fallimento delle strategie educative di quella nazione); infatti ne hanno fatto un giovane debole di carattere che non saprà dir di no a violenze e ad aberrazioni anche sessuali verso i più deboli, ma anche con una profondità introspettiva che gli faranno capire il non senso di tale azioni, che lo porteranno infine ad abbandonare il collegio.
Sembra proprio che la letteratura di lingua tedesca rifletta sulla separazione tra il mondo degli adulti contenti del loro raggiunto benessere borghese e quello dei giovani che si sente rispetto ad esso estraneo, lontano, alienato, quasi percepisse la strage che di lì a poco avrebbero proprio loro pagato a caro a prezzo.
Ma il capolavoro di Musil è L’uomo senza qualità (1930, 1933, 1943):
 Edizione originale di Der Mann ohne Eigenschaften (L’uomo senza qualità)
Edizione originale di Der Mann ohne Eigenschaften (L’uomo senza qualità)
Il filo conduttore del complesso romanzo, che si articola intorno a tre temi centrali, è Ulrich, uomo senza qualità in quanto proteso verso tutte le possibilità intellettuali e quindi vanamente impegnato a costruire il senso della propria esistenza. Costui, un colto ex ufficiale, verso nella matematica, viene eletto segretario di un comitato di aristocratici messo in piedi per organizzare le celebrazioni del giubileo di Francesco Giuseppe nel 1913. La cosa però si trascina per le lunghe e finirà per risolversi in un clamoroso fiasco. In questo filone principale sono inserite varie storie individuali, come il racconto della crisi familiare di Walter e Clarissa, che finirà con l’impazzire (prima parte), e quello del complesso legame che unisce Ulrich alla sorella Agathe, unica persona capace di influenzare il paralizzante relativismo e possibilismo del fratello (terza parte); o vicende di più ampio significativo sociale, come il caso, che affascina Ulrich, del condannato a morte Moosbrugger, o la descrizione della decadenza dell’impero asburgico, chiamato ironicamente Kakania, e della stessa società borghese (seconda parte).
UN SENTIMENTO STRANISSIMO
Ma mentre l’assurda vanità di tutti gli sforzi di cui si era gloriato lo commoveva quasi fino alle lacrime, lo sorprese nello stato di veglia notturna in cui si trovava, o sarebbe meglio dire lo sopraffece, un sentimento stranissimo. In tutte le stanze splendevano ancora i lumi che Clarisse, mentre era sola, aveva acceso dappertutto, e l’eccesso di luce inondava le pareti e gli oggetti, riempiendo lo spazio di qualcosa di vivo. E forse era la tenerezza contenuta in ogni stanchezza indolore che trasformava l’insieme delle sue sensazioni fisiche, perché quella consapevolezza del proprio corpo, sempre presente benché non curata, e ad ogni modo delimitata solo vagamente, trapassava ad uno stato più molle e più largo. Era un allenamento, come se si fosse slegato un laccio troppo stretto; e giacché nelle pareti e negli oggetti nulla v’era di realmente mutato, e nessun Dio entrava nella dimora di quell’infedele e Ulrich stesso rinunziava alla sua lucidità di giudizio (fin dove la stanchezza non l’ingannava) voleva dire che soggetto a quella trasformazione poteva essere soltanto il rapporto tra lui e l’ambiente, e di quel rapporto, a sua volta, non il lato oggettivo, né i sensi e la ragione che gli si adeguano oggettivamente; la metamorfosi era quella di un sentimento profondo come le acque del sottosuolo, sul quale questi pilastri della percezione oggettiva e del pensiero poggiavano di solito, mentre ora smossi, si allontanavano oppure si avvicinavano: questa distinzione infatti aveva perso nel momento stesso ogni significato. «E’ un altro comportamento, io subisco una metamorfosi, e quindi anche le cose che stanno in relazione con me!» pensò Ulrich, che credeva di osservarsi bene. Ma si sarebbe potuto anche dire che la sua solitudine – uno stato che si trovava non soltanto in lui ma anche intorno a lui e che quindi univa l’uno e l’altro – si sarebbe potuto dire, e lo sentiva lui stesso, che tale solitudine diventava sempre più fitta e sempre più grande. Passava attraverso i muri, invadeva la città, senza tuttavia allargarsi, invadeva il mondo. «Quale mondo?» egli pensò «Il mondo non esiste!» Gli pareva che quel concetto non avesse più senso. Ma si sorvegliava ancora abbastanza da sentire in pari tempo che quell’espressione esagerata era sgradevole; non cercò altre parole, al contrario, da allora si riavvicinò alla lucidità piena e dopo pochi secondi si mise in moto. Il giorno spuntava e mescolava il suo lividore alla chiarità sempre più smorta della luce artificiale che moriva rapidamente.
“Il brano ci mostra Ulrich passare ad un altro strato di coscienza, rispetto al quale è lui a comportarsi da strumento e non viceversa. I legami ai quali la sua percezione obbediva sembrano allentarsi; il suo corpo non appare più solidale con il dominio dello spazio e del tempo: quel che cambia è la sensazione che costituisce la base fra il nostro corpo e l’ambiente intorno, con la conseguenza che la percezione e pensiero non si disttinguono più: la percezione si spiritualizza e il pensiero diventa percettivo: E se tanto Ulrich quanto le cose intorno a lui sono avvolte nella solitudine che non permette un contatto vero, pare però che qualcosa nei rapporti possa cambiare: la solitudine ingigantisce e questo è già un modo incipiente per riappropriarsi del mondo da creatore. Nella trasformazione di Ulrich si trasforma anche tutto ciò che lo circonda e con cui viene in rapporto. Poi una sua critica espressione verbale rompe l’incantesimo. Il proseguimento interpreta quel nuovo stato di coscienza: si trattato di un momento mistico, in cui le distinzioni fra le cose perdono significato e ci si trova nel cuore del mondo senza volontà di dominarlo e senza quella volontà di possesso che nasce dalla sfera dell’avarizia e della voracità.” (Enrico De Angelis).
UNA BELLA GIORNATA DI AGOSTO
Sull’Atlantico un minimo barometrico avanza in direzione orientale incontro a un massimo incombente sulla Russia, e non mostrava per il momento alcuna tendenza a schivarlo spostandosi verso nord. Le isoterme e le isòtere si comportavano a dovere. La temperatura dell’aria era in rapporto normale con la temperatura media annua, con la temperatura del mese più caldo come quella del mese più freddo, e con l’oscillazione mensile aperiodica. Il sorgere e il tramontare del sole e della luna, le fasi della luna, di Venere, dell’anello di Saturno e molti altri importanti fenomeni si succedevano conforme alle previsioni degli annuari astronomici. Il vapore acqueo nell’aria aveva la tensione massima, e l’umidità atmosferica era scarsa. Insomma, con una frase che quantinque un po’ antiquata riassume benissimo i fatti: era una bella giornata d’agosto dell’anno 1913.
 Jack Visser: Der Mann ohne Eigenschaften (2013)
Jack Visser: Der Mann ohne Eigenschaften (2013)
In Musil non vi è solo la crisi dell’uomo contemporaneo al quale mancano punti di riferimento certi con cui identificarsi, facendo sì che la coscienza (propria) e la percezione (dell’esterno) si trovino completamente confuse, ma vi è anche una rivoluzione linguistica che tale confusione deve registrare. Ed è così che in questo brano la lingua non può registrare una sensazione, che basata su un’individuale percezione perde la sua capacità informativa: infatti se il mondo è sempre più complesso e stratificato, formato da miriadi singolari di percezioni, la lingua che lo rappresenta non può che risultare antiquata, e pertanto lo deve fare con l’unico strumento della lingua ancora possibile in quanto capace di andare al di là della singolarità percettiva e questa lingua è quella tecnica e scientifica.
Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke nasce a Praga nel 1875, conterraneo quindi dell’amato Kafka, di cui fu un attento lettore. Ma se la città boema per l’autore de La metamorfosi fu il luogo in cui visse e morì, per Rilke fu il punto di partenza che fecero di lui più un apolide, trovando la patria solo dentro se stesso. Viaggiò molto infatti: conosciuta Lou Andres Salomé, letterata russa già amante di Nietzsche, andò in Russia dove conobbe il vecchio Tolstoj e Pasternak, quindi si spostò a Parigi, lavorando per l’artista Rodin. Non pago toccò paesi come l’Egitto, la Spagna, la Svezia, la Danimarca, l’Italia e la Svizzera. La sua attività letteraria lo porta ad esprimersi soprattutto nella poesia, dando vita a diversi capolavori come le Elegie duinesi, iniziate dal 1912 ma pubblicate nel 1922) e i Sonetti ad Orfeo, scritti in Svizzera nel 1923. Muore per leucemia nel 1926.
Del 1910 è il suo romanzo Quaderni di Malte Laurids Brigge.
Il protagonista, un giovane intellettuale inquieto, va ad abitare, malato e solo, a Parigi. Vi sperimenta la paura, la solitudine, la miseria, ma impara a vedere le cose, che mostrano certe parvenze per poi fluire in altre in un flusso continuo. E’ attratto dai derelitti, dai dementi e dai miserabili che finiscono col dare alla città contorni ossessivi e allucinati. Annota in un suo diario sogni e incubi, reminiscenze all’infanzia, momenti felici e dolorosi. Su tutto prevale il senso della morte e la ricerca di Dio.
ECCO, ANCORA, TUTTE LE PAURE DIMENTICATE
Ed ecco ancora di nuovo, quella malattia che mi ha sempre colpito in modo così singolare. Sono sicuro che non se ne valuta tutta la gravità, mentre invece si esagera l’importanza delle altre. Non ha nessuna caratteristica propria – ma assume quelle delle persone che attacca. Con una sicurezza da sonnambula fruga nel nostro profondo per trarne fuori il più riposto pericolo: sembrava superato – e ce lo pone nuovamente dinanzi, vicinissimo, nell’ora imminente. Uomini che, nella loro pubertà, sperimentarono il più desolato, forse, dei vizi, di cui inconsapevoli complici sono le povere e dure mani adolescenti – se lo trovano ancora davanti; ecco, di nuovo, una malattia già vinta nella fanciullezza; oppure si ripresenta un’abitudine dimenticata, un certo modo esitante di voltare il capo, come si faceva anni prima. E insieme con quanto ritorna ecco alzarsi una selva di confusi ricordi che si avviticchiano al tutto come un viscido fuco intorno a un oggetto sommerso.
Vite di cui non avremo saputo mai nulla salgono alla superficie confondendosi con le cose realmente accadute – e cancellano così un passato che presumevamo conoscere; perché in quello che risale è una nuova e riposata forza – mentre il resto è stanco degli appelli troppo ripetuti.
Sono disteso al letto, al mio quinto piano, – e il giorno da nulla interrotto, è simile a un quadrante senza sfere. Come una cosa a lungo creduta smarrita si trova intatta una mattina al suo posto, forse più nuova che il giorno della perdita, quasi qualcuno l’avesse curata: così, sulla coperta del mio letto sono sparse cose perdute della mia fanciullezza – che sono come nuove. Ecco, ancora, tutte le paure dimenticate.
La paura che un piccolo filo di lana uscente dall’orlo della coperta sia rigido e aguzzo come un ago; la paura che questo piccolo bottone della camicia da notte sia più grande della mia testa, più grande e pesante; la paura che questa briciola di pane, in procinto di cadere dal letto, diventi diventi di vetro e si frantumi nel raggiungere il sulo – e il pensiero angoscioso che con lei tutto vada in frantumi, tutto e per sempre; la paura che l’estremità lacerata di una busta sia qualche cosa di proibito che nessuno deve vedere, qualche cosa di indicibilmente prezioso per cui nessun posto è sicuro nella stanza; la paura di ingoiare, nell’addormentarmi, quel pezzo di carbone che è lì davanti alla stufa; la paura che nel mio cervello cominci a crescere una cifra qualsiasi, fino a non trovarvi più spazio; la paura che il letto in cui sono disteso sia di granito, di scuro granito; la paura di poter gridare e che accorrano alla mia porta e che infine l’abbattano; la paura di tradirmi e di dire tutto quello che mi spaventa – e la paura di non potere dire nulla perché tutto è indicibile – e tutte le altre paure… le paure.
Ho pregato per ritrovare la mia infanzia: è ritornata, è sento che è sempre dura come una volta e che a nulla è servito invecchiare.
 Paula Modersohn-Becker, Porträt Rainer Maria Rilke, 1906
Paula Modersohn-Becker, Porträt Rainer Maria Rilke, 1906
E’ evidente dal passo che abbiamo riportato che la prosa di Rilke sia ispirata all’espressionismo: immagini forti, oniriche, malate come lo stesso protagonista del romanzo (fortemente autobiografico) che s’immagina in una Parigi disumanizzata. Infatti potremo dire che Malte, intellettuale danese, attraverso raffigurazioni oserei dire pittoriche evocando un’infanzia pieni di terrori, li riporti in vita, li senta ancora propri; il vivere non ha portato maggiore autonomia intellettiva, ma maggiore consapevolezza del male all’interno dell’uomo, che Rilke, come altri autori del primo Novecento, riporta con quello che nell’irlandese Joyce sarà lo stream of consciousness.
Opere in lingua inglese
James Joyce
James Joyce è il più radicale, almeno nel suo capolavoro l’Ulisse, sperimentatore delle capacità espressive del linguaggio, tanto da fare di quest’opera il punto più alto delle avanguardie di primo Novecento.

Nasce a Dublino nel 1882. Importante è la figura del padre, autoritario ma al contempo scialacquatore e gran bevitore, che gli fornirà il ritratto di alcuni importanti personaggi dei suoi racconti. Riceve una rigida educazione cattolica, che rifiuterà negli anni universitari. Incontra Nora Bernacle, compagna di una vita, e che lei si sposta dapprima a Parigi, quindi in Italia (Joyce si dimostrerà sin da giovane età amante della letteratura italiana), dove prima a Roma quindi a Trieste conoscerà Italo Svevo, promuovendone anche l’attività letteraria. Pubblica nel 1914 Gente di Dublino, ma a già precedentemente aveva cominciato a scrivere abbozzando un racconto Stephen Hero che diventerà nel 1917 Ritratto di un artista da giovane. Allo scoppio della guerra si rifugia in Svizzera, quindi a Parigi dove, per l’interessamento di intellettuali come Pound, Eliot e Yeats, riuscirà a pubblicare la sua opera più importante l’Ulisse (1922). Non passerà una bella vecchiaia: la sempre maggiore incapacità visiva, la schizofrenia della figlia Lucia (affidata a Jung), il problema dell’alcolismo lo accompagneranno nella stesura dell’ultima opera La veglia di Finnegam (1939). Morirà nel 1941.
Gente di Dublino, (Dubliners), sono 15 racconti, scritti tra il 1904 e il 1907, ma pubblicati nel 1914. La sua struttura è unitaria: tre racconti dell’infanzia, quattro dell’adolescenza, quattro della maturità, tre su Dublino e l’ultimo che sembra racchiuderli tutti, I morti.
E’ la storia di una notte in prossimità del Natale: le signorine Kate e Julia Morgan organizzano un ballo ed una cena a cui partecipano anche Gregor e la moglie Gretta; dopo aver descritto i partecipanti la storia si sofferma su questa coppia di giovani sposi:
I MORTI

Gabriel non era andato alla porta con gli altri. Era in una parte scura dell’ingresso e teneva gli occhi fissi sulle scale. C’era una donna in piedi vicino alla cima della prima rampa, anche lei nell’ombra. Non ne vedeva il viso ma vedeva i pannelli terra cotta e rosa salmone della gonna che l’ombra faceva sembrare neri e bianchi. Era sua moglie. Era appoggiata alla ringhiera e ascoltava qualcosa. Gabriel era stupito della sua immobilità e tese l’orecchio per ascoltare anche lui. Ma udiva poco tranne il rumore di risa e di discussioni sui gradini della facciata, qualche accordo suonato sul pianoforte e qualche nota di una voce maschile che cantava.
Rimase immobile nel buio dell’ingresso, cercando di afferrare l’aria che la voce cantava e tenendo gli occhi fissi sulla moglie. C’era grazia e mistero nell’atteggiamento di lei come se fosse un simbolo di qualcosa. Si chiese di cosa è simbolo una donna in piedi sulle scale nell’ombra, che ascolta una musica lontana. Fosse stato un pittore l’avrebbe dipinta in quell’atteggiamento, il cappello di feltro blu avrebbe messo in risalto il bronzo dei capelli contro l’oscurità e i pannelli scuri della gonna avrebbero messo in risalto i chiari. Musica lontana avrebbe chiamato il quadro se fosse stato un pittore.
La porta d’ingresso venne chiusa e zia Kate, zia Julia e Mary Jane vennero avanti nell’ingresso, ridendo ancora: «Be’, non è terribile Freddy?» disse Mary Jane. «È veramente terribile.»
Gabriel non disse niente, ma indicò le scale nella direzione dov’era la moglie. Ora che la porta d’ingresso era chiusa, la voce e il pianoforte si udivano più chiaramente. Gabriel alzò la mano perché tacessero. La canzone sembrava essere nell’antica tonalità irlandese e il cantante sembrava incerto sia nelle parole sia nella voce. La voce, resa lamentosa dalla lontananza e dalla raucedine del cantante, illuminava debolmente il ritmo dell’aria con parole che esprimevano dolore:
Cade la pioggia sui miei ricci grevi
E di rugiada son bagnata tutta,
Freddo giace il mio bimbo…
«Oh» esclamò Mary Jane. «È Bartell D’Arcy che canta, e non ha voluto cantare tutta la sera. Ah, gli farò cantare una canzone prima che se ne vada.»
«Oh, sì, Mary Jane» disse zia Kate.
Mary Jane passò davanti agli altri e corse verso la scala, ma prima che la raggiungesse il canto si fermò e il pianoforte venne chiuso bruscamente.
«Oh, che peccato! » gridò. «Sta scendendo, Gretta?»
Gabriel udì la moglie rispondere di sì e la vide scendere verso di loro. A pochi passi la seguivano il signor Bartell D’Arcy e la signorina O’Callaghan.
«Oh, signor D’Arcy» gridò Mary Jane «è una vera cattiveria interrompersi così quando eravamo tutti in estasi ad ascoltarla.»
«Gli sono stata dietro tutta la sera» disse la signorina O’Callaghan «e la signora Conroy pure, e ci ha detto che ha uno spaventoso raffreddore e che non può cantare.»
«Oh, signor D’Arcy» disse zia Kate «che grosse frottole racconta.»
«Ma non vede che sono rauco come una cornacchia?» disse il signor D’Arcy sgarbato.
Entrò nella dispensa in fretta e si infilò il cappotto. Gli altri, presi alla sprovvista dalle parole scortesi, non trovarono niente da dire. Zia Kate corrugò la fronte e fece segno agli altri di cambiare argomento. Il signor D’Arcy, in piedi, si avviluppava il collo accuratamente aggrottando le ciglia.
«E’il tempo» disse zia Julia, dopo una pausa. «Sì, tutti hanno il raffreddore» disse zia Kate prontamente «tutti.»
«Dicono» disse Mary Jane «che non abbiamo avuto una neve simile da trent’anni, e ho letto stamattina nei giornali che c’è neve in tutta l’Irlanda.»
«Amo tanto vedere la neve» disse zia Julia tristemente.
«Anch’io» disse la signorina O’Callaghan.
«Secondo me Natale non è mai veramente Natale se non c’è la neve.»
«Ma al povero signor D’Arcy la neve non piace» disse zia Kate, sorridendo.
Il signor D’Arcy uscì dalla dispensa, completamente avviluppato e abbottonato, e in tono pentito raccontò la storia del suo raffreddore. Tutti gli dettero consigli e dissero che era un gran peccato e lo esortarono a stare molto attento alla sua gola nell’aria notturna. Gabriel osservava la moglie, che non prendeva parte alla conversazione. Stava in piedi proprio sotto la lunetta polverosa e la fiamma del gas illuminava il bronzo vivido dei capelli, che le aveva visto asciugare al fuoco qualche giorno prima. L’atteggiamento era lo stesso e sembrava inconsapevole della conversazione intorno a lei. Alla fine si voltò verso di loro e Gabriel vide che aveva le guance colorite e gli occhi lucidi.
Dal cuore gli scaturì un’improvvisa ondata di gioia. «Signor D’Arcy» disse lei «come si chiama quella canzone che stava cantando?»
«Si chiama La fanciulla di Aughrim» disse il signor D’Arcy «ma non riuscivo a ricordarla bene. Perché? La conosce?»
«La fanciulla di Aughrim» lei ripeté. «Non riuscivo a ricordarne il nome.»
«E’ un’aria molto bella» disse Mary Jane. «Mi dispiace che lei fosse giù di voce stasera.»
«Su, Mary Jane» disse zia Kate «non seccare il signor D’Arcy. Non voglio che sia seccato.»
Vedendo che tutti erano pronti a partire li accompagnò alla porta, dove si augurarono la buona notte.
«Bene, buona notte, zia Kate, e grazie per la piacevole serata.»
«Buona notte, Gabriel. Buona notte, Gretta!»
«Buona notte, zia Kate, e grazie infinite. Buona notte, zia Julia.»
«Oh, buona notte, Gretta, non ti avevo vista.»
«Buona notte, signor D’Arcy. Buona notte, signorina O’Callaghan.»
«Buona notte, signorina Morkan.»
«Ancora buona notte.»
«Buona notte a tutti. Tornate a casa sani e salvi.»
«Buona notte. Buona notte.»
Il mattino era ancora buio. Un’opaca luce gialla covava sopra le case e il fiume; e il cielo sembrava abbassarsi. Per terra era fangoso, e sui tetti, sui parapetti del molo e sulle ringhiere dei seminterrati c’erano solo strisce e chiazze di neve. I lampioni mandavano ancora una luce rossa nell’aria scura e, dall’altra parte del fiume, il palazzo di giustizia si stagliava minaccioso contro il cielo plumbeo.
Lei camminava davanti con il signor Bartell D’Arcy, con le scarpe sottobraccio in un pacchetto marrone e le mani che sollevavano la gonna dalla fanghiglia. Non aveva più grazia di atteggiamento, ma gli occhi di Gabriel brillavano ancora di felicità. Il sangue gli scorreva a balzi nelle vene e i pensieri gli attraversarono in tumulto il cervello, orgogliosi, allegri, teneri, pieni di valore.
Lei camminava davanti così agile e così dritta che moriva dal desiderio di correrle dietro silenziosamente, afferrarla per le spalle e dirle qualcosa di sciocco e di affettuoso all’orecchio. Gli sembrava così fragile che desiderava difenderla contro qualcosa e poi rimanere solo con lei. Attimi della loro vita segreta insieme gli esplosero come stelle nella memoria. Una busta colore eliotropio stava accanto alla sua tazza della colazione e lui la carezzava con la mano. Gli uccelli cinguettavano nell’edera e la trama piena di sole della tenda mandava riflessi lungo il pavimento: non riusciva a mangiare dalla felicità. Erano in piedi sulla banchina affollata e lui le metteva un biglietto nel palmo caldo del guanto. Era in piedi con lei nel freddo, guardando attraverso la grata di una finestra un uomo che faceva bottiglie in una fornace ruggente. Era molto freddo. Il viso di lei, fragrante nell’aria fredda, era molto vicino al suo e improvvisamente lui gridò all’uomo alla fornace: «È caldo il fuoco, signore?».
Ma l’uomo non poteva udire per via del rumore della fornace. Tanto meglio. Avrebbe potuto rispondere sgarbatamente. Un’ondata di gioia ancora più tenera gli sfuggì dal cuore e gli scorse come un caldo flusso nelle arterie. Come il tenero fuoco di stelle attimi della loro vita insieme, di cui nessuno sapeva o avrebbe mai saputo, si scagliarono sulla sua memoria illuminandola. Desiderava rammentarle quegli attimi, farle dimenticare gli anni della noiosa vita in comune e ricordarle soltanto gli attimi di estasi. Perché gli anni, sentiva, non avevano spento la sua anima o quella di lei. I bambini, lo scrivere, le cure della famiglia non avevano spento tutto il tenero fuoco delle loro anime. In una lettera che le aveva scritto allora aveva detto: «Come mai parole come queste mi sembrano tanto fiacche e fredde? Forse perché non esiste per il tuo nome parola abbastanza tenera?».
Le parole scritte anni prima gli giunsero dal passato come una musica lontana. Moriva dal desiderio di rimanere solo con lei. Quando, andati via gli altri, lui e lei sarebbero stati nella loro camera in albergo, allora sarebbero stati soli insieme. L’avrebbe chiamata dolcemente: «Gretta!» Forse non avrebbe udito subito: si stava svestendo. Poi qualcosa nella sua voce l’avrebbe colpita. Si sarebbe voltata e lo avrebbe guardato…
All’angolo di via Winetavern trovarono una vettura. Era contento del fracasso che faceva perché gli impediva di conversare. Lei guardava fuori del finestrino e sembrava stanca. Gli altri dissero solo poche parole, indicando qualche edificio o strada. Il cavallo galoppava stracco sotto lo scuro cielo mattutino, trascinandosi dietro gli zoccoli la vecchia cassetta rumorosa, e Gabriel era di nuovo in vettura con lei, galoppando per prendere la nave, galoppando verso la loro luna di miele.
Mentre la vettura attraversava il ponte O’Connell, la signorina O’CalIaghan disse: «Dicono che non si attraversa mai il ponte O’Connell senza vedere un cavallo bianco».
«Vedo un uomo bianco stavolta» disse Gabriel.
«Dove?» chiese il signor Bartell D’Arcy.
Gabriel indicò la statua, su cui c’erano chiazze di neve. Poi la salutò familiarmente con un cenno della testa e agitò la mano.
«Buona notte, Dan» disse allegro.
Quando la vettura si fermò davanti all’albergo, Gabriel saltò giù e, malgrado le proteste del signor Bartell D’Arcy, pagò il conducente. Dette all’uomo uno scellino in più della tariffa.
L’uomo salutò e disse: «Un felice anno nuovo, signore».
«Anche a lei» disse Gabriel cordialmente.
Lei si appoggiò un istante al suo braccio uscendo dalla vettura e mentre stavano in piedi ai margini del marciapiede, augurando agli altri la buona notte. Si appoggiava leggera al suo braccio, leggera come quando aveva ballato con lui poche ore prima. Si era sentito orgoglioso e felice allora, felice che fosse sua, orgoglioso della sua grazia e del suo portamento di moglie. Ma ora, dopo il riaccendersi di tanti ricordi, il primo contatto con quel corpo, armonioso e strano e profumato, gli trasmise un’acuta fitta di sensualità. Con il pretesto del silenzio di lei si strinse quel braccio contro il fianco e, mentre stavano sulla porta dell’albergo, sentì che erano sfuggiti alle loro vite e ai loro doveri, sfuggiti alla casa e agli amici e scappati insieme con cuori selvaggi e radiosi verso una nuova avventura.
Un vecchio sonnecchiava in una poltrona a cupola nell’ingresso. Accese una candela nell’ufficio e li precedette alle scale. Lo seguirono in silenzio, e i loro piedi ricadevano con tonfi attenuati sulle scale coperte da uno spesso tappeto. Lei salì le scale dietro il portiere, chinando la testa mentre saliva, con le fragili spalle curve come sotto un peso e la gonna che la fasciava stretta. Avrebbe voluto circondarle i fianchi con le braccia tenendola ferma, perché le braccia gli tremavano dal desiderio di afferrarla e soltanto premendo le unghie contro le palme della mano tenne a freno l’impulso selvaggio del corpo. Il portiere si fermò sulle scale per sistemare la candela che colava. Si fermarono anche loro, sui gradini sotto. Nel silenzio Gabriel udiva cadere la cera liquefatta nel piattino e il battere tumultuoso del proprio cuore contro le costole.
Il portiere li guidò lungo un corridoio e aprì una porta. Poi depose la candela instabile su un tavolo da toletta e chiese a che ora volevano essere chiamati la mattina.
«Alle otto» disse Gabriel.
Il portiere indicò l’interruttore della luce elettrica e cominciò a borbottare una scusa, ma Gabriel tagliò corto.
«Non abbiamo bisogno di luce. Abbiamo abbastanza luce dalla strada. E senta» aggiunse, indicando la candela «porti pure via quel bell’oggetto, da bravo. »
Il portiere riprese la sua candela, ma lentamente, perché era stupito da un’idea così insolita. Poi mormorò buona notte e uscì. Gabriel tirò il paletto.
Dalla strada la luce spettrale del lampione si estendeva in una lunga lama da una finestra alla porta. Gabriel gettò cappotto e cappello su un divano e attraversò la stanza in direzione della finestra. Guardò giù nella strada in modo da lasciare calmare un po’ la sua emozione. Poi si volse appoggiandosi a un cassettone con la schiena alla luce. Lei si era tolta cappello e mantello e stava in piedi di fronte a un grande specchio girevole, sganciandosi il corpetto. Gabriel attese qualche istante, osservandola, poi disse: «Gretta!».
Lei distolse lentamente gli occhi dallo specchio e camminò lungo la lama di luce verso di lui. Il suo viso sembrava così serio e stanco che le parole non vollero uscire dalle labbra di Gabriel. No, non era ancora il momento.
«Sembravi stanca» disse.
«Lo sono un poco» rispose.
«Ti senti male o debole?»
«No, stanca: ecco tutto.»
Continuò verso la finestra e rimase lì, guardando fuori. Gabriel aspettò di nuovo, poi, temendo di essere sopraffatto dalla sfiducia, disse bruscamente: «A proposito, Gretta!».
«Che c’è?»
«Sai quel povero diavolo di Malins?» disse rapidamente.
«Sì. Che gli succede?»
«Be’, povero diavolo, è una brava persona, dopo tutto» continuò Gabriel con voce falsa. «Mi ha restituito quella sterlina che gli avevo prestato e non me l’aspettavo, veramente è un peccato che non voglia stare alla larga da quel Browne, perché non è un cattivo diavolo, veramente.»
Tremava adesso dall’irritazione. Perché sembrava così astratta? Non sapeva come cominciare. Era irritata, anche lei, per qualcosa? Se solo si fosse voltata o fosse venuta verso di lui spontaneamente! Prenderla com’era sarebbe stato brutale. No, doveva vederle un po’ d’ardore negli occhi prima. Moriva dal desiderio di dominare quello strano stato d’animo.
«Quando gli hai prestato la sterlina?» lei chiese, dopo una pausa.
Gabriel fece uno sforzo per trattenersi dallo scoppiare in parole brutali su quell’ubriacone di Malins e la sua sterlina. Moriva dal desiderio di gridarle dalla sua anima, di schiacciare quel corpo contro il suo, di dominarla. Ma disse: «Oh, a Natale, quando ha aperto quel negozietto di cartoncini natalizi, a via Henry».
Aveva addosso una tale febbre di rabbia e di desiderio che non la udì venire dalla finestra. Rimase in piedi davanti a lui per un istante, guardandolo in modo strano. Poi, alzandosi improvvisamente sulla punta dei piedi e appoggiandogli leggermente le mani sulle spalle, lo baciò. «Sei una persona molto generosa, Gabriel» disse.
Gabriel, tremando di gioia per l’improvviso bacio e la Jsingolarità della frase, le mise le mani sui capelli e cominciò a lisciarglieli indietro, toccandoli appena con le dita. La lavata li aveva resi fini e brillanti. Il cuore gli traboccava di felicità. Proprio quando lo desiderava era venuta da lui spontaneamente. Forse i pensieri di lei avevano seguito lo stesso corso dei suoi. Forse aveva sentito il suo violento desiderio e questo l’aveva resa incline all’abbandono. Ora che gli aveva ceduto così facilmente, si domandò il perché della sua sfiducia. Rimase in piedi, tenendole la testa fra le mani. Poi, facendole scivolare svelto un braccio intorno al corpo e attirandola a sé, disse dolcemente: «Gretta, cara, a che stai pensando?».
Non rispose né si abbandonò del tutto al suo braccio. Disse di nuovo, dolcemente: «Dimmi che c’è, Gretta. Credo di sapere cosa hai. Lo so?».
Non rispose subito. Poi disse scoppiando in lacrime: «Oh, sto pensando a quella canzone, La fanciulla di Aughrim».
Gli sfuggì e corse al letto e, gettando le braccia sulla spalliera di ferro, nascose il viso.
Gabriel per lo stupore rimase completamente immobile un attimo, poi la seguì. Mentre passava davanti allo specchio si vide dalla testa ai piedi, con lo sparato della camicia largo e ben teso, il viso la cui espressione lo rendeva sempre perplesso quando la vedeva in uno specchio e gli occhiali scintillanti dalla montatura dorata. Si fermò a qualche passo da lei e disse: «Perché la canzone? Come mai ti fa piangere?».
Lei sollevò la testa dalle braccia e si asciugò gli occhi con il dorso della mano come una bambina. Nella sua voce si insinuò una nota più gentile di quel che intendesse. «Come mai, Gretta?» chiese.
«Sto pensando a una persona che tanto tempo fa cantava quella canzone.»
«E chi era la persona di tanto tempo fa?» chiese Gabriel, sorridendo.
«Era una persona che conoscevo a Galway quando vivevo con la nonna» disse.
Il sorriso scomparve dal viso di Gabriel. Un’ira soffocata ricominciò ad accumularglisi in fondo alla mente e i fuochi soffocati della sensualità cominciarono ad avvampargli irosi nelle vene.
«Qualcuno di cui eri innamorata?» chiese ironico.
«Era un ragazzo che conoscevo» rispose «che si chiamava Michael Furey. Cantava quella canzone, La fanciulla di Aughrim. Era molto delicato.»
Gabriel tacque. Non voleva pensasse che quel ragazzo delicato lo interessava.
«Riesco a vederlo così chiaramente» lei disse, dopo un attimo. «Che occhi aveva: occhi grandi, scuri! E con una tale espressione… un’espressione!»
«Oh, allora eri innamorata di lui?» disse Gabriel.
«Uscivo a passeggio con lui» disse «quando stavo a Galway.»
Un pensiero attraversò fulmineo la mente di Gabriel. «Forse è per questo che volevi andare a Galway con quella ragazza Ivors?» disse freddamente.
Lei lo guardò e chiese meravigliata: «Perché mai?».
Quegli occhi imbarazzarono Gabriel. Alzò le spalle e disse: «Che ne so? Per vederlo, forse».
Lei in silenzio distolse lo sguardo da lui dirigendolo lungo la lama di luce verso la finestra.
«E’ morto» disse alla fine. «È morto quando aveva solo diciassette anni. Non è terribile morire così giovani?»
«Cos’era?» chiese Gabriel, ancora ironico.
«Era un operaio del gas» disse.
Gabriel si sentì umiliato dall’insuccesso della sua ironia e dall’evocazione dal mondo dei morti di quella figura, un ragazzo che era operaio del gas. Mentre lui era immerso nei ricordi della loro vita segreta insieme, pieno di tenerezza e gioia e desiderio, lei lo paragonava mentalmente a un altro. Lo assalì una vergognosa consapevolezza della propria persona. Si vide come una figura ridicola, una specie di galoppino delle zie, un sentimentale nervoso, bene intenzionato, che arringava persone volgari e idealizzava la sua grossolana sensualità, l’individuo pietoso e fatuo che aveva visto di sfuggita nello specchio. Istintivamente volse ancora di più la schiena alla luce per paura che lei potesse vedere la vergogna che gli ardeva in fronte. Cercò di mantenere il tono di freddo interrogatorio, ma la sua voce quando parlò era umile e indifferente. «Immagino che eri innamorata di questo Michael Furey, Gretta» disse.
«Andavamo molto d’accordo» disse.
La voce era velata e triste. Gabriel, sentendo ora quanto sarebbe stato vano cercare di condurla dove si era proposto, le carezzò una mano e disse, anche lui tristemente: «E di che cosa è morto così giovane, Gretta? Di tisi?».
«Credo che sia morto per me» rispose.
Un vago terrore afferrò Gabriel a questa risposta, come se, nell’ora in cui aveva sperato di trionfare, qualche essere inafferrabile e vendicativo gli venisse contro, radunando forze contro di lui nel suo mondo vago. Ma se ne liberò con uno sforzo della ragione e continuò a carezzarle la mano. Non la interrogò di nuovo, perché sentiva che gli avrebbe parlato di se stessa. La mano era calda e umida: non rispondeva al contatto, ma continuò a carezzarla proprio come aveva carezzato la sua prima lettera quella mattina di primavera.
«Era d’inverno» lei disse «press’a poco al principio dell’inverno, quando stavo per partire da casa della nonna e venire qui al convento. E a quel tempo era malato nel suo appartamentino a Galway e non volevano lasciarlo uscire, e avevano scritto ai suoi a Oughterard. Deperiva, dissero, o qualcosa del genere. Non l’ho mai saputo esattamente.»
Esitò un istante e sospirò. «Poveretto» disse. «Mi voleva molto bene ed era un ragazzo così dolce. Uscivamo insieme, a passeggio, sai, Gabriel, come si usa in provincia. Avrebbe studiato canto se non fosse stato per la sua salute. Aveva una bellissima voce, povero Michael Furey.»
«Bene, e allora?» chiese Gabriel.
«E allora quando venne per me il momento di partire da Galway e venire al convento, stava molto peggio e non mi permisero di vederlo, così gli scrissi una lettera dicendo che andavo a Dublino e sarei tornata in estate e speravo che allora sarebbe stato meglio.»
Esitò un istante per dominare la voce, poi continuò: «Allora la notte prima di partire, stavo in casa di mia nonna a Nun’s Island, facendo le valige, e udii gettare ghiaia contro la finestra. La finestra era così bagnata che non riuscivo a vedere, così corsi giù per le scale com’ero e sgattaiolai fuori da dietro in giardino e lì c’era quel poveretto in fondo al giardino, che rabbrividiva».
«E non gli hai detto di tornare a casa?»
«Lo supplicai di andare a casa subito e gli dissi che sarebbe morto con quella pioggia. Ma lui disse che non voleva vivere. Vedo i suoi occhi talmente bene! Era in piedi in fondo al muro dove c’era un albero.»
«E andò a casa?» chiese Gabriel.
«Sì, andò a casa. Ed ero in convento solo da una settimana quando morì e venne sepolto a Oughterard, di dove erano i suoi. Oh, il giorno che lo seppi, che era morto! » Si fermò, soffocando per i singhiozzi e, sopraffatta dall’emozione, si gettò a viso in giù sul letto, singhiozzando nella trapunta. Gabriel le tenne la mano ancora un attimo, indeciso, poi, timoroso di disturbarne il dolore, la lasciò cadere gentilmente e si diresse piano alla finestra.
Lei dormiva profondamente. Gabriel, appoggiandosi al gomito, contemplò qualche istante senza risentimento i capelli arruffati e la bocca semiaperta, ascoltandone il respiro profondo. Così aveva avuto quell’avventura romantica nella vita: un uomo era morto per amore suo. Pensare ora quale ruolo modesto lui, il marito, aveva interpretato in quella vita non lo faceva quasi più soffrire. La osservò mentre dormiva, come se non avessero mai vissuto insieme come marito e moglie. Gli occhi curiosi si posarono a lungo su quel viso e su quei capelli: e mentre pensava a cosa doveva essere stata allora, al tempo della sua prima bellezza adolescente, una strana, amichevole pietà per lei gli penetrò nell’anima. Non voleva dire nemmeno a se stesso che quel viso non era più bello, ma sapeva che non era più il viso per cui Michael Furey aveva sfidato la morte. Forse non gli aveva raccontato tutta la storia. Gli occhi si spostarono verso la sedia sulla quale lei aveva gettato parte dei vestiti. Il laccio di una sottoveste penzolava fino al pavimento. Uno stivaletto stava dritto, con la parte superiore floscia all’ingiù: l’altro giaceva su un fianco. Si meravigliò del tumulto di emozioni di un’ora prima. Da cosa era derivato? Dalla cena delle zie, dal suo discorso sciocco, dal vino e dal ballo, dall’allegria di quando si erano dati la buona notte nell’ingresso, dal piacere della passeggiata nella neve lungo il fiume. Povera zia Julia! Lei, pure, sarebbe stata presto un’ombra con l’ombra di Patrick Morkan e del suo cavallo. Le aveva colto per un istante quell’aria sofferente sul viso mentre cantava “Abbigliata per le nozze”. Presto, forse, sarebbe stato seduto in quello stesso salone, vestito di nero, con il cappello di seta sulle ginocchia. Le tende sarebbero state tirate e zia Kate, seduta vicino a lui, piangendo e soffiandosi il naso, gli avrebbe raccontato come era morta Julia. Avrebbe cercato qua e là nella mente qualche parola che potesse consolarla, e ne avrebbe soltanto trovate di fiacche e di inutili. Sì, sì: sarebbe accaduto molto presto. L’aria della stanza gli gelò le spalle. Si allungò cautamente sotto le lenzuola stendendosi accanto alla moglie. A uno a uno, stavano tutti diventando ombre. Meglio entrare in quell’altro mondo con audacia, nell’intensa gloria di una passione, che languire e appassire tristemente con gli anni. Pensò a come colei che gli giaceva accanto aveva custodito nel cuore per tanti anni l’immagine degli occhi dell’innamorato, quando le aveva detto che non desiderava vivere. Gli occhi di Gabriel si riempirono di lacrime generose. Non aveva mai provato niente di simile per nessuna donna, ma sapeva che un sentimento come quello doveva essere amore.
Gli occhi gli si riempirono ancora più di lacrime e nella parziale oscurità immaginò di vedere la figura di un giovane in piedi sotto un albero gocciolante. Altre figure erano vicine. La sua anima si era accostata a quella regione dove dimorano le vaste schiere dei morti. Era cosciente, pure non riuscendo a percepirla, della loro esistenza capricciosa e guizzante. La sua identità svaniva in un mondo grigio e inafferrabile: il mondo solido stesso, che quei morti avevano eretto un tempo e in cui avevano vissuto, si dissolveva e dileguava.
Pochi colpetti leggeri sul vetro lo fecero voltare verso la finestra. Aveva ricominciato a nevicare. Guardò assonnato i fiocchi, argentei e scuri, che cadevano obliquamente contro la luce del lampione. Era venuto il momento di mettersi in viaggio verso occidente. Sì, i giornali avevano ragione: c’era neve in tutta l’Irlanda. Cadeva dovunque sulla scura pianura centrale, sulle colline senza alberi, cadeva dolcemente sulla palude di Allen e, più a occidente, cadeva dolcemente nelle scure onde ribelli dello Shannon. Cadeva anche dovunque nel cimitero isolato sulla collina dove Michael Furey era sepolto. Si posava in grossi mucchi sulle croci storte esulle lapidi, sulle lance del cancelletto, sugli sterili spini. La sua anima si abbandonò lentamente mentre udiva la neve cadere lieve nell’universo e lieve cadere, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e i morti.
 La grandezza di questo racconto, considerato come una delle prove più alte dell’intera narrazione novecentesca, sta nell’incredibile capacità nel descrivere oserei dire in modo “realistico” un momento piccolo borghese quale una cena prenatalizia e di averlo disseminato di notazioni che invece lo facevano virare verso un’interpretazione di tipo simbolico. Una di esse è il concetto di “epifania” “come un’illuminazione improvvisa che rivela, a chi lo percepisce o la vive, un senso profondo e remoto di un evento, si tratta di situazioni, gesti, eventi per lo più minimi e insignificanti, nella considerazione abituale e agli occhi distratti degli uomini, che tuttavia, per un concorso particolare di circostante, vengono investiti da un fascio di luce, balzano in primo piano con tutta la loro carica di senso, doloroso e gioioso che sia, e determinano un movimento complesso della coscienza dei personaggi.” (Grosser). La vediamo dapprima investire Gretta: non è ancora l’atto finale, ma è come se una macchina da presa afferrata da Gabriel, riprendesse e “vedesse” la moglie per la prima volta: ascolta una musica e nell’ascoltarla diventa più leggera, radiosa, la melodia ne turba la coscienza. Tuttavia Gabriel, vedendola quasi illuminata, sembra non comprendere questa nuova luce che irradia nell’anima della moglie se non come oggetto di un forte desiderio sessuale che per il momento sembra invaderlo. Ma una volta soli, lui viene a sapere la motivazione per cui Gretta sia stata così sconvolta dalle note di una canzone: nel paese in cui precedentemente viveva quando aveva diciassette anni, un povero operaio del gas gliela cantava. Costui era morto giovane, era malato; ma il giorno prima che lei partisse per Dublino, durante la notte, sfidando il freddo era andato a salutarla. Tale gesto forse ne aveva affrettato la morte. Dopo averlo raccontato a Gabriel, Gretta si addormentò piangendo.
La grandezza di questo racconto, considerato come una delle prove più alte dell’intera narrazione novecentesca, sta nell’incredibile capacità nel descrivere oserei dire in modo “realistico” un momento piccolo borghese quale una cena prenatalizia e di averlo disseminato di notazioni che invece lo facevano virare verso un’interpretazione di tipo simbolico. Una di esse è il concetto di “epifania” “come un’illuminazione improvvisa che rivela, a chi lo percepisce o la vive, un senso profondo e remoto di un evento, si tratta di situazioni, gesti, eventi per lo più minimi e insignificanti, nella considerazione abituale e agli occhi distratti degli uomini, che tuttavia, per un concorso particolare di circostante, vengono investiti da un fascio di luce, balzano in primo piano con tutta la loro carica di senso, doloroso e gioioso che sia, e determinano un movimento complesso della coscienza dei personaggi.” (Grosser). La vediamo dapprima investire Gretta: non è ancora l’atto finale, ma è come se una macchina da presa afferrata da Gabriel, riprendesse e “vedesse” la moglie per la prima volta: ascolta una musica e nell’ascoltarla diventa più leggera, radiosa, la melodia ne turba la coscienza. Tuttavia Gabriel, vedendola quasi illuminata, sembra non comprendere questa nuova luce che irradia nell’anima della moglie se non come oggetto di un forte desiderio sessuale che per il momento sembra invaderlo. Ma una volta soli, lui viene a sapere la motivazione per cui Gretta sia stata così sconvolta dalle note di una canzone: nel paese in cui precedentemente viveva quando aveva diciassette anni, un povero operaio del gas gliela cantava. Costui era morto giovane, era malato; ma il giorno prima che lei partisse per Dublino, durante la notte, sfidando il freddo era andato a salutarla. Tale gesto forse ne aveva affrettato la morte. Dopo averlo raccontato a Gabriel, Gretta si addormentò piangendo.
Michael Frey, il nome dell’operaio, la notte che aveva salutato Gretta aveva gettato della ghiaia nei vetri per mostrare la sua presenza; uno sbruffo di neve sulla finestra illumina ora la coscienza di Gregor (seconda epifania). Il confronto è impietoso, un povero operaio aveva dato la sua vita per amore di Gretta. Lui l’aveva amata con la stessa intensità: no, il suo amore era mediocre e certamente anche lei ne era consapevole. Inevitabilmente il pensiero vaga ora sul mondo dei morti: è meglio morire vivendo una forte passione, piuttosto che condurre una vita insignificante. I morti del passato quindi ci chiamano, ci istigano a cercare dentro noi stessi un significato ulteriore per il nostro vivere, per questo continuiamo a comunicare condividendo insieme il freddo della neve che ci ricopre.
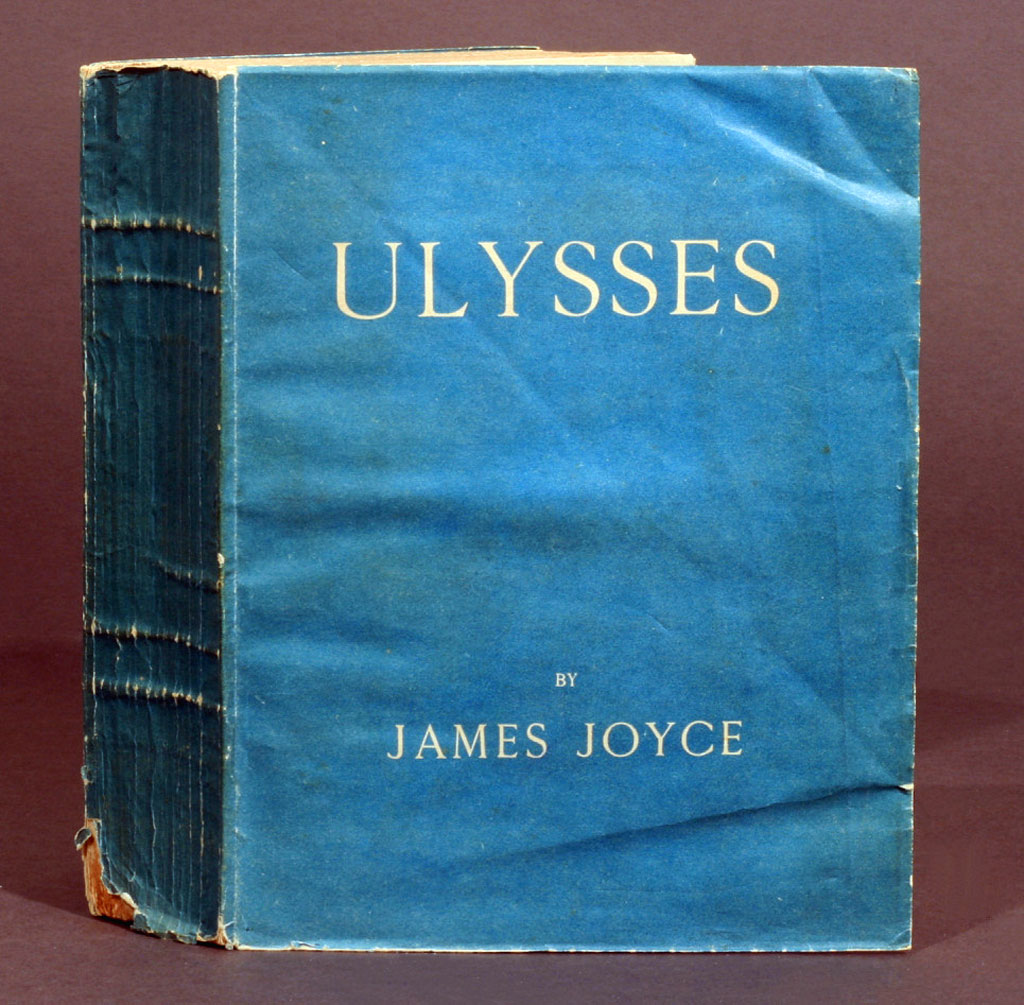 L’Ulisse rappresenta un salto qualitativo non tanto nei contenuti (viene ripresa la descrizione della vita di Dublino), quanto nella tecnica compositiva.
L’Ulisse rappresenta un salto qualitativo non tanto nei contenuti (viene ripresa la descrizione della vita di Dublino), quanto nella tecnica compositiva.
E’ il racconto degli avvenimenti vissuti nel corso di una giornata da Leopold Bloom e Stephen Dedalus a Dublino, in un vagabondaggio che ripercorre le mitiche tappe dell’Odissea: l’uno è alla ricerca inconscia di un figlio che sostituisca quello che gli è morto bambino, l’altro ha bisogno, altrettanto inconsciamente, di una figura paterna che sia per lui punto di riferimento nelle sue inquietudini intellettuali. Stephen lascia la torre dove vive con Mulligan, disgustato dall’amico: Leopold, dopo aver fatto colazione con la moglie Molly, cantante, si reca a un funerale. Nel loro andirivieni per la città si incontrano brevemente nella sede di un giornale, alla Biblioteca nazionale e infine nel quartiere malfamato della città, dove Leopold-Ulisse opera una sorta di salvataggio di Stephen-Telemaco che, ubriaco, è assalito da due soldati inglesi. Poi Leopold si porta a casa Stephen, e lì i due parlano di letteratura, di donne, di assassini e di suicidi. Si è fatta notte fonda: Stephen se ne va e Bloom si corica. Molly è già a letto e il romanzo si conclude con un ininterrotto fluire, tra il ricordo e il sogno, delle immagini che le affollano la mente, immagini del passato, della giovinezza, del primo incontro con Molly.
MISTER BLOOM INIZIA LA GIORNATA
Mr Leopold Bloom mangiava con gran gusto le interiora di animali e di volatili. Gli piaceva la spessa minestra di rigaglie, gozzi piccanti, un cuore ripieno arrosto, fette di fegato impanate e fritte, uova di merluzzo fritte. Più di tutto gli piacevano i rognoni di castrato alla griglia che gli lasciavano nel palato un fine gusto d’urina leggermente aromatica.
I rognoni erano nel suo pensiero mentre si moveva quietamente per la cucina, sistemando le stoviglie per la colazione di lei sul vassoio ammaccato. Luce e aria gelida nella cucina ma fuori una dolce mattina d’estate dappertutto. Gli facevano venire un po’ di prurito allo stomaco.
I carboni si arrossavano.
Un’altra fetta di pane e burro: tre, quattro: giusto. Non le piaceva il piatto troppo pieno. Giusto. Lasciò il vassoio, sollevò il bollitore dalla mensola e lo mise di sbieco sul fuoco. Stava, grullo e accosciato, col beccuccio sporgente. Tazza di tè fra poco. Bene. Bocca secca. La gatta interita girò attorno a una gamba del tavolo con la coda ritta.
«Mkgnao»
«Oh, sei qui» disse Mr Bloom, distogliendosi dal fuoco.
La gatta rispose miagolando e girò di nuovo interita intorno a una gamba del tavolo, miagolando. Proprio come quando incede impettita sulla mia scrivania. Prr. Grattami la testa. Prr.
Mr Bloom guardava curioso, gentile, la flessuosa forma nera. Pulita a vedersi: la lucidità del pelo liscio, il bottoncino bianco sotto la radice della coda, i lampeggianti occhi verdi. Si chinò verso di lei, mani sulle ginocchia.
«Latte per la miciolina» disse.
«Mrkgnao!» piagnucolò la gatta.
Li chiamano stupidi. Capiscono quello che si dice meglio di quanto noi non si capisca loro. Capisce tutto quel che vuole. Vendicativa anche. Chi sa che cosa le sembro io. Alto come una torre? No, mi salta benissimo.
«Ha paura dei polli lei» disse canzonatorio. Paura dei pìopìo Mai visto una miciolina così
sciocchina.
Crudele. La sua natura. Curioso che i topi non stridono mai. Sembra gli piaccia.
«Mrkrgnao!» disse forte la gatta.
Guardò in su con gli occhi avidi ammiccanti per la vergogna, miagolando lamentosamente e a lungo, mostrandogli i denti biancolatte. Egli guardava le fessure nere degli occhi che si restringevano per l’avidità fino a che gli occhi divennero pietre verdi. Poi s’avvicinò alla credenza, prese il bricco che il lattaio di Hanlon gli aveva appena riempito, versò il latte tepido gorgogliante in un piattino e lo posò lentamente in terra.
«Grr!» esclamò lei e corse a lambire.
Guardò i baffi splendere metallici nella debole luce mentre lei ammusava tre volte e leccava lievemente. Chissà se è vero che se glieli tagli non pigliano più topi. Perché? Risplendono al buio, forse, le punte. O una specie di antenne al buio, forse.
Tese l’orecchio al leccottìo. Uova e prosciutto, no. Niente uova buone con questa siccità. Ci vuole acqua fresca pura. Giovedì: non è nemmeno giornata per un rognone di castrato da Buckley. Fritto nel burro, un zinzino di pepe. Meglio un rognone di maiale da Dlugacz. Aspettando che l’acqua bolla. Leccò più lentamente, poi ripulì ben bene il piattino. Perché hanno la lingua così ruvida? Per leccare meglio, tutta buchi porosi. Niente da mangiare per lei? Si guardò intorno. No.
Con le scarpe che scricchiolavano in sordina salì la scala fino al vestibolo, si fermò alla porta della camera da letto. Forse le piacerebbe qualcosa di saporito. Fettine di pane imburrato le piacciono la mattina. Forse però: una volta tanto. Disse a bassa voce nel vestibolo vuoto: «Vado qui all’angolo, torno tra un minuto».
Udita la sua voce dir questo soggiunse: «Vuoi niente per colazione?»
Un debole grugnito assonnato rispose: «Mn».
No. Non voleva niente. Sentì poi un profondo sospiro caldo, più debole, mentre la donna si rivoltava e gli anelli d’ottone ballonzolanti della lettiera tintinnavano. Bisogna mi decida a farli riparare. Peccato. Fin quassù da Gibilterra. Dimenticato quel po’ di spagnolo che sapeva. Chissà quanto l’ha pagato suo padre. Vecchio stile. Eh sì, naturalmente. Comprato all’asta del governatore. Venduto al primo colpo. Tenace nel contrattare, il vecchio Tweedy. Sissignore. Fu a Plevna. Vengo dalla gavetta, signore, e ne sono fiero. Eppure aveva abbastanza cervello da far soldi coi francobolli. Questo si chiama esser previdenti.
La sua mano tolse il cappello dal piolo, sopra il suo cappotto pesante con le iniziali, e l’impermeabile usato comprato all’ufficio oggetti smarriti. Francobolli: figurine dal retro adesivo. Direi che un sacco d’ufficiali siano nel giro. Naturale. La scritta sudaticcia nell’interno del cappello gli disse muta: Plasto i migliori capp. Sbirciò rapido all’interno della banda di cuoio. Cartoncino bianco. Bene al sicuro. Sulla soglia si tastò nella tasca posteriore dei pantaloni per accettarsi se aveva la chiave. Non c’è. Nei pantaloni che mi sono cambiato. Devo prenderla. La patata c’è. L’armadio scricchiola. Inutile disturbarla. Quando si è rivoltata era piena di sonno. Si tirò dietro la porta d’ingresso molto piano, ancora un po’, finché la parte inferiore del battente ricadde piano sulla soglia, lento coperchio. Sembrava chiusa. Va bene finché torno comunque.
Attraversò dalla parte del sole, evitando la botola mal ferma della cantina del numero settantacinque. Il sole si avvicinava al campanile della chiesa di San Giorgio. Sarà una giornata calda immagino. Specialmente con questo vestito nero si sente di più. Il nero conduce, riflette (rifrange?), il calore. Ma non potevo uscire con quel vestito chiaro. Come andassi a un picnic. Le palpebre gli si abbassavano spesso dolcemente mentte camminava nel beato tepore. Il furgoncino del pane di Boland che distribuisce a domicilio in telai il nostro quotidiano ma lei preferisce le forme di pane di ieri rivoltate nel forno con la crosta superiore calda crocchiante.
 Leopold Bloom e Stephen Dedalus passeggiano
Leopold Bloom e Stephen Dedalus passeggiano
Leopold Bloom è certamente il protagonista, l’Ulisse di questa moderna epopea. Lo vediamo qui, di prima mattina, mentre fa colazione in cucina, la moglie dorme ed il gatto miagola. Quindi esce. Un altro autore, forse con più parole, avrebbe certamente racchiuso in pochi periodi questo evento. Joyce no. In lui il tempo si diluisce in una serie di attimi vissuti mescolati con attimi “pensati”. Ma in questo non c’è logicità: forse iperrealismo, nel momento in cui l’autore registra anche l’azione accompagnata dall’associazione libera di idee, dal dialogo impossibile tra uomo e animali, tra sensazioni di dover fare e nel contempo riflettere. No c’è, qui, a ben guardare, psicologia, la vita interiore di Leopold non è poi così ricca, è azione: prepara da mangiare, lo dà al gatto, sente il respiro della moglie nel letto; Leopold Bloom si prepara una giornata di vita.

Un amabile sorriso si diffuse pacatamente sulle sue labbra.
«Che canzonatura, disse gaio. Quel tuo nome assurdo, da greco antico.
Lo segnò a dito con amichevole celia e Si avviò al parapetto, ridendo tra sé.
Stephen Dedalus venne su, lo seguì stancamente per un tratto e si sedette sull’orlo della piazzuola continuando a guardarlo mentre lui appoggiava lo specchio sul parapetto, intingeva il pennello nel bacile e si insaponava guance e collo.
La gaia voce di Buck Mulligan continuò: «Anch’io ho un nome assurdo: Màlachi Mùlligan, due dattili. Ma ha un certo qual suono ellenico, vero? Saltellante e solare proprio come un cerbiatto. Dobbiamo andare ad Atene. Ci vieni se riesco a far sborsare venti sterline alla zia?»
Mise giù il pennello e, ridendo di gusto, urlò: «Verrà lo sparuto gesuita?»
Chetatosi, cominciò a sbarbarsi con cura.
«Senti, Mulligan» disse piano Stephen.
«Parla, amor mio».
«Quanto tempo starà ancora Haines in questa torre?»
Buck Mulligan mostrò una gota rasata al disopra della spalla destra.
«Dio, ma quello è tremendo, no?» disse con franchezza. «Un sassone ponderoso. Non ti considera un gentiluomo. Dio, questi dannati inglesi. Crepano di quattrini e di indigestione. Perché lui viene da Oxford. Sai, Dedalus, tu hai tutto il tono di Oxford. Non arriva a capirti. Oh, ma il nome che ti ho dato è l’ideale: Kinch, lama di coltello».
Si faceva una cauta passata sul mento.
«Ha delirato tutta la notte di una pantera nera» disse Stephen. «Dov’è la fonda del suo fucile?»
«Un miserabile pazzo» disse Mulligan.
«Hai avuto fifa?»
«Eccome», disse Stephen con energia e con crescente paura.
«In un posto simile al buio con un uomo che non conosco, che delira e geme tra sé di sparare a una pantera nera. Tu hai salvato uomini che stavano per affogare. Ma io, non sono un eroe. Se resta qui lui me ne vado io».
Buck Mulligan guardò accigliato la spuma sulla lama del rasoio. Saltò giù dal suo trespolo e cominciò a frugarsi in fretta nelle tasche dei pantaloni.
«Taglia la corda» gridò con voce spessa.
Si avvicinò alla piazzuola e, cacciando una mano nel taschino di Stephen, disse: «Mollaci in prestito il tuo moccichino per asciugare il rasoio».
Stephen tollerò che tirasse fuori e tenesse in mostra per un angolo un fazzoletto sporco e gualcito. Buck Mulligan pulì diligentemente la lama. Poi, percorrendo con lo sguardo il fazzoletto, disse: «Il moccichino del bardo. Nuovo colore pittorico per i nostri poeti irlandesi: verdemoccio. Sembra di sentirselo in bocca, vero?
Risalì sul parapetto e percorse con lo sguardo la baia di Dublino, i biondi capelli querciapallida lievemente mossi.
«Dio» disse tranquillamente. Il mare è proprio come dice Algy: una dolce madre grigia, no? Il mare verdemoccio. Il mare scrotocostrittore. Epi oinopa ponton. Ah, Dedalus, i Greci. Ti devo erudire. Li devi leggere nell’originale. Thalatta! Thalatta! E’ la nostra grande dolce madre. Vieni a vedere.
Stephen si alzò e si accostò al parapetto. Appoggiatosi abbassò lo sguardo sull’acqua e sul postale che usciva dall’imboccatura del porto di Kingstown.
«La madre nostra possente» disse Buck Mulligan.
 Stephen Dedalus e il preside Mr. Deasy
Stephen Dedalus e il preside Mr. Deasy
Stephen Dedalus è l’altro protagonista dell’Ulisse e non solo. Era anche il protagonista del romanzo autobiografico del Ritratto dell’artista da giovane: nell’Ulisse egli è il Telemaco, il figlio che, capovolgendo la storia omerica, troverà il padre Ulisse/Leopold e infine lo porterà per una sera a casa sua, dove troverà un Penelope/Milly dormiente. In questo brano, che rappresenta l’incipit del complesso romanzo, lo troviamo con l’amico da cui si distaccherà Mulligan. Sono entrambi studenti e pertanto il linguaggio joyciano si soggettivizza in una mimesi che sta tra la sfrontatezza giovanile e la conoscenza intellettuale. Da qui quasi una forma di pastiche: dal greco antico “epi oinopa ponton” (sul mare color del vino) o ancora Thalassa (mare) sino ad aggettivare lo stesso con “il mare dal colore verdemoccio” o indicarlo come “scrotocostrittore”. Anche in questo passo uno sperimentalismo linguistico ad adeguare il linguaggio descrittivo a quello dei personaggi.
Lo stesso accadrà nella sezione dedicata a Nausica:
UNA GIOVANE BELLEZZA IRLANDESE
Ma Gerty chi era? Gerty MacDowell che era seduta vicino alle compagne, perduta nei suoi pensieri, lo sguardo fisso nell’infinito, era a vero dire il più bell’esempio che si potesse desiderar di vedere di giovane bellezza irlandese. Era riconosciuta come una bellezza da tutti quelli che la conoscevano benché, come la gente soleva dire, fosse più una Giltrap che una MacDowell. La sua figurina era svelta e graziosa, un tantino esile se vogliamo ma quelle pastiglie di ferro che stava prendendo da qualche tempo le avevan fatto un mondo di bene molto meglio delle pillole per la donna della vedova Welch e stava molto meglio riguardo a quelle perdite che era solita avere e a quel senso di stanchezza. Il pallore cereo del volto aveva un che di spirituale nella sua eburnea purezza, per quanto la bocca a bocciolo di rosa fosse un vero arco di Cupido, di perfezione greca. Le sue mani erano di un alabastro finemente venato con dita affusolate bianche quanto avevano potuto renderle il sugo di limone e la regina delle pomate, però non era vero che si mettesse i guanti di camoscio quando era a letto o facesse i pediluvi di latte. L’aveva detto una volta a Edy Boardman Bertha Supple, mentendo spudoratamente, quando era ai ferri corti con Gerty (le amichette avevano naturalmente le loro questioncelle di tanto in tanto come tutti gli altri mortali) e le aveva detto di non far sapere qualsiasi cosa succedesse che gliel’aveva detto lei sennò non le avrebbe più rivolto la parola in vita sua. No. Rendiamo onore al merito. C’era un’innata raffinatezza, una languida regale hauteur in Gerty, di cui erano prove inequivocabili le sue mani delicate e il collo del piede inarcato. Se solo il fato benigno avesse voluto che nascesse gentildonna di alto rango al suo giusto posto e se solo avesse usufruito d’una buona istruzione, Gerty MacDowell sarebbe stata tranquillamente alla pari accanto a qualsiasi altra gran dama e la si sarebbe vista adorna di vesti preziose, con gioielli sulla fronte e nobili adoratori ai piedi in gara l’uno con l’altro a renderle devoto omaggio. E chissà che non fosse questo, l’amore che avrebbe potuto essere, a donare talora al suo volto dai lineamenti così dolci, quella intensità dai mille taciti significati, e a impartire uno strano senso di vaga nostalgia ai begli occhi quel fascino cui pochi sapevano resistere. Perché le donne hanno occhi così maliardi? Quelli di Gerty erano del più puro azzurro irlandese, messo in risalto da ciglia lucenti e nere sopracciglia espressive. Ci fu un tempo in cui quelle ciglia non erano così seriche e seducenti. Fu Madame Vera Verity, direttrice della Rubrica della Donna Bella di Novelle della Principessa, che per prima le consigliò di provare la ciglioleina che dava quell’espressione penetrante agli occhi, che stava tanto bene alle signore che dettavano legge in fatto di moda, e lei non aveva mai avuto da lamentarsene. Poi c’era il sistema di guarire scientificamente dalla tendenza ad arrossire e come diventare più alte aumentate la vostra statura e avete un bel visetto ma il naso? Quello andava bene per Mrs Dignam che ce l’aveva a patata. Ma ciò di cui Gerty andava a buon diritto più orgogliosa era l’abbondanza dei suoi meravigliosi capelli. Erano di un castano scuro con onde naturali. Se li era tagliati proprio quel giorno perché c’era la luna nuova e le ricadevano attorno alla testolina in una profusione di riccioli lussureggianti e poi si era tagliate le unghie, il giovedì porta abbondanza. E proprio ora alle parole di Edy, come un rossore rivelatore, delicato come il più tenue petalo di rosa, le imporporava le guance, ella appariva così graziosa nella sua dolce pudicizia virginale che di sicuro in tutta l’Irlanda bella, benedetta da Dio, non v’era di lei l’uguale.
Per un istante rimase silenziosa coi begli occhi tristi abbassati. Stava quasi per ribattere, ma qualcosa le trattenne le parole sulla punta della lingua. La sua indole le suggeriva di parlare apertamente: la sua dignità le disse di tacere. Le graziose labbra tennero il broncio per un po’, ma poi alzò gli occhi e scoppiò in una gaia risatina che aveva in sé tutta la freschezza di una prima mattina di maggio. Lo sapeva benissimo nessuno meglio di lei, che cosa faceva dire così a quella strabica di Edy: era perché lui era un po’ più freddo con lei e invece non erano altro che liti d’innamorati. Come accade in questi casi, qualcuno torceva il naso perché quel ragazzo con la bicicletta andava sempre su e giù davanti alle sue finestre. Solo che ora suo padre lo teneva a casa la sera a studiar sodo per una borsa dl studio delle scuole medie e lui sarebbe andato a studiare da dottore al Trinity College, quando finiva il liceo come suo fratello W. E. Wylie che era nella squadra ciclistica all’università di Trinity College. Forse lui si curava poco di quello che provava lei, quel vuoto doloroso nel cuore che ogni tanto la trafiggeva. Ma era giovane, e chi può dire se col tempo non avrebbe imparato ad amarla? Erano protestanti nella sua famiglia, e Gerty naturalmente sapeva Chi veniva per primo e dopo di Lui la santa Vergine e poi San Giuseppe. Ma egli era innegabilmente bello, con un naso perfetto ed era quel che sembrava, signore fino alla punta dei capelli, e poi la forma della testa da dietro senza berretto lei l’avrebbe riconosciuta dovunque tanto era fuor dell’ordinario e come svoltava al lampione in bicicletta senza mani e anche il buon odore di quelle sigarette e oltre a tutto erano alti uguali e per questa ragione Edy Boardman si credeva tanto furba perché lui non andava in su e in giù davanti a quel suo pezzetto di giardino.
Gerty era vestita semplicemente ma con il buon gusto istintivo d’una devota di Madonna Moda perché presentiva una certa probabilità che egli fosse in giro. Una bella camicetta blu elettrico, tinta con palline coloranti (perché l’Illustrazione Femminile riteneva che il blu elettrico sarebbe venuto di moda) con un’elegante scollatura a V fino al sommo dei seni e un taschino (in cui teneva sempre un po’ di ovatta imbevuta del suo profumo preferito perché il fazzoletto guasta la linea) e una gonna da passeggio a tre quarti blu scura non molto ampia mettevano in risalto alla perfezione la sua svelta, graziosa figurina. Portava un amoruccio di cappello sbarazzino di paglia cioccolato a larghe tese guarnito a contrasto con una sottotesa in ciniglia azzurro germano e di lato un nodo a farfalla in colore. Tutto il pomeriggio del martedì prima era andata alla caccia di qualcosa che intonasse con la ciniglia ma alla fine aveva trovato alla liquidazione estiva di Clery proprio quel che cercava, un fondo di magazzino leggermente macchiato ma non ce se ne accorge, alta sette dita, due scellini e un penny. L’aveva fatto tutto da sé, e che gioia fu la sua quando poi se lo provò, sorridendo al grazioso riflesso che lo specchio le rimandava indietro! E quando lo mise sulla caraffa dell’acqua perché mantenesse la forma sapeva bene che avrebbe fatto rider verde certe persone di sua conoscenza. Le sue scarpe erano l’ultimo grido in fatto di calzature (Edy Boardman andava orgogliosa d’esser molto petite ma non aveva mai avuto un piede come Gerty MacDowell, un trentadue, e acqua in bocca, lago, laghetto) con le punte di coppale e solo una fibbia elegante al collo del piede inarcato. La caviglia tornita mostrava le sue perfette proporzioni sotto la gonna e lo stesso si dica di quel tanto e non più degli arti perfetti inguainati in calze fini con talloni rinforzati e risvolto ampio. Quanto alla biancheria intima era la cura principale di Gerty e chiunque conosca le trepide speranze e le apprensioni dei bei diciassette anni (per quanto Gerty li avesse già salutati) come potrà avere il coraggio di biasimarla? Aveva quattro completini deliziosi, squisitamente ricamati, tre pezzi e in più le camicie da notte, e ognuno con nastri di diverso colore, rosa, azzurro pallido, lilla e verde pisello e li metteva ad asciugare e li sbiancava lei stessa quando tornavano dalla lavandaia e se li stirava e aveva un pezzo di mattone per posarci il ferro perché non si fidava delle lavandaie nemmeno se poteva tenerle d’occhio tanto bruciacchiavano la roba. Vestiva di blu perché portava fortuna, sperando contro ogni aspettativa, era il suo colore e il colore delle spose, anche, devono sempre aver qualcosa di blu addosso perché il verde che indossava otto giorni fa aveva portato scarogna perché suo padre lo aveva rinchiuso a studiare per quella borsa di studio delle medie e perché lei pensava che forse poteva essere in giro perché mentre si vestiva quella mattina si stava quasi infilando quel vecchio paio alla rovescia e questo era un buon segno e voleva dire che si incontrava l’innamorato se si mettevano alla rovescia o se si aprivano voleva dire che lui stava pensando a te purché non fosse di venerdì.
Joyce non viene meno alla registrazione dei pensieri Gerty, una bellezza irlandese. Nella spiaggia, fra le rocce insieme ad altre due amiche, ambedue con i loro pargoli. Solo lei, ancora ragazza a pensare e a pensarsi. E, secondo la tecnica joyciana il suo pensare è frutto della sua cultura: quindi tutta la pagina è intessuta del gergo delle riviste femminili e di moda del tempo.

Cosimo Maiorelli: Molly Bloom
MOLLY BLOOM
eravamo stesi tra i rododendri sul promontorio di Howth con quel suo vestito di tweed grigio e la paglietta il giorno che gli feci fare la dichiarazione sì prima gli passai in bocca quel pezzetto di biscotti all’anice e era un anno bisestile come ora sì 16 anni fa Dio mio dopo quel bacio così lungo non avevo più fiato sì disse che ero un fior di montagna sì siamo tutti fiori allora un corpo di donna sì è stata una delle poche cose giuste che ha detto in vita sua e il sole splende per te oggi sì perciò mi piacque sì perché vidi che capiva o almeno sentiva cos’è una donna e io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo e gli detti quanto più piacere potevo per portarlo a quel punto finché non mi chiese di dir di sì e io dapprincipio non volevo rispondere guardavo solo in giro il cielo e il mare pensavo a tante cose che lui non sapeva di Mulveyl e Mr Stanhope e Hester e papà e il vecchio capitano Groves e i marinai che giocavano al piattello e alla cavallina come dicevan loro sul molo e la sentinella davanti alla casa del governatore con quella cosa attorno all’elmetto bianco povero diavolo mezzo arrostito e le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli e quei pettini alti e le aste la mattina i Greci e gli ebrei e gli Arabi e il diavolo chi sa altro da tutte le parti d’Europa e Duke street e il mercato del pollame un gran pigolio davanti a Larby Sharonl e i poveri ciuchini che inciampavano mezzi addormentati e gli uomini avvolti nei loro mantelli addormentati all’ombra sugli scalini e le grandi ruote dei carri dei tori e il vecchio castello vecchio di mill’anni sì e quei bei Mori tutti in bianco e turbanti come re /he ti chiedevano di metterti a sedere in quei loro buchi di botteghe e Ronda con le vecchie finestre delle posadas fulgidi occhi celava l’inferriata perché il suo amante baciasse le sbarre e le gargotte mezzo aperte la notte e le nacchere e la notte che perdemmo il battello ad Algesiras il sereno che faceva il suo giro con la sua lampada e Oh quel pauroso torrente laggiù in fondo Oh e il mare il mare qualche volta cremisi come il fuoco e gli splendidi tramonti e i fichi nei giardini dell’Alameda sì e tutte quelle stradine curiose e le case rosa e azzurre e gialle e i roseti e i gelsomini e i geranii e i cactus e Gibilterra da ragazza dov’ero un Fior di montagna sì quando mi misi la rosa nei capelli come facevano le ragazze andaluse o ne porterò una rossa sì e come mi baciò sotto il muro moresco e io pensavo be’ lui ne vale un altro e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì allora mi chiese se io volevo sì dire di sì mio fior di montagna e per prima cosa gli misi le braccia intorno sì e me lo tirai addosso in modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato sì e il suo cuore batteva come impazzito e sì dissi sì voglio sì.
Solo nell’ultima parte Joyce adotta integralmente lo stream of consciousness. Molly sta sul letto nel dormiveglia e cerca di focalizzare i suoi pensieri nel ricordo del primo incontro con Leopold. Il fluire di essi procede senza pause (nessun punto d’interpunzione) facendo emergere il cosciente ed il rimosso, il ricordo e la pulsione. Non per niente la pagina venne censurata. La critica, soprattutto per il flusso di coscienza, ha parlato della piena realizzazione della teoria psicoanalitica in letteratura mettendo in atto, nella scrittura, la libertà delle associazioni mentali in cui convergono sapori, odori, colori, paesaggi e parole del ricordo in una contemporaneità incosciente, quando il super io freudiano allenta e il subconscio mette in luce la vita interiore.
 Joyce oggi
Joyce oggi
Nell’Ulisse l’interesse per la realtà interiore dei personaggi porta Joyce ad adottare il monologo interiore inteso come alogico fluire di ricordi, associazioni d’idee, di desideri, fantasticherie, in una parola un magma di pensieri che ribolle nella nostra mente al di là della nostra volontà (stream of consciousness):
- I monologhi dei personaggi sono opportunamente differenziati a seconda del retroterra culturale: così in Dedalus, l’intellettuale, saranno fitti d’immagini poetiche ed auliche, mentre in Bloom, uomo prosaico, saranno opportunamente banali;
- Nello scrupolo di “verità”, Joyce adotterà per ogni ambiente un “linguaggio” ed uno “stile” loro propri, che si rifà dai moduli medievali sino a quelli del romanzo rosa;
- Egli inoltre applicherà nel suo romanzo un vero e proprio sperimentalismo linguistico, utilizzando la componente fonica, allusiva, simbolica della parola. Egli crea una vera e propria tessitura fitta di neologismi, parole straniere, fusioni di lingue differenti, onomatopeee, capace di suggerire, ogni volta, una gamma infinita di implicazioni ed interpretazioni.
- Un romanzo di tal genere deve la sua importanza al fatto che l’autore ha compiuto nella sua opera un’operazione nella quale registra la “totalità del reale” nel suo esplicitarsi quotidiano;
- La realtà del quotidiano che Joyce ci offre nella sua completezza è tuttavia desolante: nessun personaggio si salva, né Bloom che trova soltanto nell’ubriachezza al pub quel senso di cameratismo virile, fatto di fantasticherie, né sua moglie Molly, che pur apparendo esternamente soddisfatta, con il marito e un amante, appare realmente sola, intristita dalla mancanza d’amore cui è attorniata.
- L’Ulisse è l’emblema dell’uomo moderno, opposto all’eroe omerico: il sig. Bloom, dileggiato, tradito dalla moglie, impossibilitato a realizzare una paternità spirituale (ha una figlia femmina, il maschio muore dopo undici giorni) è l’esatto opposto di Ulisse.
Virginia Woolf
 Virginia Woolf, nata Stephen, nasce a Londra nel 1882 da un critico letterario. La sua adolescenza è ricca di conoscenze letterarie, formate soprattutto da coloro che daranno vita al Circolo di Bloomsbury (gruppo di giovani laureati a Cambridge soprattutto ostili all’Inghilterra vittoriana ed edoardiana). Nel 1912 sposa Leonard, con il quale darà vita ad una casa editrice che pubblicherà le sue maggiori opere, tra le quali ricordiamo La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927) e l’anno successivo Orlando; il suo impegno oltre che letterario, sarà anche civile, prendendo parte alle rivendicazioni femminili per i loro diritti. Ciò ci è testimoniato da Una stanza tutta per sé del 1929. Pubblicherà ancora il romanzo Le onde, ma verrà colpita da un forte esaurimento nervoso, accompagnato da momenti di depressione che la condurranno ad uccidersi annegando nel 1941.
Virginia Woolf, nata Stephen, nasce a Londra nel 1882 da un critico letterario. La sua adolescenza è ricca di conoscenze letterarie, formate soprattutto da coloro che daranno vita al Circolo di Bloomsbury (gruppo di giovani laureati a Cambridge soprattutto ostili all’Inghilterra vittoriana ed edoardiana). Nel 1912 sposa Leonard, con il quale darà vita ad una casa editrice che pubblicherà le sue maggiori opere, tra le quali ricordiamo La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927) e l’anno successivo Orlando; il suo impegno oltre che letterario, sarà anche civile, prendendo parte alle rivendicazioni femminili per i loro diritti. Ciò ci è testimoniato da Una stanza tutta per sé del 1929. Pubblicherà ancora il romanzo Le onde, ma verrà colpita da un forte esaurimento nervoso, accompagnato da momenti di depressione che la condurranno ad uccidersi annegando nel 1941.
La vicenda si svolge tutta in una giornata: Clarissa Dalloway va a comprare dei fiori per una festa che darà in serata. Ripensa a un amico d’infanzia, Peter, che è stato innamorato di lei e che è da poco tornato dall’India, e alla propria adolescenza; e nello stesso accoglie, con vivo senso di partecipazione, le immagini della vita che le scorre intorno. Di ritorno a casa Peter viene a salutarla e a risvegliare emozioni dimenticate; Elizabeth, la figlia che Clarissa teme di aver perduto perché presa da altri affetti e interessi, sente invece, quello stesso pomeriggio, l’impulso improvviso di tornare dalla madre; anche il marito, profondamente innamorato di lei, sente il bisogno di rivederla un attimo, nel bel mezzo di una giornata di lavoro. La festa della sera è come il punto di confluenza di tutti gli avvenimenti della giornata: riappare Peter, riappare una vecchia amica ora sposata e madre, riappare perfino, nelle parole di un ospite, un personaggio intravisto al parco che ha colpito Clarissa per il suo smarrimento, e del quale si viene a sapere che si è ucciso.
 LA SIGNORA DALLOWAY
LA SIGNORA DALLOWAY
La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comperati lei.
Lucy ne aveva fin che ne voleva, del lavoro. C’era da levare le porte dai cardini; e per questo dovevano venire gli uomini di Rumplemayer. “E che mattinata!” pensava Clarissa Dalloway “fresca, pare fatta apposta per dei bimbi su una spiaggia.”
Che voglia matta di saltare! Così ella s’era sentita a Bourton: quando, col lieve cigolar di cardini che ancora le pareva di sentire, aveva spalancato le porte-finestre e s’era tuffata nell’aria aperta. Ma quanto più fresca e calma, e anche più silenziosa di questa era quell’altra aria, di buon mattino; come il palpito di un’onda; il bacio di un’onda; gelida e pungente eppure (per la fanciulla di diciott’anni ch’ella era allora) solenne: là alla finestra aperta, elle provava infatti un presagio di qualcosa di terribile ch’era lì lì per accadere; e guardava ai fiori, agli alberi ove s’annidavano spire di fumo, alle cornacchie che si libravano alte, e ricadevano; e rimaneva trasognata, fino a che udiva la voce di Peter Walsh: “Fate la poetica in mezzo ai cavoli?” – così aveva detto? – oppure: “Preferisco gli uomini ai cavolfiori” – aveva detto così? Doveva averlo detto una certa mattina a colazione, quando lei era uscita sul terrazzo… Peter Walsh! Sarebbe tornato dall’India quanto prima, a giugno o a luglio, ella non rammentava più, ché le sue lettere erano disastrosamente monotone. Erano i suoi motti che vi si imprimevano in mente; i suoi occhi, il suo temperino, il suo sorriso e, quando milioni d’altre cose erano interamente svanite – strano davvero! – poche parole, come quelle a proposito dei cavolfiori.
In attesa che passasse il furgone di Durnell, ella si irrigidì un poco, sull’orlo del marciapiede. Una donna graziosa, la giudicò Scrope Purvis (egli la conosceva come ci si conosce tra vicini; aveva in sé qualcosa di uccellino, della gazza, un che di verdazzurro, lieve, vivace, quantunque avesse varcato la cinquantina e fatto molti capelli bianchi dopo la sua malattia. In attesa di attraversare ella se ne stava là, dritta nella vita, come appollaiata su di un ramo; e non lo vide neppure.
Poiché il semplice fatto di vivere a Westminster – da quanti anni ormai? più di venti – impone indiscutibilmente (Clarissa lo affermava) seppur nel bel mezzo di un viavai dìuna piazza, o destandosi all’improvviso la notte, una particolare calma, anzi solennità, una pausa che non si potrebbe descrivere, un sostar della vita (ma questo poteva ben essere il cuore, indebolito dall’influenza) nell’attimo prima che Big Ben suoni le ore. Ecco il rintocco! Prima è un monito, musicale, poi l’ora irrevocabile. I plumbei circoli si dissolvevano per aria. Poveri di spirito che siamo, pensava Clarissa, attraversando Victoria Street. Dio solo sa perché l’amiamo così, la vediamo così, perché ce la facciamo così, costruendola attorno al nostro io per poi scomporla, e ricrearla da capo ogni momento; eppure l’ultima delle pitocche, i più sciagurati rifiuti umani seduti sui gradini delle porte (istupiditi dal bere) non farebbero altrimenti; e per quella precisa ragione non c’è legge né decreto che possa domarli: perché amano la vita. Negli occhi dei passanti, nella foga del brulichio cittadino, nel muggito e nel frastuono; nel trapestio e nell’ondeggiar di carrozze, automobili, omnibus, furgoni, uomini-sandwich; nelle bande e negli organetti, nella nota trionfante e nello strano altissimo canto di un aereo che ronzava su in cielo era ciò che ella amava: la vita, Londra, e quell’attimo di giugno.
Poiché si era a metà giugno. Finita ormai la guerra, fuorché per certuni, come la signora Foxcroft che iersera all’Ambasciata si mangiava il cuore perché quel bel ragazzo era caduto al fronte, e ora il vecchio maniero avito sarebbe andato a un cugino; o Lady Bexborough, della quale si diceva che avesse inaugurato una fiera di beneficienza tenendo in mano il telegramma che le anninciava la morte di John, il suo beniamino; ma insomma era finita; grazie al Cielo – finita. Si era a giugno, Le Loro Maestà erano a Palazzo. E ovunque, sebbene fosse ancora presto, c’era in aria uno scalpiccio inquieto di puledri galoppanti, un picchiar di mazze da cricket; Lords, Ascot, Ranelagh e gli altri campi apparivano tuttora velati nella lieve rete grigio azzurra dell’aria mattutina, che con lo snodarsi delle ore dirandasi avrebbe rivelato sui prati e giù per le chine i focosi cavallini che appena sfioravano con gli zoccoli il suolo e partivano d’un balzo; e giovani audaci e ridenti fanciulle in trasparenti vesti di mussola, le quali pur ora, dopo aver danzato tutta la notte, portavano a spasso certi buffi cani lanosi; e nonostante fosse ancora presto, discrete vecchie dame filavano via nelle automobili padronali, dirette a misteriose imprese; e i negozianti si davano da fare a mettere in mostra orpelli e diamanti falsi, e quelle graziose spille color verdemare, stile diciottesimo secolo, che tentano gli americani (“bisogna fare economia però, non fare spese pazze per Elizabeth”); e Clarissa, che per tutte queste cose nutriva un’assurda e fedele passione, e ne faceva parte – i suoi non erano stati cortigiani sotto l’uno o l’altro re Giorgio? – anche lei quella sera, avrebbe sfilato e brillato, dando la sua festa. Ma intanto la colpì il silenzio, all’entrar nel parco, la nebbia, e un ronzar d’insetti , e le anatre felici che nuotavano lente, e i trampolieri panciuti che si dimenavano goffi.
Il romanzo della Woolf, successivo all’Ulisse di Joyce, prende dall’opera dell’autore irlandese l’idea di raccontarci una sola giornata della signora Dalloway. Tuttavia, pur adottando ambedue la tecnica dello stream of consciousness, notiamo una differenza perché la scrittrice inglese conserva un maggior controllo narrativo e non si annulla per dar voce al personaggio. Troviamo, infatti varie tecniche narrative, che vanno dalla narrazione eterodiegetica al monologo indiretto al discorso indiretto, sino al discorso indiretto libero. Più importante è la molteplicità delle focalizzazioni, cui Clarissa non solo è soggetto ma anche oggetto di attenzioni.
 Tutto ciò è bene espresso nel brano iniziale: si parte dal comprare dei fiori e dalla constatazione che bisogna togliere le porte dai cardini, per innescare l’afflusso dei ricordi quando nella casa di campagna cambiava l’aria e ancora ragazza veniva corteggiata da Peter. Mentre attraversa la strada Clarissa è investita dal rumore della città, ma proprio allora sente il bisogno di focalizzare la sua attenzione sul rintocco dell’orologio, quindi sul passar del tempo. Anche i più sciagurati si attaccano a questo tempo perché amano la vita e l’amore per essa la conduce all’idea di giovani uomini morti in guerra. Ma i giovani ora sono pronti all’amore, negli ippodromi della città e le signore si fanno belle con gli orpelli messi in vendita (ma deve fare attenzione a non spendere troppo per sua figlia). Ma anche lei quella sera sarà bella.
Tutto ciò è bene espresso nel brano iniziale: si parte dal comprare dei fiori e dalla constatazione che bisogna togliere le porte dai cardini, per innescare l’afflusso dei ricordi quando nella casa di campagna cambiava l’aria e ancora ragazza veniva corteggiata da Peter. Mentre attraversa la strada Clarissa è investita dal rumore della città, ma proprio allora sente il bisogno di focalizzare la sua attenzione sul rintocco dell’orologio, quindi sul passar del tempo. Anche i più sciagurati si attaccano a questo tempo perché amano la vita e l’amore per essa la conduce all’idea di giovani uomini morti in guerra. Ma i giovani ora sono pronti all’amore, negli ippodromi della città e le signore si fanno belle con gli orpelli messi in vendita (ma deve fare attenzione a non spendere troppo per sua figlia). Ma anche lei quella sera sarà bella.
La prosa è irregolare, frammentata: anch’essa ci riporta all’affollarsi dei pensieri di Clarissa: tuttavia la capacità di mescolare linguaggio informale, figurato, similitudini e metafore senza cadere in una disarmonia, innalza lo stesso in ritmo capace di toccare la levità, come lievi sono i pensieri della protagonista.
Un altro grande romanzo è Gita al faro:
La famiglia Ramsey è in villeggiatura, con alcuni ospiti, in una delle isole Ebridi. E’ una sera del settembre del 1914; si progetta una gita al faro, che agli occhi di James, il più piccolo dei figli, si presenta come una meta di sogno, ricca di misteriosi significati. Ma la gita viene rimandata per il maltempo. Passano gli anni: la guerra tiene i Ramsey lontano dall’isola e la loro vecchia casa va in rovina. Muoiono la signora Ramsey, il figlio Andrew, la figlia Prue. Dopo dieci anni i Ramsey superstiti e alcuni degli stessi ospiti di un tempo tornano all’isola. Il signor Ramsey e i due figli fanno finalmente la gita al faro: intanto una degli ospiti, la pittrice Lily Briscoe, finisce di dipingere un quadro cominciato dieci anni prima. Nelle due azioni si riallacciano simbolicamente passato e presente, e i personaggi e i rapporti che li legano si collocano in una luce rivelatrice del loro più autentico significato.
IL CALZEROTTO MARRONE
«E anche se domani non sarà bello» disse la signora Ramsay, alzando gli occhi su William Bankes e Lily Briscoe che passavano «ci andremo un altro giorno. E ora» disse, pensando che il fascino di Lily stava in quegli occhi cinesi, messi sghembi nella pallida faccina grinzosa, ma ci voleva un uomo intelligente per vederlo; «e ora alzati su, fammi misurare la gamba» perché alla fine magari sarebbero riusciti ad andare al Faro, e doveva vedere se allungare i calzerotti di qualche centimetro.
Sorridendo a un’eccellente idea che le era balenata in mente in quell’istante – William e Lily dovevano sposarsi – prese la calzerotto color dell’erica, col suo incrocio d’aghi all’imboccatura, e la misurò alla gamba di James.
«Sta’ fermo, caro!» disse, perché a James, per gelosia, non andava affatto di fare da modello per il figlio del custode, si scalpitava apposta; ma se scapitava, come faceva lei a vedere se era lungo, o corto? gli domandò.
Alzò gli occhi – quale demonio si era impossessato del suo piccolo, il suo prediletto? – e guardò la stanza, guardò le sedie, e pensò che erano spaventosamente logore. L’imbottitura, aveva detto Andrew l’altro giorno, invece che dentro stava fuori, sul pavimento. Ma a che serviva, si chiedeva, comprare delle sedie nuove per farle andare in malora d’inverno, quando la casa, custodita da una vecchia donna, gocciava addirittura per l’umidità? Che importava? L’affitto non arrivava a tre penny, i bambini l’amavano, a suo marito faceva bene a starsene a tremila, per la precisione erano trecento – miglia di distanza dalla biblioteca, le lezioni, gli studenti. E c’era posto anche per gli ospiti. Stuoie, brande, fantastici spettri di sedie e tavoli che avevano esaurito la loro funzione a Londra, lì andavano benissimo: con in più qualche fotografia, e i libri. I libri, pensò, crescevano da soli. Non aveva mai tempo di leggerli. Peccato! Anche i libri che le venivano regalati con tanto di dedica dell’autore: “A colei i cui desideri sono legge…” “Alla più felice Elena dei nostri tempi…” si vergognava di dirlo, ma non li aveva mai letti. Il libro di Croom sulla mente, di Bates sui Costumi dei Selvaggi Polinesia ( «Sta’ fermo, caro» ripeté) – non li poteva certo mandare al Faro. A un certo punto, pensò, la casa sarebbe andata in malora, e avrebbero per forza dovuto fare qualcosa. Se avessero almeno imparato a pulirsi i piedi, invece di portare dentro casa tutta la sabbia – sarebbe già stato qualcosa. I granchi doveva pur permetterli, visto che Andrew li voleva dissezionare; e se Jasper aveva deciso che con le alghe si doveva fare la zuppa, non glielo poteva impedire; o così per gli oggetti di Rose, le conchiglie, le canne, i sassi. I suoi ragazzi erano tutti dotati, ognuno a suo modo. E il risultato era, sospirò, avvolgendo con lo sguardo tutta la stanza dal soffitto al soffitto, sempre tenendo il calzerotto appoggiato alla gamba di James, che da un’estate all’altra la casa diventava sempre più squallida. La stuoia s’era scolorita; la carta da parati si scollava, non si riconosceva neppure più se erano rose. D’altronde, a forza di lasciare le porte aperte, perché in tutta la Scozia non si trova un fabbro che sappia aggiustare un chiavistello, le cose si sciupano. A che serviva poggiare sull’orlo della cornice uno scialle di cachemire? In due settimane sarebbe diventato dello stesso colore del brodo di piselli. Ma erano le porte soprattutto che le davano fastidio; le porte lasciate aperte. Si fermò ad ascoltare: la porta del salotto era aperta; ed era sicuramente aperta anche la finestra sul pianerottolo, l’aveva aperta lei quella. Perché mai nessuno si ricordava di una cosa così semplice – le finestre dovevano stare aperte e le porte chiuse? Se andava nella stanza delle cameriere di notte le trovava sigillate come forni, eccetto quella di Marie, la ragazza svizzera, che avrebbe preferito fare a meno dell’acqua calda piuttosto che dell’aria fresca. Al suo paese aveva detto «le montagne sono così belle». L’aveva detto la sera prima, guardando fuori dalla finestra con le lacrime agli occhi: «Le montagne sono così belle.» Suo padre stava morendo laggiù, la signora Ramsay lo sapeva. Li avrebbe lasciati orfani. Era andata su per rimproverarla e darle delle dimostrazioni (come si fa letto, come si apre la finestra, e muoveva come fosse una donna francese) ma quando la ragazza disse così, subito si quietò, come dopo un volo dispiegato nel sole si quietano le ali di un uccello, e l’azzurro delle piume da grigio acceso si fa rosso porpora chiaro. Era rimasta lì ferma in silenzio perché non c’era niente da dire. Aveva un cancro alla gola. A quel pensiero – al pensiero di com’era rimasta lì immobile, di come la ragazza aveva detto: «A casa mia le montagne sono così belle», no, non c’era speranza, nessuna – ebbe una contrazione irritata, e in tono brusco disse a James: «Sta’ fermo. Non essere noioso» e James si rese subito conto che quella severità era reale, allungò la gamba, e lei prese la misura.
La calzerotto era troppo corto, mancava almeno un centimetro anche tenendo conto che il bambino di Sorley era meno sviluppato di James.
«E’ troppo corto» disse «troppo corto.»

Non succede nulla: Mrs Ramsey sta provando sulla gamba del suo figlio più piccolo un calzerotto che dovrà donare al figlio del custode del faro. All’interno di questa esiguità il flusso di pensieri della protagonista. Ciò permette lo sbalzo cronologico tra ciò che avviene all’esterno, oggettivo e reale e i vissuti soggettivi: Erich Auerbach, in Mimemis (1956) definendo questo fenomeno – tipico della cultura novecentesca – “spostamento del centro di gravità” ed aggiungendo “si attribuisce meno importanza alle grandi svolte esteriori e ai colpi del destino, come se da essi non possa scaturire nulla di decisivo (…); si ha fiducia invece che un qualunque fatto della vita scelto casualmente contenga in ogni momento e possa rappresentare la somma dei destini”.
Opere in lingua francese
Marcel Proust

Marcel Proust nasce nel 1871 ad Auteuil, vicino Parigi, da una famiglia borghese. Di salute malferma, passa l’infanzia a Illiers e alla stazione balneare Trouville. Sin da giovane, dopo essersi inserito negli ambienti culturali della capitale francese, collabora a diverse riviste e pubblica alcune novelle. La morte dei genitori, il padre nel 1903, a madre nel 1905, crea in Proust quasi uno spartiacque tra cioè che è felicità (quindi passato) e la realtà presente. Da allora passa tutto il suo tempo nella realizzazione della sua opera Alla ricerca del tempo perduto, opera che si struttura in sette romanzi (Dalla parte di Swann, All’ombra delle fanciulle in fiore, La parte di Guermantes, Sodoma e Gomorra, La prigioniera, Albertine scomparsa, Il tempo ritrovato) opera monumentale che diventa sin da subito paradigma di tutto ciò che verrà scritto dopo di lui. Muore nel 1922.
Alla ricerca del tempo perduto è un ciclo narrativo in sette volumi. Nella prima parte di La strada di Swann (1913) il Narratore, mosso da un’associazione fortuita, rievoca il mondo dell’infanzia a Combray con le care figure della madre, della nonna, della vecchia zia Lèonie, della fedele Françoise. Le passeggiate quotidiane lo portano in due direzioni opposte: la strada di Méséglise (dove abitano Swann con la figlia Gilberte e il musicista Vinteuil, genio ancora sconosciuto) e la strada dei Guermantes, i grandi aristocratici che appaiono remoti, quasi irreali al Narratore. Nella seconda parte, che costituisce quasi un racconto separato, Un amore di Swann, è rievocata la passione di Swann per la famosa demi-mondaine Odette de Crécy, poi diventata sua moglie: messo al bando dalla migliore società, Swann frequenta il salotto dei Verdurin, ricchi borghesi con pretese intellettuali. Nella terza parte il Narratore racconta le vicende del suo amore adolescente per Gilberte, sullo sfondo degli Champe Elysées. In All’ombra delle fanciulle in fiore (1919) il Narratore giovinetto conosce lo scrittore Bergotte e la grande attrice Berma, mentre l’amore per Gilberte svanisce lentamente. Si reca a Balbec, la grande spiaggia alla moda, e lì incontra il giovane Robert de Saint-Loup, imparentato con i Guermantes, che lo presenta allo zio, il barone di Charlus; ma il narratore è incantato soprattutto dal gruppetto delle “fanciulle in fiore”, Andreé, Albertine, Rosamonde e le loro amiche. In I Guermantes (1920-1921) il Narratore, ormai tornato a Parigi, va ad abitare con i suoi in un appartamento del palazzo dei Guermantes, appena intravisti nell’infanzia a Combray. Si innamora della duchessa e per poterla avvicinare si trasferisce per qualche giorno a Donciéres, la città dove presta servizio militare Saint-Loup. Fa la conoscenza dell’amante di Robert, la giovane attrice Rachel, e frequenta il salotto di Mme de Villeparisis. Muore la nonna materna; il Narratore rinnova l’amicizia con Albertine. In Sodoma e Gomorra (1922) appare per l’ultima volta Swann, condannato da un male incurabile. Il Narratore ha la rivelazione dell’omosessualità di Charlus. Le vicende dell’amore del barone per il violinista Morel e del Narratore per Albertine spostano la scena da Parigi a Balbec e poi a La Raspeliére, la villa dei Verdurin. Avendo ormai quasi dimenticato la morte della nonna, il Narratore si interroga sull’importanza dell’amore che le portava, e scopre “le intermittenze del cuore”. Quando viene a sapere che Albertine ha avuto rapporti omosessuali con Mlle Vinteuil, decide di riportarla a Parigi. La prigioniera (1923, postumo) e Albertine scomparsa (1925, postumo) sono dedicati all’amore per Albertine, che il Narratore tiene come prigioniera, in attesa di sposarla. La sua gelosia morbosa, i suoi sospetti e le sue paure sono rinfocolati dall’esempio di Charlus, tradito da Morel. Muore Bergotte, e Charlus precipita sempre più in basso: se queste vicende sottolineano la vanità della vita, il Settimino di Vinteuil conferma il Narratore nella certezza che essa è riscattata dall’eternità dell’arte. Ormai quasi indifferente ad Albertine, il Narratore si prepara a lasciarla quando la fuga e poi la morte accidentale della fanciulla rinfocolano la sua passione. Ma il tempo cancella anche questo amore: il Narratore si innamora di una giovane che, dapprima non riconosciuta, si rivela poi per Gilberte. Gilberte sposa Saint-Loup: le due strade, quella dei Guermantes e quella dei Méséglise si sono incontrate. Ma ben presto il Narratore scopre che Saint-Loup è omosessuale come suo zio Charlus. In Il tempo ritrovato (1927, postumo) il Narratore trascorre qualche giorno a Tansonville, nella villa di Gilberte. Insieme rievocano episodi dell’infanzia, ma Gilberte soffre per le infedeltà di Saint-Loup. Scoppia la guerra. Nella Parigi bombardata Charlus continua nella ricerca dei suoi piaceri particolari. Muore Saint-Loup, mentre l’astro dei Verdurin sale sempre di più sull’orizzonte mondano. Finisce la guerra: dopo un soggiorno di qualche mese in una casa di cura, il Narratore si reca a un ricevimento della principessa di Guermantes (che non è altri che Mme Verdurin, rimasta vedova e subito risposata). Incontra vecchi amici ma stenta a riconoscerli, segnati e trasformato dal tempo come sono. Una irregolarità del pavimento del cortile, il tintinnio di un cucchiaino posato sul piatto gli riportano di colpo momenti del passato, che lo riempiono di ineffabile gioia. Decide di cominciare a scrivere l’opera alla quale pensa sin dalla giovinezza per resuscitare il passato, di cui ha scoperto gli infiniti risvolti, nella poesia.
Cominciamo la lettura con uno dei passi più celeberrimi dell’intero romanzo, tratti dal primo romanzo La strada di Swann:
 David Richardson: Proust e la madeleine
David Richardson: Proust e la madeleine
LA MADELEINE
Così per molto tempo, quando, stando sveglio di notte, ripensavo a Combray, non ne rividi mai se non quella specie di lembo luminoso, che si tagliava in mezzo a tenebre indistinte, simili a quelle che la vampa d’un fuoco di bengala o qualche proiettore elettrico illuminano e sezionano in un edificio, di cui le altre parti restino immerse nel buio: alla base, piuttosto larga, il salottino, la sala da pranzo, il richiamo dell’oscuro viale donde sarebbe giunto Swann, l’autore inconscio delle mie tristezze, il vestibolo per cui m’incamminavo verso il primo gradino della scala, che mi era tanto duro salire, e che costituiva da sola il tronco assai stretto di quella piramide irregolare; e in cima, la mia camera da letto col piccolo corridoio dalla porta a vetri per cui entrava la mamma; in una parola, sempre veduto alla stessa ora, isolato da ogni cosa che vi potesse essere intorno, stagliandosi solo nell’oscurità, lo scenario strettamente indispensabile (come quello che si vede indicato a capo delle vecchie commedie per le rappresentazioni in provincia) al dramma dello spogliarmi, come se Combray non fosse consistita che in due piani riuniti da un’angusta scala, e come se là non fossero mai state che le sette di sera. A dire il vero, a chi m’avesse interrogato avrei potuto rispondere che Combray racchiudeva anche altre cose ed esisteva in altre ore. Ma, poiché quel che avrei ricordato mi sarebbe stato offerto soltanto dalla memoria volontaria, la memoria dell’intelligenza, e poiché le notizie che essa dà sul passato non mi serbano nulla, non avrei mai avuto voglia di pensare a quel resto di Combray. Tutto questo, in verità, era morto per me.
Morto per sempre? Forse.
Il caso ha una grande parte in tutte queste cose, e un secondo caso, quello della nostra morte, spesso non ci permette d’attendere a lungo i favori del primo. Mi sembra molto ragionevole la credenza celtica secondo cui le anime di quelli che abbiamo perduto sono prigioniere entro qualche essere inferiore, una bestia, un vegetale, una cosa inanimata, perdute di fatto per noi fino al giorno, che per molti non giunge mai, che ci troviamo a passare accanto all’albero, che veniamo in possesso dell’oggetto che le tiene prigioniere. Esse trasaliscono allora, ci chiamano e non appena le abbiamo riconosciute, l’incanto è rotto. Liberate da noi, hanno vinto la morte e ritornano a vivere con noi.
Così è per il passato nostro. E’ inutile cercare di rievocarlo, tutti gli sforzi della nostra intelligenza sono vani. Esso si nasconde all’infuori del suo campo e del suo raggio di azione in qualche oggetto materiale (nella sensazione che ci verrebbe data da quest’oggetto materiale) che noi non supponiamo. Quest’oggetto, vuole il caso che lo incontriamo prima di morire, o che non lo incontriamo.
Già da molti anni di Combray tutto ciò che non era il teatro o il dramma del coricarmi non esisteva più per me, quando in una giornata d’inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po’ di tè. Rifiutai dapprima, e poi, non so perché, mutai d’avviso. Ella mandò a prendere una di quelle focacce pienotte e corte chiamate «madeleinine», che paiono aver avuto come stampo la valva scanalata d’una conchiglia.
Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione d’un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di «madeleine». Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità, la sua brevità illusoria, nel modo stesso che agisce l’amore, colmandomi d’un’essenza preziosa: o meglio quest’essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m’era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del tè e della focaccia, ma la sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla?
Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale ricevo meno che dal secondo. E’ tempo ch’io mi fermi, la virtù della bevanda sembra diminuire. E chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. Essa l’ha risvegliata, ma non la conosce, e non può che ripetere indefinitamente, con forza sempre minore, quella stessa testimonianza che io sono incapace d’interpretare e che voglio almeno poterle donare di nuovo e ritrovare a mia disposizione intatta, fra poco, per una spiegazione decisiva. Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca a esso trovare la verità. Ma come? Grave incertezza, ogni qualvolta l’animo nostro si sente sorpassato da sé medesimo; quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla. Cercare? non soltanto: creare. Si trova di fronte a qualcosa che ancora non è, e che esso solo può rendere reale, poi far entrare nella sua luce.
E ricomincio a domandarmi che mai potesse essere quello stato sconosciuto, che non portava con sé alcuna prova logica, ma l’evidenza della sua felicità, della sua realtà dinanzi alla quale ogni altra svaniva. Voglio provarvi a farlo riapparire. Indietreggio col pensiero al momento in cui ho bevuto il primo sorso di tè. Ritrovo lo stesso stato, senza una nuova luce. Chiedo al mio animo ancora uno sforzo, gli chiedo di ricondurmi di nuovo la sensazione che fugge. E perché niente spezzi l’impeto con cui tenterà di riafferrarla, allontano ogni ostacolo, ogni pensiero estraneo, mi difendo l’udito e l’attenzione dai rumori della stanza accanto. Ma, sentendo come l’animo mio si stanchi senza successo, lo costringo a prendersi quella distrazione che gli rifiutavo, a pensare ad altro, a ripigliar vigore prima d’un tentativo supremo. Poi, una seconda volta, gli faccio intorno il vuoto; di nuovo gli metto di fronte il sapore ancora recente di quel primo sorso, e sento in me trasalire qualcosa che si sposta e che vorrebbe alzarsi, qualcosa che si fosse come disancorata, a una grande profondità, non so che sia, ma sale adagio adagio; sento la resistenza, e odo il rumore delle distanze traversate.
Certo, ciò che palpita così in fondo a me dev’essere l’immagine, il ricordo visivo, che, legato a quel sapore, tenta di seguirlo fino a me. Ma si agita in modo troppo confuso; percepisco appena il riflesso neutro in cui si confonde l’inafferrabile turbinio dei colori smossi; ma non so distinguere la forma, né chiederle, come al solo interprete possibile, di tradurmi la testimonianza del suo contemporaneo, del suo inseparabile compagno, il sapore, chiederle di rivelarmi di quale circostanza particolare, di quale epoca del passato si tratti.
Toccherà mai la superficie della mia piena coscienza quel ricordo, l’attimo antico che l’attrazione d’un attimo identico è venuta così di lontano a richiamare, a commuovere, a sollevare nel più profondo di me stesso? Non so. Adesso non sento più nulla, s’è fermato, è ridisceso forse; chi sa se risalirà mai dalle sue tenebre? Debbo ricominciare, chinarmi su di lui dieci volte. E ogni volta la viltà, che ci distoglie da ogni compito difficile, da ogni impresa importante, m’ha consigliato di lasciar stare, di bere il mio tè pensando semplicemente ai miei fastidi di oggi, ai miei desideri di domani, che si possono ripercorrere senza fatica.
E ad un tratto il ricordo m’è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di «madeleine» che la domenica mattina a Combray (giacché quel giorno non uscivo prima della messa), quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio.
La vista della focaccia, prima d’assaggiarla, non m’aveva ricordato niente; forse perché, avendone viste spesso, senza mangiarle, sui vassoi dei pasticcieri, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combray per unirsi ad altri giorni più recenti; forse perché di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori della memoria, niente sopravviveva, tutto s’era disgregato; le forme – anche quella della conchiglietta di pasta – così grassamente sensuale sotto la sua veste a pieghe severa e devota – erano abolite, o, sonnacchiose, avevano perduto la forza d’espansione che avrebbe loro permesso di raggiungere la coscienza. Ma, quando niente sussiste d’un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore, lungo tempo ancora perdurano, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l’immenso edificio del ricordo.
E, appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di “madeleine” inzuppato nel tiglio che mi dava la zia (pur ignorando sempre e dovendo rimandare a molto più tardi la scoperta della ragione per cui questo ricordo mi rendesse così felice), subito la vecchia casa grigia sulla strada, nella quale era la sua stanza, si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione sul giardino, dietro di essa, costruito per i miei genitori (il lato tronco che solo avevo riveduto fin allora); e con la casa la città, la piazza dove mi mandavano prima di colazione, le vie dove andavo in escursione dalla mattina alla sera e con tutti i tempi, le passeggiate che si facevano se il tempo era bello. E come in quel gioco in cui i Giapponesi si divertono a immergere in una scodella di porcellana piena d’acqua dei pezzetti di carta fin allora indistinti, che, appena immersi, si distendono, prendono contorno, si colorano, si differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili, così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Swann, e le ninfee della Vivonne e la buona gente del villaggio e le loro casette e la chiesa e tutta Combray e i suoi dintorni, tutto quello che vien prendendo forma e solidità, è sorto, città e giardini, dalla mia tazza di tè.
In questo brano troviamo il protagonista che inizia a recuperare il proprio passato attraverso il ricordo. Marcel è consapevole della differenza tra ricordo volontario e memoria involontaria. Il ricordo non si ottiene attraverso un processo cosciente, se non ottenendo immagini sterili, non emotive; solo l’emozione involontaria ed improvvisa, in questo caso suscitata da una madeleine è in grado di riportarlo ad un intero mondo che si credeva perduto. Questa memoria “liberata” dalla ragione, operando sulla coscienza, ci permette di ricercare per ritrovare noi stessi anche attraverso le azioni passate.
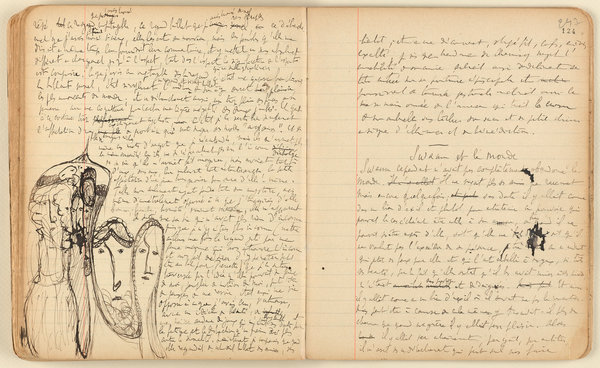 Pagina del manoscritto de “La strada di Swann”
Pagina del manoscritto de “La strada di Swann”
Tutto questo ci viene detto da Proust in una prosa involuta, dove le proposizioni s’innestano una nell’altra, rallentando il ritmo narrativo. Eppure proprio nel momento in cui assapora la madeleine, gli basta una semplice frase che gli permette di comunicare l’improvvisa felicità emotiva e “la riconquista di un passato che emerge attraverso il potere evocativo delle sensazioni” (Barberi Squarotti)
Sempre da La strada di Swann, leggiamo ora i primi innamoramenti di Marcel:
GILBERTE
Françoise aveva troppo freddo per star ferma; ci spingemmo sino al Ponte della Concordia, a veder la Senna imprigionata, a cui tutti e perfino i bambini s’accostavano senza timore come a un’immensa balena arenata, senza difesa, e che sarà squartata fra poco. Tornammo ai Champs-Elysées; io languivo di dolore tra i cavalli a legno immobili e il prato bianco caduto in prigionia nel reticolato nero dei viali dov’era stata rimossa la neve, sopra il quale la statua aveva in mano uno zampillo di ghiaccio aggiunto quasi a spiegazione del suo gesto. Perfino la vecchia signora , dopo aver ripiegato i suoi “Débats”, chiese l’ora a una bambinaia che passava e che ringraziò dicendo: «Come siete cortese!» poi, pregando il guardiano di dire ai suoi nipotini che tornassero perché lei aveva freddo, soggiunse: «Sarete mille volte buono. Davvero, ne sono confusa!». D’un tratto l’aria si lacerò: fra il teatrino delle marionette e il circo, all’orizzonte rifiorito, sul cielo dischiuso, avevo scorto, come un segno favoloso, la piuma azzurra della signorina. E già Gilberte correva a tutta velocità verso di me, sfavillante e rossa sotto un berretto di pelo di forma quadrata, animata dal freddo, dal ritardo e dalla voglia di giocare; un po’ prima d’avermi raggiunto, si lasciò scivolare sul ghiaccio e, sia per meglio tenersi in equilibrio, sia perché le pareva più grazioso, o per imitare il portamento di una pattinatrice, ella avanzava sorridendo con le braccia aperte, quasi vi avesse voluto accogliermi.
«Brava, brava! benissimo, direi come voi che è una cosa chic, una cosa audace, se non fossi di un altro tempo, del tempo dell’antico regime», esclamò la vecchia signora, prendendo la parola in nome dei Champs-Elysées silenziosi per ringraziare Gilberte d’essere venuta senza lasciarsi intimidire dal tempo. «Siete come me, fedele nonostante tutto ai vostri vecchi Champs-Elysées; siamo due donne intrepide. Se vi dicessi che li amo anche così. Questa neve, voi riderete di me, mi ricorda l’ermellino!» E la vecchia signora si mise a ridere.
Il primo di quei giorni, – a cui la neve, immagine delle forze che potevan privarmi della vista di Gilberte, dava la tristezza d’un giorno di separazione e perfino l’aspetto d’un giorno di partenza perché mutava le fattezze e quasi impediva l’uso del luogo consueto dei nostri soli incontri, ora trasformato, tutto coperto di neve, – quel giorno tuttavia fece progredire il mio amore, perché fu come un primo dolore ch’ella avesse condiviso con me. Della nostra brigata c’eravamo soltanto noi due, e trovarmi così solo con lei non soltanto era come un inizio d’intimità, ma anche, – quasi se, con un tempo simile, ella non fosse venuta che per me, – mi pareva altrettanto commovente da parte sua come se, uno di quei giorni in cui ella era stata invitata ad una festa, vi avesse rinunciato per venire ad incontrarmi ai Champs-Elysées; acquistavo maggior fiducia nella vitalità e nell’avvenire della nostra amicizia, che si manteneva vivace in mezzo al torpore, la solitudine e la rovina delle cose intorno; e, mentre lei mi metteva delle palle di neve nel collo, io sorridevo intenerito a quel che mi appariva al tempo stesso una predilezione ch’ella mi manifestava, tollerandomi come compagno di viaggio in quel paese invernale e nuovo, e una sorta di fedeltà che mi serbava nella sventura. Ben presto, una dopo l’altra, come passeri esitanti, arrivarono le sue amiche, nere nere sulla neve. Cominciammo a giocare, e, poiché quel giorno iniziatosi così tristemente doveva finire nella gioia, come io m’avvicinavo, prima di giocare a barriera, all’amica dalla voce breve che il primo giorno avevo udita gridare il nome di Gilberte, ella mi disse: «No, no, sappiamo bene che voi preferite stare nel campo di Gilberte, del resto vedete, lei vi fa segno». Infatti, ella mi chiamava perch’io andassi sul prato coperto di neve, nel suo campo, al quale il sole dava riflessi rosa, il logoramento metallico dei broccati antichi, facendone un Campo del Drappo d’oro.
Quel giorno da me così temuto fu invece uno dei soli in cui non mi sentissi troppo infelice. Invero, io che non pensavo più che a non stare mai un giorno senza vedere Gilberte (al punto che una volta, come la nonna non era rientrata per l’ora di pranzo, non potei fare a meno di dirmi subito che, se era finita sotto una carrozza, per qualche tempo non sarei potuto andare ai Champs-Elysées; non amiamo più nessuno quando amiamo), tuttavia in quei momenti ch’ero presso di lei e che avevo atteso dal giorno prima con tanta impazienza, per i quali avevo tremato, ai quali avrei sacrificato tutto il resto, non erano per nulla felici; e lo sapevo bene, essendo quelli i soli momenti della mia vita su cui concentrassi un’attenzione meticolosa, intensa, la quale non vi scopriva un atomo di piacere. Tutto il tempo ch’ero lontano da Gilberte, avevo bisogno di vederla, perché, cercando incessantemente di rappresentarmi l’immagine sua, infine non vi riuscivo più, e non sapevo più con precisione a che cosa corrispondesse il mio amore. Poi, ella non mi aveva ancora mai detto che m’amava. Al contrario, aveva affermato sovente d’aver degli amici che preferiva a me, che io ero un buon compagno col quale giocava volentieri, benché troppo distratto, non abbastanza interessato al gioco; infine, m’aveva dato spesso segni evidenti di freddezza che avrebbero potuto turbare la fiducia ch’io possedevo d’essere per lei qualcosa di diverso dagli altri, se tal fiducia avesse tratto origine da un amore che Gilberte provasse per me, e non invece, com’era in realtà, dall’amore che io provavo per lei: il che la rendeva ben più resistente, facendola dipendere dal modo stesso in cui, per un’intima necessità, io mi trovavo costretto a pensare a Gilberte. Ma i miei sentimenti per lei, io stesso non glieli avevo ancora dichiarati. Certo, scrivevo all’indefinito il suo nome e il suo indirizzo su ogni pagina dei miei quaderni; ma alla vista di quelle vaghe linee che tracciavo senza che per questo lei pensasse a me, e per opera delle quali prendeva tanto posto intorno a me apparentemente, senza trovarsi maggiormente unita alla mia esistenza, mi sentivo scoraggiato, perché non mi parlavano di Gilberte, che non le avrebbe neppure vedute, ma del mio desiderio, ch’esse parevamo mostrarmi come qualcosa di puramente personale, d’irreale, d’importuno e d’impotente. La cosa più urgente era che ci vedessimo, Gilberte ed io, e potessimo confessarci reciprocamente il nostro amore, che fino allora non avrebbe, per così dire, neppure avuto inizio. Senza dubbio, le svariate ragioni che mi rendevano così impaziente di vederla sarebbero state meno imperiose per un adulto. Più tardi avviene che, divenuti abili nella coltura dei nostri piaceri, ci accontentiamo del piacere provato nel pensare a una donna come io pensavo a Gilberte, senza curarci di sapere se questa immagine corrisponda alla realtà, e anche dal piacere di amarla senza una necessità d’una certezza che lei ci ami; o ancora avviene che noi rinunciamo al piacere di confessarle la nostra simpatia per lei per mantenere più viva la simpatia che lei ha per noi, imitando quei giardinieri giapponesi che per ottenere un fiore più bello ne sacrificano parecchi altri. Ma, nel tempo in cui amavo Gilberte, credevo ancora che l’Amore esistesse effettivamente fuori di noi; credo che, permettendoci tutt’al più di allontanare gli ostacoli, esso offrisse i suoi beni in un ordine in cui non vi fosse libertà di mutar nulla; mi pareva che se io, di mia volontà, avessi sostituito alla dolcezza della dichiarazione la simulazione dell’indifferenza, non soltanto mi sarei privato d’una delle gioie da me più sognate, ma mi sarei costruito a modo mio un amore fittizio e senza valore, senza comunicazione con l’amore vero, del quale avrei rinunciato a seguire le strade misteriose e preesistenti.
 Proust con la madre e il fratello Robert
Proust con la madre e il fratello Robert
Gilberte è la prima esperienza sentimentale del Narratore e ci viene narrata quando lo stesso è diventato ormai adulto. Ciò permette a Proust una variazione di tipo stilistico che passa dalla descrizione analitica della prima parte, con i Champs-Elysées innevati e, all’interno di essa una vecchietta d’altri tempi, di una gentilezza un po’ demodè, che sembrano anch’essi attendere l’arrivo di Gilberte, carica di ebbrezza giovanile, cui s’accompagnano in seguito, le sue amiche. Da questo punto lo stile cambia e diventa riflessivo, dove il suo atteggiamento viene vagliato alla luce dell’esperienza matura: quindi una serie di proposizioni ipotetiche in cui il nostro analizza il suo agire, qual era stato e quale sarebbe stato opportuno e le diverse conseguenze che tale agire ha e avrebbe avuto su Gilberte, mettendo in luce il tipico atteggiamento di Proust verso la materia narrata, che è sempre in lui una miscela tra narrazione vera e propria e riflessione. Ma quello che Proust in questo passo sottolinea è l’acquisizione da parte di un giovane Marcel di come l’amore sia ancora per lui un sentimento da oggettivare in un atto che lo dichiari, lo renda palese, insomma renda partecipe l’amata del sentimento provato.
Questo brano invece lo traiamo da La prigioniera:
ALBERTINE, LA DEA DEL TEMPO
Negli occhi della mia amica, nel brusco infiammarsi del suo viso sentivo a tratti come un lampo di calore trascorrere furtivamente in regioni che erano per me più inaccessibili del cielo e nelle quali si muovevano i ricordi, a me ignoti, di Albertine. La bellezza che – pensando agli anni che s’erano succeduti da quando conoscevo Albertine, sia sulla spiaggia di Balbec che a Parigi – le avevo scoperto da poco, e che consisteva nel fatto che la sua persona si sviluppava su tanti piani e conteneva tanti giorni passati, quella bellezza acquistava allora qualcosa di straziante. Sotto quel viso che arrossiva sentivo che si nascondeva, simile a una voragine, la riserva inesauribile delle sere in cui ancora non conoscevo Albertine. Potevo, sì, prendermi Albertine sulle ginocchia, tenerle la testa fra le mie mani, potevo accarezzarla, passare a lungo le mie mani su di lei; ma, come se avessi maneggiato una pietra che racchiude la salsedine degli oceani o il raggio di una stella, sentivo di non toccare che l’involucro chiuso d’un essere che, dal suo interno, era in comunicazione con l’infinito. Quanto soffrivo della posizione cui ci ha ridotti l’oblio della natura che, istituendo la divisione dei corpi, non si è curata di rendere possibile l’interpretazione delle anime! E mi rendevo conto che Albertine, per me, non era nemmeno (giacché se il suo corpo era in potere del mio, il suo pensiero sfuggiva alla presa del mio pensiero) la meravigliosa prigioniera di cui avevo creduto d’arricchire la mia dimora, nascondendone per altro la presenza – anche a chi veniva a trovarmi e certo non la sospettava in fondo al corridoio, nella camera accanto – non meno perfettamente di quel personaggio di cui tutti ignoravano che tenesse la principessa della Cina rinchiusa in una bottiglia; era piuttosto come una grande dea del Tempo, che mi invitava in una forma pressante, crudele e senza scampo alla ricerca del passato. E se è stato necessario che perdessi per lei degli anni e il mio patrimonio – e ammesso) cosa – ahimè, tutt’altro che sicura) che lei non ci abbia a sua volta perduto – non ho niente, io, da rimpiangere. E’ probabile che meglio sarebbe valsa la solitudine, più feconda, meno dolorosa. Ma quanto alla vita del collezionista che Swann mi consigliava, che il signor di Charlus mi rimproverava di non conoscere quando con un misto di spirito, di insolenza e di compiacimento mi diceva: «Quant’è brutta la vostra casa!», quali mai statue, quali quadri lungamente perseguiti e infine posseduti o, nel migliore dei casi, contemplati con disinteresse, mi avrebbero, quanto la piccola ferita che si cicatrizzava abbastanza in fretta, ma che l’incosciente sbadataggine di Albertine, degli estranei, o dei miei stessi pensieri non tardava a riaprire, consentito l’accesso a quell’uscita fuor di se stessi, a quella via di comunicazione privata, ma destinata a immettersi nella grande strada dove passa ciò che ci è dato conoscere solo quando cominciamo a soffrire: la vita degli altri?
A volte c’era un così bel chiaro di luna che, appena un’ora dopo che Albertine s’era coricata, andavo fino al suo letto per dirle di guardare fuori dalla finestra. Sono sicuro che è per questo che andavo in camera sua, e non per accertarmi che lei ci fosse. Come avrebbe potuto andarsene, o anche desiderarlo? Ci sarebbe voluta una collusione, inverosimile con Françoise. Nella camera buia non vedevo, sul candore del cuscino, che un sottile diadema di capelli neri. Ma sentivo il respiro di Albertine. Il suo sonno era così profondo che esitavo ad accostarmi al letto; mi sedevo sul bordo; il sonno continuava a scorrere con lo stesso mormorio. Non è possibile dire quanto fossero allegri i suoi risvegli. La baciavo, la scuotevo. Subito lei smetteva di dormire e, senza un solo istante di intervallo, scoppiava a ridere, e annodandomi le braccia intorno al collo mi diceva: «Stavo giusto chiedendomi se non saresti venuto», e teneramente rideva a più non posso. Si sarebbe detto che la sua testa incantevole, quando dormiva, fosse piena soltanto d’allegria, di tenerezza e di risa. E che, svegliandola, io non avessi fatto altro, come quando si apre un frutto, che sprigionarne il suo succo zampillante che disseta. L’inverno, intanto, finiva; tornò la bella stagione, e spesso, quando Albertine m’aveva appena detto buonanotte e la mia camera, le tende, la parete al di sopra di esse erano ancora tutte nere, nel giardino del vicino convento, ricca e preziosa nel silenzio come l’armonium di una chiesa, sentivo la modulazione d’un uccello sconosciuto che già cantava mattutino secondo il modo lidio, illuminando le mie tenebre con la ricca nota di splendore di quel sole che già vedeva. Presto le notti si accorciarono, e prima di quelle ch’erano state le ore del mattino già vedevo il biancore quotidianamente incrementato del giorno filtrare dalle tende della finestra. Se mi rassegnavo a lasciare che Albertine facesse ancora quella vita in cui, malgrado i suoi dinieghi, sentivo che aveva l’impressione di essere prigioniera, era solo perché ogni giorno ero sicuro che l’indomani mi sarei messo, oltre che lavorare, ad alzarmi, a uscire di casa, a fare preparativi per la partenza verso qualche proprietà che avremmo acquistata e dove Albertine avrebbe potuto condurre più liberamente, e senza inquietudine per me, la vita di campagna o di mare, di navigazione o di caccia, che le fosse piaciuta.
Senonché, l’indomani, quel passato che volta a volta amavo e detestavo in Albertine (giacché, mentre ancora è presente, ciascuno tende – per interesse, per cortesia, per pietà – a tessere fra esso e noi una cortina di menzogne che scambiamo per realtà – succedeva che, retrospettivamente, una delle ore che lo componevano, non escluso quelle che avevo creduto di conoscere, mi presentasse di colpo un aspetto che non si cercava più di velarmi e che era fatto diverso da quello sotto il quale m’era apparsa. Dietro quel certo sguardo c’era, al posto del pensiero buono che allora m’era apparso di vederci, un desiderio ancora inconfessato che si rivelava, alienandomi un’altra parte del cuore di Albertine che avevo creduto assimilato al mio.

David Wesley Richardson: Albertine
Marcel non era ancora un uomo quando palpitava per Gilberte, ed arrivato alla conclusione che senza un’esplicita dichiarazione dell’amore provato, esso diventasse un sentimento dimezzato. In Albertine tale problema si è capovolto: non solo l’ha “rapita” per gelosia, non permette a nessuno di vederla e mettere a rischio la sua totale padronanza su di lei. Ma è una padronanza illusoria: egli può avere il corpo, ma non può possedere i suoi pensieri. L’amore allora non può essere totale, ma solo tendere verso un infinito irraggiungibile. Albertine, infatti, non è solo una donna, lì presente nella sua esclusività, e tale è perché lei è sì ciò che gli occhi desiderosamente guardano dormire, ma è anche il suo passato e i suoi ricordi che saranno solo suoi e che non può condividere. Se il recupero del passato è un atto difficile, frutto di quelle “intermittenze del cuore” che permettono di cogliere l’essenza di una vita, è impossibile cogliere la totalità di una vita altrui: ciò porta alla consapevolezza che se un essere, foss’anche un essere profondamente amato, di cui si crede che il cuore sia assimilato al proprio, costui gli è profondamente alienato, e questo ci è detto in una delle pagine più profonde del capolavoro proustiano.
Ed eccoci Al tempo ritrovato:
 Immagine dal film “Il tempo ritrovato” (1999)
Immagine dal film “Il tempo ritrovato” (1999)
L’ARTE COME RIVELAZIONE
La grandezza dell’arte vera, consiste nel ritrovare, nel riafferrare, nel farci conoscere quella realtà da cui viviamo lontani, da cui ci scostiamo sempre più via via che si acquista maggior spessore e impermeabilità la conoscenza convenzionale che le sostituiamo: quella realtà che noi rischieremmo di morire senza aver conosciuta, e che è semplicemente la nostra vita. La vita vera, la vita finalmente scoperta e tratta alla luce, la sola vita quindi realmente vissuta, quella che, in un certo senso, dimora in ogni momento in tutti gli uomini altrettanto che nell’artista. Ma essi non la vedono, perché non cercano di chiarirla. E così il loro passato è ingombro d’innumerevoli lastre fotografiche, che rimangono inutili perché l’intelligenza non le ha sviluppate. Riafferrare la nostra vita, e anche la vita altrui: giacché lo stile, per lo scrittore, come il colore per il pittore, è un problema non di tecnica, ma di visione. Esso è la rivelazione, impossibile con mezzi diretti e coscienti, della differenza qualitativa che esiste nel modo come ci appare il mondo: differenza che, se non ci fosse l’arte, resterebbe l’eterno segreto di ognuno. Solo grazie all’arte ci è dato uscire da noi stessi, sapere quel che un altro vede di un universo non identico al nostro e i cui paesaggi ci rimarrebbero altrimenti ignoti come quelli che possono esserci nella Luna. Grazie all’arte, anziché vedere un solo mondo, il nostro, noi lo vediamo moltiplicarsi; e, quanto più sono gli artisti originali, tanti più sono i mondi a nostra disposizione, diversi gli uni dagli altri più ancora dei mondi roteanti dell’infinito; e molto secoli dopo che v’è spento il focolaio da cui emanavano – si chiamino Rembrandt o Vermeer – continuano a inviarci il loro raggio particolare.
Questo lavoro dell’artista, volto a cercar di scorgere sotto una certa materia, sotto una certa esperienza, sotto certe parole, qualcos’altro, è esattamente inverso a quello che, in ogni istante, allorché viviamo stornati da noi stessi, l’orgoglio, la passione, l’intelligenza e anche l’abitudine, compiono in noi, ammassando sopra le nostre genuine impressioni, per nascondercele, le nomenclature, gli scopi pratici, cui diamo erroneamente il nome di “vita”. Insomma, quest’arte così complessa è davvero la sola arte viva. Solo essa esprime agli altri e mostra a noi stessi la nostra propria vita, la vita che non si può “osservare”, le cui apparenze, che osserviamo, debbono venir tradotte e spesso lette a rovescio, e decifrate con grande fatica. Il lavoro compiuto dal nostro orgoglio, dalla nostra passione, dal nostro spirito imitativo, dalla nostra intelligenza astratta, dalle nostre abitudini, quel lavoro l’arte lo distruggerà, ci ricondurrà indietro, ci farà tornare agli abissi profondi dove quel che è esistito realmente giace ignoto. E, di certo, era una grande tentazione voler ricreare la vita, ringiovanire le impressioni. Ma esigeva coraggio di ogni genere, anche sentimentale. Infatti, significava, anzitutto, rinunciare alle più care illusioni, non creder più all’oggettività di quanto noi stessi abbiamo elaborato, e, in luogo di cullarsi un’ennesima volta al suono delle parole “era tanto cara”, leggere in trasparenza: “Mi piaceva baciarla”. Certo, quel che avevo provato io in quelle ore di amore, anche ogni altro uomo lo prova. La proviamo, ma quel che si è provato è simile a certe negative, dove non vediamo che nero finché non le accostiamo una lampada, e che vanno guardate anch’esse a rovescio: quel che abbiamo provato non sappiamo che cosa sia finché non l’abbiamo accostato all’intelligenza. Solo allora, quand’essa lo ha illuminato, lo ha intellettualizzato, distinguiamo, e sempre con stento, il volto di quel che si è sentito.
Cos’è l’arte? Mi torna in mente il Dante del Convivio, quello secondo cui tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere; potremo dire che in Proust il “sapere” equivalga a conoscersi e quindi avere la consapevolezza della propria vita. Tale consapevolezza tuttavia è quasi cancellata dagli attimi del presente, inframezzati è vero anche dalla capacità del ricordo, che tuttavia in quanto passato ci appare come cronologicamente determinato e finito (il loro passato è ingombro d’innumerevoli lastre fotografiche, che rimangono inutili perché l’intelligenza non le ha sviluppate). Compito dell’artista è quello di riesumare tale passato affinché si arrivi alla conoscenza della nostra vera vita, attraverso un processo intellettuale che permetta di svelare e di svelarci la più intima realtà. Allora sarà l’artista che in grado di descrivere e far rivivere tutti gli attimi di un vissuto, ci darà l’integrità della vita e pertanto sarà l’arte l’unica realtà.
 Proust a Venezia
Proust a Venezia
Alla ricerca del tempo perduto si presenta come un grandioso affresco della società aristocratica ed alto borghese francese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. La Recherche contiene infinite pagine dedicate alla caratterizzazione dei personaggi, degli ambienti in cui vivono, dei loro gusti e della loro qualità della vita. Tuttavia l’opera non è un romanzo descrittivo e rappresentativo della realtà, anzi è il capolavoro dell’interiorità e tutto questo è determinato dalla tecnica narrativa proustiana. Per Proust le sensazioni e le cose sono immerse nel flusso della transitorietà del tempo. Bisogna dunque dar vita ad una lotta strenua contro il tempo per recuperare la nostra memoria, il patrimonio del nostro io più autentico. Già il filosofo Bergson aveva parlato della coesistenza nella nostra coscienza di un tempo interiore che dissolveva le categorie spazio-temporali. Anche Proust si muove all’interno di un tempo interiore e si affida per il recupero memoriale all’inconscio e ai rapporti analogici. Per l’autore francese esiste una memoria volontaria (o intellettuale), che richiama alla nostra intelligenza eventi del passato ma in termini logico-razionali, cioè senza ridarci l’insieme delle sensazioni di un determinato episodio, che lo hanno reso unico ed irripetibile; ma possediamo anche una memoria involontaria (o spontanea / sensoriale) che sollecitata da un profumo, un sapore, una musica, un colore, un paesaggio ci rituffa nel passato con un processo analogico che ci permette di sentire la “contemporaneità” di quell’evento passato. Egli chiama questa capacità di simultaneità tra presente e passato intermittenze del cuore, ed è attraverso esse che egli scrive la sua Recherche. Tutte le vicende presenti nei sette volumi non sono pertanto strutturati secondo un procedimento cronologico, ma attraverso ciò che le “intermittenze del cuore” dettano alla sua sensibilità. Tuttavia ciò non porta Proust ad una prosa irrazionale; sarà la coscienza dell’io che, una volta registrata “l’intermittenza”, la porterà alla nitezza e logicità della pagina proustiana. Essendo l’io a raccontare sia gli eventi che i personaggi perdono la loro oggettività, perché non sono che il riflesso dell’angolazione temporale con cui l’autore li osserva. Così Swann non lo vedremo nella sua “oggettiva” evoluzione temporale, ma nella soggettiva “temporalizzazione” dell’io narrante che lo vede in modo diverso a seconda del momento in cui lo racconta.
André Gide
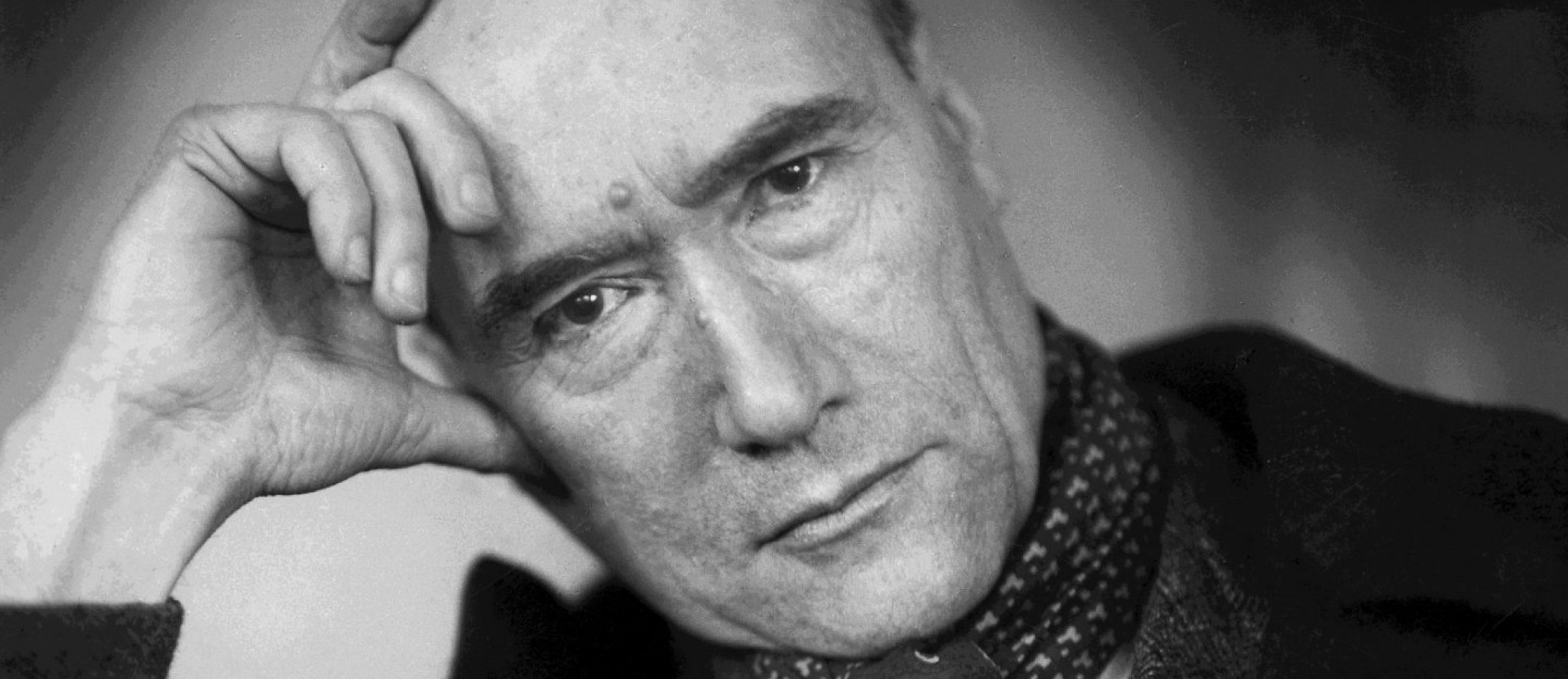
André Gide, intellettuale francese, nasce a Parigi nel 1869 da una famiglia facoltosa. Rimasto orfano di padre, ricevette, per volere materno, una rigida educazione puritana. Morta anche la madre nel 1895 Gide sposò la cugina Madelaine Rondeaux, con la quale aveva un intenso rapporto spirituale (non certo sessuale, essendo Gide omosessuale). Con alcuni intellettuali fondò, sin dal 1908 la Nouvelle Revue Française, che divenne nel periodo fra le due guerre, la più importante rivista letteraria europea. Dopo un viaggio in Congo, s’iscrisse nel 1932 al Partito Comunista per poi uscirne dopo un viaggio in URSS. Nel 1947 fu insignito del premio Nobel per la letteratura. Morì nel 1951.
Tra le sue opere ricordiamo L’immoralista e La porta stretta, romanzi rispettivamente del 1902 e del 1909 che potremo considerare complementari: infatti se nel primo l’esigenza di autorealizzazione di Michel, il suo nietzschismo, lo portano ad uccidere la giovane moglie, nel secondo Alissa percorre la strada opposta della rinuncia e dell’ascesi spirituale che terminerà con il proprio annullamento ottenuto col suicidio. Il suo capolavoro è considerato I sotterranei del Vaticano, famosi anche per la polemica anticattolica. In seguito pubblicherà ancora resoconti sui suoi viaggi come Viaggio in Congo e Ritorno dal Ciad (1928 e 1929), dove emerge una forte critica contro il colonialismo. Importantissimo è anche il romanzo I falsari (l’unico a cui Gide attribuì tale genere), opera fondamentale non soltanto per la Francia ma anche per l’intera cultura europea.
I sotterranei del Vaticano viene pubblicato nel 1914. Lafcadio Wluiti scopre di essere figlio naturale del vecchio conte Agénor de Baraglioul, con il quale avrà un commovente colloquio; e poco dopo, alla morte del conte, ne diverrà uno degli eredi. Frattanto a Pau, in Guascogna, un ex compagno di scuola di Lafcadio, Protos, ha inventato con la sua banda dei “Millepiedi”, un colossale imbroglio: che il papa Leone XIII è tenuto prigioniero nei sotterranei di Castel Sant’Angelo da una congiura di logge massoniche e che è stato sostituito da un sosia. Per estorcere denaro agli ingenui fedeli organizza una crociata. Fra le vittime di questo inganno c’è Amédée Fleurissoire, cognato di Julius Baraglioul, il fratellastro di Lafcadio. Una sera, sulla linea Roma-Napoli, Amedée muore vittima di un “atto gratuito” di Lafcadio che, viaggiando per una coincidenza fortuita nello stesso scompartimento, lo butta dal treno. Protos, testimone del fatto, ricatta Lafcadio, mentre Carola, ex amante di Lafcadio e ora donna di Protos, credendo quest’ultimo colpevole, lo denuncia. Protos la uccide prima che la polizia lo arresti. Lafcadio, ora sconvolto e in preda ai rimorsi, si rivolge al fratellastro Julius che gli consiglia di confessare il delitto e di cercare conforto nella fede. Lafcadio ancora esita. E Gènevieve, figlia di Julius, quella stessa notte si getta tra le braccia di Lafcadio e gli dichiara il suo amore, accrescendo così, la sua drammatica incertezza.
L’ATTO GRATUITO
Lafcadio benché abbia gli occhi chiusi, non dorme; non riesce a dormire.
“Il vecchietto che sento lì, avanti a me, crede che io dorma” pensava. “Se socchiudessi gli occhi, lo vedrei che mi guarda. Protos diceva che è notevolmente difficile fingere di dormire spiando intorno; egli asseriva di poter discernere il falso sonno da quel leggero tremito delle palpebre… che io reprimo in questo momento. Ma anche Protos si ingannerebbe…”
Frattanto il sole era tramontato; già gli ultimi riflessi della sua gloria s’attenuavano e Fleurissoire li contemplava estatico. Improvvisamente, nel soffitto a volta del vagone, l’elettricità s’accese; illuminazione troppo brutale dopo quel tenero crepuscolo; e, anche per timore che essa disturbasse il sonno del suo vicino, Fleurissoire girò l’interruttore: ciò non fece l’oscurità completa, ma diramò la corrente, dalla lampada centrale, a una lampada azzurra da notte. Ma secondo Fleurissoire anche quella lampadina azzurra dava troppa luce; diede un altro giro alla chiavetta; la lampada azzurra si spense, ma si accesero immediatamente due lampade laterali, più abbaglianti della lampada centrale; un altro giro e ancora la lampada azzurra; si adattò a questa.
“La finirà di giocare con la luce?” pensava spazientito Lafcadio. “Che diavolo fa, adesso? (no, non alzerò le palpebre). E’ in piedi… Lo attirerebbe forse la mia valigia? Bravo! Egli constata che è aperta. Valeva proprio la pena che a Milano facessi applicare una serratura complicata, per essere costretto a farla forzare a Bologna, avendone perso subito la chiave! Un lucchetto almeno si sostituisce… Accidenti, si leva la giacca? E allora guardiamo!”.
Senza badare alla valigia di Lafcadio, Fleurissoire, occupato del suo nuovo colletto, s’era levato la giacca per poterlo abbottonare più comodamente; ma la tela inamidata, dura come cartone, resisteva a tutti i suoi sforzi.
“Non ha l’aria gaia” riprendeva per conto suo Lafcadio. “Deve avere una fistola o qualche altro male nascosto. Debbo aiutarlo? Credo che da solo non ci riuscirà…”
Eppure, sì. Il colletto ricevette finalmente il bottone. Allora Fleurissoire riprese sul sedile la cravatta che aveva posata presso il cappello, la giacca e i polsini, e, avvicinandosi al finestrino, cercò, come Narciso, di distinguere sul vetro il suo volto dal paesaggio.
“Non ci vede abbastanza”.
Lafcadio riaccese la luce. Il treno correva lungo una scarpata che attraverso il finestrino si scorgeva illuminata dalla luce che proiettava ogni scompartimento; questo faceva una fila di quadrati chiari che danzavano lungo la ferrovia e di deformavano ad ogni accidente del terreno. In mezzo ad uno di essi si scorgeva l’ombra buffa di Fleurissoire. Gli altri quadrati erano vuoti!
“Chi lo vedrebbe?” pensava Lafcadio. “Lì, vicinissimo alla mia mano, la doppia maniglia di chiusura che io posso smuovere facilmente; questa porta che, aprendosi improvvisamente, lo lascerebbe capitombolare in avanti; una piccola spinta basterebbe; egli cadrebbe nella notte come un masso; non si udirebbe nemmeno il suo grido… E domani, in strada per le isole!… Chi lo saprebbe?”
La cravatta era messa; un piccolo nodo già fatto; in quel momento Fleurissoire aveva ripreso un polsino e lo adattava al suo braccio destro; e facendo ciò, esaminava, al di sopra del posto in cui era stato seduto poco prima, la fotografia (una delle quattro che ornavano lo scompartimento) di un palazzo in riva al mare.
“Un delitto senza scopo” continuava Lafcadio “che imbarazzo per la polizia! Ma in fondo, chiunque potrebbe vedere da uno scompartimento vicino, nel riflesso sulla scarpata, uno sportello che s’apre e l’ombra cinese che fa una capriola: meno male che le tende del corridoio sono chiuse… Non è tanto degli avvenimenti che sono curioso, quanto di me stesso. Ci sono tanti che si credono capaci di tutto, ma al momento d’agire si tirano indietro… Che enorme distanza tra l’immaginazione e il fatto!… Ed è come nel gioco degli scacchi: pezzo toccato, pezzo giocato! Ma a prevedere tutti i rischi, il gioco perderebbe d’interesse!… Tra l’immaginazione del fatto e… Guarda! La scarpata cessa. Siamo su un ponte, credo; un fiume.”
Sul fondo del vetro, nero adesso, i riflessi apparivan più chiari e Fleurissoire si chinò per rettificare la posizione della sua cravatta.
“Lì, sotto la mia mano, la doppia maniglia (mentr’egli è distratto e guarda lontano) si apre, già! più facilmente di quanto avessi creduto. Se posso contar sino a dodici, senza affrettarmi, prima di vedere qualche lume nel paesaggio, il tapiro è salvo. Comincio: uno, due, tre, quattro (lentamente! lentamente!) cinque, sei, sette, otto, nove… dieci, una luce…”
Fleurissoire non gettò nemmeno un grido: sotto la spinta di Lafcadio e dinanzi all’abisso bruscamente aperto ai suoi piedi, egli fece un gran gesto per trattenersi, la sua mano sinistra afferrò lo stipite liscio dello sportello, mentre egli, per metà voltato, gettava la destra indietro, lontana al di sopra di Lafcadio, mandando a rotolare sotto il sedile, all’altra estremità del vagone, il secondo polsino che stava mettendo a posto.
Lafcadio sentì un artiglio orribile abbattersi sulla sua nuca; abbassò la testa e diede una seconda spinta, più impaziente della prima; e Fleurissoire non trovò più nulla cui aggrapparsi a eccezione del cappello di castoro che afferrò disperatamente e portò con sé nella caduta.
“E ora, sangue freddo” disse tra sé Lafcadio. “Non sbattiamo lo sportello; nel vagone vicino potrebbero sentire.”
Tirò a sé lo sportello, controvento, con un certo sforzo, poi lo richiuse pian piano.
“Mi ha lasciato il suo orribile cappello di paglia; ancora un po’ e con una pedata lo mandavo a raggiungere il suo padrone; ma egli mi ha preso il mio, e deve bastargli. Ottima precauzione quella che ho avuto di togliere le iniziali!… Ma nella fodera rimane la marca del cappellaio, al quale certo non si ordinano tutti i giorni i cappelli di castoro… Tanto peggio, la mossa è fatta… E non potranno nemmeno credere a un incidente, perché ho richiuso lo sportello… Far fermare il treno? Suvvia, Cadio, niente ritocchi: tutto è come tu lo hai voluto. Per provarmi che sono perfettamente padrone di me cominciamo col guardare che cosa rappresenta questa fotografia, che il vecchio contemplava poco fa… Miramare!… Non ho nessuna voglia di andarlo a vedere. Qui manca l’aria”. Aprì il finestrino.
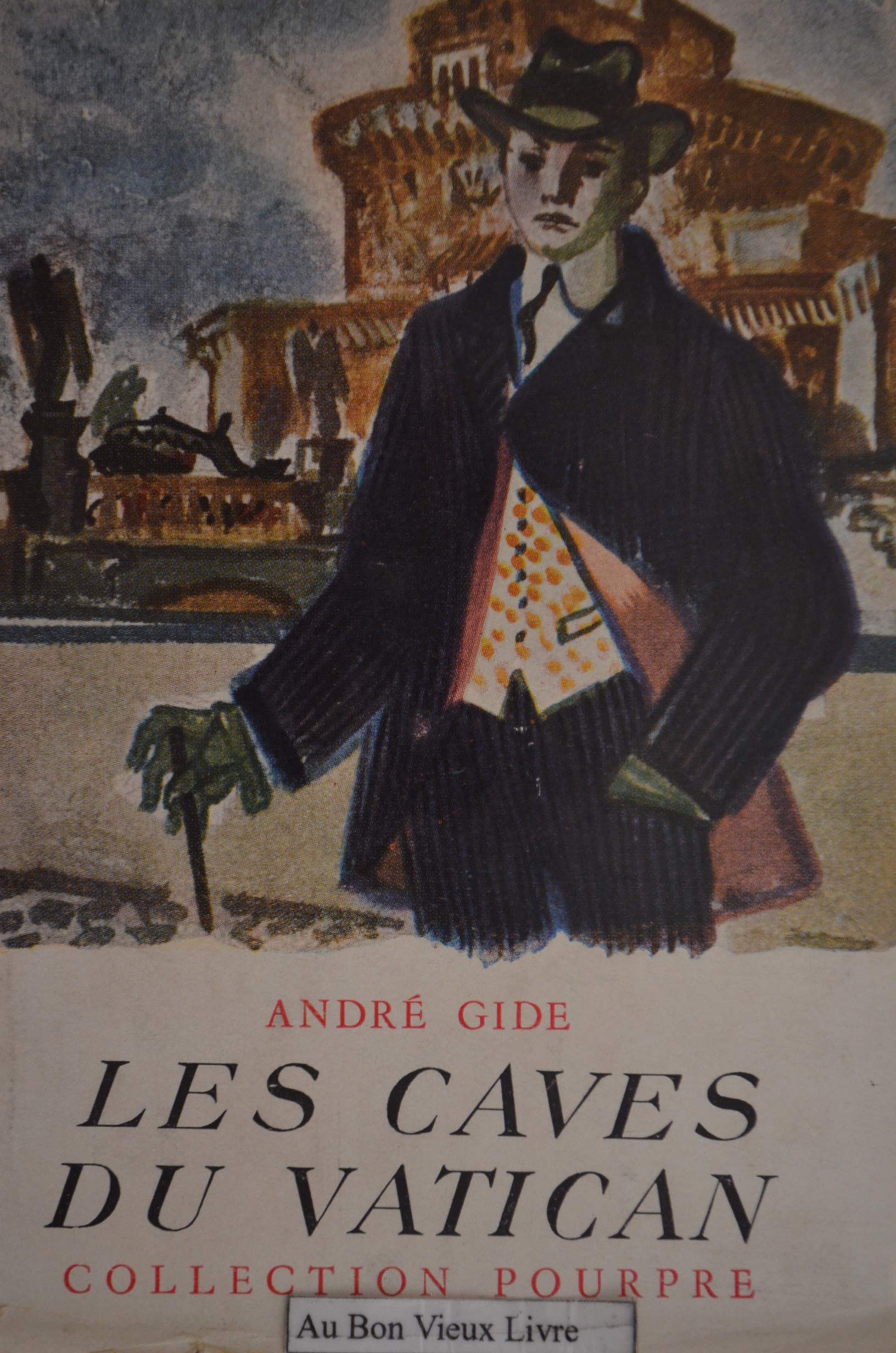
Si potrebbe dire che qui Gide imiti il Dostoevskij di Delitto e castigo, eppure l’atto gratuito di Lafcadio è completamente diverso da quello di Raskol’nikov: se alla base dell’omicidio del personaggio russo vi è il nichilismo, qui l’atto gratuito è nicciano figlio della teorizzata morte di Dio del filosofo tedesco. Nasce, se così si può dire, da un monologo interiore che il protagonista svolge durante il viaggio in treno (non è un caso la scelta di un treno: durante il viaggio non c’è né spazio, né tempo definito, ergo non c’è altrettanto alcuna morale definita). La scommessa è quella di mettere sotto scacco non solo le capacità della polizia, ma, di fronte ad un’azione delittuosa immotivata, la morale di una società. Ma Lafcadio mette in gioco un altro elemento fondamentale: il suo delitto è frutto di una scelta irrazionale, pertanto laddove non c’è morale, non vi è neanche ragione. Quindi se è un atto irrazionale a Nietzsche bisogna aggiungere Freud, il quale afferma che gli atti gratuiti sono figli del nostro inconscio sede degli istinti più elementari fra i quali predominano quello sessuale e aggressivo.
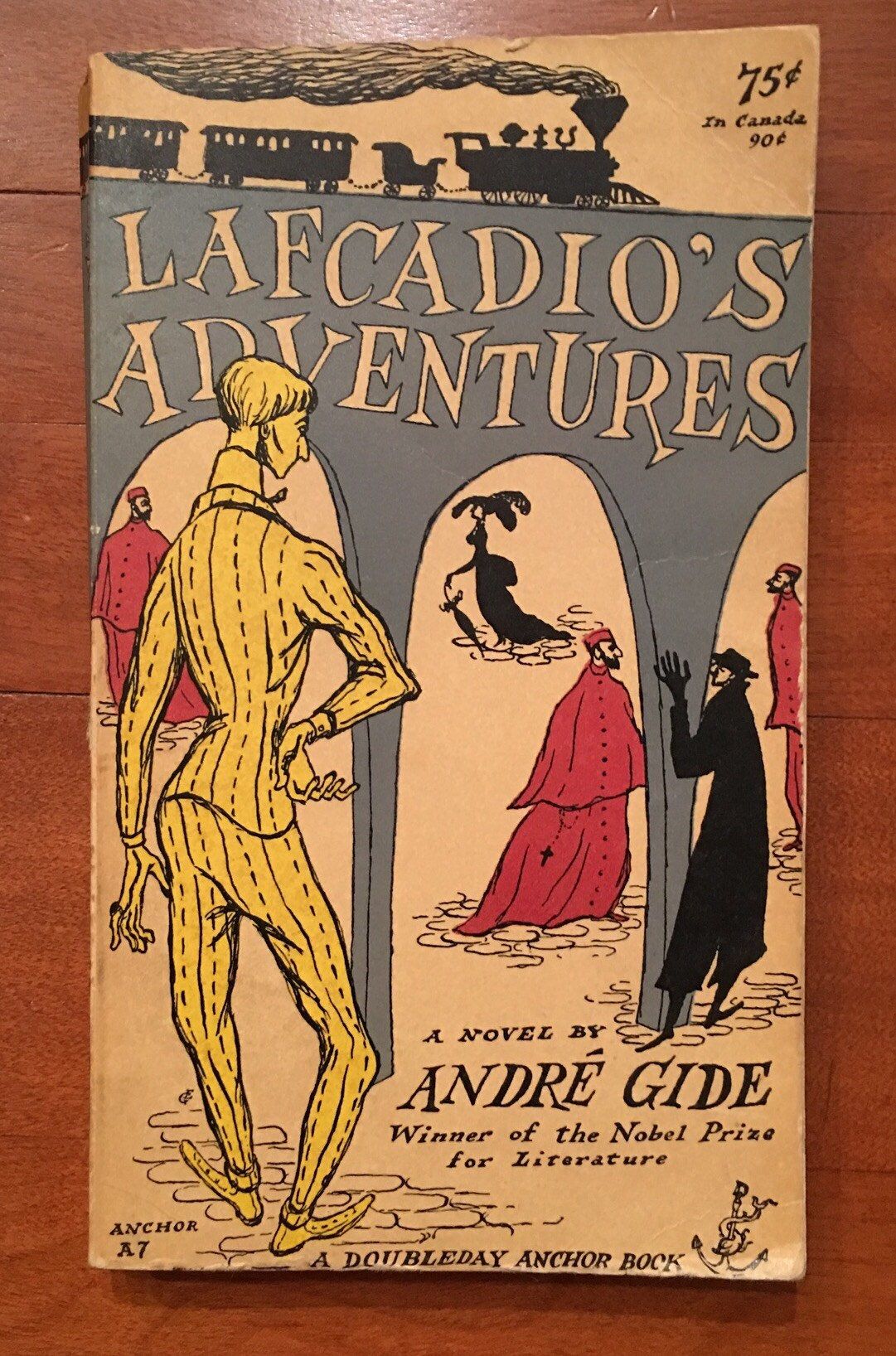
L’opera dello scrittore francese, ed anche in questa opera, riprende in parte il processo di decostruzione della trama tipica del romanzo contemporaneo, ma come sostiene Stefano Agosti, in Gide c’è una differenza sostanziale rispetto ad altri scrittori che hanno utilizzato la stessa tecnica narrativa: “Le plurispettazioni dell’oggetto corrispondono qui non tanto a volontà di disarticolazione del reale per successiva restituzione plenaria dello stesso al di là della progressione temporale lineare e univoca (come accade in celebri testi del Novecento, da Virginia Woolf a Faulkner), quanto invece a necessità di rilanciare l’intreccio da una situazione collaterale, che diventa, a sua volta, centrale e così via. Praticamente le plurispettazioni corrispondono al progetto di esaurire intenzionalmente il maggior numero di possibilità relativamente agli elementi presenti in una data situazione.
A ciò si aggiunga il fatto che Gide non chiude mai le sue storia, lasciando sempre un finale aperto: anche di Lafcadio non sapremo cosa farà dopo l’omicidio: si denuncerà o continuerà come nulla fosse successo?
Opere in lingua spagnola e portoghese
Miguel de Unamuno
 Miguel de Unamuno è uno scrittore e filosofo spagnolo, più precisamente nativo della regione Basca. Nasce infatti a Bilbao nel 1880. Fu un uomo che da giovane viaggiò sia in Francia che in Italia e al suo ritorno ricoprì la cattedra di lingua e cultura greca nell’università di Salamanca. Divenne rettore nel 1901, ruolo che ricoprì fino al 1914 quando fu destituito per la sua attività contro la monarchia. Dopo dieci anni venne esiliato per la sua opposizione al regime di Primo de Rivera. Fuggì e su una nave francese raggiunse il suolo transalpino dove rimase sino al 1930. Allo scoppio delle guerra civile appoggiò il franchismo, pur criticando l’atteggiamento terroristico dei militari. Per averli attaccati viene un ennesima volta destituito e messo agli arresti domiciliari. Muore d’infarto nel 1936.
Miguel de Unamuno è uno scrittore e filosofo spagnolo, più precisamente nativo della regione Basca. Nasce infatti a Bilbao nel 1880. Fu un uomo che da giovane viaggiò sia in Francia che in Italia e al suo ritorno ricoprì la cattedra di lingua e cultura greca nell’università di Salamanca. Divenne rettore nel 1901, ruolo che ricoprì fino al 1914 quando fu destituito per la sua attività contro la monarchia. Dopo dieci anni venne esiliato per la sua opposizione al regime di Primo de Rivera. Fuggì e su una nave francese raggiunse il suolo transalpino dove rimase sino al 1930. Allo scoppio delle guerra civile appoggiò il franchismo, pur criticando l’atteggiamento terroristico dei militari. Per averli attaccati viene un ennesima volta destituito e messo agli arresti domiciliari. Muore d’infarto nel 1936.
Da un punto di vista filosofico potremo così sintetizzare il suo pensiero, che anticipa i temi dell’esistenzialismo:
- l’ansia di immortalità che anima ogni individuo e ne determina la sua religiosità, la quale non coincide necessariamente con il cattolicesimo;
- la dottrina dell’uomo concreto (“in carne ed ossa”) con la sua singolarità e e la sua solitudine, condizionato sì dalla vita circostante, ma in pari misura dal sentimento della ragione;
- l’attenzione concessa ao motivi dell’espressione e della lingua, con la conseguenza che la filosofia vive più nei poeti che nella speculazione astratta;
- il senso dell’angoscia che tinge di amarezza e di conflittualità l’esistenza umana.
Da un punto di vista letterario egli viene fortemente influenzato da Pirandello e occuperà ogni genere come nell’autobiografico Pace nella guerra (1897) o nel romanzo Nebbia (1914). Importanti sono anche le Tre novelle esemplari (1920). Scrisse anche per il teatro, senza tuttavia raggiungere grandissimi esiti. Migliori gli esiti poetici dove si avvicinò al simbolismo, aggiungendo tuttavia un forte scavo interiore, come nelle raccolte Romancero dell’esilio (1928) il Canzoniere, diario poetico, pubblicato postumo nel 1955.
Nebbia parla del personaggio di Augusto Pérez giovane ricco ed introverso. Innamoratosi di Eugenia vista mentre attraversa la strada, decide di corteggiarla, aiutato dai membri della famiglia della ragazza, che cercano così di risollevare i problemi finanziari della nipote. Eugenia rifiuta la corte del ragazzo, visto che è già impegnata in una relazione con Mauricio. Augusto provvede al pagamento dell’ipoteca di Eugenia senza che ella lo sappia, ma invece che ottenere l’effetto sperato, la ragazza si sente offesa dal suo gesto. Successivamente, Augusto si invaghisce di un’altra ragazza, Rosario, e quindi inizia a chiedersi se fosse mai stato innamorato di Eugenia. Dopo aver parlato con alcuni amici Augusto decide di fare comunque la proposta di matrimonio ad Eugenia che accetta. Pochi giorni prima del matrimonio, però viene a sapere che lei è andata a vivere con Mauricio. Augusto, devastato dalla notizia, decide di uccidersi, ma prima di farlo, decide di contattare Unamuno (l’autore del romanzo) che aveva scritto sul suicidio. Il fatto è che Augusto è un personaggio creato da Unamuno, e per questo non può uccidersi in quanto non è reale. Augusto pur sapendolo afferma di esistere, si rivolge duramente ad Unamuno, dicendogli che non è l’autore supremo e quindi ritornerà a casa, dove morirà ucciso dall’autore. Il libro termina con un monologo del cane di Augusto, Orfeo, che si commuove di fronte alla morte del padrone ed alla situazione degli esseri umani in generale.
LA PARTITA A SCACCHI
«Oggi sei in ritardo» disse Victor ad Augusto «tu sei sempre così puntuale!»
«Cosa vuoi, impegni…»
«Impegni tu? Credi forse che abbiano impegni soltanto gli agenti di borsa? La vita è molto più complessa di quanto tu possa immaginare».
«Più semplice di quanto tu possa credere…»
«Può essere».
«Bene, gioca!»
Augusto fece avanzare di due posti un pezzo, e invece di canterellare, come faceva altre volte un brano d’opera, disse a se stesso: “Eugenia, Eugenia, Eugenia mia, scopo della mia vita, splendore di stelle gemelle fra la nebbia: combatteremo! Sì, vi è una logica nel gioco degli scacchi e, tuttavia, come tutto è nebuloso, fornito in fin dei conti! Sarà anche la logica qualcosa di fortuito, qualcosa d’accidentale? E quest’apparzione della mia Eugenia, non sarà qualcosa di logico? Non obbedirà ad un divino gioco di scacchi?”
«Ma, perbacco» lo interruppe Victor «non sai che non vale ritirare la mossa? Pezzo toccato, pezzo giocato!»
«Lo so, sì».
«E se muovi così ti mangio gratis l’alfiere».
«E’ vero, è vero! Mi ero distratto».
«E non distrarti; chi gioca non deve fare altro. E poi lo sai: pezzo toccato, pezzo giocato».
«Sì, l’irreparabile!»
«Così è; in questo consiste l’insegnamento del gioco»
“Perché uno non dovrebbe distrarsi durante il gioco?» Diceva fra sé Augusto. “E non è un gioco la vita? E perché non vale ritirare la mossa? Questa è logica! Forse a quest’ora la lettera è già nelle mani di Eugenia. Alea iacta est! Quello che è fatto, è fatto. E domani? Il domani è Dio. E lo ieri di chi è? di chi è lo ieri? Oh! Ieri tesoro dei forti. Santo ieri, sostanza della nebbia quotidiana!”
«Scacco!» lo interruppe nuovamente Victor.
«E’ vero, è vero… vediamo… ma come ho fatto a lascia giungere le cose a questo punto?»
«Distraendoti, come sempre. Se non fossi tanto distratto, saresti uno dei nostri migliori giocatori».
«Ma dimmi, Victor, la vita è un gioco o una distrazione? »
«Il gioco non è altro che distrazione».
«E allora cosa importa distrarsi in un modo o nell’altro?»
«Perbacco, se si gioca, bisogna giocar bene».
«E perché non giocar male? Perché non possiamo muovere questi pezzi in modo diverso da come li muoviamo?»
«Questa è la tesi, caro Augusto; come tu, quale tu, illustre filosofo, mi hai insegnato».
«Bene; devo darti una grande notizia».
«Ben venga!»
«Però preparati, carissimo».
«Io non sono di quelli che si meravigliano a priori o in anticipo».
«Allora: sai cosa mi capita?»
«Che sei sempre distratto».
«Mi capita che mi sono innamorato».
«Bah, questo lo sapevo!»
«Come facevi a saperlo?»
«Tu sei innamorato ab initio; da quando sei nato, possiedi la capacità d’innamorarti».
«Sì, l’amore nasce quando noi nasciamo».
«Non ho detto amore, ma capacità d’innamorarsi, ed io, senza che tu me lo dicessi, sapevi che eri innamorato o piuttosto che ti sei preso una cotta».
«Ma di chi? Dimmi: di chi?»
«Questo non lo sappiamo né tu né io».
«Sta zitto, forse hai ragione».
«Non te l’ho detto? E piuttosto, dimmi: è bionda o bruna?»
«Veramente non lo so. tuttavia immagino che non sia né l’uno né l’altro. Ecco, così, castana.
«E’alta o bassa?»
«Non ricordo bene, però dev’essere normale. Ma che occhi, caro mio, che occhi ha la mia Eugenia!»
«Eugenia?»
«Sì, Eugenia Domenico dell’Arco, via dell’Alameda 58».
«La professoressa di piano?»
«Lei. Ma…»
«La conosco. E adesso… scacco un’altra volta!»
«Ma…»
«Scacco ho detto!»
«E va bene…»
E Augusto coprì il re col cavallo. E finì per perdere la partita. Quando si salutarono, Victor, appoggiando la destra sul collo dell’amico, come un giogo, gli sussurrò all’orecchio: «E così la piccola Eugenia, la pianista, vero? Bene, Augustino, bene, sarai padrone dell’universo».
«Questi diminutivi» pensò Augusto «questi terribili diminutivi…». E uscì per strada.
 José Gutiérrez Solana: Unanumo in finestra con vista a Salamana
José Gutiérrez Solana: Unanumo in finestra con vista a Salamana
Niebla (Nebbia) è il romanzo più illustre di Unamuno. Attraverso questo termine l’autore può metaforizzare lo stato indeterminato, per meglio dire indefinito dell’individuo e del suo esistere. Per superare ciò Unanumo ricorre spesso al dialogo, tecnica narrativa assai usata dallo scrittore spagnolo (non dimentichiamo inoltre che il suo lavoro intellettuale è soprattutto di tipo filosofico per cui il dialogo, sin dai tempi di Platone è la forma prediletta).
 Unanumo e il paradosso scacchistico
Unanumo e il paradosso scacchistico
Nel brano ad essere al centro è il gioco degli scacchi, o per meglio dire in spagnolo dell’ajedrez, lotta tra bianchi e neri che, metaforizzati, sono immagine sia dei diversi personaggi del romanzo, sia delle opposte tensioni all’interno dell’animo del protagonista Augusto Pérez. Il protagonista gioca con il suo amico Vìctor Goti, personaggio quest’ultimo che rappresenta colui con il quale Augusto riflette e ragiona. Nella partita qui presentata la finalità del gioco diviene la finalità della vita di Augusto, ovvero la donna amata, Eugenia; ma gli scacchi sottintendono la logica che potrebbe diventare azzardo; ma allora l’azzardo riguarderà la vita di Augusto, ma egli gioca distrattamente, senza logica per cui la logica sarà perfetta e chiara soltanto se è divina e quindi impossibile da comprendere. Si può andare solo alla ricerca di una possibile comprensione della razionalità di Dio attraverso la scacchiera materiale su cui l’uomo gioca. Il gioco e la vita sono metafora l’uno dell’altra: “pezzo toccato, pezzo giocato”, non si può ripetere la mossa, la vita non può tornare indietro neanche di un minuto, la vita diventa un percorso in cui, se si sbaglia, se si gioca distrattamente, veniamo battuti da un definitivo scacco matto.
Fernando Pessoa

Fernando Pessoa nasce a Lisbona nel 1988. Orfano di padre all’età di sette anni, dopo le seconde nozze della madre con il console portoghese a Durban, si trasferisce con la famiglia in Sudafrica, studiando nell’Università di Città del Capo. Ciò gli permise di conoscere la lingua inglese che gli permise di poetare in quella lingua sin dall’adolescenza. Nel 1905 tornò a Lisbona, diventando animatore di circoli letterari attraverso riviste da lui fondate. Importante, attraverso la sua figura, l’inserimento della cultura portoghese al modernismo europeo. A livello umano la personalità di Pessoa è estremamente complessa: ad una vita sorprendentemente piatta, risponde una difficoltà dell’espressione dell’io che si riconosce in vari personaggi (eteronimia) ad alcuni dei quali Pessoa diede una data di nascita, uno stile e l’attribuzione di vere e proprie opere – non dimenticando di aver già determinato per alcuni di essi la data di morte. I più importanti di essi sono: Alberto Caerio (poeta bucolico), Ricardo Reis (poeta ellenistico e oraziano), Alvaro de Campos, (modernista e futurista).
A un altro eteronomo Bernardo Soares Pessoa assegnò la composizione de Il libro dell’inquietudine “il più bel diario del nostro secolo”. E’ un libro non realizzato, fatto di frammenti, che la critica ha raccolto e ha cercato di sistemare: molto presumibilmente alcuni sono appunti che dovevano far parte di un vero e proprio romanzo il cui titolo è certamente quello con cui questi frammenti vengono editi, altri appartengono ad altri lavori (tra i quali riconosciamo quelli riferiti al poeta turco Omar Khayyam).
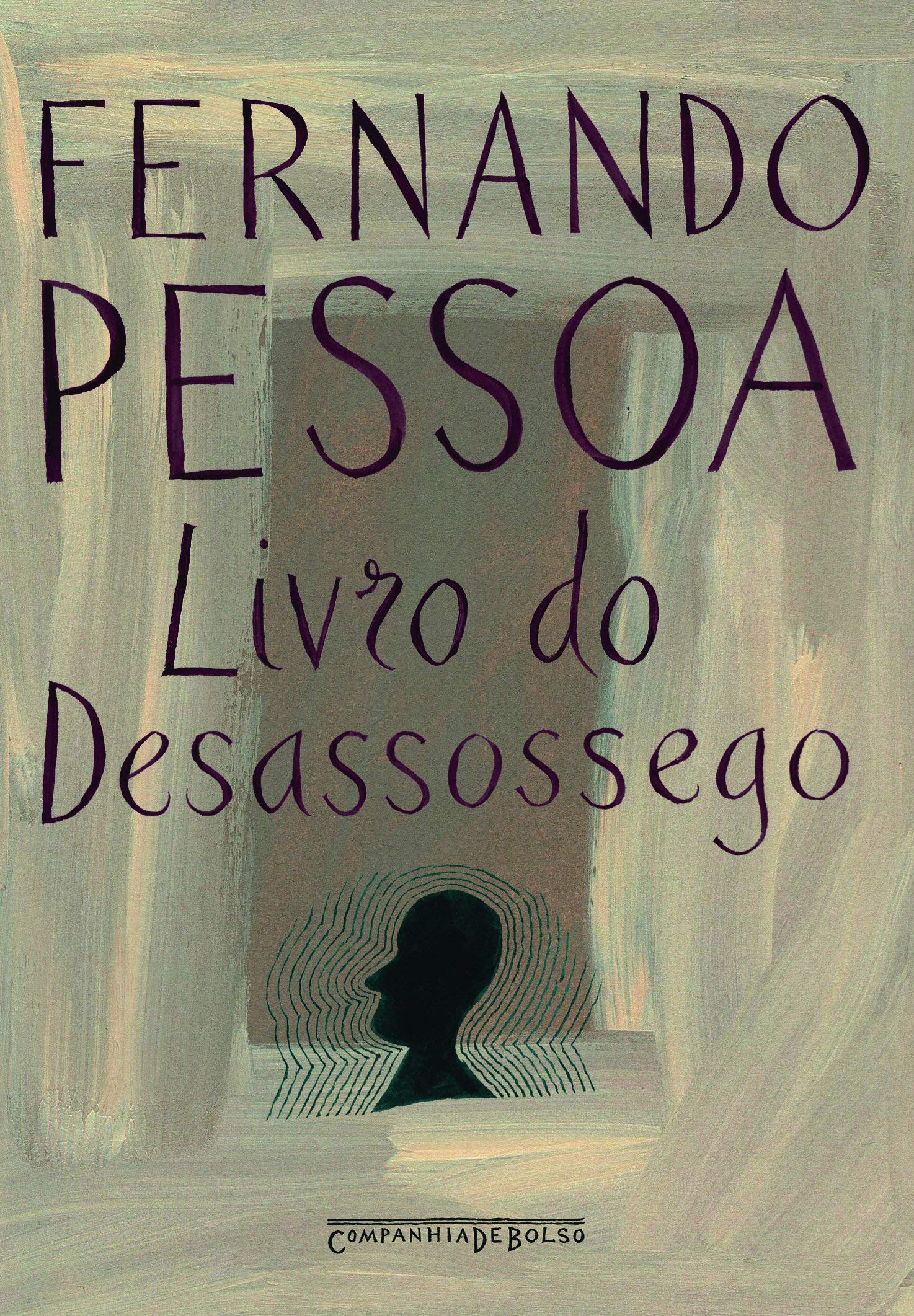
FRAMMENTI
Ho capito, con una illuminazione segreta, di non essere nessuno. Nessuno, assolutamente nessuno. Nel balenio del lampo quella che avevo creduto essere una città era una radura deserta; e la luce sinistra che mi ha mostrato me stesso non ha rivelato nessun cielo sopra di essa. Sono stato derubato dal poter esistere prima che esistesse il mondo. Se sono costretto a reincarnarmi, mi sono reincarnato senza di me, senza essermi reincarnato. Io sono la periferia di una città inesistente, la chipsa prolissa di un libro non scritto
… Come vorrei, lo sento in questo momento, essere una persona che fosse capace di vedere tutto questo come se non avesse con esso altro rapporto se non vederlo: contemplare le cose come se io fossi il viaggiatore adulto arrivato oggi alla superficie della vita! Non aver imparato molto fino dalla nascita e attribuire significati usati a tutte queste cose; poter separare l’immagine che è stata loro imposta (…) Capire tutto per la prima volta, non in modo apocalittico, come se fosse una rivelazione del Mistero, ma direttamente, come una fioritura della Realtà.
 Film portoghese tratto dall’opera di Pessoa
Film portoghese tratto dall’opera di Pessoa
Vivere è essere un altro. Neppure sentire è possibile se si sente oggi come si è sentito ieri: sentire oggi come si è sentito ieri, è essere oggi il cadavere vivo di ciò che ieri è stata la vita perduta.
Ah, chi mi salverà dall’esistere? Non è la morte che voglio, né la vita: è quel qualcosa che brilla nel fondo dell’inquietudine come un diamante possibile nel fondo di un pozzo in cui non si può scendere. E’ tutto il peso e tutta la pena di questo universale reale e impossibile, di questo cielo vessillo di un esercito sconosciuto, di questi toni che vanno impallidendo nell’aria fittizia di cui l’immaginaria falce crescente della luna emerge con una bianchezza elettrica immobile, ritagliata di lontananza e insensibilità.
Pensando mi sono creato eco e abisso. Approfondendomi, mi sono moltiplicato (…) Vivo di impressioni che mi appartengono, dissipatore di rinunce, altro nel mio essere io.
 Almada Negreiro: Fernando Pessoa
Almada Negreiro: Fernando Pessoa
Anche in questo libro non compiuto “emergono le difficoltà tipiche delle narrazioni novecentesche. Anch’esso è testimonianza di quell’isolamento dell’individuo che rende la scrittura una forma di preghiera che salva la vita (come in Kafka). Anch’esso riesce a parlare solo per frammenti, come molte delle scritture primonovecentesche (Eliot, Pound). Anch’esso dimostra di non riuscire a contenere e a riprodurre la mobile complessità del mondo (come in Joyce). Il frammento è la forma di pensiero e di scrittura più autentica di Pessoa: solo una parola scheggiata, straziata può esprimere il dolore di un mondo senza più fondamenti di verità e di saldezza, nel quale ogni individuo vive una sconfinata solitudine, un’inguaribile frammentazione della coscienza che può tradursi in dispersione dell’io nella realtà, sia in concentrazione assoluta sulla propria derelitta esistenza”. (Bologna, Rocchi)