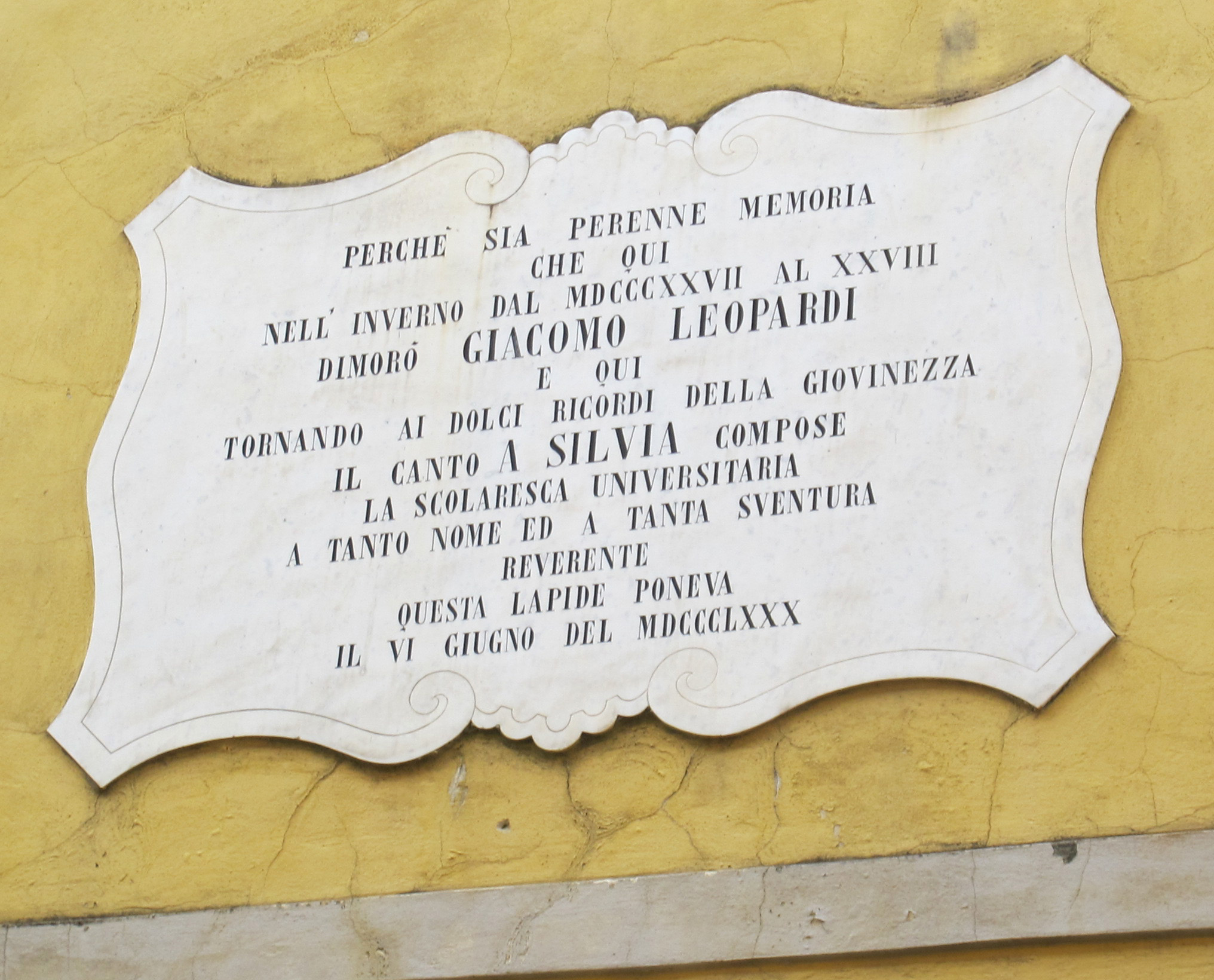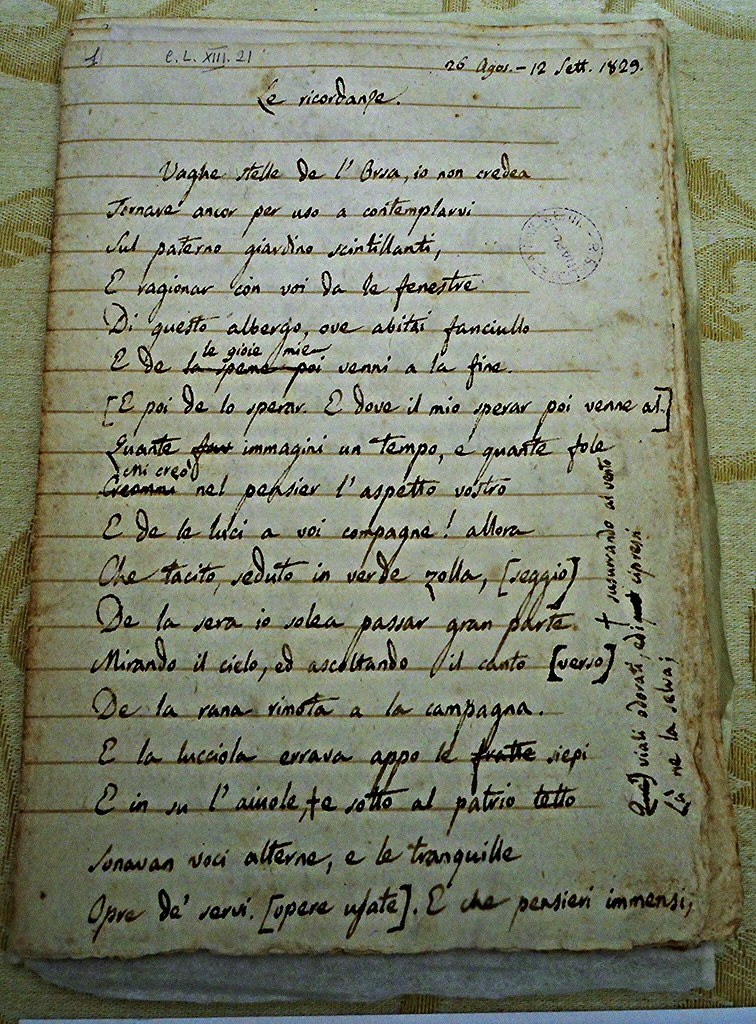Biografia

Monaldo Leopardi e Adelaide Antici
Giacomo Leopardi, nasce a Recanati, piccolo centro all’interno dello Stato Pontificio, il 29 giugno del 1798, dal conte Monaldo e da Adelaide Antici. L’ambiente sociale e il periodo storico nel quale Giacomo si forma è quello della Restaurazione reso ancora più pesante dal vivere in un luogo considerato periferia di uno Stato che si faceva forza nel combattere qualsiasi forma di modernità e nel contrastare ferocemente le idee della Rivoluzione Francese.

Casa Leopardi a Recanati nella seconda dell’800
La famiglia Leopardi, nel piccolo borgo, per nome e nobiltà è abbastanza prestigiosa, ma non altrettanto ricca. Gran parte del denaro era stato infatti speso dal conte Monaldo nell’arricchimento di una cospicua biblioteca, che non solo raccoglieva classici greci e latini, ma anche opere più antiche come quelle in ebraico e più moderne, in lingua francese, appartenenti, addirittura al pensiero illuminato. Il giovane Giacomo trascorre la sua infanzia insieme ai fratelli a lui più vicini, Carlo e Paolina, con cui condivide momenti e giochi. Comincia, tuttavia, a mostrare i segni della sindrome di Pott, che ne influenza la crescita: tutto ciò verrà accentuato dagli anni in cui, con determinazione, deciderà di acquisire quanta più conoscenza possibile, passando dagli 11 ai 18 anni, che lui stesso definirà “sette anni di studio matto e disperatissimo”, nella biblioteca paterna di oltre ventimila volumi, ed uscendone con una perfetta conoscenza del greco e del latino, nonché dell’ebraico, ma fortemente minato nel fisico.

La biblioteca a casa Leopardi (oggi con il busto del poeta)
Ma perché lo fece?
Spiegarlo come meccanismo psicologico in risposta alla solitudine che lo attanagliava, può sembrare semplicistico. Ma dobbiamo tener presente l’aridità di affetti da cui si sentiva circondato. Il grido d’amore che egli espresse gli fece infatti rappresentare in casa, in età ancora infantile, due tragedie e scrivere a quindici anni opere d’estrema erudizione, come Storia dell’astronomia e a diciassette il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. Infatti, come ci dice nello Zibaldone (una sorta di diario di riflessioni che tenne tra il 1817 e il 1832) il padre, che pur lo amava immensamente, s’aspettava da lui onore e successo, la madre, bigotta oltre ogni limite, per cui era meglio un figlio morto piccolo affinché non cadesse nel peccato, gli diede una fame d’amore che poteva ottenere solo mostrandosi genialmente eccezionale. Tutto ciò, per la sua estrema sensibilità e capacità, poteva accadere solo con la cultura.
Le traduzioni di allora, soprattutto quella del II libro dell’Eneide, della Batracomiomachia pseudomerica e degli Idilli di Mosco (poeta greco di cui ci sono pervenute liriche, ma di cui non si sa nulla) e la non comune preparazione filologica lo misero in contatto epistolare con l’intellettuale Pietro Giordani (di idee liberali) che lo posero contro il reazionario Monaldo, ma soprattutto gli diedero la misura dell’arretratezza culturale e dell’isolamento del luogo in cui viveva. E’ di questi anni il passaggio “dall’erudizione al bello” come lui stesso, nello Zibaldone lo definirà e in un passo più tardi della “conversione letteraria” che maturò a partire dal 1816. Dopo il possesso degli strumenti tecnici, Leopardi, infatti, approfondisce i temi o, per meglio dire, la bellezza della poesia omerica, virgiliana e oraziana, e comincia anch’egli a comporre canzoni come All’Italia e Sopra il monumento di Dante, che testimoniano l’allontanamento dal conservatorismo e bigottismo della sua famiglia.

Pietro Giordani
L’amicizia con Giordani, conosciuto personalmente a Recanati nel 1818, non solo aiutarono la sua maturazione, ma lo misero in contatto con gli intellettuali più in vista della penisola italiana. Ed è proprio l’affacciarsi al dibattito culturale che avveniva allora in Italia, alimentato dall’articolo della De Staël, che gli permise di porsi in modo attivo nella discussione di allora, per rispondere in modo del tutto originale rispetto alle teorie allora correnti, con la Lettera ai compilatori italiani della Biblioteca italiana (1816), rimasta inedita, confluita poi nel più argomentato Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, anch’essa non pubblicata. La mancanta diffusione accentuano in qualche modo l’isolamento non solo geografico, ma anche intellettuale del giovane recanatese.
Siamo nel 1819 quanto tenta “la fuga” da Recanati, purtroppo fallita: la frustrazione per l’atto mancato, una forma di esaurimento psicofisico, che si materializzò soprattutto nell’organo della vista, non permette a lui di leggere; l’isolamento del pensiero lo conduce a quello che potremo definire “dal bello al vero” o, modellandolo a quello precedente, alla “conversione filosofica”, portandolo ad un assoluto ateismo. Ciò non provoca in lui l’abbandono della poesia, ma darà vita a sei idilli scritti tra il 1819 e il 1821 e nel ’20 alla terza canzone civile: Ad Angelo Mai a cui ne seguiranno altre sei in cui esplicherà tutto il suo pessimismo.
Ottenuto, finalmente, il permesso di lasciare Recanati, nel 1822 si recò a Roma, dove rimase fino al 1823: grandi furono le aspettative, altrettanto grande la delusione: il vuoto culturale accompagnato dallo sfarzo gli procurano più fastidi che piacere. Si vide quasi costretto quindi a tornare “nel natio borgo selvaggio” e nel 1824 fece pubblicare a Bologna le Canzoni fino ad allora elaborate. L’acquisizione della verità filosofica ebbe influenza anche sulla successiva produzione letteraria: in pochi anni scrive venti prose di carattere filosofico, sulla stregua dei Dialoghi di Luciano di Samosata (intellettuale siriaco, di lingua greca, vissuto nel periodo degli Antonini) che prendono il titolo di Operette morali.
Riesce, intanto, ad allontanarsi da Recanati per recarsi a Milano su invito dell’editore Stella come commentatore di scrittori classici: il clima della città lombarda, tuttavia, non si confaceva alla salute del nostro; si trasferisce quindi prima a Firenze e quindi a Pisa. Sia la bellezza della città, sia il rinascere della sua ispirazione poetica lo riportano a comporre versi. Dopo un breve soggiorno fiorentino, Leopardi deve, per ristrettezze economiche, tornare a Recanati, ma in questa prigione scriverà forse alcune tra le poesie più belle. Si trovò a chiedere a Viesseux (intellettuale ed editore) un impiego qualsiasi, pur di rifuggire dallo Stato di Chiesa. Otterrà un assegno vitalizio da generosi amici fiorentini, dove trovò inizio una certa vita sociale, grazie anche all’amicizia con il giovane napoletano Antonio Ranieri.

Ritratto di Antonio Ranieri in età matura
La vita esuberante di quest’ultimo, sempre a caccia di qualche gonnella, mise Leopardi a maggior contatto con realtà, specie di quella amorosa, fino ad allora solo idealizzata, e se s’innamora, forse realmente per la prima volta, di Fanny Targioni Tozzetti, è altrettanto forte la delusione da fargli cambiare registro poetico nel cosiddetto Ciclo d’Aspasia. Per un consiglio del medico, grazie anche ad un piccolo appannaggio che riesce ad ottenere dalla famiglia, riesce a non rientrare a Recanati ma a trasferirsi a Napoli, città dell’amico Ranieri, ma anche località consigliata da un medico per, parafrasando Parini, la “salubrità dell’aria”. Va a vivere in una villa, presso la sorella dell’amico Antonio, posta alle pendici del Vesuvio, che gli darà l’ispirazione per le sue ultime due liriche, una delle quali fra le più belle della maturità La ginestra. Muore in questa città il 14 giugno del 1837 a soli 39 anni.
Zibaldone
Prima di qualsiasi approccio verso la produzione letteraria/filosofica di Leopardi è necessario soffermarci su questa raccolta di pensieri, appunti, riflessioni che il nostro elabora dal 1817 al 1832, e che sistema, intorno al ’27, scrivendo un indice analitico degli stessi, quasi a voler codificare un percorso di autobiografia intellettuale a cui lui stesso dà il nome Zibaldone. Ma cosa vuol dire Zibaldone? La parola era già attestata come titolo di alcune raccolte disordinate di pensieri e testi e sembra fare riferimento allo zabaione, dunque a un amalgama montato con ingredienti diversi tra loro. Nello Zibaldone leopardiano, il titolo ha una valenza sia formale che contenutistica: allude alla varietà disordinata dei temi e al carattere provvisorio e frammentario della scrittura.
Possiamo dividirlo, per comodità didattica, a grandi linee, in:
- teoria del piacere e pessimismo;
- poetica del vago e indefinito.
tenendo ben presente che le tematiche su esposte si intersecano necessariamente tra loro.
TEORIA DEL PIACERE
Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a riempierci l’animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e più materiale che spirituale. L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, benchè sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o congenita coll’esistenza, e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti 1. nè per durata, 2. nè per estensione. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli 1. nè la sua durata, perchè nessun piacere è eterno, 2. nè la sua estensione, perchè nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che tutto esista limitatamente e tutto abbia confini, e sia circoscritto. Il detto desiderio del piacere non ha limiti per durata, perchè, come ho detto non finisce se non coll’esistenza, e quindi l’uomo non esisterebbe se non provasse questo desiderio. Non ha limiti per estensione perch’è sostanziale in noi, non come desiderio di uno o più piaceri, ma come desiderio del piacere. Ora una tal natura porta con se materialmente l’infinità, perchè ogni piacere è circoscritto, ma non il piacere la cui estensione è indeterminata, e l’anima amando sostanzialmente il piacere, abbraccia tutta l’estensione immaginabile di questo sentimento, senza poterla neppur concepire, perchè non si può formare idea chiara di una cosa ch’ella desidera illimitata. Veniamo alle conseguenze. Se tu desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo, e come un tal piacere, ma in fatti lo desideri come piacere astratto e illimitato. Quando giungi a possedere il cavallo, trovi un piacere necessariamente circoscritto, e senti un vuoto nell’anima, perchè quel desiderio che tu avevi effettivamente, non resta pago. Se anche fosse possibile che restasse pago per estensione, non potrebbe per durata, perchè la natura delle cose porta ancora che niente sia eterno. (…) Quindi potrete facilmente concepire come il piacere sia cosa vanissima sempre, del che ci facciamo tanta maraviglia, come se ciò venisse da una sua natura particolare, quando il dolore la noia ec. non hanno questa qualità. Il fatto è che quando l’anima desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo desiderio infinito, desidera veramente il piacere, e non un tal piacere; ora nel fatto trovando un piacere particolare, e non astratto, e che comprenda tutta l’estensione del piacere, ne segue che il suo desiderio non essendo soddisfatto di gran lunga, il piacere appena è piacere, perchè non si tratta di una piccola ma di una somma inferiorità al desiderio e oltracciò alla speranza. E perciò tutti i piaceri debbono esser misti di dispiacere, come proviamo, perchè l’anima nell’ottenerli cerca avidamente quello che non può trovare, cioè una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato. Veniamo alla inclinazione dell’uomo all’infinito. Indipendentemente dal desiderio del piacere, esiste nell’uomo una facoltà immaginativa, la quale può concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono. Considerando la tendenza innata dell’uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di questa forza immaginativa, ella può figurarsi dei piaceri che non esistano, e figurarseli infiniti 1. in numero, 2. in durata, 3. e in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni ec. Perciò non è maraviglia 1. che la speranza sia sempre maggior del bene, 2. che la felicità umana non possa consistere se non se nella immaginazione e nelle illusioni. Quindi bisogna considerare la gran misericordia e il gran magistero della natura, che da una parte non potendo spogliar l’uomo e nessun essere vivente, dell’amor del piacere che è una conseguenza immediata e quasi tutt’uno coll’amor proprio e della propria conservazione necessario alla sussistenza delle cose, dall’altra parte non potendo fornirli di piaceri reali infiniti, ha voluto supplire 1. colle illusioni, e di queste è stata loro liberalissima, e bisogna considerarle come cose arbitrarie in natura, la quale poteva ben farcene senza, 2. coll’immensa varietà acciocchè l’uomo stanco o disingannato di un piacere ricorresse all’altro, o anche disingannato di tutti i piaceri fosse distratto e confuso dalla gran varietà delle cose, ed anche non potesse così facilmente stancarsi di un piacere, non avendo troppo tempo di fermarcisi, e di lasciarlo logorare, e dall’altro canto non avesse troppo campo di riflettere sulla incapacità di tutti i piaceri a soddisfarlo. Quindi deducete le solite conseguenze della superiorità degli antichi sopra i moderni in ordine alla felicità. 1. L’immaginazione come ho detto è il primo fonte della felicità umana. Quanto più questa regnerà nell’uomo, tanto più l’uomo sarà felice. Lo vediamo nei fanciulli. Ma questa non può regnare senza l’ignoranza, almeno una certa ignoranza come quella degli antichi. La cognizione del vero cioè dei limiti e definizioni delle cose, circoscrive l’immaginazione. E osservate che la facoltà immaginativa essendo spesse volte più grande negl’istruiti che negl’ignoranti, non lo è in atto come in potenza, e perciò operando molto più negl’ignoranti, li fa più felici di quelli che da natura avrebbero sortito una fonte più copiosa di piaceri. (…) Del resto il desiderio del piacere essendo materialmente infinito in estensione (non solamente nell’uomo ma in ogni vivente), la pena dell’uomo nel provare un piacere è di veder subito i limiti della sua estensione, i quali l’uomo non molto profondo gli scorge solamente da presso. Quindi è manifesto 1. perchè tutti i beni paiano bellissimi e sommi da lontano, e l’ignoto sia più bello del noto; effetto della immaginazione determinato dalla inclinazione della natura al piacere, effetto delle illusioni voluto dalla natura. 2. perchè l’anima preferisca in poesia e da per tutto, il bello aereo, le idee infinite. Stante la considerazione qui sopra detta, l’anima deve naturalmente preferire agli altri quel piacere ch’ella non può abbracciare. Di questo bello aereo, di queste idee abbondavano gli antichi, abbondano i loro poeti, massime il più antico cioè Omero, abbondano i fanciulli veramente Omerici in questo, gl’ignoranti ec. in somma la natura. La cognizione e il sapere ne fa strage, e a noi riesce difficilissimo il provarne. La malinconia, il sentimentale moderno ec. perciò appunto sono così dolci, perchè immergono l’anima in un abbisso di pensieri indeterminati de’ quali non sa vedere il fondo nè i contorni. (…) Del rimanente alle volte l’anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio dell’infinito, perchè allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione e il fantastico sottentra al reale. L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse da per tutto, perchè il reale escluderebbe l’immaginario. Quindi il piacere ch’io provava sempre da fanciullo, e anche ora nel vedere il cielo ec. attraverso una finestra, una porta, una casa passatoia, come chiamano. Al contrario la vastità e moltiplicità delle sensazioni diletta moltissimo l’anima. Ne deducono ch’ella è nata per il grande ec. Non è questa la ragione. Ma proviene da ciò, che la moltiplicità delle sensazioni, confonde l’anima, gl’impedisce di vedere i confini di ciascheduna, toglie l’esaurimento subitaneo del piacere, la fa errare d’un piacere in un altro senza poterne approfondare nessuno, e quindi si rassomiglia in certo modo a un piacere infinito.
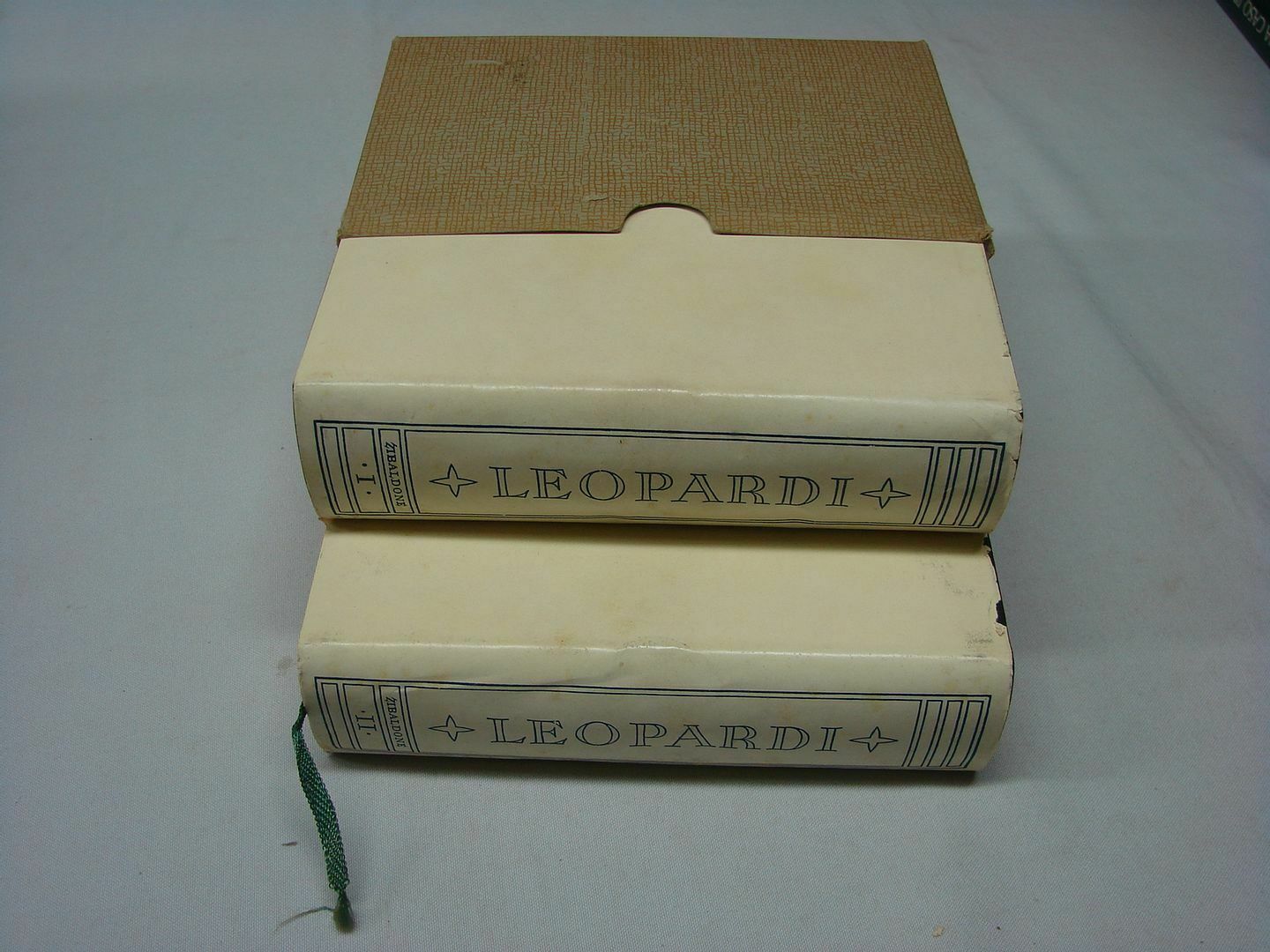 Edizione dello Zibaldone del 1961
Edizione dello Zibaldone del 1961
Queste rilessioni “sul piacere” di Leopardi, scritte nel tra il 12 e il 23 luglio del 1820, rappresentano uno dei nuclei fondamentali della sua speculazione filosofica. In primo luogo bisogna sottolineare come l’autore recanatese parti da considerazioni “sensistiche”, figlie dell’illuminismo: il piacere, come sensazione, è innato nell’uomo, senza di esso non esisterebbe la vita umana. Essendo questo parte integrante dell’uomo diventa “naturale aspirazione”, a cui, tuttavia la realtà non può corrispondere in modo completo e ciò perché la vita dell’uomo, rispetto al tempo e allo spazio, è limitata (e quindi può dare a lui piaceri limitati) mentre lo stesso essere umano tende a qualcosa di illimitato e quindi irraggiungibile. Per questo l’ottenimento di un piacere “reale” porta con sé, inevitabilmente, la consapevolezza della sua limitatezza, dando luogo al dolore. Ora l’uomo un tempo, secondo Leopardi, era più felice proprio perché aveva la possibilità di raggiungere l’illimitatezza del piacere attraverso la facoltà immaginativa: quest’ultima è certamente illimitata in quanto non può essere circoscritta ed era maggiore un tempo perché non ancora limitata dal progresso che, svelando la realtà, uccide l’immaginazione. Rimane oggi tale facoltà solo quando vi è un qualcosa che, privando o frapponendosi tra la vista o l’udito, ci offre la possibilità d’immaginare cosa vi è “oltre esso”. E’ tale concetto che sta alla base del “pessimismo storico”, intendendo con esso quella felicità che la natura ci offre (quindi natura a noi benigna) di contro al progresso della storia che la cancella.
Tale riflessione trova la sua esplicitazione nelle canzoni elaborate intorno al ’20, nate a seguito delle sollecitazioni culturali del Giordani e che vedono il nostro Leopardi, oltre a prendere posizione riguardo la situazione politica dell’Italia, staccarsi, in modo definitivo, dall’ideologia bigotta e retriva a cui la famiglia lo aveva indirizzato, tra queste ricordiamo : All’Italia (1918): in cui il giovane poeta mostra di aver assimilato la lezione di Petrarca e lo spirito libertario di Alfieri e Foscolo; Ad Angelo Mai (1920): dedicata al cardinale che ritrovò il De Republica di Cicerone; Bruto minore (1821): l’dea del suicidio come risposta al tramonto di ogni di ogni magnanima illusione; Ultimo canto di Saffo (1922): la canzone nasce con l’intenzione di “rappresentare la infelicità di un animo delicato, tenero, sensitivo, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane” (Annotazioni alle 10 canzoni stampate a Bologna nel 1824), e nei cosiddetti “Piccoli idilli“.

Paolina Leopardi
La radicalizzazione del “pessimismo” leopardiano, avviene durante il lungo silenzio, dal 1824 al 1828, e che sfocerà nella pubblicazione delle Operette morali: generalmente in esse troviamo la risoluzione del conflitto uomo natura attraverso qualsiasi negazione della sua benevolenza verso l’uomo, in ogni attimo della storia dell’uomo e della sua singolare vita. Non c’è mai alcuna felicità se, come è nella realtà, egli nasce per morire e diventa parte di un meccanismo che trascende ogni sua volontà.
LA REA NATURA
La mia filosofia, non solo non è conducente alla misantropia, come può parere a chi la guarda superficialmente, e come molti l’accusano; ma di sua natura esclude la misantropia, di sua natura tende a sanare, a spegnere quel mal umore, quell’odio, non sistematico, ma pur vero odio, che tanti e tanti, i quali non sono filosofi, e non vorrebbono esser chiamati né creduti misantropi, portano però cordialmente a’ loro simili, sia abitualmente, sia in occasioni particolari, a causa del male che, giustamente o ingiustamente, essi, come tutti gli altri, ricevono dagli altri uomini. La mia filosofia fa rea d’ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l’odio, o se non altro il lamento, a principio piú alto, all’origine vera de’ mali de’ viventi ec. ec.
La natura, per necessità della legge di distruzione e riproduzione, e per conservare lo stato attuale dell’universo, è essenzialmente, regolarmente e perpetuamente persecutrice e nemica mortale di tutti gl’individui d’ogni genere e specie, ch’ella dà in luce; e comincia a perseguitarli dal punto medesimo in cui gli ha prodotti. Ciò, essendo necessaria conseguenza dell’ordine attuale delle cose, non dà una grande idea dell’intelletto di chi è o fu autore di tale ordine.
Sono questi “pensieri”, ambedue vergati nel 1829, a darci l’evoluzione del pesiero leopardiano dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. Infatti “Leopardi tiene a precisare che la sua filosofia è apparentemente misantropica, in quanto si prefigge lo scopo di convertire l’odio che l’uomo prova verso i suoi simili nella consapevolezza che la vera causa dell’infelicità umana è appunto la natura. Il suo invito a reagire alla malignità della natura nasce, prima che da un atteggiamento filosofico, dalla sofferenza e dall’esperienza personale della propria e dell’altrui infelicità”.

Ale ’98: Leopardi e la Natura
LA POETICA
Il passato, a ricordarsene, è più bello del presente, come il futuro a immaginarlo. Perché? Perché il solo presente ha la sua vera forma nella concezione umana; è la sola immagine del vero, e tutto il vero è brutto.
Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra come degli oggetti veduti per metà o con certi impedimenti ec. ci destino idee indefinite, si spiega perché piaccia la luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano e non si scopra la sorgente della luce; un luogo solamente in parte illuminato da essa luce; il riflesso di detta luce e i vari effetti materiali che ne derivano; il penetrare di detta luce in luoghi dov’ella divenga incerta e impedita e non bene si distingua, come attraverso un canneto, in una selva, per li balconi socchiusi ec. ec.; la detta luce veduta in luogo, oggetto ec. dov’ella non entri e non percota dirittamente, ma vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro luogo od oggetto ec. dov’ella venga a battere; in un andito veduto al di dentro o al di fuori e in una loggia parimente ec.; quei luoghi dove la luce si confonde ec. ec. colle ombre, come sotto un portico, in una loggia elevata e pensile, fra le rupi e i burroni, in una valle, sui colli veduti dalla parte dell’ombra, in modo che ne sieno indorate le cime; il riflesso che produce, per esempio, un vetro colorato su quegli oggetti su cui si riflettono i raggi che passano per detto vetro; tutti quegli oggetti insomma che per diversi materiali e menome circostanze giungono alla nostra vista, udito ec. in modo incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor dell’ordinario ec. Per lo contrario la vista del sole o della luna in una campagna vasta ed aprica e in un cielo aperto ec. è piacevole per la vastità della sensazione. Ed è pur piacevole, per la ragione assegnata di sopra, la vista di un cielo diversamente sparso di nuvoletti, dove la luce del sole o della luna produca effetti variati e indistinti e non ordinari ec. È piacevolissima e sentimentalissima la stessa luce veduta nelle città, dov’ella è frastagliata dalle ombre, dove lo scuro contrasta in molti luoghi col chiaro, dove la luce in molte parti degrada a poco a poco, come sui tetti, dove alcuni luoghi riposti nascondono la vista dell’astro luminoso ec. ec. A questo piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il non veder tutto e il potersi perciò spaziare coll’immaginazione, riguardo a ciò che non si vede. Similmente dico dei simili effetti, che producono gli alberi, i filari, i colli, i pergolati, i casolarii pagliai, le ineguaglianze del suolo ec. nelle campagne. Per lo contrario una vasta e tutta uguale pianura, dove la luce si spazi e diffonda senza diversità, né ostacolo; dove l’occhio si perda ec. è pure piacevolissima, per l’idea indefinita in estensione, che deriva da tal veduta. Cosí un cielo senza nuvolo. Nel qual proposito osservo che il piacere della varietà e dell’incertezza prevale a quello dell’apparente infinità e dell’immensa uniformità. E quindi un cielo variamente sparso di nuvoletti è forse piú piacevole di un cielo affatto puro; e la vista del cielo è forse meno piacevole di quella della terra e delle campagne ec., perché meno varia (ed anche meno simile a noi, meno propria di noi, meno appartenente alle cose nostre ec.). Infatti ponetevi supino in modo che voi non vediate se non il cielo, separato dalla terra, voi proverete una sensazione molto meno piacevole che considerando una campagna o considerando il cielo nella sua corrispondenza e relazione colla terra ed unitamente ad essa in un medesimo punto di vista. È piacevolissima ancora, per le sopraddette cagioni, la vista di una moltitudine innumerabile, come delle stelle o di persone ec., un moto moltiplice, incerto, confuso, irregolare, disordinato, un ondeggiamento vago ec., che l’animo non possa determinare né concepire definitamente e distintamente ec., come quello di una folla o di un gran numero di formiche o del mare agitato ec. Similmente una moltitudine di suoni irregolarmente mescolati e non distinguibili l’uno dall’altro ec. ec. ec.
Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste e indefinite e non determinabili e confuse.
Le parole notte notturno ec., le descrizioni della notte ec., sono poeticissime, perché, la notte confondendo gli oggetti, l’animo non ne concepisce che un’immagine vaga, indistinta, incompleta, sí di essa che [di] quanto ella contiene. Cosí oscurità, profondo ec. ec.
Le rimembranze che cagionano la bellezza di moltissime immagini ec. nella poesia ec. non solo spettano agli oggetti reali, ma derivano bene spesso anche da altre poesie, vale a dire che molte volte un’immagine ec. riesce piacevole in una poesia, per la copia delle ricordanze della stessa o simile immagine veduta in altre poesie.
Quello che altrove ho detto sugli effetti della luce o degli oggetti visibili, in riguardo all’idea dell’infinito, si deve applicare parimente al suono, al canto, a tutto ciò che spetta all’udito. È piacevole per se stesso, cioè non per altro se non per un’idea vaga ed indefinita che desta, un canto (il piú spregevole) udito da lungi o che paia lontano senza esserlo o che si vada a poco a poco allontanando e divenendo insensibile o anche viceversa (ma meno) o che sia cosí lontano, in apparenza o in verità, che l’orecchio e l’idea quasi lo perda nella vastità degli spazi; un suono qualunque confuso, massime se ciò è per la lontananza; un canto udito in modo che non si veda il luogo da cui parte; un canto che risuoni per le volte di una stanza ec., dove voi non vi troviate però dentro; il canto degli agricoltori che nella campagna s’ode suonare per le valli, senza però vederli, e cosí il muggito degli armenti ec. Stando in casa, e udendo tali canti o suoni per la strada, massime di notte, si è piú disposti a questi effetti, perché né l’udito né gli altri sensi non arrivano a determinare né circoscrivere la sensazione e le sue concomitanze. È piacevole qualunque suono, anche vilissimo, che largamente e vastamente si diffonda, come in taluno dei detti casi, massime se non si vede l’oggetto da cui parte. A queste considerazioni appartiene il piacere che può dare e dà, quando non sia vinto dalla paura, il fragore del tuono, massime quand’é piú sordo, quando è udito in aperta campagna; lo stormire del vento, massime nei detti casi, quando freme confusamente in una foresta o tra i vari oggetti di una campagna, o quando è udito da lungi, o dentro una città trovandosi per le strade ec. Perocché oltre la vastità e l’incertezza e confusione del suono non si vede l’oggetto che lo produce, giacché il tuono e il vento non si vedono. È piacevole un luogo echeggiante, un appartamento ec. che ripeta il calpestio de’ piedi o la voce ec. Perocché l’eco non si vede ec. E tanto piú quanto il luogo e l’eco è piú vasto, quanto piú l’eco vien da lontano, quanto piú si diffonde; e molto piú ancora se vi si aggiunge l’oscurità del luogo che non lasci determinare la vastità del suono né i punti da cui esso parte ec. ec. E tutte queste immagini in poesia ec. sono sempre bellissime, e tanto piú quanto piú negligentemente son messe e toccando il soggetto, senza mostrar l’intenzione per cui ciò si fa, anzi mostrando d’ignorare l’effetto e le immagini che son per produrre e di non toccarli se non per ispontanea e necessaria congiuntura e indole dell’argomento ec. Vedi in questo proposito Virg. Eneide, VII, v.8, seqq.* La notte o l’immagine della notte è la piú propria ad aiutare, o anche a cagionare, i detti effetti del suono. Virgilio da maestro l’ha adoperata .
*aspirant aurae in noctem nec candida cursus // luna negat, splendet tremulo sub lumine pontus
Spirano le brezze sulla notte né la candida luna nega // il percorso, il mare splende sotto tremula luce
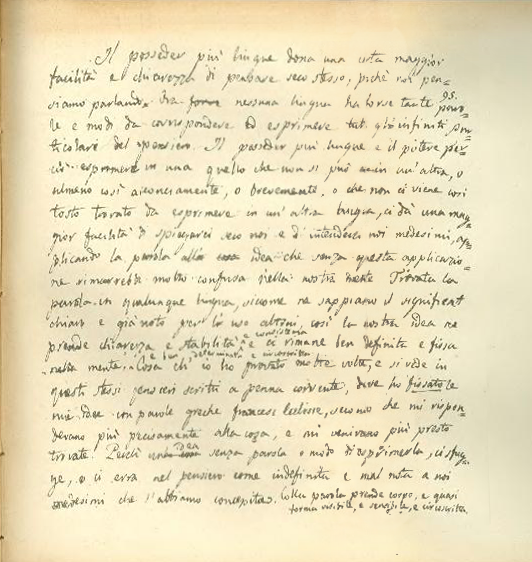 Pagina autografa dello Zibaldone
Pagina autografa dello Zibaldone
Una voce o un suono lontano, o decrescente e allontanantesi a poco a poco, o echeggiante con un’apparenza di vastità ec. ec., è piacevole per il vago dell’idea ec. Però è piacevole il tuono, un colpo di cannone, e simili, udito in piena campagna, in una gran valle ec., il canto degli agricoltori, degli uccelli, il muggito de’ buoi ec. nelle medesime circostanze.
All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi un suono d’una campana; e nel tempo stesso coll’immaginazione vedrà un’altra torre, un’altra campagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di obbietti sta tutto il bello e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione.
Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, una campagna, per bella che sia, se non desta alcuna rimembranza, non è poetica punto a vederla. La medesima, ed anche un sito, un oggetto qualunque, affatto impoetico in se, sarà poetichissimo a rimembrarlo. La rimembranza è essenziale e principale nel sentimento poetico, non per altro, se non perché il presente, qual ch’egli sia, non può esser poetico; e il poetico, in uno o in altro modo, si trova sempre consistere nel lontano, nell’indefinito, nel vago.
I primi passi sono del 1821, corrispondenti al periodo dei primi idilli; gli ultimi tre del 1827/1828, quando a Pisa sente rinascere in sé la volontà di scrivere poesia (periodo dei “grandi idilli”), a dimostrazione di come il pensiero leopardiano, come appunto troviamo all’interno dello Zibaldone, si accompagni al fare poetico.
Per la prima parte infatti notiamo come la sua poetica si collega in modo indissolubile alla teoria del piacere: all’impossibilità di recuperare l’immaginazione, si risponde con la poesia sentimentale, e questa non può che essere intessuta di parole vaghe, indefinite, capaci di porci al di là delle limitazioni spazio/temporali. Gli ultimi tre pensieri fondono alla poetica “del vago e indefinito” quella delle “rimembranze” e della “doppia visione”: anche questi aspetti, rimandano a qualcosa che si perde nel tempo o si costituiscono come indefinite e amplificano la capacità del poeta di allargare lo spazio a sensazioni personali che si perdono nel tempo o riescono a contrapporre al “presente” la facoltà del pensiero immaginativo.
Opere in prosa giovanili
L’impegno nello studio definito nello Zibaldone “matto e disperatissimo” dal 1809 al 1816 si può dire si concretizzi in due opere che potremmo definire divulgative: la Storia dell’astronomia (1813) e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815). Non possono certo dirsi opere originali e non ci sentiamo, come alcuni critici poi hanno detto, di dire che l’interesse per l’astronomia o per il sapere primitivo siano prodromi di uno svolgersi poetico successivo. Più corretto ci sembra il fatto è che egli voglia “divulgare” nel sonnacchioso paese le acquisizioni scientifiche galileiane, un po’ come fece l’Algarotti nel ‘700 nel Newtonismo per le dame. Se qualche interesse tale opere suscitano è per l’evoluzione tra uno scritto e l’altro della prosa leopardiana.
Più interessante è la Lettera ai compilatori della Biblioteca italiana del 1816, che sarà poi ripresa nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, di due anni più tarda, in cui il nostro prende posizione sul dibattito culturale suscitato dall’articolo della De Staël Sull’utilità delle traduzioni, apparso appunto sulla Biblioteca Italiana, anche se, è importante dirlo, nessuna influenza avrà su tale dibattito, non essendo stata pubblicata.
L’IMITAZIONE DEGLI ANTICHI
Ora da tutto questo e dalle altre cose che si son dette, agevolmente si comprende che la poesia dovette essere agli antichi oltremisura più facile e spontanea che non può essere presentemente a nessuno, e che a’ tempi nostri per imitare poetando la natura vergine e primitiva, e parlare il linguaggio della natura (lo dirò con dolore della condizione nostra, con disprezzo delle risa dei romantici) è pressoché necessario lo studio lungo e profondo de’ poeti antichi. Imperocché non basta ora al poeta che sappia imitar la natura; bisogna che la sappia trovare, non solamente aguzzando gli occhi per iscorgere quello che mentre abbiamo tuttora presente, non sogliamo vedere, impediti dall’uso, la quale è stata sempre necessarissima opera del poeta, ma rimovendo gli oggetti che la occultano, e scoprendola, e diseppellendo e spastando e nettando dalla mota dell’incivilimento e della corruzione umana quei celesti esemplari che si assume di ritrarre. A noi l’immaginazione è liberata dalla tirannia dell’intelletto, sgombrata dalle idee nemiche alle naturali, rimessa nello stato primitivo o in tale che non sia molto discosto dal primitivo, rifatta capace dei diletti soprumani della natura, dal poeta; al poeta da chi sarà? o da che cosa? Dalla natura? Certamente, in grosso, ma non a parte a parte, né da principio; vale a dire appena mi si lascia credere che in questi tempi altri possa cogliere il linguaggio della natura, e diventare vero poeta senza il sussidio di coloro che vedendo tutto il dì la natura scopertamente e udendola parlare, non ebbero per esser poeti, bisogno di sussidio. Ma noi cogli orecchi così pieni d’altre favelle, adombrate inviluppate nascoste oppresse soffocate tante parti della natura, spettatori e partecipi di costumi lontanissimi o contrari ai naturali, in mezzo a tanta snaturatezza e così radicata non solamente in altri ma in noi medesimi, vedendo sentendo parlando operando tutto giorno cose non naturali, come, se non mediante l’uso e la familiarità degli antichi, ripiglieremo per rispetto alla poesia la maniera naturale di favellare, rivedremo quelle parti della natura che a noi sono nascoste, agli antichi non furono, ci svezzeremo di tante consuetudini, ci scorderemo di tante cose, ne impareremo o ci ricorderemo o ci riavvezzeremo a tante altre, e in somma nel mondo incivilito vedremo e abiteremo e conosceremo intimamente il mondo primitivo, e nel mondo snaturato la natura? E in tanta offuscazione delle cose naturali, quale sarà se non saranno gli antichi, specialmente alle parti minute della poesia, la pietra paragone che approvi quello ch’è secondo la natura, e accusi quello che non è? La stessa natura? Ma come? quando dubiteremo appunto di questo, se avremo saputo vederla e intenderla bene? L’indole e l’ingegno? Non nego che ci possano essere un’indole e un ingegno tanto espressamente fatti per le arti belle, tanto felici tanto singolari tanto divini, che volgendosi spontaneamente alla natura come l’ago alla stella, non sieno impediti di scoprirla dove e come ch’ella si trovi, e di vederla e sentirla e goderla e seguitarla e considerarla e conoscerla, né da incivilimento né da corruttela né da forza né da ostacolo di nessuna sorta; e sappiano per se medesimi distinguere e sceverare accuratamente le qualità e gli effetti veri della natura da tante altre qualità ed effetti che al presente o sono collegati e misti con quelli in guisa che a mala pena se ne discernono, o per altre cagioni paiono quasi e senza quasi naturali; e in somma arrivino senza l’aiuto degli antichi a imitar la natura come gli antichi facevano. Non nego che questo sia possibile, nego che sia provabile, dico che l’aiuto degli antichi è tanto grande tanto utile tanto quasi necessario, che appena ci sarà chi ne possa far senza, nessuno dovrà presumere di potere. Non mancherà mai l’amore degli uomini alla natura, non il desiderio delle cose primitive, non cuori e fantasie pronte a secondare gl’impulsi del vero poeta, ma la facoltà d’imitar la natura, e scuotere e concitare negli uomini questo amore, e pascere questo desiderio, e muovere ne’ cuori e nelle fantasie diletti sostanziosi e celesti, languirà ne’ poeti, come già langue da molto tempo. E qui non voglio compiangere l’età nostra, né dire come sia vantaggioso, quello che tuttavia, così per la ragione che ho mentovata, come per altre molte, è, almeno generalmente parlando, necessarissimo, né pronosticare dei tempi che verranno quello che l’esperienza dei passati e del presente dimostra pur troppo chiaro, che qualunque sarà poeta eccellente somiglierà Virgilio e il Tasso, non dico in ispecie ma in genere; un Omero un Anacreonte un Pindaro un Dante un Petrarca un Ariosto appena è credibile che rinasca.
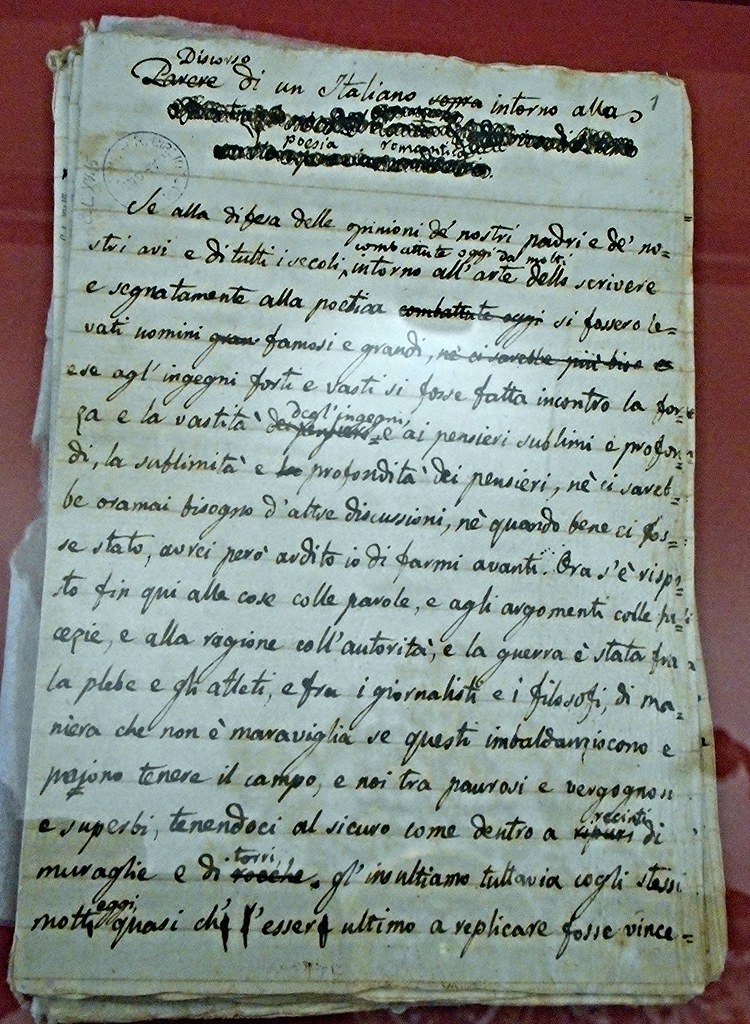 Discorso di un italiano sopra la poesia romantica (autografo)
Discorso di un italiano sopra la poesia romantica (autografo)
Il ragionamento critico leopardiano si muove su due direttive precise:
- se il diletto della poesia sta nell’imitazione della natura, risulta naturale che laddove tale imitazione sia risultata preponderante in quanto la stessa natura era osservata “naturalmente” (diremo senza sovrastrutture culturali) la poesia ha raggiunto i suoi vertici, e questa è l’età antica;
- oggi proprio a causa della capacità razionale, che si è tradotta in un aumento culturale, tale approccio con la natura è impossibile e quindi sarebbe quasi impossibile la poesia; sbagliano pertanto i Romantici quando criticano l’atteggiamento che vede nell’imitazione degli antichi un freno per la poesia, perché a far da freno alla poesia è la “modernità”;
- ma, andando al di là del passo su riportato, non è “emulando” il loro stile che s’otterrà la poesia (e qui si mostra contrario ad un erudito neoclassicismo), ma cercando d’imitare l’atteggiamento degli antichi, togliendo le scorie dall’oggetto poetico e porsi “naturalmente”, diremo quasi istintivamente di fronte alla natura (ottenendo, se così si può dire, un esito romantico, lontano tuttavia dal Romanticismo preponderante di stampo manzoniano).
Il Discorso può riflettere il primo momento della meditazione filosofico-letteraria di Leopardi. Esso si muove sotto l’influsso delle teorie di Rousseau, secondo cui la civiltà aveva prodotto, nonostante un miglioramento della condizione di vita, uno stato di infelicità. Ciò era dovuto ad un allontanamento progressivo dell’uomo dalla natura, privandolo appunto dallo stato di felicità “naturale”. Tale atteggiamento culturale è detto, scolasticamente, “pessimismo storico”. Con questo termine s’intende, appunto, il rapporto tra felicità e uomo che si può illustrare con l’antinomia natura/civiltà o natura/ragione, dove il primo è positivo ed il secondo negativo.
Pertanto risulta evidente che, se la felicità è figlia di un rapporto esclusivo con la natura, tale rapporto è oggi negato e pertanto è negata la possibilità di far poesia, soprattutto se, per i Romantici, si tratta di imitare i contemporanei d’oltralpe. Tuttavia Leopardi è consapevole che se la capacità poetica “descrittiva” dell’evento naturale è conclusa, lo stesso non si può dire per la poesia sentimentale, cioè per una poesia che non sia più rappresentativa, ma che sia capace di far esprimere l’io lirico sulla natura.
Produzione letteraria e concezioni filosofiche dal 1817 al 1822
Il Discorso nasce a seguito dell’amicizia con Pietro Giordani, anch’egli posizionato contro le teorie dei cosiddetti romantici italiani, il cui esponente principale è Giovanni Berchet. Il classicismo di Giordani, infatti, parte da un punto di vista differente, oserei dire, politico (il classico rappresenta una lunga tradizione della nostra cultura: abdicare da esso vuol dire venir meno a ciò che potrebbe stare alla base di una cultura patriottica). E’ da questa posizione che il Leopardi all’inizio si cimenterà con la canzone All’Italia e Sopra il monumento di Dante, ambedue dedicate a Vincenzo Monti, la cui forma e il cui stile rispecchiano ancora un’estetica tradizionale.
ALL’ITALIA
O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e l’erme
torri degli avi nostri,
ma la gloria non vedo,
non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
i nostri padri antichi. Or fatta inerme,
nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè! quante ferite,
che lividor, che sangue! oh, qual ti veggio,
formosissima donna! Io chiedo al cielo
e al mondo: «Dite, dite;
chi la ridusse a tale?» E questo è peggio,
che di catene ha carche ambe le braccia;
sí che sparte le chiome e senza velo
siede in terra negletta e sconsolata,
nascondendo la faccia
tra le ginocchia, e piange.
Piangi, ché ben hai donde, Italia mia,
le genti a vincer nata
e nella fausta sorte e nella ria
mai non potrebbe il pianto
adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;
ché fosti donna, or sei povera ancella.
Chi di te parla o scrive,
che, rimembrando il tuo passato vanto,
non dica: «Giá fu grande, or non è quella?»
Perché, perché? Dov’è la forza antica?
dove l’armi e il valore e la costanza?
Chi ti discinse il brando?
chi ti tradí? Qual arte o qual fatica
o qual tanta possanza
valse a spogliarti il manto e l’auree bende?
Come cadesti o quando
da tanta altezza in cosí basso loco?
Nessun pugna per te? non ti difende
nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo
combatterò, procomberò sol io.
Dammi, o ciel, che sia foco
agl’italici petti il sangue mio.
Dove sono i tuoi figli? Odo suon d’armi
e di carri e di voci e di timballi:
in estranie contrade
pugnano i tuoi figliuoli.
Attendi. Italia, attendi. Io veggio, o parmi,
un fluttuar di fanti e di cavalli,
e fumo e polve, e luccicar di spade
come tra nebbia lampi.
Né ti conforti? e i tremebondi lumi
piegar non soffri al dubitoso evento?
A che pugna in quei campi
l’itala gioventude? O numi, o numi!
pugnan per altra terra itali acciari.
Oh misero colui che in guerra è spento,
non per li patrii lidi e per la pia
consorte e i figli cari,
ma da nemici altrui,
per altra gente, e non può dir morendo:
«Alma terra natia,
la vita che mi desti ecco ti rendo.»
Oh venturose e care e benedette
l’antiche etá, che a morte
per la patria correan le genti a squadre,
e voi sempre onorate e gloriose,
o tessaliche strette,
dove la Persia e il fato assai men forte
fu di poch’alme franche e generose!
Io credo che le piante e i sassi e l’onda
e le montagne vostre al passeggere
con indistinta voce
narrin siccome tutta quella sponda
coprîr le invitte schiere
de’ corpi ch’alla Grecia eran devoti.
Allor, vile e feroce,
Serse per l’Ellesponto si fuggia,
fatto ludibrio agli ultimi nepoti;
e sul colle d’Antela, ove morendo
si sottrasse da morte il santo stuolo,
Simonide salía,
guardando l’etra e la marina e il suolo.
E di lacrime sparso ambe le guance,
e il petto ansante, e vacillante il piede,
toglieasi in man la lira:
«Beatissimi voi,
ch’offriste il petto alle nemiche lance
per amor di costei ch’al sol vi diede;
voi, che la Grecia cole e il mondo ammira.
Nell’armi e ne’ perigli
qual tanto amor le giovanette menti,
90qual nell’acerbo fato amor vi trasse?
Come sí lieta, o figli,
l’ora estrema vi parve, onde ridenti
correste al passo lacrimoso e duro?
Parea ch’a danza e non a morte andasse
ciascun de’ vostri, o a splendido convito:
ma v’attendea lo scuro
Tartaro, e l’onda morta;
né le spose vi fôro o i figli accanto,
quando su l’aspro lito
senza baci moriste e senza pianto.
Ma non senza de’ Persi orrida pena
ed immortale angoscia.
Come lion di tori entro una mandra
or salta a quello in tergo e sí gli scava
con le zanne la schiena,
or questo fianco addenta or quella coscia;
tal fra le perse torme infuriava
l’ira de’ greci petti e la virtute.
Ve’ cavalli supini e cavalieri;
vedi intralciare ai vinti
la fuga i carri e le tende cadute,
e correr fra’ primieri
pallido e scapigliato esso tiranno;
ve’ come infusi e tinti
del barbarico sangue i greci eroi,
cagione ai Persi d’infinito affanno,
a poco a poco vinti dalle piaghe,
l’un sopra l’altro cade. Oh viva! oh viva!
beatissimi voi
mentre nel mondo si favelli o scriva.
Prima divelte, in mar precipitando,
spente nell’imo strideran le stelle,
che la memoria e il vostro
amor trascorra o scemi.
La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando
verran le madri ai parvoli le belle
orme del vostro sangue. Ecco, io mi prostro,
o benedetti, al suolo,
e bacio questi sassi e queste zolle,
che fien lodate e chiare eternamente
dall’uno all’altro polo.
Deh! foss’io pur con voi qui sotto, e molle
fosse del sangue mio quest’alma terra.
Ché, se il fato è diverso, e non consente
ch’io per la Grecia i moribondi lumi
chiuda prostrato in guerra,
cosí la vereconda
fama del vostro vate appo i futuri
possa, volendo i numi,
tanto durar quanto la vostra duri.

Alessandro Puttinati: Italia turrita (1850)
Italia mia, vedo le mura di Roma, gli archi di trionfo, le colonne, le statue e le solitarie torri dei nostri avi, ma non vedo la gloria, la grandezza militare ottenuti con le armi, dei quali erano carichi i nistri antenati. Ora indifesa, mostri la fronte ed il petto nudo. Ora quante ferite, quanti lividi, quanto sangue! In che stato ti vedo, bellissima donna! Chiedo al cielo e al mondo: raccontate, dite; chi l’ha ridotta in tale stato? E quel che è peggio è che ha le braccia cariche di catene, in questo stato con i capelli sciolti e senza velo, siede per terra trascurata e afflitta, nascondendo la faccia tra le ginocchia, e piange. Piangi, ché ne hai tutte le ragioni, Italia mia, che eri nata per essere superiore agli altri popoli nella buona così come nella cattiva sorte. // Anche se i tuoi occhi fossero due fonti perenni, il tuo pianto non sarebbe adeguato alla tua rovina e alla vergogna che ne segue; poiché fosti regina, e ora sei un’umile serva. Chi parla o scrive di te senza dire, ricordando la tua gloria passata, non dica: «un tempo fu grande, adesso non è più quella che fu? Perché? Perché Dov’è l’antica forza militare, dove sono le armi, dove il valore, dove la costanza? Chi ti ha tolto la spada? Chi ti ha tradito? Quale inganno quale fatica o quale potenza fu capace di strapparti il manto e le bende d’oro? In che modo o quando sei precipitata da una così grande altezza in basso loco? Nessuno combatte per te? Nessuno dei tuoi figli ti difende? Le armi, datemi le armi: io solo combatterò, morirò io solo. Concedimi o cielo che il mio sangue diventi fuoco nel cuore degli italiani. // Dove sono i tuoi figli? Sento suoni di armi, di carri, di voci e di tamburi in paesi stranieri, combattono i tuoi figli. Ascolta, Italia, fa’ attenzione. Io vedo, mi sembra, un ondeggiare di fanti e di cavalli, fumo e polvere, un luccicare di armi, come lampi nella nebbia. E ciò non ti conforta? e non sopporti di rivolgere gli occhi spaventati a quel fatto dall’esito incerto? Per quale scopo la gioventù italiana combatte? O numi, o numi: combattono per un’altra terra le armi italiane. Oh disgraziato colui che è ucciso in guerra, non per la terra dei suoi padri e l’onesta moglie e i cari figli, ma da nemici di altri e combattendo per un altro popolo, e non può dire morendo: mia terra nutrice (mia patria), ecco, ti restituisco la vita che mi hai dato. // Oh fortunate e amate e benedette le epoche antiche, quando i popoli, uniti in eserciti, correvano per la patria incontro alla morte, e tu, sempre onorato e glorioso, passo della Tessaglia, dove la Persia e il fato furono sconfitti da pochi soldati arditi e magnanimi! Io credo che la vegetazione, le rocce e il mare, le montagne, in coro raccontino a chi visita quei luoghi come le schiere non vinte ricoprirono tutta quella costa coi loro corpi di guerrieri consacrati alla patria greca. Allora il re persiano Serse, tanto vigliacco quanto feroce, fuggiva per l’Ellesponto, divenuto oggetto di scherno per tutti i discendenti; e sulla collina d’Antela, dove, morendo, il sacro esercito spartano divenne immortale, saliva Simonide, guardando il cielo e la spiaggia e la terra. // E con le guance bagnate di lacrime, il petto affannato e il piede incerto, prendeva in mano la sua cetra: «Beatissimi voi, che offriste i vostri petti alle lance dei nemici (sacrificaste la vostra vita) per amore di costei che vi diede alla luce (la patria); voi che la Grecia venera, e il mondo ammira. Quale amore così grande spinse i vostri giovani animi alle armi e ai pericoli, quale amore vi condusse al crudele destino della morte? O figli, come è possibile che la vostra ultima ora (di vita) vi sia sembrata così gloriosa, per cui correste felici al passo doloroso e terribile? Sembrava che ciascuno di voi andasse a un ballo o a un ricco banchetto, e non a morire: ma vi attendeva il Tartaro oscuro e l’onda della morte; e non vi furono vicini le spose o i figli quando moriste sul terreno scosceso, senza baci e senza lacrime. // Ma (la vostra morte) non avvenne senza il dolore tremendo e la sofferenza immensa dei Persiani. Come il leone in mezzo a una mandria di tori ora si slancia sulla groppa di uno e gli lacera la schiena con i denti, ora gli azzanna un fianco o una coscia, allo stesso modo la rabbia e la virtù dei cuori greci si scatenavano in mezzo alla massa dei Persiani. Vedi cavalli e cavalieri abbattuti; vedi i carri e le tende a terra impedire la fuga ai vinti, e il tiranno stesso (Serse) correre tra i primi, pallido e con i capelli scarmigliati; vedi come, intrisi e macchiati del sangue dei barbari, gli eroi greci, loro che inflissero immenso dolore ai Persiani, cadono l’uno sull’altro, uccisi a poco a poco dalle ferite. Viva, viva: beatissimi voi, finché al mondo si parli o si scriva (perché si parlerà e si scriverà delle vostre gesta eroiche). // Strideranno le stelle strappate via dal cielo in mare, precipitando, spente nei suoi fondali, prima che passino o si riducano il ricordo di voi e l’amore per voi. La vostra tomba è un altare; e qua verranno le madri per mostrare ai figli le tracce gloriose del sangue da voi versato. Ecco, io mi prostro al suolo, o benedetti, e bacio questi sassi e questa terra, che saranno lodate e conosciute in eterno da un capo all’altro del mondo. Oh, se fossi anch’io con voi qui sotto e se questa terra materna fosse bagnata del mio sangue. Ma se il mio destino è un altro, e non permette che io chiuda gli occhi moribondi ucciso in guerra, almeno la fama modesta del vostro cantore possa durare presso i posteri finché duri la vostra.
Questa canzone, scritta nel 1818, è figlia delle conversazioni che il poeta ha avuto con Giordani e segna un distacco netto sia dal conservatorismo paterno, sia dal dibattito culturale nato dall’invito di Madame De Stael e al quale il nostro aveva già risposto con la lettera alla Biblioteca italiana. Egli infatti, partendo dalla poesia petrarchesca (ma si sentono anche echi foscoliani) vuole sottolineare la superiorità della poesia antica su quella moderna, evidenziando nel testo il valore del passato contro la mediocrità del presente. Certo il tema può sembrare abusato, così come il linguaggio che sembra ricalcare più che un’estetica neoclassica, i cui riferimenti sono solo di valore estetico, un significato patriottico e quindi politico, proprio come l’amico Giordani gli aveva insegnato. Eppure, come dice il critico letterario Luperini “si delinea, accanto al tema civile, una tematica esistenziale: il poeta fa corrispondere alla crisi storica dell’Italia una propria crisi personale, proponendosi gesti eroico riscatto indivinduale”.

Leopardi e Giordani nel film di Martone
Contemporanea a quella delle Canzoni civili e quella degli idilli, definiti dalla critica letteraria come “piccoli idilli” per differenziarli dalla produzione successiva, che conterrà testi composti tra il 1827 ed il 1828. Tra i più importanti di essi ricordiamo La sera del dì di festa, L’infinito, Alla luna.
LA SERA DEL DI’ DI FESTA
Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna. O donna mia,
già tace ogni sentiero, e pei balconi
rara traluce la notturna lampa:
tu dormi, che t’accolse agevol sonno
nelle tue chete stanze; e non ti morde
cura nessuna; e già non sai nè pensi
quanta piaga m’apristi in mezzo al petto.
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno
appare in vista, a salutar m’affaccio,
e l’antica natura onnipossente,
che mi fece all’affanno. A te la speme
nego, mi disse, anche la speme; e d’altro
non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.
Questo dì fu solenne: or da’ trastulli
prendi riposo; e forse ti rimembra
in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
piacquero a te: non io, non già, ch’io speri,
al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo
quanto a viver mi resti, e qui per terra
mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi
in così verde etate! Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto
dell’artigian, che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. Or dov’è il suono
di que’ popoli antichi? or dov’è il grido
de’ nostri avi famosi, e il grande impero
di quella Roma, e l’armi, e il fragorio
che n’andò per la terra e l’oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
il mondo, e più di lor non si ragiona.
Nella mia prima età, quando s’aspetta
bramosamente il dì festivo, or poscia
ch’egli era spento, io doloroso, in veglia,
premea le piume; ed alla tarda notte
un canto che s’udia per li sentieri
lontanando morire a poco a poco,
già similmente mi stringeva il core.
 Elio Giordano nei panni di Leopardi illuminato dalla luna nel film Il giovane favoloso
Elio Giordano nei panni di Leopardi illuminato dalla luna nel film Il giovane favoloso
Dolce e luminosa è la notte senza vento e placida sopra i tetti riposa e in mezzo agli orti riposa la luna e rivela da lontano nitida ogni montagna. O, donna mia, ormai tace ogni sentiero e attraverso i balconi trapela fioca la luce delle lampade accese: tu dormi, che un facile sonno ti prese nelle stanze silenziose e non ti angustia alcun affanno e di certo non sai né pensi quale grande ferita d’amore mi hai inferto nel cuore. Tu dormi: ed io mi affaccio a salutare questo cielo, che sembra così benevolo alla vista e l’antica natura onnipotente che mi ha generato per la sofferenza. Mi disse: a te nego anche la speranza e tuoi occhi non luccichino se non per le lacrime. Questo è stato un giorno festivo: ora tu (riferito alla donna) riposati dopo gli svaghi; e forse ti torna alla memoria durante il sonno a quanti sei piaciuta, e quanti ti piacquero: non io ti ritorno al pensiero e nemmeno lo spero. Nel frattempo io chiedo quanto mi resti da vivere e mi getto a terra, e piango e sono percorso da fremiti. Ah orrendi giorni in una così giovane età! Ahimè, per la via sento non lontano il canto dell’artigiano, che torna a notte tarda, dopo i divertimenti, alla sua povera casa; e mi si stringe dolorosamente il cuore nel pensare a come tutto nel mondo passa, e quasi non lascia traccia. Ecco è terminato il giorno festivo, e al giorno di festa segue quello volgare ed il tempo porta via con sé ogni cosa umana. Ora dov’è il rumore di quei popoli antichi? ora dov’è la fama dei nostri antenati famosi ed il grande impero di Roma, tanto celebre e il clamore dei suoi eserciti che da lei si sparse per terra e per mare? Tutto è tranquillo e silenzioso, tutto il mondo riposa e di loro non si parla più. nella mia fanciullezza, quando si aspetta con desiderio il giorno di festa, dopo quando era finito, io con dolore, giacevo nel letto sveglio e nella notte fonda un canto che si udiva allontanarsi e morire piano piano, già in modo simile mi stringeva il cuore.
Il testo lirico, tutto in endecasillabi senza interruzioni strofiche, presenta una varietà stilistico tematica che pur intrecciandosi in modo non sempre armonico all’interno dei versi, ne dà tuttavia un’immagine unitaria. Inizia con la descrizione notturna, placando il verso con il polisintedo, che ci prepara all’epifania lunare. Quindi la presenza femminile, posta in rilievo oppositivo: la seconda persona con cui la indica sottolinea da una parte lo struggimento, dall’altra l’esclusione di contro alla di lei indifferrenza fatta di nessun affanno, inconsapevole del dolore provocatogli. Si affianca a lei la natura, «l’antica natura onnipossente che mi fece all’affanno». L’ultima parte è introdotta dalla sensazione uditiva del canto dell’artigiano e che lo porta al pensiero dell’età antica e alla considerazione topica dell’omnia fert aetas che investe l’intera storia, immagine del canto dell’artigiano che si allontana ripetuta nell’ultimo verso: la sensazione che tutto trascorri e passi senza lasciare traccia permane come acquisizione conoscitiva per il giovane poeta.
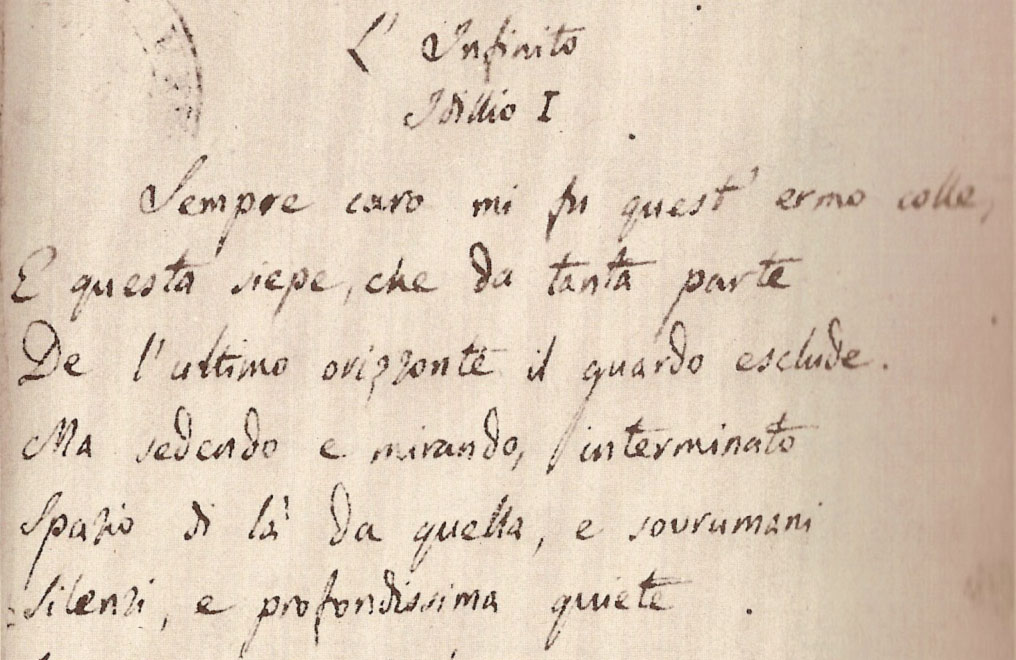
Pagina autografa
L’INFINITO
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
Sempre caro mi è stato questo colle solitario e questa siepe che sottrae allo sguardo tanta parte dell’estremo orizzonte. Stando fermo e guardando fisso io immagino nel pensiero spazi infiniti al di là di quella siepe e silenzi che un uomo non può percepire e quiete profonde, per cui per poco il cuore non si smarrisce. E quando sento stormire le foglie a causa del vento io paragono quell’infinito silenzio a questa voce e mi viene in mente l’eternità, le stagioni passate, la presente e viva ed il suo suono. Tra questa immensità si smarrisce il mio pensiero ed il lasciarsi andare in questo mare mi è gradito.
L’idillio, in quindici endecasillabi sciolti, ci vuole presentare un’esperienza reale/psichica nella quale il nostro trova, nell’indeterminatezza della natura la voce della poesia, che la civiltà ha in parte distrutto. Esso si situa in una duplice direzione:
- Definisce quello che nella Lettera di un italiano intorno alla romantica ritiene essere l’imitatio verso gli antichi: riprodurre il sentimento verso la natura, la sola che dà diletto. Ma se la natura, oggi, si svuota della capacità immaginativa in quanto “incrostata” di sapienza razionale, essa può ridare gioia in ciò che tale “incrostazione” non vi è;
- Chiarisce ciò che nello Zibaldone aveva definito come lessico poetico: e tale lessico richiede parole assolutamende vaghe e indefinite.
L’idillio è costruito sapientemente attraverso un’opposizione che pone elementi reali contro elementi immaginativi. Dapprima il poeta è limitato dalla siepe che non gli permette di vedere lo spazio. Tale spazio, razionalmente, è finito, perché per Leopardi, la terra e l’universo sono realtà finite, ma in quanto inconcepibili nella loro interminatezza dalla ragione umana, esse danno vita ad una funzione immaginativa e quindi poetica. In questa prima parte inserisce anche l’infinito silenzio che richiama alla seconda parte dell’idillio, dove tale sensazione è prodotta dallo stormire delle foglie. A dire il vero la seconda sensazione è più vasta, maggiormente richiamata: l’infinito silenzio, il tempo remoto, il presente e quello limitato in cui il poeta è (sedendo e mirando, come fosse posto in terra, in un angolo un po’ sopraelevato del suo giardino). Tale capacità è resa mirabilmente dall’uso sapientissimo degli enjambement, che dal quarto verso mettono in rilievo parole indefinite o aggettivi dimostrativi a denotare la distanza dell’io poeta da ciò che immagina (questo, quello).

Se nell’intenzione del poeta vi era quasi la volontà di realizzare una poesia classicamente atteggiata, non è un caso che essa risulti fortemente romantica: è infatti un testo metafisico, che si basa sull’immaginazione e quindi sul “non definito”. Ma tale indeterminatezza non nasce come un allontanamento totale dalla realtà, come un puro sogno. Egli parte da un dato reale per immaginare, non cede al fascino della teoria dell’onirico, dell’impalpabile, dell’etereo: è infatti una siepe o il fruscio a determinare l’immaginazione. E che tale immaginazione crei diletto lo sottolinea nello splendido ultimo verso, dove al centro di esso pone il lemma “dolce”, con la o tonica a fermare la voce del lettore.
Un altro importante aspetto della meditazione leopardiana di questo periodo riguarda la teoria del piacere. Il Leopardi deriva tale teoria dalla filosofia sensistica settecentesca, ma la determina e l’approfondisce con meditazioni culturali e personali. Il piacere è una condizione indefinita dell’uomo, in quanto irrealizzabile nella sua totalità: ciò che l’uomo prova è una serie di piaceri caratterizzati da limitatezza temporale, che interrompono una naturale condizione di insoddisfazione che cessa solo con la morte. Il compito della natura, in questa fase, è tuttavia quello di dispensarci di tali momenti di felicità, fornendoci le “illusioni” e attimi di “godimento”. Essa infatti attenua e lenisce il senso di finitezza e precarietà della vita umana. Allora come mai anche gli antichi, nella loro produzione poetica, spesso parlano dell’infelicità dell’uomo? In questa fase Leopardi non incolpa la ragione, ma il destino o gli dei (definizioni che rimandano ad unico concetto). Ma vedremo che tale spiegazione, che presumibilmente apparirà anche a lui insufficiente, sarà presto superata.
Tale posizione è illustrata mirabilmente in una delle più famose canzoni leopardiane, ancora appartenenti al primo periodo:
L’ULTIMO CANTO DI SAFFO
Placida notte, e verecondo raggio
della cadente luna; e tu che spunti
fra la tacita selva in su la rupe,
nunzio del giorno; oh dilettose e care
mentre ignote mi fur l’erinni e il fato,
sembianze agli occhi miei; già non arride
spettacol molle ai disperati affetti.
Noi l’insueto allor gaudio ravviva
quando per l’etra liquido si volve
e per li campi trepidanti il flutto
polveroso de’ Noti, e quando il carro,
grave carro di Giove a noi sul capo,
tonando, il tenebroso aere divide.
Noi per le balze e le profonde valli
natar giova tra’ nembi, e noi la vasta
fuga de’ greggi sbigottiti, o d’alto
fiume alla dubbia sponda
il suono e la vittrice ira dell’onda.
Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella
sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta
infinita beltà parte nessuna
alla misera Saffo i numi e l’empia
sorte non fenno. A’ tuoi superbi regni
vile, o natura, e grave ospite addetta,
e dispregiata amante, alle vezzose
tue forme il core e le pupille invano
supplichevole intendo. A me non ride
l’aprico margo, e dall’eterea porta
il mattutino albor; me non il canto
de’ colorati augelli, e non de’ faggi
il murmure saluta: e dove all’ombra
degl’inchinati salici dispiega
candido rivo il puro seno, al mio
lubrico piè le flessuose linfe
disdegnando sottragge,
e preme in fuga l’odorate spiagge.
Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso
macchiommi anzi il natale, onde sì torvo
il ciel mi fosse e di fortuna il volto?
In che peccai bambina, allor che ignara
di misfatto è la vita, onde poi scemo
di giovanezza, e disfiorato, al fuso
dell’indomita Parca si volvesse
il ferrigno mio stame? Incaute voci
spande il tuo labbro: i destinati eventi
move arcano consiglio. Arcano è tutto,
fuor che il nostro dolor. Negletta prole
nascemmo al pianto, e la ragione in grembo
de’ celesti si posa. Oh cure, oh speme
de’ più verd’anni! Alle sembianze il Padre,
alle amene sembianze eterno regno
diè nelle genti; e per virili imprese,
per dotta lira o canto,
virtù non luce in disadorno ammanto.
Morremo. Il velo indegno a terra sparto,
rifuggirà l’ignudo animo a Dite,
e il crudo fallo emenderà del cieco
dispensator de’ casi. E tu cui lungo
amore indarno, e lunga fede, e vano
d’implacato desio furor mi strinse,
vivi felice, se felice in terra
visse nato mortal. Me non asperse
del soave licor del doglio avaro
Giove, poi che perìr gl’inganni e il sogno
della mia fanciullezza. Ogni più lieto
giorno di nostra età primo s’invola.
Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l’ombra
della gelida morte. Ecco di tante
sperate palme e dilettosi errori,
il Tartaro m’avanza; e il prode ingegno
han la tenaria Diva,
e l’atra notte, e la silente riva.
Placida notte e pudico raggio della luna tramontante luna e tu stella che spunti tra il silente bosco della scoscesa rupe annunciando il mattino; piacevoli e gradite immagini al mio sguardo, quando ancora sconosciute erano la passione e il destino d’amore; oramai un dolce spettacolo non giova a chi è disperato. A noi vivifica un’inconsueta felicità quando il soffio del vento turbina per la piovigginosa aria e per i campi agitati, quando l’imponente carro di Giove scaglia fulmini sul nostro capo, squarciando il cielo. A noi giova annegare per i dirupi e le profonde valli, per noi la disordinata fuga delle greggi o il suono e la vincitrice forza dell’onda di un profondo fiume sulla non sicura sponda. // Bella la tua copertura, o cielo divino, e bella sei tu, terra ricoperta di rugiada: ah di questa infinita bellezza niente hanno fatto gli dei ed il triste destino alla povera Saffo. Ai tuoi superbi regni, o natura, data come misera e non gradita ospite e disprezzata amante, invano supplichevole sollevo il cuore e lo sguardo. A me non giova un campo soleggiato, o l’alba che spunta dalla porta del cielo; non giovano il canto di variopinti uccelli e non il mormorio delle foglie dei faggi: e dove all’ombra dei salici pendenti un limpido ruscello dispiega le sue acque trasparenti, quello stesso ruscello disprezzandomi sottrae al mio incerto piede le sue acque sinuose e fuggendomi urta contro le sue rive profumate. // Quale colpa, quale così vergognosa enormità mi ha macchiato prima di nascere, per cui così ostile il cielo e la fortuna mi fossero? In cosa peccai bambina, quando la vita ignorava il male, quando ormai privata del fiore della giovinezza, il filo della mia spenta vita si riavvolgeva nel fuso della irremovibile Parca? (Rivolgendosi a se stessa) La tua bocca pronuncia incauti parole: i futuri avvenimenti sono voluti da una misteriosa volontà. Tutto è mistero, al di fuori del nostro dolore. Figli non desiderati nascemmo per piangere, e il motivo sta nel grembo degli dei. Oh preoccupazioni o vane aspirazioni della mia gioventù. Giove ha dato alla gente dominio eterno alla beltà; non risplende in un corpo brutto la virtù per imprese gloriose, suono sapiente o capacità letteraria. // Moriremo. Con il brutto corpo sparso sulla terra, l’animo nudo fuggirà verso la morte e correggerà il crudele errore del destino. E tu (Faone) a cui mi strinse un inutile lungo amore ed una lunga fedeltà ed una illusoria implacabile passione, vivi felice, se felicemente possa vivere sulla terra un mortale. Giove non asperse su di me il soave liquore della felicità dal vaso cui raccoglieva raramente. Ogni giorno più felice della nostra vita vola via. Subentrano le malattie, la vecchiaia, e la minaccia della fredda morte: ecco, di tante sperate glorie e piacevoli svaghi, la morte mi avanza, il mio tenace ingegno lo possiede la regina dell’Infero (Proserpina), l’oscura notte e il silenzioso rivo.
Antoine-Jean Gros Sappho a Leucode (1801)
Questo testo, tra le canzoni di Leopardi, nella pubblicazione dei Canti da lui voluti, precede gli idilli, che invece verranno scritti prima. E’ un testo infatti del 1822, in cui si può misurare il classicismo leopardiano, ma come questo, al contrario di Foscolo, sia intessuto di elementi soggettivi e non più civili. Questa canzone è composta da quattro strofe di 18 versi sciolti, solo gli ultimi due che hanno rima baciata; i versi sono prevalentemente endecasillabi ad eccezione del penultimo che è settenario. Tale struttura risponde, secondo la retorica classica, ad un tema “gravissimo”, sia per la superiorità degli endecasillabi che per la quasi mancanza di rime.
Il tema, come ci dice egli stesso, è quello di “rappresentare l’infelicità di un animo delicato, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane”. Ciò ci conduce, direi quasi semplicisticamente, ad identificare la situazione del poeta recanatese con quella di Saffo. Ma se si accettasse una totale identificazione si perderebbe il senso ultimo di questo scritto. Troviamo infatti la concezione secondo la quale è il destino a serbarci un triste svolgersi della nostra esistenza, ma troviamo altresì un inizio di un ripensamento/approfondimento del ruolo della natura nella vita dell’uomo, come verrà poi sviluppato nelle Operette morali.
Operette morali: la morte della voce poetica: 1823 – 1826
Il giovane Leopardi, a seguito della corrispondenza col Giordani, aveva fortemente sentito la necessità di un allontanamento da Recanati e nel ’19 ci tentò, provando a fuggire. Scoperto dal padre, che temeva per la salute del giovane nonché, e forse ancor di più, delle meditazioni filosofiche politiche che nel figlio andavano maturando, lo fece desistere dal tentativo. Frustrato, senza poter più leggere, il nostro si lascerà andare a una più radicale meditazione che lo porta a riflettere sul senso della vita. Alla fine, col consenso del padre, ma siamo già nel ’22, riuscirà a partire e a raggiungere la grande città, Roma, ospite di uno zio, fratello della madre. Non sarà affatto entusiasta: laddove cercava un confronto vitale per l’affermazione della sua cultura, trova soltanto conformismo e grettezza; laddove cerca nelle vie la storia, non sa trovarla, perché si sente solo, non la conosce e non vuole sempre chiedere d’essere accompagnato. Vive in casa dello zio, circondato dall’affetto, ma non lo stesso che gli davano i fratelli a Recanati. Vi torna nel ’23 e sente che la poesia per lui non ha più voce. Accentua il sarcasmo sulla sua condizione ed inevitabilmente sulla condizione dell’uomo e medita di scrivere una serie di prose sul modello di Luciano di Samosata, scrittore irreverente del II secolo dopo Cristo. Nel 1824 scrive il corpus maggiore di esse (20) a cui se ne aggiungeranno 3 nel ’27 e due nel ’32. Nell’edizione definitiva, dettata da Leopardi a Ranieri ed uscita postuma, Leopardi ne eliminerà una, Dialogo di un lettore di umanità e Sallustio.
DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO
FOLLETTO: Oh sei tu qua, figliuolo di Sabazio*? Dove si va?
GNOMO: Mio padre m’ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchinando questi furfanti degli uomini; perché ne sta con gran sospetto, a causa che da un pezzo in qua non ci danno briga, e in tutto il suo regno non se ne vede uno. Dubita che non gli apparecchino qualche gran cosa contro, se però non fosse tornato in uso il vendere e comperare a pecore, non a oro e argento; o se i popoli civili non si contentassero di polizzine per moneta come hanno fatto più volte, o di paternostri di vetro, come fanno i barbari; o se pure non fossero state ravvalorate le leggi di Licurgo, che gli pare il meno credibile.
FOLLETTO: “Voi gli aspettate invan: son tutti morti”, diceva la chiusa di una tragedia dove morivano tutti i personaggi.
GNOMO: Che vuoi tu inferire?
FOLLETTO: Voglio inferire che gli uomini son tutti morti, e la razza è perduta.
GNOMO: Oh cotesto è caso da gazzette. Ma pure fin qui non s’è veduto che ne ragionino.
FOLLETTO: Sciocco, non pensi che, morti gli uomini, non si stampano più gazzette?
GNOMO: Tu dici il vero. Or come faremo a sapere le nuove del mondo?
FOLLETTO: Che nuove? che il sole si è levato o coricato, che fa caldo o freddo, che qua o là è piovuto o nevicato o ha tirato vento? Perché, mancati gli uomini, la fortuna si ha cavato via la benda, e messosi gli occhiali e appiccato la ruota a un arpione, se ne sta colle braccia in croce a sedere, guardando le cose del mondo senza più mettervi le mani; non si trova più regni né imperi che vadano gonfiando e scoppiando come le bolle, perché sono tutti sfumati; non si fanno guerre, e tutti gli anni si assomigliano l’uno all’altro come uovo a uovo.
GNOMO: Né anche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più lunari.
FOLLETTO: Non sarà gran male, che la luna per questo non fallirà la strada.
GNOMO: E i giorni della settimana non avranno più nome.
FOLLETTO: Che, hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? o forse ti pensi, poiché sono passati, di farli tornare indietro se tu li chiami?
GNOMO: E non si potrà tenere il conto degli anni.
FOLLETTO: Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo; e non misurando l’età passata, ce ne daremo meno affanno, e quando saremo vecchissimi non istaremo aspettando la morte di giorno in giorno.
GNOMO: Ma come sono andati a mancare quei monelli?
FOLLETTO: Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l’un l’altro, parte ammazzandosi non pochi di propria mano, parte infracidando nell’ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzovigliando, e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male.
GNOMO: A ogni modo, io non mi so dare ad intendere che tutta una specie di animali si possa perdere di pianta, come tu dici.
FOLLETTO: Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo, e che varie qualità di bestie si trovarono anticamente che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. E certo che quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifizi che, come io ti diceva, hanno usato gli uomini per andare in perdizione.
GNOMO: Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero, e sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli.
FOLLETTO: E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per li folletti.
GNOMO: Tu folleggi veramente, se parli sul sodo.
FOLLETTO: Perché? io parlo bene sul sodo.
GNOMO: Eh, buffoncello, va via. Chi non sa che il mondo è fatto per gli gnomi?
FOLLETTO: Per gli gnomi, che stanno sempre sotterra? Oh questa è la più bella che si possa udire. Che fanno agli gnomi il sole, la luna, l’aria, il mare, le campagne?
GNOMO: Che fanno ai folletti le cave d’oro e d’argento, e tutto il corpo della terra fuor che la prima pelle?
FOLLETTO: Ben bene, o che facciano o che non facciano, lasciamo stare questa contesa, che io tengo per fermo che anche le lucertole e i moscherini si credano che tutto il mondo sia fatto a posta per uso della loro specie. E però ciascuno si rimanga col suo parere, che niuno glielo caverebbe di capo: e per parte mia ti dico solamente questo, che se non fossi nato folletto, io mi dispererei.
GNOMO: Lo stesso accadrebbe a me se non fossi nato gnomo. Ora io saprei volentieri quel che direbbero gli uomini della loro presunzione, per la quale, tra l’altre cose che facevano a questo e a quello, s’inabissavano le mille braccia sotterra e ci rapivano per forza la roba nostra, dicendo che ella si apparteneva al genere umano, e che la natura gliel’aveva nascosta e sepolta laggiù per modo di burla, volendo provare se la troverebbero e la potrebbero cavar fuori.
FOLLETTO: Che maraviglia? quando non solamente si persuadevano che le cose del mondo non avessero altro uffizio che di stare al servigio loro, ma facevano conto che tutte insieme, allato al genere umano, fossero una bagatella. E però le loro proprie vicende le chiamavano rivoluzioni del mondo e le storie delle loro genti, storie del mondo: benché si potevano numerare, anche dentro ai termini nella terra, forse tante altre specie, non dico di creature, ma solamente di animali, quanti capi d’uomini vivi: i quali animali, che erano fatti espressamente per coloro uso, non si accorgevano però mai che il mondo si rivoltasse.
GNOMO: Anche le zanzare e le pulci erano fatte per benefizio degli uomini?
FOLLETTO: Sì erano; cioè per esercitarli nella pazienza, come essi dicevano.
GNOMO: In verità che mancava loro occasione di esercitar la pazienza, se non erano le pulci.
FOLLETTO: Ma i porci, secondo Crisippo erano pezzi di carne apparecchiati dalla natura a posta per le cucine e le dispense degli uomini, e, acciocché non imputridissero, conditi colle anime in vece di sale.
GNOMO: Io credo in contrario che se Crisippo avesse avuto nel cervello un poco di sale in vece dell’anima, non avrebbe immaginato uno sproposito simile.
FOLLETTO: E anche quest’altra è piacevole; che infinite specie di animali non sono state mai viste né conosciute dagli uomini loro padroni; o perché elle vivono in luoghi dove coloro non misero mai piede, o per essere tanto minute che essi in qualsivoglia modo non le arrivavano a scoprire. E di moltissime altre specie non se ne accorsero prima degli ultimi tempi. Il simile si può dire circa al genere delle piante, e a mille altri. Parimenti di tratto in tratto, per via de’ loro cannocchiali, si avvedevano di qualche stella o pianeta, che insino allora, per migliaia e migliaia d’anni, non avevano mai saputo che fosse al mondo; e subito lo scrivevano tra le loro masserizie: perché s’immaginavano che le stelle e i pianeti fossero, come dire, moccoli da lanterna piantati lassù nell’alto a uso di far lume alle signorie loro, che la notte avevano gran faccende.
GNOMO: Sicché, in tempo di state, quando vedevano cadere di quelle fiammoline che certe notti vengono giù per l’aria, avranno detto che qualche spirito andava smoccolando le stelle per servizio degli uomini.
FOLLETTO: Ma ora che ei sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non sono stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si vede che si rasciughi.
GNOMO: E le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non hanno preso le gramaglie.
FOLLETTO: E il sole non s’ha intonacato il viso di ruggine; come fece, secondo Virgilio, per la morte di Cesare: della quale io credo ch’ei si pigliasse tanto affanno quanto ne pigliò la statua di Pompeo.
* gli gnomi erano spiriti che vivevano sottoterra, figli di Sabazio, divinità dei Traci corrispondente al Dioniso dei Greci. I folletti, al contrario erano natura dell’aria.

Illustrazione per l’operetta leopardiana
L’operetta, come la maggior parte di quelle della prima edizione, è del 1824 e viene considerata fra le più riuscite per il ritmo serrato del dialogo, che fa sì che in essa si riveli una “levità musicale” come dice il critico Fubini, e per la forte ironia che riesce a togliere il senso tragico al tema che fa da sottofondo alla riflessione leopardiana. E’ evidente che qui venga criticata l’arroganza di chi crede che la terra sia a servizio dell’uomo e ci viene mostrato, attraverso un efficace paradosso che alla scomparsa dell’uomo, non corrisponderebbe affatto un’altrettanta scomparsa della terra. Ma l’importanza dell’operetta è che essa sembra situarsi ancora in un momento d’incertezza leopardiana, la stessa che si era già mostrata nell’ultimo canto di Saffo: non è un caso che in un passo citi le colpe dell’uomo per la loro autodistruzione e non dia colpa alcuna colpa alla natura che prende solamente “atto” della loro assenza.
Bisognerà attendere il capolavoro delle Operette in cui tale “empasse” verrà finalmente risolto:
DIALOGO DI UN ISLANDESE E DELLA NATURA
Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre; andando una volta per l’interiore dell’Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a Vasco di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove acque. Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza parlare, all’ultimo gli disse:
NATURA: Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?
ISLANDESE: Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.
NATURA: Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se medesimo. Io sono quella che tu fuggi.
ISLANDESE: La Natura?
NATURA: Non altri.
ISLANDESE: Me ne dispiace fino all’anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di questa non mi potesse sopraggiungere.
NATURA: Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?
ISLANDESE: Tu dei sapere che io fino nella prima gioventù, a poche esperienze, fui persuaso e chiaro della vanità della vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo continuamente gli uni cogli altri per l’acquisto di piaceri che non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini, e infiniti mali, che affannano e nocciono in effetto; tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la cercano. Per queste considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla; e disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche corporali: che ben sai che differenza è dalla fatica al disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova come egli è vano a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti offendano; e cedendo sempre spontaneamente, e contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia lasciato un qualsivoglia luogo, e che questo menomo non ti sia contrastato. Ma dalla molestia degli uomini mi liberai facilmente, separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: cosa che nell’isola mia nativa si può recare ad effetto senza difficoltà. Fatto questo, e vivendo senza quasi verun’immagine di piacere, io non poteva mantenermi però senza patimento: perché la lunghezza del verno, l’intensità del freddo, e l’ardore estremo della state, che sono qualità di quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il fuoco, presso al quale mi conveniva passare una gran parte del tempo, m’inaridiva le carni, e straziava gli occhi col fumo; di modo che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da un perpetuo disagio. Né anche potea conservare quella tranquillità della vita, alla quale principalmente erano rivolti i miei pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di terra, i ruggiti e le minacce del monte Ecla, il sospetto degl’incendi, frequentissimi negli alberghi, come sono i nostri, fatti di legno, non intermettevano mai di turbarmi. Tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme a se medesima, e spogliata di qualunque altro desiderio e speranza, e quasi di ogni altra cura, che d’esser quieta; riescono di non poco momento, e molto più gravi che elle non sogliono apparire quando la maggior parte dell’animo nostro è occupata dai pensieri della vita civile, e dalle avversità che provengono dagli uomini. Per tanto veduto che più che io mi ristringeva e quasi mi contraeva in me stesso, a fine d’impedire che l’esser mio non desse noia né danno a cosa alcuna del mondo; meno mi veniva fatto che le altre cose non m’inquietassero e tribolassero; mi posi a cangiar luoghi e climi, per vedere se in alcuna parte della terra potessi non offendendo non essere offeso, e non godendo non patire. E a questa deliberazione fui mosso anche da un pensiero che mi nacque, che forse tu non avessi destinato al genere umano se non solo un clima della terra (come tu hai fatto a ciascuno degli altri generi degli animali, e di quei delle piante), e certi tali luoghi; fuori dei quali gli uomini non potessero prosperare né vivere senza difficoltà e miseria; da dover essere imputate, non a te, ma solo a essi medesimi, quando eglino avessero disprezzati e trapassati i termini che fossero prescritti per le tue leggi alle abitazioni umane. Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi tutti i paesi; sempre osservando il mio proposito, di non dar molestia alle altre creature, se non il meno che io potessi, e di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato arso dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, afflitto nei climi temperati dall’incostanza dell’aria, infestato dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho veduto, nei quali non passa un dì senza temporale: che è quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una battaglia formata a quegli abitanti, non rei verso te di nessun’ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle stagioni tranquille dagli altri furori dell’aria. Tal volta io mi ho sentito crollare il tetto in sul capo pel gran carico della neve, tal altra, per l’abbondanza delle piogge la stessa terra, fendendosi, mi si è dileguata di sotto ai piedi; alcune volte mi è bisognato fuggire a tutta lena dai fiumi, che m’inseguivano, come fossi colpevole verso loro di qualche ingiuria. Molte bestie salvatiche, non provocate da me con una menoma offesa, mi hanno voluto divorare; molti serpenti avvelenarmi; in diversi luoghi è mancato poco che gl’insetti volanti non mi abbiano consumato infino alle ossa. Lascio i pericoli giornalieri, sempre imminenti all’uomo, e infiniti di numero; tanto che un filosofo antico non trova contro al timore, altro rimedio più valevole della considerazione che ogni cosa è da temere. Né le infermità mi hanno perdonato; con tutto che io fossi, come sono ancora, non dico temperante, ma continente dei piaceri del corpo. Io soglio prendere non piccola ammirazione considerando che tu ci abbi infuso tanta e sì ferma e insaziabile avidità del piacere; disgiunta dal quale la nostra vita, come priva di ciò che ella desidera naturalmente, è cosa imperfetta: e da altra parte abbi ordinato che l’uso di esso piacere sia quasi di tutte le cose umane la più nociva alle forze e alla sanità del corpo, la più calamitosa negli effetti in quanto a ciascheduna persona, e la più contraria alla durabilità della stessa vita. Ma in qualunque modo, astenendomi quasi sempre e totalmente da ogni diletto, io non ho potuto fare di non incorrere in molte e diverse malattie: delle quali alcune mi hanno posto in pericolo della morte; altre di perdere l’uso di qualche membro, o di condurre perpetuamente una vita più misera che la passata; e tutte per più giorni o mesi mi hanno oppresso il corpo e l’animo con mille stenti e mille dolori. E certo, benché ciascuno di noi sperimenti nel tempo delle infermità, mali per lui nuovi o disusati, e infelicità maggiore che egli non suole (come se la vita umana non fosse bastevolmente misera per l’ordinario); tu non hai dato all’uomo, per compensarnelo, alcuni tempi di sanità soprabbondante e inusitata, la quale gli sia cagione di qualche diletto straordinario per qualità e per grandezza. Ne’ paesi coperti per lo più di nevi, io sono stato per accecare: come interviene ordinariamente ai Lapponi nella loro patria. Dal sole e dall’aria, cose vitali, anzi necessarie alla nostra vita, e però da non potersi fuggire, siamo ingiuriati di continuo: da questa colla umidità, colla rigidezza, e con altre disposizioni; da quello col calore, e colla stessa luce: tanto che l’uomo non può mai senza qualche maggiore o minore incomodità o danno, starsene esposto all’una o all’altro di loro. In fine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena; laddove io non posso numerare quelli che ho consumati senza pure un’ombra di godimento: mi avveggo che tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il non godere; tanto impossibile il viver quieto in qual si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi risolvo a conchiudere che tu sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c’insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto rimango privo di ogni speranza: avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione, non lasci mai d’incalzarci, finché ci opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e questo tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de’ viventi, preveduto da ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro in là, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo della vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione, tutto il rimanente allo scadere, e agl’incomodi che ne seguono.
NATURA: Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.
ISLANDESE: Ponghiamo caso che uno m’invitasse spontaneamente a una sua villa, con grande instanza; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d’intrattenermi in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e battere da’ suoi figliuoli e dall’altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali trattamenti, mi rispondesse: forse che ho fatto io questa villa per te? o mantengo io questi miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de’ tuoi sollazzi, e di farti le buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non hai fatto questa villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l’avessi fatto e ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: t’ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e straziato, e che l’abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura.
NATURA: Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna libera da patimento.
ISLANDESE: Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono?
Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall’inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell’Islandese; come fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l’Islandese parlava, lo stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di Europa.
Tale “operetta” ci conduce ad un punto di svolta in cui la meditazione leopardiana sul rapporto natura/uomo era giunta.
Convergono in essa alcuni punti interessanti:
- identificazione islandese/ Leopardi: ambedue viventi ai confini del mondo. Il primo in un’isola poco frequentata nel nord Europa; il secondo in un piccolo centro dello Stato della Chiesa, chiuso ad ogni contatto culturale “moderno”;
- La trasformazione del “viaggio” di settecentesca memoria, rivolto alla conoscenza e acquisizione di usi e costumi di realtà diverse; qui, invece, la conoscenza è di origine filosofica e si ammanta di sapere classico (epicureo e quindi lucreziano, nonché dell’apporto stoico di Seneca).
Proprio a partire dal primo punto notiamo che l’Islandese/Leopardi è un protagonista lontano dalla civiltà e quindi “naturalmente” portato a vivere in contatto con la natura. Il fatto che egli la fugga, lo pone in antitesi proprio al viaggio settecentesco: si pensi, per la letteratura italiana, ai passi di Alfieri sul mar Baltico e come l’imponenza dei ghiacci portava l’uomo a quella sublimità che potremo certamente definire “preromatica”.
Qui vi è non il viaggio, ma la fuga, illusoria: la natura non si può fuggire in quanto sta dentro di noi; per Leopardi noi stessi siamo natura e pertanto è illusorio cercare di fuggirla. L’uomo vi ha tentato anche con razionalità, vincendo lo stupido antropocentrismo e cercando un luogo in cui l’uomo potesse stare senza adattamento, come gli orsi nel gelo o i leoni nella savana. Ma tale luogo la natura non lo ha predisposto. Allora, attraverso un incalzante interrogativo Leopardi le chiede perché la Natura stessa ha creato l’uomo per poi disinteressarsi completamente di lui. Riprende la teoria illuminista, già vista in Foscolo, secondo cui, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi quella teoria che vede la natura come un processo meccanico. Tale è la risposta della stessa Natura, che non può generare, a sua volta, che l’interrogativo sul motivo del vivere se poi tale vita è inutile per l’uomo, ma utile solo alla stessa natura. Non c’è risposta e la chiusura è grottesca, amara. I due leoni, rappresentanti essi stessi la natura, sbranandolo, campano un giorno in più, o ancora, diventato mummia, si riduce ad essere oggetto di sguardi curiosi (di chi?).

Attilio Del Giudice: Dialogo della natura e di un islandese
Concludendo potremo solo dire che, quello già intuito ne L’ultimo canto di Saffo, approfondito nel Dialogo di un folletto e di uno gnomo, negato quello che precedentemente aveva rappresentato l’idillio L’infinito, ci troviamo di fronte al passaggio per cui l’antinomia natura/ragione viene a cadere, determinando l’ineluttabile infelicità umana. Tale fase del pensiero leopardiano prende il nome di “pessimismo cosmico”.
Produzione letteraria nel periodo pisano-recanatese 1828 -1830
Questo è lo stesso atteggiamento che Leopardi avrà nella stagione dei cosiddetti “Grandi Idilli”, scritti nel periodo pisano-recanatese, in cui, dopo l’esperienza prosastica delle Operette, sente rinascere la voglia della poesia, come dice, in una lettera, alla sorella Paolina: Dopo due anni ho fatto dei versi quest’Aprile; ma versi veramente all’antica, e con quel mio cuore d’una volta.
Nascono infatti Il risorgimento e la celeberrima A Silvia, composta a Pisa nel ’28:
A SILVIA
Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi?
Sonavan le quiete stanze,
e le vie d’intorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all’opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare il giorno.
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte,
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte,
d’in su i veroni del paterno ostello
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
e tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?
Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,
da chiuso morbo combattuta e vinta,
perivi, o tenerella. E non vedevi
il fior degli anni tuoi;
non ti molceva il core
la dolce lode or delle negre chiome,
or degli sguardi innamorati e schivi;
né teco le compagne ai dì festivi
ragionavan d’amore.
Anche perìa fra poco
la speranza mia dolce: agli anni miei
anche negaro i fati
la giovinezza. Ahi come,
come passata sei,
cara compagna dell’età mia nova,
mia lacrimata speme!
Questo è il mondo? Questi
i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,
onde cotanto ragionammo insieme?
questa la sorte delle umane genti?
All’apparir del vero
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.
Silvia, ricordi ancora quel tempo della tua vita, quando la bellezza risplendeva nei tiuoi occhi felici e pudichi e tu, lieta e pensosa, ti preparavi ad affrontare l’età che immette alla giovinezza? // La casa e le vie intorno risuonavano del tuo interrotto canto, quando occupata in lavori femminili sedevi abbastanza contenta di quell’incerto futuro che sognavi. Era il mese del profumato Maggio e tu trascorrevi così le tue giornate. // Io, a volte interrompendo i graditi studi e le fatiche letterarie tra le quali trascorrevo la mia giovinezza e la parte migliore di me, dai balconi della casa paterna ascoltavo il suono della tua voce ed il telaio che velocemente facevi scorrere con la mano. Contemplavo il cielo sereno, le strade illuminate dal sole, i giardini e da una parte il mare in lontananza e dall’altra i monti. Nessuno può dire ciò che provavo dentro di me. // Che dolci pensieri, che speranze, o Silvia mia! Come ci sembrava allora la vita umana e il destino! Quado mi viene in mente quanto grandi fossero le nostre speranze mi sento opprimere da un senso di angoscia crudele e inconsolabile e ricomincio a sentire tutto il dolore per la mia vita sventurata. O natura, natura, perché non mantieni le promesse che fai in gioventù? Perché così tanto inganni i tuoi figli? // Tu prima che l’inverno facesse seccare l’erba, morivi, dopo essere stata combattuta e vinta da un male incurabile, o tenera ragazza. E non vedevi la giovinezza, non ti rallegrava il cuore ascoltare le dolci lodi rivolte ora alla tua bellezza dei tuoi neri capelli, ora ai tuoi occhi innamorati e sfuggenti, né con te le compagne, nei giorni di festa, parlavano d’amore. // Poco dopo venivano meno anche i miei dolci sogni; il destino ha negato anche a me la giovinezza. Ahi come sei irrevocabilmente svanita, cara compagna della mia giovinezza, mia compianta speranza. Questo è quel mondo tanto desiderato? Questi i piaceri, l’amore, il lavoro gli accadimenti di cui parlammo tanto insieme? Questa è la sorte degli uomini? Appena la vita è apparsa per quello che è veramente tu infelice cadesti: e con la mano mostravi di lontano la fredda morte e la tomba disadorna.
Questa canzone è considerata, al pari dell’Infinito, come uno dei punti più alti della poesia leopardiana. Essa è composta da sei strofe di lunghezza ineguale in versi endecasillabi e settenari liberamente rimati.
Non vi è in essa un racconto, ma le immagini di un ricordo (non è un caso che, nello stesso periodo egli componga Le Ricordanze) e, come ricordo, appare al poeta degno di essere cantato perché essendo esso indefinito e di contorni sfumati, non può che nascere dall’immaginazione della mente (che richiama in sé episodi), e pertanto risulta essere fortemente poetico.
Tale discorso ci è confermato proprio dalla figura di Silvia, appena tratteggiata (occhi scuri e fuggitivi, mani veloci che tessono). Ella è altrettanto vaga da essere richiamata dal senso uditivo più che visivo, ricreando quell’opposizione siepe/infinito, fruscio/silenzio e qui limite della finestra, sguardi fuggenti, lavoro e canto.
Il loro, come ci viene suggerito, è un non rapporto, è un non incontro tra una giovane popolana ed giovane intellettuale, ambedue fermi sul limitare della giovinezza. Ed è proprio in questo limitare che si ferma il pensiero leopardiano: Oh natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Domanda retorica, certamente, la cui risposta non può che essere quella già formulata nel Dialogo di un islandese e della natura: essa è indifferente al destino dell’uomo. Ma qui, come nel venditore d’almanacchi (non per niente più o meno della stessa fase) vi è in più condivisione di un identico destino, quella che latinamente potremo definire compassione, che non ha nulla di religioso, ma come soffro con te, quindi soffriamo insieme (cum patior) per un identico destino.
Tale compassione deriva dalla constatazione di una duplice morte; la prima fisica: l’orrenda tisi porta via una giovane donna, uccidendo in lei ogni illusione di vita futura, ma di pienezza di vita, dell’esplodere della giovinezza e della sessualità; la seconda è una morte intellettuale: accortosi dell’“aridità del vero” la vita perde senso, coincidendo, quindi, con la non vita.
Anche qui, sapientemente disseminati operano richiami filosofici e letterari: Virgilio e il canto di Circe Solis filia lucos / adsiduo resonat cantu … arguto tenues percurrens pectine telas (dove la figlia del Sole fa risuonare gli inaccessibili boschi del suo continuo canto …, percorrendo le tele sottili col pettine sonoro); concetto di morte come nulla, di matrice stoica.
La gioia ritrovata nel mite ambiente pisano non può durare a lungo. Le gravi difficoltà economiche, determinate dall’interrompersi del rapporto con l’editore Stella che gli aveva proposto un commento dei classici, il peggiorare delle sue condizioni fisiche, che non gli consentono né di leggere, né di scrivere (ha bisogno di qualcuno che lo faccia per lui) lo riportano nel natìo borgo selvaggio.
Ma questo non gli uccide la vena poetica, anzi sembra prosegua grazie al ricordo e all’affetto ritrovato (soprattutto per la sorella Paolina).
Tuttavia le sue condizioni peggiorano; ad esse si aggiunge la notizia della morte del fratello Luigi, morto per tisi a soli 24 anni. Prostrato da una parte dal dolore, dall’altra da difficoltà fisiche ed economiche, si sposta per l’estate a Firenze, ma le sue condizioni peggiorano. Quindi ad autunno inoltrato torna a Recanati, in compagnia di Vincenzo Gioberti, giovane prete conosciuto a Firenze. In casa le condizioni non sono delle migliori: gli viene anche a mancare il diletto fratello Carlo, che è scappato per sposarsi contro la volontà dei genitori. Cade in una incredibile malinconia, che lo estraniano ancora di più, anche dalle figure familiari. Ma, nonostante tale “infelicità”, non si attenua la vena poetica, che gli permette di riprendere a scrivere delle pagine poetiche di altissima intensità. La prima di esse è Le ricordanze, composta in Recanati nel ’29:

Recanati al tramonto
LE RICORDANZE
Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea
tornare ancor per uso a contemplarvi
sul paterno giardino scintillanti,
e ragionar con voi dalle finestre
di questo albergo ove abitai fanciullo,
e delle gioie mie vidi la fine.
Quante immagini un tempo, e quante fole
creommi nel pensier l’aspetto vostro
e delle luci a voi compagne! Allora
che, tacito, seduto in verde zolla,
delle sere io solea passar gran parte
mirando il cielo, ed ascoltando il canto
della rana rimota alla campagna!
E la lucciola errava appo le siepi
e in su l’aiuole, susurrando al vento
i viali odorati, ed i cipressi
là nella selva; e sotto al patrio tetto
sonavan voci alterne, e le tranquille
opre de’ servi. E che pensieri immensi,
che dolci sogni mi spirò la vista
di quel lontano mar, quei monti azzurri,
che di qua scopro, e che varcare un giorno
io mi pensava, arcani mondi, arcana
felicità fingendo al viver mio!
Ignaro del mio fato, e quante volte
questa mia vita dolorosa e nuda
volentier con la morte avrei cangiato.
Nè mi diceva il cor che l’età verde
sarei dannato a consumare in questo
natio borgo selvaggio, intra una gente
zotica, vil; cui nomi strani, e spesso
argomento di riso e di trastullo,
son dottrina e saper; che m’odia e fugge,
per invidia non già, che non mi tiene
maggior di se, ma perchè tale estima
ch’io mi tenga in cor mio, sebben di fuori
a persona giammai non ne fo segno.
Qui passo gli anni, abbandonato, occulto,
senz’amor, senza vita; ed aspro a forza
tra lo stuol de’ malevoli divengo:
qui di pietà mi spoglio e di virtudi,
e sprezzator degli uomini mi rendo,
per la greggia ch’ho appresso: e intanto vola
il caro tempo giovanil; più caro
che la fama e l’allor, più che la pura
luce del giorno, e lo spirar: ti perdo
senza un diletto, inutilmente, in questo
soggiorno disumano, intra gli affanni,
o dell’arida vita unico fiore.
Viene il vento recando il suon dell’ora
dalla torre del borgo. Era conforto
questo suon, mi rimembra, alle mie notti,
quando fanciullo, nella buia stanza,
per assidui terrori io vigilava,
sospirando il mattin. Qui non è cosa
ch’io vegga o senta, onde un’immagin dentro
non torni, e un dolce rimembrar non sorga.
Dolce per se; ma con dolor sottentra
il pensier del presente, un van desio
del passato, ancor tristo, e il dire: io fui.
Quella loggia colà, volta agli estremi
raggi del dì; queste dipinte mura,
quei figurati armenti, e il Sol che nasce
su romita campagna, agli ozi miei
porser mille diletti allor che al fianco
m’era, parlando, il mio possente errore
sempre, ov’io fossi. In queste sale antiche,
al chiaror delle nevi, intorno a queste
ampie finestre sibilando il vento,
rimbombaro i sollazzi e le festose
mie voci al tempo che l’acerbo, indegno
mistero delle cose a noi si mostra
pien di dolcezza; indelibata, intera
il garzoncel, come inesperto amante,
la sua vita ingannevole vagheggia,
e celeste beltà fingendo ammira.
O speranze, speranze; ameni inganni
della mia prima età! sempre, parlando,
ritorno a voi; che per andar di tempo,
per variar d’affetti e di pensieri,
obbliarvi non so. Fantasmi, intendo,
son la gloria e l’onor; diletti e beni
mero desio; non ha la vita un frutto,
inutile miseria. E sebben vóti
son gli anni miei, sebben deserto, oscuro
il mio stato mortal, poco mi toglie
la fortuna, ben veggo. Ahi, ma qualvolta
a voi ripenso, o mie speranze antiche,
ed a quel caro immaginar mio primo;
indi riguardo il viver mio sì vile
e sì dolente, e che la morte è quello
che di cotanta speme oggi m’avanza;
sento serrarmi il cor, sento ch’al tutto
consolarmi non so del mio destino.
E quando pur questa invocata morte
sarammi allato, e sarà giunto il fine
della sventura mia; quando la terra
mi fia straniera valle, e dal mio sguardo
fuggirà l’avvenir; di voi per certo
risovverrammi; e quell’imago ancora
sospirar mi farà, farammi acerbo
l’esser vissuto indarno, e la dolcezza
del dì fatal tempererà d’affanno.
E già nel primo giovanil tumulto
di contenti, d’angosce e di desio,
morte chiamai più volte, e lungamente
mi sedetti colà su la fontana
pensoso di cessar dentro quell’acque
la speme e il dolor mio. Poscia, per cieco
malor, condotto della vita in forse,
piansi la bella giovanezza, e il fiore
de’ miei poveri dì, che sì per tempo
cadeva: e spesso all’ore tarde, assiso
sul conscio letto, dolorosamente
alla fioca lucerna poetando,
lamentai co’ silenzi e con la notte
il fuggitivo spirto, ed a me stesso
in sul languir cantai funereo canto.
Chi rimembrar vi può senza sospiri,
o primo entrar di giovinezza, o giorni
vezzosi, inenarrabili, allor quando
al rapito mortal primieramente
sorridon le donzelle; a gara intorno
ogni cosa sorride; invidia tace,
non desta ancora ovver benigna; e quasi
(inusitata maraviglia!) il mondo
la destra soccorrevole gli porge,
scusa gli errori suoi, festeggia il novo
suo venir nella vita, ed inchinando
mostra che per signor l’accolga e chiami?
Fugaci giorni! a somigliar d’un lampo
son dileguati. E qual mortale ignaro
di sventura esser può, se a lui già scorsa
quella vaga stagion, se il suo buon tempo,
se giovanezza, ahi giovanezza, è spenta?
O Nerina! e di te forse non odo
questi luoghi parlar? caduta forse
dal mio pensier sei tu? Dove sei gita,
che qui sola di te la ricordanza
trovo, dolcezza mia? Più non ti vede
questa Terra natal: quella finestra,
ond’eri usata favellarmi, ed onde
mesto riluce delle stelle il raggio,
è deserta. Ove sei, che più non odo
la tua voce sonar, siccome un giorno,
quando soleva ogni lontano accento
del labbro tuo, ch’a me giungesse, il volto
scolorarmi? Altro tempo. I giorni tuoi
furo, mio dolce amor. Passasti. Ad altri
il passar per la terra oggi è sortito,
e l’abitar questi odorati colli.
Ma rapida passasti; e come un sogno
fu la tua vita. Ivi danzando; in fronte
la gioia ti splendea, splendea negli occhi
quel confidente immaginar, quel lume
di gioventù, quando spegneali il fato,
e giacevi. Ahi Nerina! In cor mi regna
l’antico amor. Se a feste anco talvolta,
se a radunanze io movo, infra me stesso
dico: o Nerina, a radunanze, a feste
tu non ti acconci più, tu più non movi.
Se torna maggio, e ramoscelli e suoni
van gli amanti recando alle fanciulle,
dico: Nerina mia, per te non torna
primavera giammai, non torna amore.
Ogni giorno sereno, ogni fiorita
piaggia ch’io miro, ogni goder ch’io sento,
dico: Nerina or più non gode; i campi,
l’aria non mira. Ahi tu passasti, eterno
sospiro mio: passasti: e fia compagna
d’ogni mio vago immaginar, di tutti
i miei teneri sensi, i tristi e cari
moti del cor, la rimembranza acerba.
Le Ricordanze: pagina autografa
Belle stelle dell’Orsa, non avrei mai creduto di tornare a contemplarvi ancora dopo così tanto tempo come facevo una volta mentre brillate nel giardino della casa di mio padre e parlare con voi dalle finestre della casa che fu mia quando ero un adolescente e dove conobbi la fine delle gioie della mia vita. Quante immagini e quante fantasie un tempo mi creavo nei pensieri vedendo voi e le altre stelle vicine nel cielo! Quando seduto sul prato, silenzioso, trascorrevo le mie serata scrutando il cielo e ascoltando il canto della rana lontana nei campi. E la lucciola volava sulle siepi e sulle aiuole mentre i viali profumati e i cipressi lontani nella selva sussurravano al vento; e nella casa paterna risuonavano le voci e il lavoro dei servi. E quali pensieri immensi e dolci sogni mi ispirò guardare il mare lontano, e i monti azzurri che scopro dalla casa e che un giorno sognavo di varcare, credendo di trovare al di là dei mondi misteriosi e immaginando per la mia vita una felicità sconosciuta. Ignaro del mio destino e di quante volte in seguito avrei scambiato questa vita con la morte senza alcun rimpianto dolorosa e priva di gioie. // Nemmeno il cuore mi ha fatto cenno del fatto che sarei stato condannato a consumare la mia giovinezza in questo verde borgo selvaggio in cui sono nato, fra gente ignobile e incivile; per questa gente, la cui voglia di conoscere e di cultura sono parole strane e spesso oggetto di scherno; questa gente che mi odia e mi sfugge non per invidia, poiché non mi ritiene migliore di sé, ma perché pensa che migliore mi ritenga io rispetto a loro, sebbene io non abbia mai dato segno di ciò. Qui passo i miei anni, nascosto e abbandonato, senza vita e senza amore, e tra le persone malevoli divento come non sono mai stato, aspro e scortese: qui mi spoglio di pietà e virtù e disprezzo le persone meschine tra cui vivo; e intanto se ne va il tempo caro della gioventù, più caro della gloria e della fama, più caro della luce pura del giorno e dello stesso vivere: ti perdo senza aver avuto un attimo di gioia, inutilmente, in questo inumano soggiorno, con solo gli affanni come unico fiore nella vita arida. // Viene il vento facendo suonare le campane della torre del borgo. E ricordo che questo suono era per me un conforto quando ero un ragazzino e durante le notti passate nella camera buia vegliavo a causa di incubi e inquietudini incessanti, sospirando perché arrivassero presto il mattino e la luce del giorno. Non c’è nulla qui che, vedendolo o sentendolo, non faccia riaffiorare alla mia memoria un’immagine dalla quale prende vita un ricordare dolce. Dolce di per sé; però poi con dolore arriva il pensiero del presente e un desiderio vano del passato che mi porta a dire: ho esaurito la mia esistenza. Quella loggia volta ad ovest queste pareti affrescate e i dipinti che raffigurano greggi, e il sole che sorge sulla campagna solitaria mi procurano mille diletti nei momenti di riposo dagli studi quando, dovunque mi trovassi, si trovava vicino a me quella mia capacità di credere nei sogni. In quelle antiche sale, al riflesso della neve, mentre il vento sibilava forte tutt’attorno a queste ampie finestre, risuonarono i giochi e le mie grida felici nel tempo in cui si mostra il duro pieno di dolcezza, l’indegno mistero della vita e della realtà non ancora sperimentata e intatta; e chi è il ragazzo che ancora sogna, come un innamorato inesperto una vita che sarà piena di inganni e che ammira una bellezza celeste vista con gli occhi dell’immaginazione. // O speranze, speranze, dolci inganni della mia adolescenza! Sempre, parlando, io torno a voi; poiché non so dimenticarvi per quanto trascorra il tempo, per quanto anche gli affetti e i pensieri cambino. Fantasmi, io lo so, sono gloria e onore, il bene e i diletti solo un puro desiderio. E sebbene i miei anni siano vuoti, sebbene oscura e solitaria sia la mia vita mortale, so bene che la fortuna ha ben poco da prendersi da me. Ma, ahimè, ogni volta che vi ripenso, o mie speranze antiche, e che penso al mio fantasticare sul futuro e lo confronto con questa mia vita così inutile e priva di scopo e così dolorosa, che solo la morte mi resta dopo aver sognato grandi speranze sento stringermi il cuore e sento che non mi riesco a rassegnare del tutto al mio destino. E anche quando questa morte che invoco mi raggiungerà e sarà arrivata la fine delle mie sventure; quando per me la terra sarà una valle straniera e dal mio sguardo il futuro fuggirà; mi ricorderò sicuramente di voi, mie speranze, quell’immagine mi farà ancora sospirare, e renderà amaro il mio aver vissuto invano; e l’amarezza del ricordo andrà a guastare perfino il giorno in cui avrò la gioia di cessare di vivere. // E già in adolescenza, in quel primo tumulto di felicità di angosce di desideri, più volte ho invocato la morte e a lungo stetti seduto là, su quella fontana pensando di fermare dentro di me l’acqua di quelle speranze, il dolore di questa mia vita. Poi, ridotto in pericolo di vita da una malattia, rimpiansi la mia bella giovinezza il fiore dei miei giorni così poveri di gioie che così precocemente appassiva; e spesso, la sera tardi, seduto sul letto che, testimone delle mie sofferenze, scrivendo dolorosamente poesie alla luce fioca, piansi col silenzio e la notte come unici compagni, l’energia della vita che mi abbandonava. E proprio nel momento in cui la vita mancava, cantai un canto funebre. // Chi può mai ricordarvi senza sospiri, o primi momenti della mia giovinezza, giorni pieni di lusinghe indescrivibili, e allorquando al giovane estasiato sorridono le fanciulle; tutto intorno ogni cosa sorride a gara, l’invidia tace e non eccita ancora oppure è innocua; e quasi il mondo porge la mano destra in aiuto, come volesse scusarsi dei suoi errori, festeggiando il nuovo entrare della vita e facendogli omaggio mostra di accettarlo come suo signore e lo chiami? Ma quei giorni sono fugaci e si sono dileguati come un lampo. E quale uomo può dire di non aver conosciuto sventura se ormai è trascorsa la bellezza di quell’età se il suo bel tempo, la sua giovinezza, ahi la giovinezza è oramai finita e spenta? // O, Nerina! E non sento forse questi luoghi che parlano di te? Sei forse caduta dal mio pensiero? Dove sei fuggita, che qui di te trovo solo le ricordanze, o dolcezza mia? Questa terra mia natale oramai non ti vede più: quella finestra, dalla quale avevi l’abitudine di parlarmi, e dove si riflette mesta la luce delle stelle, è ora deserta. Dove sei, ora che non sento la tua voce che risuona, quando ogni parola che mi arrivava dalle tue labbra da lontano mi faceva impallidire? Altro tempo. Furono i tuoi giorni, amore mio dolce. Passasti. Il passaggio su questo mondo ad altri ora è dato in sorte, l’abitare questi odorati colli. Ma troppo rapida sei passata e la tua vita è stata breve quasi come un sogno. Danzavi, tu, nel cammino della vita. La gioia risplendeva intorno a te, e quel fiducioso immaginare intorno all’avvenire e la luce della giovinezza splendevano nei tuoi occhi, quando il destino li ha poi spenti facendoti morire. Ahi Nerina. Nel mio cuore ancora regno l’amore antico. Quando, a volte, vado a feste o a raduni dico tra me e me: o Nerina, a feste e raduni tu non vai più, e più non ti prepari. Se maggio torna, e gli amanti vanno donando canti e ramoscelli alle fanciulle, dico: per te, Nerina mia, la primavera non tornerà mai più, né tornerà l’amore. Ogni bella giornata, ogni valle in fiore che io guardo, ogni piacere che io sento, mi dico: Nerina ora non ne gode più; i campi e l’aria lei non guarda più. Ahi, tu sei passata, eterno sospiro mio: passasti e il tuo ricordo acerbo sarà mio compagno in ogni dolce immaginare, di tutti i miei teneri sentimenti, di tutti i miei cari e tristi moti del cuore.

Parco letterario a Recanati
La poesia che sboccia a Pisa, continua a modulare la sua voce nel “natio borgo selvaggio”, come definisce Recanati nel terzo verso della seconda strofa. E’ tra le mura di una casa e di un paese ostile, più forte si fa sentire il sentimento del ricordo, di come quei luoghi li ha vissuti e come ora gli si presentano. E lo fa in un testo che viene definito “della rimembranza”, concetto già definito da lui intrinsecamente poetico.
Il testo è composto da sette strofe di endecasillabi e settenari variamente rimati.
- L’incipit con l’evocazione alle stelle rimanda alla poesia del “vago” e dell'”indefinito”, già presente nei piccoli idilli e in A Silvia. A questi viene aggiunto il concetto della “rimembranza” di quegli stessi luoghi vissuti nella fanciullezza, dove il poeta ora è tornato “a contemplarvi sul paterno giardino”. In questa strofa l’uso verbale tra imperfetto e passato remoto sottolinea questo rapporto tra passato vissuto ed immaginato e il presente, ma viene anche ripetuta l’opposizione tra dentro e fuori, interno esterno, realtà immaginazione già vista sin dall’Infinito: il poeta all’interno della casa osserva il cielo dalle finestre per ragionar con le stelle dell’Orsa. A tutto questo si contrappone la consapevolezza filosofica del vero: da una felicità solo pensata e fantasticata emerge la realtà che era solamente finzione per questa vita dolorosa e nuda che avrebbe cambiato volentieri con la morte;
- Contrasto fra poeta e il paese reale, pieno di gente “zotica, vil”. Ora, qui (avverbio posto ad inizio verso, a rimarcare il luogo in cui si sente incarcerato), in questo luogo “abbandonato e occulto” (segregato in casa e isolato) il poeta non può che esacerbare il suo astio, diventando “sprezzator degli uomini”. Ed è proprio qui che ha perduto la sua giovinezza, unico fiore di una vita arida.
- Torna il ricordo, dal suonare dell’orologio della torre agli armenti dipinti sulle pareti. L’acerbità del presente e dei luoghi in cui vive, può solo essere attenuata dai ricordi che questi stessi luoghi possono suscitare; ed ecco riaffiorare nella mente del poeta la neve che appare dalle chiuse finestre o il sibilare del vento tra le mura, visioni e rumori accompagnati dalle grida festose di loro bambini (è evidente il riferimento ai giochi infantili tra Giacomo, Carlo e Paolina). La dolcezza infinità di un mondo in cui è possibile fingere una vita “pien di dolcezza” per il “mistero delle cose”.
- Almeno la giovinezza si alimenta di speranze, che soltanto la maturità può definirle “ameni (dolci) inganni”. Il rapporto tra il passato e presente qui si fa più intenso e la felicità del ricordo di ciò che è stato non placa il desiderio di una morte che annulli ogni dolore. Anche in quel momento in cui viene spento ogni futuro, nell’attimo stesso dell’abbandono della vita, il poeta sarà travolto dal pensiero della disillusione per l’uomo, dall’infelicità della condizione umana.
- La strofa si più cupa, ma sempre letterariamente controllata (si noti il richiamo petrarchesco dal sonetto proemiale – in sul mio primo giovanil errore: nel primo giovanil tumulto). In essa il poeta ricorda che già allora riemergeva l’idea del suicidio.
- Qui, in questa stanza, le immagini si fanno più chiare, leggere: l’idea di una giovinezza accompagnata dal sorriso di fanciulle, da una vita solare che perdona gli errori giovanili, dal nascere. Ma queste immagini non possono che portare alla consapevolezza dell’infelicità della vita, in quanto, diventati adulti, tali illusioni non sono che vaghi sogni.
- Nell’ultima strofa appare Nerina, compagna ideale di Silvia, per alcuni critici, la stessa persona. Qui tuttavia, al contrario della poesia scritta a Pisa, Nerina è cantata in assenza. Il paese vive la sua assenza, non la vede alla finestra, non la sente cantare: lei è la vita che si spegne di cui è rimasto solo il ricordo.
IL SABATO DEL VILLAGGIO
La donzelletta vien dalla campagna
in sul calar del sole,
col suo fascio dell’erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e viole,
onde, siccome suole, ornare ella si appresta
dimani, al dí di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dí della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch’ebbe compagni nell’età piú bella.
Già tutta l’aria imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
giú da’ colli e da’ tetti,
al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto romore;
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dí del suo riposo.
Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi al chiarir dell’alba.
Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno.
Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita
è come un giorno d’allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa
ch’anco tardi a venir non ti sia grave.
La fanciulla ritorna dalla campagna al tramonto del giorno, portando un fascio d’erba (per gli animali) e tiene in mano un mazzolino di rose e di viole, delle quali, come è solita,. Si prepara ad ornare l’indomani, giorno di festa, il petto ed i capelli. Intanto sulle scale siede a filare con le vicine una vecchietta, rivolta là dove tramonta il sole, e racconta la sua giovinezza, quando anch’ella si prepara la domenica e ancora giovane e bella era solita andare a ballare con coloro che erano giovani come lei. Ormai inizia a scurire, il cielo torna azzurro e al biancheggiare della luna appena sorta ritornano le ombre giù dai colli e dalle case. Ora la campana dà il segno della festa che sta arrivando; e a quel suono si direbbe che il cuore si consola. I ragazzini, cantando in gruppo sulla piazzola, e saltando di qua e di là fanno un rumore allegro, e intanto il contadino torna alla sua povera casa, fischiettando e tra sé e sé pensa al giorno del riposo. // Poi quando intorno tutti i lumi sono spenti e tutto è silenzio, senti il martello picchiare, senti la sega del falegname che, sveglio nella sua bottega chiusa, alla luce di una lucerna si affretta a finire un lavoro prima della luce dell’alba. // Questo è il giorno più gradito della settimana, pieno di speranza e di gioia: domani le ore porteranno tristezza e noia, e ognuno tornerà al pensiero delle fatiche di tutti i giorni. // Ragazzino scanzonato, questa giovinezza è come un giorno luminoso sereno, che precede la maturità. Godi, ragazzo, della giovinezza; questa è una condizione beata, un’età gioiosa. Non ti pesi che la maturità tardi ancora a venire.
La canzone, composta da 4 strofe di endecasillabi e settenari, variamente rimati, fu composta nel ’29. Il tema centrale in essa è il piacere, riprendendolo da ciò che aveva elaborato in gioventù. Infatti nel ’21 Leopardi, nello Zibaldone, scriveva: Il piacere umano (…) sui può dire ch’è sempre futuro, non è se non futuro, consiste solamente nel futuro. L’atto proprio del piacere non si dà. Io spero un piacere; e questa speranza in moltissimi casi si chiama piacere. Tale concetto viene qui vivificato in un quadretto recanatese, il giorno di sabato, in cui, appunto, nell’attesa della domenica, si vive nell’aspettativa del riposo; ma la domenica si riempie a sua volta dalla preoccupazione del lavoro del lunedì. Tale concetto si riaffaccia con plasticità nella figura della donzelletta e della vecchierella: esse diventano a loro volta simbolo dell’attesa del futuro e del ricordo, due attimi che negano il presente, per cui la felicità non si dà. L’immagine finale vuole infatti sottolineare il concetto di giovinezza come momento d’aspettativa di maturità, dell’illusione di felicità: ma non può nascondere, verso i giovani vocianti nella piazza quel sentimenti di compassione che umanizza la tragicità della condizione umana.
La condizione tragica della vita di un uomo riappare in uno dei canti più alti di Leopardi: anche qui, come l’Islandese, un isolato dal mondo:

Antonio Berté: Quadro ispirato dalla canzone leopardiana
CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
la vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
move la greggia oltre pel campo, e vede
greggi, fontane ed erbe;
poi stanco si riposa in su la sera:
altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
al pastor la sua vita,
la vostra vita a voi? dimmi: ove tende
questo vagar mio breve,
il tuo corso immortale?
Vecchierel bianco, infermo,
mezzo vestito e scalzo,
con gravissimo fascio in su le spalle,
per montagna e per valle,
per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
al vento, alla tempesta, e quando avvampa
l’ora, e quando poi gela,
corre via, corre, anela,
varca torrenti e stagni,
cade, risorge, e piú e piú s’affretta,
senza posa o ristoro,
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
colá dove la via
e dove il tanto affaticar fu vòlto:
abisso orrido, immenso,
ov’ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
è la vita mortale.
Nasce l’uomo a fatica,
ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
per prima cosa; e in sul principio stesso
la madre e il genitore
il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre
con atti e con parole
studiasi fargli core,
e consolarlo dell’umano stato:
altro ufficio piú grato
non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
perché reggere in vita
chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
è lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
e forse del mio dir poco ti cale.
Pur tu, solinga, eterna peregrina,
che sí pensosa sei, tu forse intendi
questo viver terreno,
il patir nostro, il sospirar, che sia;
che sia questo morir, questo supremo
scolorar del sembiante,
e perir della terra, e venir meno
ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
il perché delle cose, e vedi il frutto
del mattin, della sera,
del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
rida la primavera,
a chi giovi l’ardore, e che procacci
il verno co’ suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
che son celate al semplice pastore.
Spesso quand’io ti miro
star cosí muta in sul deserto piano,
che, in suo giro lontano, al ciel confina;
ovver con la mia greggia
seguirmi viaggiando a mano a mano;
e quando miro in cielo arder le stelle;
dico fra me pensando:
A che tante facelle?
che fa l’aria infinita, e quel profondo
infinito seren? che vuol dir questa
solitudine immensa? ed io che sono?
Cosí meco ragiono: e della stanza
smisurata e superba,
e dell’innumerabile famiglia;
poi di tanto adoprar, di tanti moti
d’ogni celeste, ogni terrena cosa,
girando senza posa,
per tornar sempre lá donde son mosse;
uso alcuno, alcun frutto
indovinar non so. Ma tu per certo,
giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
che degli eterni giri,
che dell’esser mio frale,
qualche bene o contento
avrá fors’altri; a me la vita è male.
O greggia mia che posi, oh te beata,
che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
quasi libera vai;
ch’ogni stento, ogni danno,
ogni estremo timor subito scordi;
ma piú perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
tu se’ queta e contenta;
e gran parte dell’anno
senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,
e un fastidio m’ingombra
la mente; ed uno spron quasi mi punge
sí che, sedendo, piú che mai son lunge
da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
e non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
non so giá dir; ma fortunata sei.
Ed io godo ancor poco,
o greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
Dimmi: perché giacendo
a bell’agio, ozioso,
s’appaga ogni animale;
me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?
Forse s’avess’io l’ale
da volar su le nubi,
e noverar le stelle ad una ad una,
o come il tuono errar di giogo in giogo,
piú felice sarei, dolce mia greggia,
piú felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
forse in qual forma, in quale
stato che sia, dentro covile o cuna,
è funesto a chi nasce il dí natale.
Che fai nel cielo, luna? Dimmi che fai silenziosa luna? Sorgi di sera e vai sopra i deserti, poi tramonti. Non sei ancora stanca di far lo stesso tragitto in eterno? Ancora non sei stufa, ancora sei desiderosa di contemplare queste valli? La tua vita somiglia a quella di un pastore: si sveglia all’alba, porta il gregge sempre avanti nei campi e vede pecore, sorgenti e prati; poi, stanco, si riposa la sera e non spera nient’altro. Dimmi, luna, quale vantaggio trae il pastore da questa vita e a voi, corpi celesti, la vostra vita? Dimmi, qual è il fine di questa mia breve vita e della tua, invece, eterna? // Un vecchio dai capelli bianchi, infermo, mal vestito e scalzo, porta sulle spalle un carico pesantissimo lungo un percorso di sassi aguzzi, sabie dove si sprofonda, macchie piene di spine, al vento, nella tempesta, nel caldo afoso, nel gelo e corre desideroso, supera torrenti e stagni, cade, si rialza e si affretta sempre più, senza quiete né ristoro, lacero e insanguinato, finché non arriva là dove questo faticoso tragitto lo conduce: un abisso orrendo, immenso, dove egli, precipitando, dimentica tutto. Vergine luna, questa e la tua vita mortale. // L’uomo nasce nel dolore del parto, e la nascita è un momento in cui rischiamo la vita. Dolore e tormento sono per il nato le prime sensazioni e nel momento stesso in cui nasce, il padre e la madre cominciano a consolarlo per il fatto di essere nato; poi, man mano che cresce, padre e madre gli danno aiuto e in continuazione con gesti e parole si preoccupano di fargli coraggio e di consolarlo della situazione che vive da essere umano: non c’è nessun altro compito più prezioso che svolgano i genitori per il proprio figlio. Ma per quale motivo si dà vita, perché si continua a sostenere qualcuno se poi bisogna consolarlo di questa stessa vita? Se la vita è una sventura, perché mai dovremmo continuare a sopportarla e a vivere? Intatta luna, questo è lo stato dell’essere umano. Ma tu non sei mortale, e forse non t’importa nulla di quello che ti dico. // Eppure, tu che te ne stai sola e viaggi in eterno, e sei così pensierosa, tu forse capisci che cosa sono questo nostro vivere terreno, le nostre sofferenze, i nostri sospiri; questo morire, questo pallore del viso nel momento in cui moriamo e spariamo dalla terra, mancando alla consueta, compagnia di uomini che ci hanno voluto bene. E tu forse comprendi il senso profondo di queste cose, del ciclo del tempo e delle leggi dell’universo. Tu sai certamente per amore di che cosa giunga la primavera, sorridente, a chi sia di vantaggio l’estate e a chi l’inverno con il suo gelo. Conosci mille cose e mille ne scopri, mentre queste sono nascoste al semplice pastore. Spesso quando ti contemplo, mentre tu sei muta su questa pianura deserta, che è tanto estesa che all’orizzonte confina con il cielo; o quando ti vedo che mi segui mentre conduco il gregge; e quando vedo in cielo brillare le stelle, dico pensando fra me e me: qual è il senso di tutte queste luci? Che scopo ha l’aria infinita, e quel profondo infinito sereno? E che cosa significa questa immensa solitudine? E io chi sono? Così penso fra me e me: e così allo stesso modo non so indovinare quale utilità e valore vi sia della immensa stanza [dell’universo] e dello sterminato numero di esseri viventi; e poi nemmeno di questo darsi da fare, di questi movimenti di ogni cosa celeste e terrestre, che girano senza posa per tornare sempre là da dove sono partite. Ma tu, giovane immortale, sicuramente conosci il tutto. Io conosco e sento questo, che dei giri eterni [dei corpi celesti], che della mia fragilità, qualche bene o soddisfazione l’avrà forse qualche altro; per me la vita è sofferenza. // O gregge mio che ti riposi, oh te beata, che forse non conosci la tua miseria! Quanto ti invidio! Non solo perché vivi quasi libero da ogni sofferenza; perché ogni fatica, ogni dolore, ogni paura anche mortale dimentichi subito; ma soprattutto perché non conosci la noia. Quando tu giaci all’ombra [degli alberi], sull’erba, tu sei sereno e contento; e la maggior parte dell’anno conduci senza noia in quello stato. Anch’io siedo sopra l’erba, all’ombra [degli alberi] eppure una pena mi occupa la mente, e quasi mi dà fastidio come fosse un assillo, a tal punto che pur seduto sono più lontano che mai dal trovar pace o dal trovar un luogo tranquillo. Eppure non desidero nulla, e non ho finora nessuna ragione di dolore. Non so dire la qualità e la quantità del tuo godimento; ma sei fortunata. E anch’io come te godo poco, o mio gregge, ma non mi lamento solo di questo. Se tu sapessi parlare ti chiederei: dimmi, perché ogni animale è appagato quando giace in piena comodità e nell’ozio; mentre se io mi riposo il tedio mi assale? // Forse se avessi le ali e potessi volare tra le nuvole come un uccello, e potessi contare le stelle ad una ad una, o se fossi come il tuono che può passare da cima a cima, sarei più felice, mio dolce gregge, sarei più felice, mia candida luna. O forse il mio pensiero, osservando il destino degli altri esseri viventi, si allontana dalla verità: forse il giorno della nascita è dannoso a chi viene alla vita in qualsiasi forma e in qualsiasi stato esso sia, dentro una tana o dentro una culla.
E’ questa l’ultima canzone del periodo pisano-recanatese, terminata nel ’30. La suggestione per il tema gliel’aveva data un articolo sul Journal des savants (Giornale dei sapienti) del ’26 in cui si recensiva un libro di viaggi. L’autore descriveva la vita dei pastori kirghisi e riportava il fatto che essi, durante il lavoro della pastorizia, seduti soli in terra, cantassero canzoni tristi e malinconiche. Leopardi prende le mosse da tale suggestione e immagina un dialogo con la luna (ormai divenuto topico del suo linguaggio poetico), in cui ripropone il suo interrogativo sul destino della vita dell’uomo.
Tale canto è stato, strofe per strofe, ben riassunto dal critico letterario Contini:
- Domande alla luna (…) circa il significato della sua vita, ciclica come la vita vana del pastore;
- Metafora negativa, esalata senza pause, sulla vita dell’uomo;
- Tristezza della nascita per l’uomo;
- Domande alla luna circa il senso della vita, che per il pastore è male;
- Invidia il gregge, sprovvisto del taedium vitae;
- Sospetto che il volo darebbe la felicità al pastore; ma il sospetto che il male di vivere sia universale.
In questo canto il poeta sembra riprenda elementi tipici della sua produzione precedente: si pensi a come il pastore/Leopardi si trovi qui avvolto in un infinito spaziale estremamente indefinito e vago. Se questo, tuttavia, può creare ancora una volta la parola poetica, non può più illuderlo sulla possibile felicità. A testimoniarlo è un altro richiamo identificativo natura/luna, che nel suo silenzio può forse solo sottolineare l’indifferenza per la vita del pastore.
La dolcezza del dettato, ottenuta soprattutto attraverso la cantabilità del testo (si pensi alla terminazione in –ale di ogni strofa) non nasconde l’allargamento di riflessione leopardiana che descrive il corso della vita umana dalla nascita alla morte, corso nel quale, come già detto altrove, non vi è felicità. Ma qui sembra maggiormente sottolinearlo perché nega a se stesso e quindi anche all’uomo la ricordanza e quindi la compassione verso i suoi simili ed inoltre abbraccia la totalità del creato, in un senza senso senza Dio, che apre a nuove prospettive poetiche che prenderanno forma in un diverso e strabiliante poetare.
Periodo fiorentino 1830 – 1833
Grazie all’interessamento di Pietro Colletta (intellettuale napoletano, in quel periodo, per motivi politici a Firenze, dove collabora all’Antologia) Leopardi lascia definitivamente Recanati e si sposta nella città toscana dove, per la prima volta, si può dire, conducesse un intenso e felice rapporto con la vita. A tale cambiamento corrisposero due fattori fondamentali: l’amicizia con Antonio Ranieri (giovane ed esuberante intellettuale napoletano che seppe donargli un affetto fraterno e un appoggio pratico nei momenti di difficoltà) e l’amore per Fanny Fargioni Tozzetti, signora fiorentina usa a frequentare salotti letterari.

Fanny Targioni Tozzetti
In questo clima Leopardi s’inserisce in un dibattito culturale più ampio: pensa di pubblicare, insieme all’amico napoletano con l’intervento del finanziatore Freppa una rivista Lo spettatore fiorentino (che non vedrà mai la luce, per l’intervento della censura), pubblica l’edizione dei Canti, contenenti le liriche scritte fine al ’31. Aggiunge con Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere e con il Dialogo di Tristano ed un amico altre due prose alle Operette morali.
DIALOGO DI UN VENDITORE D’ALMANACCHI E DI UN PASSEGGERE
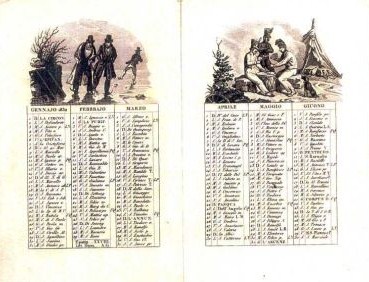
Almanacco del 1832
VENDITORE: Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?
PASSEGGERE: Almanacchi per l’anno nuovo?
VENDITORE:Si signore.
PASSEGGERE: Credete che sarà felice quest’anno nuovo?
VENDITORE: Oh illustrissimo si, certo.
PASSEGGERE: Come quest’anno passato?
VENDITORE: Più più assai.
PASSEGGERE: Come quello di là?
VENDITORE: Più più, illustrissimo.
PASSEGGERE: Ma come qual altro? Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi?
VENDITORE: Signor no, non mi piacerebbe.
PASSEGGERE: Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
VENDITORE: Saranno vent’anni, illustrissimo.
PASSEGGERE: A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno venturo?
VENDITORE: Io? non saprei.
PASSEGGERE: Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?
VENDITORE: No in verità, illustrissimo.
PASSEGGERE: E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?
VENDITORE: Cotesto si sa.
PASSEGGERE: Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste?
VENDITORE: Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse.
PASSEGGERE: Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati?
VENDITORE: Cotesto non vorrei.
PASSEGGERE: Oh che altra vita vorreste rifare? La vita ch’ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro, risponderebbe come voi per l’appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?
VENDITORE: Lo credo cotesto.
PASSEGGERE: Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo?
VENDITORE: Signor no davvero, non tornerei.
PASSEGGERE: Oh che vita vorreste voi dunque?
VENDITORE: Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti.
PASSEGGERE: Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno nuovo?
VENDITORE: Appunto.
PASSEGGERE: Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest’anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male che gli e toccato, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?
VENDITORE: Speriamo.
PASSEGGERE: Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete.
VENDITORE: Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.
PASSEGGERE: Ecco trenta soldi.
VENDITORE: Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi.
Questa breve operetta ha un andamento circolare, per meglio dire inizia nello stesso modo con cui finisce, quasi a sottolineare la circolarità e non il “progresso” di cui si vanta il liberalismo cattolico. Di fronte alla materia, che, pur non prendendo di petto la natura in modo diretto, non ne rifiuta la sostanza (la vita è dolore) è tuttavia mostrata in un rapporto in cui i due interlocutori, in cui si potrebbe leggere da una parte Leopardi stesso, (il passeggere), dall’altra un persona umile, non sono differenti l’uni all’altro ma si corrispondono nella “verità” del loro destino.
DIALOGO DI TRISTANO E DI UN AMICO
AMICO: Ho letto il vostro libro. Malinconico al vostro solito.
TRISTANO: Sì, al mio solito.
AMICO: Malinconico, sconsolato, disperato: si vede che questa vita vi pare una gran brutta cosa.
TRISTANO: Che v’ho a dire? io aveva fitta in capo questa pazzia, che la vita umana fosse infelice.
AMICO: Infelice sì forse. Ma pure alla fine…
TRISTANO: No no, anzi felicissima. Ora ho cambiata opinione. Ma quando scrissi cotesto libro, io aveva quella pazzia in capo, come vi dico. E n’era tanto persuaso, che tutt’altro mi sarei aspettato, fuorché sentirmi volgere in dubbio le osservazioni ch’io faceva in quel proposito, parendomi che la coscienza d’ogni lettore dovesse rendere prontissima testimonianza a ciascuna di esse. Solo immaginai che nascesse disputa dell’utilità o del danno di tali osservazioni, ma non mai della verità: anzi mi credetti che le mie voci lamentevoli, per essere i mali comuni, sarebbero ripetute in cuore da ognuno che le ascoltasse. E sentendo poi negarmi, non qualche proposizione particolare, ma il tutto, e dire che la vita non è infelice, e che se a me pareva tale, doveva essere effetto d’infermità, o d’altra miseria mia particolare, da prima rimasi attonito, sbalordito, immobile come un sasso, e per più giorni credetti di trovarmi in un altro mondo; poi, tornato in me stesso, mi sdegnai un poco; poi risi, e dissi: gli uomini sono in generale come i mariti. I mariti, se vogliono viver tranquilli, è necessario che credano le mogli fedeli, ciascuno la sua; e così fanno; anche quando la metà del mondo sa che il vero è tutt’altro. Chi vuole o dee vivere in un paese, conviene che lo creda uno dei migliori della terra abitabile; e lo crede tale. Gli uomini universalmente, volendo vivere, conviene che credano la vita bella e pregevole; e tale la credono; e si adirano contro chi pensa altrimenti. Perché in sostanza il genere umano crede sempre, non il vero, ma quello che è, o pare che sia, più a proposito suo. Il genere umano, che ha creduto e crederà tante scempiataggini, non crederà mai né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non aver nulla a sperare. Nessun filosofo che insegnasse l’una di queste tre cose, avrebbe fortuna né farebbe setta, specialmente nel popolo: perché, oltre che tutte tre sono poco a proposito di chi vuol vivere, le due prime offendono la superbia degli uomini, la terza, anzi ancora le altre due, vogliono coraggio e fortezza d’animo a essere credute. E gli uomini sono codardi, deboli, d’animo ignobile e angusto; docili sempre a sperar bene, perché sempre dediti a variare le opinioni del bene secondo che la necessità governa la loro vita; prontissimi a render l’arme, come dice il Petrarca, alla loro fortuna, prontissimi e risolutissimi a consolarsi di qualunque sventura, ad accettare qualunque compenso in cambio di ciò che loro è negato o di ciò che hanno perduto, ad accomodarsi con qualunque condizione a qualunque sorte più iniqua e più barbara, e quando sieno privati d’ogni cosa desiderabile, vivere di credenze false, così gagliarde e ferme, come se fossero le più vere o le più fondate del mondo. Io per me, come l’Europa meridionale ride dei mariti innamorati delle mogli infedeli, così rido del genere umano innamorato della vita; e giudico assai poco virile il voler lasciarsi ingannare e deludere come sciocchi, ed oltre ai mali che si soffrono, essere quasi lo scherno della natura e del destino. Parlo sempre degl’inganni non dell’immaginazione, ma dell’intelletto. Se questi miei sentimenti nascano da malattia, non so: so che, malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn’inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera. La quale se non è utile ad altro, procura agli uomini forti la fiera compiacenza di vedere strappato ogni manto alla coperta e misteriosa crudeltà del destino umano. Io diceva queste cose fra me, quasi come se quella filosofia dolorosa fosse d’invenzione mia; vedendola così rifiutata da tutti, come si rifiutano le cose nuove e non più sentite. Ma poi, ripensando, mi ricordai ch’ella era tanto nuova, quanto Salomone e quanto Omero, e i poeti e i filosofi più antichi che si conoscano; i quali tutti sono pieni pienissimi di figure, di favole, di sentenze significanti l’estrema infelicità umana; e chi di loro dice che l’uomo è il più miserabile degli animali; chi dice che il meglio è non nascere, e per chi è nato, morire in cuna; altri, che uno che sia caro agli Dei, muore in giovanezza, ed altri altre cose infinite su questo andare. E anche mi ricordai che da quei tempi insino a ieri o all’altr’ieri, tutti i poeti e tutti i filosofi e gli scrittori grandi e piccoli, in un modo o in un altro, avevano ripetute o confermate le stesse dottrine. Sicché tornai di nuovo a maravigliarmi: e così tra la maraviglia e lo sdegno e il riso passai molto tempo: finché studiando più profondamente questa materia, conobbi che l’infelicità dell’uomo era uno degli errori inveterati dell’intelletto, e che la falsità di questa opinione, e la felicità della vita, era una delle grandi scoperte del secolo decimonono. Allora m’acquetai, e confesso ch’io aveva il torto a credere quello ch’io credeva.
AMICO: E avete cambiata opinione?
TRISTANO: Sicuro. Volete voi ch’io contrasti alle verità scoperte dal secolo decimonono?
AMICO: E credete voi tutto quello che crede il secolo?
TRISTANO: Certamente. Oh che maraviglia?
AMICO: Credete dunque alla perfettibilità indefinita dell’uomo?
TRISTANO: Senza dubbio.
AMICO: Credete che in fatti la specie umana vada ogni giorno migliorando?
TRISTANO: Sì certo. È ben vero che alcune volte penso che gli antichi valevano, delle forze del corpo, ciascuno per quattro di noi. E il corpo è l’uomo; perché (lasciando tutto il resto) la magnanimità, il coraggio, le passioni, la potenza di fare, la potenza di godere, tutto ciò che fa nobile e viva la vita, dipende dal vigore del corpo, e senza quello non ha luogo. Uno che sia debole di corpo, non è uomo, ma bambino; anzi peggio; perché la sua sorte è di stare a vedere gli altri che vivono, ed esso al più chiacchierare, ma la vita non è per lui. E però anticamente la debolezza del corpo fu ignominiosa, anche nei secoli più civili. Ma tra noi già da lunghissimo tempo l’educazione non si degna di pensare al corpo, cosa troppo bassa e abbietta: pensa allo spirito: e appunto volendo coltivare lo spirito, rovina il corpo: senza avvedersi che rovinando questo, rovina a vicenda anche lo spirito. E dato che si potesse rimediare in ciò all’educazione, non si potrebbe mai senza mutare radicalmente lo stato moderno della società, trovare rimedio che valesse in ordine alle altre parti della vita privata e pubblica, che tutte, di proprietà loro, cospirarono anticamente a perfezionare o a conservare il corpo, e oggi cospirano a depravarlo. L’effetto è che a paragone degli antichi noi siamo poco più che bambini, e che gli antichi a confronto nostro si può dire più che mai che furono uomini. Parlo così degl’individui paragonati agl’individui, come delle masse (per usare questa leggiadrissima parola moderna) paragonate alle masse. Ed aggiungo che gli antichi furono incomparabilmente più virili di noi anche ne’ sistemi di morale e di metafisica. A ogni modo io non mi lascio muovere da tali piccole obbiezioni, credo costantemente che la specie umana vada sempre acquistando.
AMICO: Credete ancora, già s’intende, che il sapere, o, come si dice, i lumi, crescano continuamente.
TRISTANO: Certissimo. Sebbene vedo che quanto cresce la volontà d’imparare, tanto scema quella di studiare. Ed è cosa che fa maraviglia a contare il numero dei dotti, ma veri dotti, che vivevano contemporaneamente cencinquant’anni addietro, e anche più tardi, e vedere quanto fosse smisuratamente maggiore di quello dell’età presente. Né mi dicano che i dotti sono pochi perché in generale le cognizioni non sono più accumulate in alcuni individui, ma divise fra molti; e che la copia di questi compensa la rarità di quelli. Le cognizioni non sono come le ricchezze, che si dividono e si adunano, e sempre fanno la stessa somma. Dove tutti sanno poco, e’ si sa poco; perché la scienza va dietro alla scienza, e non si sparpaglia. L’istruzione superficiale può essere, non propriamente divisa fra molti, ma comune a molti non dotti. Il resto del sapere non appartiene se non a chi sia dotto, e gran parte di quello a chi sia dottissimo. E, levati i casi fortuiti, solo chi sia dottissimo, e fornito esso individualmente di un immenso capitale di cognizioni, è atto ad accrescere solidamente e condurre innanzi il sapere umano. Ora, eccetto forse in Germania, donde la dottrina non è stata ancora potuta snidare, non vi par egli che il veder sorgere di questi uomini dottissimi divenga ogni giorno meno possibile? Io fo queste riflessioni così per discorrere, e per filosofare un poco, o forse sofisticare; non ch’io non sia persuaso di ciò che voi dite. Anzi quando anche vedessi il mondo tutto pieno d’ignoranti impostori da un lato, e d’ignoranti presuntuosi dall’altro, nondimeno crederei, come credo, che il sapere e i lumi crescano di continuo.
AMICO: In conseguenza, credete che questo secolo sia superiore a tutti i passati.
TRISTANO: Sicuro. Così hanno creduto di sé tutti i secoli, anche i più barbari; e così crede il mio secolo, ed io con lui. Se poi mi dimandaste in che sia egli superiore agli altri secoli, se in ciò che appartiene al corpo o in ciò che appartiene allo spirito, mi rimetterei alle cose dette dianzi.
AMICO: In somma, per ridurre il tutto in due parole, pensate voi circa la natura e i destini degli uomini e delle cose (poiché ora non parliamo di letteratura né di politica) quello che ne pensano i giornali?
TRISTANO: Appunto. Credo ed abbraccio la profonda filosofia de’ giornali, i quali uccidendo ogni altra letteratura e ogni altro studio, massimamente grave e spiacevole, sono maestri e luce dell’età presente. Non è vero?
AMICO: Verissimo. Se cotesto che dite, è detto da vero e non da burla, voi siete diventato de’ nostri.
TRISTANO: Sì certamente, de’ vostri.
AMICO: Oh dunque, che farete del vostro libro? Volete che vada ai posteri con quei sentimenti così contrari alle opinioni che ora avete?
TRISTANO: Ai posteri? Io rido, perché voi scherzate; e se fosse possibile che non ischerzaste, più riderei. Non dirò a riguardo mio, ma a riguardo d’individui o di cose individuali del secolo decimonono, intendete bene che non v’è timore di posteri, i quali ne sapranno tanto, quanto ne seppero gli antenati. Gl’individui sono spariti dinanzi alle masse, dicono elegantemente i pensatori moderni. Il che vuol dire ch’è inutile che l’individuo si prenda nessun incomodo, poiché, per qualunque suo merito, né anche quel misero premio della gloria gli resta più da sperare né in vigilia né in sogno. Lasci fare alle masse; le quali che cosa sieno per fare senza individui, essendo composte d’individui, desidero e spero che me lo spieghino gl’intendenti d’individui e di masse, che oggi illuminano il mondo. Ma per tornare al proposito del libro e de’ posteri, i libri specialmente, che ora per lo più si scrivono in minor tempo che non ne bisogna a leggerli, vedete bene che, siccome costano quel che vagliono, così durano a proporzione di quel che costano. Io per me credo che il secolo venturo farà un bellissimo frego sopra l’immensa bibliografia del secolo decimonono; ovvero dirà: io ho biblioteche intere di libri che sono costati quali venti, quali trenta anni di fatiche, e quali meno, ma tutti grandissimo lavoro. Leggiamo questi prima, perché la verisimiglianza è che da loro si cavi maggior costrutto; e quando di questa sorta non avrò più che leggere, allora metterò mano ai libri improvvisati. Amico mio, questo secolo è un secolo di ragazzi, e i pochissimi uomini che rimangono, si debbono andare a nascondere per vergogna, come quello che camminava diritto in paese di zoppi. E questi buoni ragazzi vogliono fare in ogni cosa quello che negli altri tempi hanno fatto gli uomini, e farlo appunto da ragazzi, così a un tratto senza altre fatiche preparatorie. Anzi vogliono che il grado al quale è pervenuta la civiltà, e che l’indole del tempo presente e futuro, assolvano essi e loro successori in perpetuo da ogni necessità di sudori e fatiche lunghe per divenire atti alle cose. Mi diceva, pochi giorni sono, un mio amico, uomo di maneggi e di faccende, che anche la mediocrità è divenuta rarissima; quasi tutti sono inetti, quasi tutti insufficienti a quegli uffici o a quegli esercizi a cui necessità o fortuna o elezione gli ha destinati. In ciò mi pare che consista in parte la differenza ch’è da questo agli altri secoli. In tutti gli altri, come in questo, il grande è stato rarissimo; ma negli altri la mediocrità ha tenuto il campo, in questo la nullità. Onde è tale il romore e la confusione, volendo tutti esser tutto, che non si fa nessuna attenzione ai pochi grandi che pure credo che vi sieno; ai quali, nell’immensa moltitudine de’ concorrenti, non è più possibile di aprirsi una via. E così, mentre tutti gl’infimi si credono illustri, l’oscurità e la nullità dell’esito diviene il fato comune e degl’infimi e de’ sommi. Ma viva la statistica! vivano le scienze economiche, morali e politiche, le enciclopedie portatili, i manuali, e le tante belle creazioni del nostro secolo! e viva sempre il secolo decimonono! forse povero di cose, ma ricchissimo e larghissimo di parole: che sempre fu segno ottimo, come sapete. E consoliamoci, che per altri sessantasei anni, questo secolo sarà il solo che parli, e dica le sue ragioni.
AMICO: Voi parlate, a quanto pare, un poco ironico. Ma dovreste almeno all’ultimo ricordarvi che questo è un secolo di transizione.
TRISTANO: Oh che conchiudete voi da cotesto? Tutti i secoli, più o meno, sono stati e saranno di transizione, perché la società umana non istà mai ferma, né mai verrà secolo nel quale ella abbia stato che sia per durare. Sicché cotesta bellissima parola o non iscusa punto il secolo decimonono, o tale scusa gli è comune con tutti i secoli. Resta a cercare, andando la società per la via che oggi si tiene, a che si debba riuscire, cioè se la transizione che ora si fa, sia dal bene al meglio o dal male al peggio. Forse volete dirmi che la presente è transizione per eccellenza, cioè un passaggio rapido da uno stato della civiltà ad un altro diversissimo dal precedente. In tal caso chiedo licenza di ridere di cotesto passaggio rapido, e rispondo che tutte le transizioni conviene che sieno fatte adagio; perché se si fanno a un tratto, di là a brevissimo tempo si torna indietro, per poi rifarle a grado a grado. Così è accaduto sempre. La ragione è, che la natura non va a salti, e che forzando la natura, non si fanno effetti che durino, Ovvero, per dir meglio, quelle tali transizioni precipitose sono transizioni apparenti, ma non reali.
AMICO: Vi prego, non fate di cotesti discorsi con troppe persone, perché vi acquisterete molti nemici.
TRISTANO: Poco importa. Oramai né nimici né amici mi faranno gran male.
AMICO: O più probabilmente sarete disprezzato, come poco intendente della filosofia moderna, e poco curante del progresso della civiltà e dei lumi. Tristano: Mi dispiace molto, ma che s’ha a fare? se mi disprezzeranno, cercherò di consolarmene.
TRISTANO: Mi dispiace molto, ma che s’ha a fare? se mi disprezzeranno, cercherò di consolarmene.
AMICO: Ma in fine avete voi mutato opinioni o no? e che s’ha egli a fare di questo libro?
TRISTANO: Bruciarlo è il meglio. Non lo volendo bruciare, serbarlo come un libro di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci malinconici, ovvero come un’espressione dell’infelicità dell’autore: perché in confidenza, mio caro amico, io credo felice voi e felici tutti gli altri; ma io quanto a me, con licenza vostra e del secolo, sono infelicissimo; e tale mi credo; e tutti i giornali de’ due mondi non mi persuaderanno il contrario.
AMICO: Io non conosco le cagioni di cotesta infelicità che dite. Ma se uno sia felice o infelice individualmente, nessuno è giudice se non la persona stessa, e il giudizio di questa non può fallare.
TRISTANO: Verissimo. E di più vi dico francamente, ch’io non mi sottometto alla mia infelicità, né piego il capo al destino, o vengo seco a patti, come fanno gli altri uomini; e ardisco desiderare la morte, e desiderarla sopra ogni cosa, con tanto ardore e con tanta sincerità, con quanta credo fermamente che non sia desiderata al mondo se non da pochissimi. Né vi parlerei così se non fossi ben certo che, giunta l’ora, il fatto non ismentirà le mie parole; perché quantunque io non vegga ancora alcun esito alla mia vita, pure ho un sentimento dentro, che quasi mi fa sicuro che l’ora ch’io dico non sia lontana. Troppo sono maturo alla morte, troppo mi pare assurdo e incredibile di dovere, così morto come sono spiritualmente, così conchiusa in me da ogni parte la favola della vita, durare ancora quaranta o cinquant’anni, quanti mi sono minacciati dalla natura. Al solo pensiero di questa cosa io rabbrividisco. Ma come ci avviene di tutti quei mali che vincono, per così dire, la forza immaginativa, così questo mi pare un sogno e un’illusione, impossibile a verificarsi. Anzi se qualcuno mi parla di un avvenire lontano come di cosa che mi appartenga, non posso tenermi dal sorridere fra me stesso: tanta confidenza ho che la via che mi resta a compiere non sia lunga. E questo, posso dire, è il solo pensiero che mi sostiene. Libri e studi, che spesso mi maraviglio d’aver tanto amato, disegni di cose grandi, e speranze di gloria e d’immortalità, sono cose delle quali è anche passato il tempo di ridere. Dei disegni e delle speranze di questo secolo non rido: desidero loro con tutta l’anima ogni miglior successo possibile, e lodo, ammiro ed onoro altamente e sincerissimamente il buon volere: ma non invidio però i posteri, né quelli che hanno ancora a vivere lungamente. In altri tempi ho invidiato gli sciocchi e gli stolti, e quelli che hanno un gran concetto di se medesimi; e volentieri mi sarei cambiato con qualcuno di loro. Oggi non invidio più né stolti né savi, né grandi né piccoli, né deboli né potenti. Invidio i morti, e solamente con loro mi cambierei. Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell’avvenire, ch’io fo, come accade, nella mia solitudine, e con cui vo passando il tempo, consiste nella morte, e di là non sa uscire. Né in questo desiderio la ricordanza dei sogni della prima età, e il pensiero d’esser vissuto invano, mi turbano più, come solevano. Se ottengo la morte morrò così tranquillo e così contento, come se mai null’altro avessi sperato né desiderato al mondo. Questo è il solo benefizio che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse proposta da un lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall’altro di morir oggi, e che dovessi scegliere, io direi, morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi.
L’operetta, scritta nel ’32 e che appare anche l’ultima nell’edizione definitiva dell’opera, è una risposta all’accoglienza che le Operette morali del ’27 avevano ricevuto e che reputavano la meditazione filosofica leopardiana come frutto della sua deformità fisica. Ciò determina una reazione il Leopardi che si risolve in sarcasmo e riso e quindi in un atteggiamento maggiormente distaccato. Si veda l’esempio con cui descrive il rifiuto della società contemporanea alla sua speculazione: mariti cornuti che fingono di non esserlo per non sentirsi tali (esempio irridente e popolaresco).
Egli rovescia il discorso: vile è colui che crede che il progresso o la religione possano risolvere il problema dell’infelicità umana, coraggioso è colui che, senza finzioni consolatorie riesce a guardare in faccia la realtà. Non è un problema di dolore personale, quindi, ma dell’intera umanità. Egli non scrive pertanto spinto da un sentimento individuale e prova ne è la cultura stessa: anche la Bibbia descrive l’infelicità dell’uomo, così come la cultura classica greca o latina.
Possiamo sintetizzare il testo attraverso 5 questioni questioni/domande:
- La vita umana è infelice?
- L’umanità è sempre più perfetta
- Il sapere e la cultura progrediscono
- Quest’epoca è superiore a quelle passate
- Che cosa si fa delle “operette morali”, opera negatrice il progresso dell’umanità
a cui Tristano/Leopardi, fingendo di ritrattare risponde:
- Il sapere contemporaneo non accetta l’infelicità dell’uomo che tuttavia non è espressa da Leopardi ma da moltissima letteratura classica e teologica. Lo strano si è che se si riporta l’ideologia di Teognide o di Lucrezio, o addirittura passi biblici non si ha nulla da dire; se lo si pubblica in un libro contemporaneo lo si reputa “non vero” e controproducente il progresso storico “inevitabile”;
- L’umanità si dice che oggi sia più perfetta, ma si è abbandonata la cultura che faceva tutt’uno tra cultura del corpo e cultura della mente. Molto probabilmente l’educazione classica, rafforzando il corpo, perché è da un corpo sano che nascono le sensazioni, era certamente migliore rispetto alla moderna, in cui si predilige lo “spirito”;
- Alla diffusione culturale non corrisponde una elevatezza culturale. Al contrario affinché più gente conosca più la cultura si abbassa, deprimendo così e riducendo il grado d’intellettualità dei pochi, che si ottiene selezionando il processo conoscitivo;
- Tutte le epoche si sono credute superiori a quelle che le avevano precedute; non esiste epoca superiore all’altra; ma se proprio dovessimo riferirci a quella del secolo decimonono, essa non lo è affatto in quanto delega il sapere nei giornali, creando una falsa cultura di massa, nuova parola con cui s’intende un’unione di individui quindi, per Leopardi contraddizione (massa/ individuo)
- Riguardo le “Operette morali” possono essere anche bruciate, ma ciò non permetterà all’autore di cambiare opinione
La posizione con cui l’amico tenta di “giustificare” il suo secolo viene smontata in modo reciso da Leopardi: immaginare la felicità futura e non possederla perché la si sta costruendo, quindi il secolo attuale sarebbe quasi un ponte, è ridicola. Tutti i tempi sono stati aspettative di tempi futuri, non esiste età definitiva. Anzi questo secolo è forse il peggiore, perché creando illusioni nega la verità della naturale infelicità.
Ai tempi del pessimismo storico, Leopardi aveva creduto che l’infelicità fosse conseguenza della consapevolezza razionale del vero; ma ora sa che è una condizione ontologica dell’intero universo. Dunque, neppure gli sciocchi possono sottrarvisi. Per questo motivo, nei confronti dei propri simili prova un sentimento di profonda e dolente pietà.
Ciclo d’Aspasia (1833 – 1835)
L’amore per la nobildonna Fanny Targioni Tozzetti è fortemente sentito dall’inesperto Leopardi; è talmente vivo in lui da dettargli altre parole per la sua poesia. Consalvo, la prima, con il nome del protagonista di un poema epico cavalleresco del ‘600, in cui dichiara che sarebbe andato fino all’inferno, pur di ricevere un suo bacio; Il pensiero dominante, in cui si sente pienamente investito da questo nuovo dio; Amore e morte, in cui riprendendo il mito greco di Eros e Thanatos, il poeta agognerebbe la morte, pur di non soffrire. Ma il capolavoro di questo ciclo avviene quando si rende conto che il sentimento provato per Fanny è pura illusione: la rabbia provata per questa estrema delusione si traduce in un piccolo canto in cui versifica con nuovissimi accenti:
A SE STESSO
Or poserai per sempre,
stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,
ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
in noi di cari inganni,
non che la speme, il desiderio è spento.
Posa per sempre. Assai
palpitasti. Non val cosa nessuna
i moti tuoi, nè di sospiri è degna
la terra. Amaro e noia
la vita altro mai nulla; e fango è il mondo.
T’acqueta omai. Dispera
l’ultima volta. Al gener nostro il fato
non donò che il morire. Omai disprezza
te, la natura, il brutto
poter che, ascoso, a comun danno impera,
e l’infinita vanità del tutto.
Ora, o mio cuore stanco, riposerai per sempre. E’ finita l’ultima illusione che avevo creduto eterna. E’ svanita. Sento profondamente che in noi non solo la speranza ma anche il desiderio delle gradite illusioni è spento. Riposa per sempre. Troppo hai sofferto. Non c’è nessuna cosa che valga i tuoi palpiti, né il mondo è degno dei (tuoi) sospiri. La vita non è altro che amarezza e noia; e spregevole è il mondo. Calmati ormai. Rinuncia definitivamente ad ogni speranza. Agli uomini il destino donò solo la morte. Ormai (o mio cuore) disprezza te stesso, la natura, il potere perverso che domina occultamente a danno di tutto e l’infinita vanità dell’universo.
Leopardi c’aveva creduto: l’amore poteva superare il nichilismo con cui aveva definito l’esistenza: null’altro, solo lui. La caduta dell’illusione non può che provocare un verso rabbioso, franto, “antidillico”, dove la cruda parola viene spezzata in continui enjambement, ma dove, pur sapientemente occultandola, continua ad esercitare un incredibile controllo tecnico: tre strofe uguali, un settenario, due endecasillabi, un settenario ed un endecasillabo, a cui si aggiunge il verso finale (endecasillabo).
Chiude la raccolta la lirica Aspasia, con il nome della concubina di Pericle, in cui il poeta, rifugiandosi nel ricordo di Fanny, cerca di sbollire “la rabbia” ed ammette la sua sconfitta.
A Napoli (1833-1837)
Nel 1833 Leopardi, insieme all’amico Antonio Ranieri, si trasferisce a Napoli. Qui, sempre più ammalato, elabora alcune opere, quali I Paralipòmeni della Batracomiomachia (riprendendo un testo omerico già tradotto in gioventù) in cui satireggia la situazione politica italiana (disegna gli italiani come topi, gli austriaci come granchi i Borboni come rane) e la Palinodia a Gino Capponi con il quale polemizza sul liberalismo. Contiene, inoltre, due lunghi canti, Il tramonto della luna, ma soprattutto l’ultimo, che costituisce la summa del pensiero leopardiano e, se così possiamo dire, il suo testamento letterario:

Pierre Henri de Valenciennes, Eruzione del Vesuvio sotto i tempi di Tito (1813)
LA GINESTRA
Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον
τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς
E gli uomini vollero piuttosto le tenebre
che la luce.
Giovanni, III, 19.
Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo,
la qual null’altro allegra arbor né fiore,
tuoi cespi solitari intorno spargi,
odorata ginestra,
contenta dei deserti. Anco ti vidi
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
che cingon la cittade
la qual fu donna de’ mortali un tempo,
e del perduto impero
par che col grave e taciturno aspetto
faccian fede e ricordo al passeggero.
Or ti riveggo in questo suol, di tristi
lochi e dal mondo abbandonati amante
e d’afflitte fortune ognor compagna.
Questi campi cosparsi
di ceneri infeconde, e ricoperti
dell’impietrata lava,
che sotto i passi al peregrin risona;
dove s’annida e si contorce al sole
la serpe, e dove al noto
cavernoso covil torna il coniglio;
fûr liete ville e cólti,
e biondeggiâr di spiche, e risonâro
di muggito d’armenti;
fûr giardini e palagi,
agli ozi de’ potenti
gradito ospizio; e fûr cittá famose,
che coi torrenti suoi l’altèro monte
dall’ignea bocca fulminando oppresse
con gli abitanti insieme. Or tutto intorno
una ruina involve,
ove tu siedi, o fior gentile, e quasi
i danni altrui commiserando, al cielo
di dolcissimo odor mandi un profumo,
che il deserto consola. A queste piagge
venga colui che d’esaltar con lode
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
è il gener nostro in cura
all’amante natura. E la possanza
qui con giusta misura
anco estimar potrá dell’uman seme,
cui la dura nutrice, ov’ei men teme,
con lieve moto in un momento annulla
in parte, e può con moti
poco men lievi ancor subitamente
annichilare in tutto.
Dipinte in queste rive
son dell’umana gente
«Le magnifiche sorti e progressive».
Qui mira e qui ti specchia,
secol superbo e sciocco,
che il calle insino allora
dal risorto pensier segnato innanti
abbandonasti, e vòlti addietro i passi,
del ritornar ti vanti,
e procedere il chiami.
Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti,
di cui lor sorte rea padre ti fece,
vanno adulando, ancora
ch’a ludibrio talora
t’abbian fra sé. Non io
con tal vergogna scenderò sotterra;
ma il disprezzo piuttosto che si serra
di te nel petto mio,
mostrato avrò quanto si possa aperto;
bench’io sappia che obblio
preme chi troppo all’etá propria increbbe.
Di questo mal, che teco
mi fia comune, assai finor mi rido.
Libertá vai sognando, e servo a un tempo
vuoi di novo il pensiero,
sol per cui risorgemmo
della barbarie in parte, e per cui solo
si cresce in civiltá, che sola in meglio
guida i pubblici fati.
Cosí ti spiacque il vero
dell’aspra sorte e del depresso loco
che natura ci die’. Per queste il tergo
vigliaccamente rivolgesti al lume
che il fe’ palese; e, fuggitivo, appelli
vil chi lui segue, e solo
magnanimo colui
che sé schernendo o gli altri, astuto o folle,
fin sopra gli astri il mortal grado estolle.
Uom di povero stato e membra inferme
che sia dell’alma generoso ed alto,
non chiama sé né stima
ricco d’òr né gagliardo,
e di splendida vita o di valente
persona infra la gente
non fa risibil mostra;
ma sé di forza e di tesor mendíco
lascia parer senza vergogna, e noma
parlando, apertamente, e di sue cose
fa stima al vero uguale.
Magnanimo animale
non credo io giá, ma stolto,
quel che nato a perir, nutrito in pene,
dice: “A goder son fatto,”
e di fetido orgoglio
empie le carte, eccelsi fati e nòve
felicitá, quali il ciel tutto ignora,
non pur quest’orbe, promettendo in terra
a popoli che un’onda
di mar commosso, un fiato
d’aura maligna, un sotterraneo crollo
distrugge sí, ch’avanza
a gran pena di lor la rimembranza.
Nobil natura è quella
ch’a sollevar s’ardisce
gli occhi mortali incontra
al comun fato, e che con franca lingua,
nulla al ver detraendo,
confessa il mal che ci fu dato in sorte,
e il basso stato e frale;
quella che grande e forte
mostra sé nel soffrir, né gli odii e l’ire
fraterne, ancor piú gravi
d’ogni altro danno, accresce
alle miserie sue, l’uomo incolpando
del suo dolor, ma dá la colpa a quella
che veramente è rea, che de’ mortali
madre è di parto e di voler matrigna.
Costei chiama inimica; e incontro a questa
congiunta esser pensando,
siccom’è il vero, ed ordinata in pria
l’umana compagnia,
tutti fra sé confederati estima
gli uomini, e tutti abbraccia
con vero amor, porgendo
valida e pronta ed aspettando aita
negli alterni perigli e nelle angosce
della guerra comune. Ed alle offese
dell’uomo armar la destra, e laccio porre
al vicino ed inciampo,
stolto crede cosí, qual fôra in campo
cinto d’oste contraria, in sul piú vivo
incalzar degli assalti,
gl’inimici obbliando, acerbe gare
imprender con gli amici,
e sparger fuga e fulminar col brando
infra i propri guerrieri.
Cosí fatti pensieri
quando fien, come fûr, palesi al volgo;
e quell’orror che primo
contra l’empia natura
strinse i mortali in social catena,
fia ricondotto in parte
da verace saper; l’onesto e il retto
conversar cittadino,
e giustizia e pietade altra radice
avranno allor che non superbe fole,
ove fondata probitá del volgo
cosí star suole in piede
quale star può quel c’ha in error la sede.
Sovente in queste rive,
che, desolate, a bruno
veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
seggo la notte; e su la mesta landa,
in purissimo azzurro
veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
cui di lontan fa specchio
il mare, e tutto di scintille in giro
per lo vòto seren brillare il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
ch’a lor sembrano un punto,
e sono immense, in guisa
che un punto a petto a lor son terra e mare
veracemente; a cui
l’uomo non pur, ma questo
globo, ove l’uomo è nulla,
sconosciuto è del tutto; e quando miro
quegli ancor piú senz’alcun fin remoti
nodi quasi di stelle,
ch’a noi paion qual nebbia, a cui non l’uomo
e non la terra sol, ma tutte in uno,
del numero infinite e della mole,
con l’aureo sole insiem, le nostre stelle
o sono ignote, o cosí paion come
essi alla terra, un punto
di luce nebulosa; al pensier mio
che sembri allora, o prole
dell’uomo? E rimembrando
il tuo stato quaggiú, di cui fa segno
il suol ch’io premo; e poi dall’altra parte,
che te signora e fine
credi tu data al Tutto; e quante volte
favoleggiar ti piacque, in questo oscuro
granel di sabbia, il qual di terra ha nome,
per tua cagion, dell’universe cose
scender gli autori, e conversar sovente
co’ tuoi piacevolmente; e che, i derisi
sogni rinnovellando, ai saggi insulta
fin la presente etá, che in conoscenza
ed in civil costume
sembra tutte avanzar; qual moto allora,
mortal prole infelice, o qual pensiero
verso te finalmente il cor m’assale?
Non so se il riso o la pietá prevale.
Come d’arbor cadendo un picciol pomo,
cui lá nel tardo autunno
maturitá senz’altra forza atterra,
d’un popol di formiche i dolci alberghi
cavati in molle gleba
con gran lavoro, e l’opre,
e le ricchezze ch’adunate a prova
con lungo affaticar l’assidua gente
avea provvidamente al tempo estivo,
schiaccia, diserta e copre
in un punto; cosí d’alto piombando,
dall’utero tonante
scagliata al ciel profondo,
di ceneri e di pomici e di sassi
notte e ruina, infusa
di bollenti ruscelli,
o pel montano fianco
furiosa tra l’erba
di liquefatti massi
e di metalli e d’infocata arena
scendendo immensa piena,
le cittadi che il mar lá su l’estremo
lido aspergea, confuse
e infranse e ricoperse
in pochi istanti: onde su quelle or pasce
la capra, e cittá nove
sorgon dall’altra banda, a cui sgabello
son le sepolte, e le prostrate mura
l’arduo monte al suo piè quasi calpesta.
Non ha natura al seme
dell’uom piú stima o cura
ch’alla formica: e se piú rara in quello
che nell’altra è la strage,
non avvien ciò d’altronde
fuor che l’uom sue prosapie ha men feconde.
Ben mille ed ottocento
anni varcâr poi che sparîro, oppressi
dall’ignea forza, i popolati seggi,
e il villanello intento
ai vigneti, che a stento in questi campi
nutre la morta zolla e incenerita,
ancor leva lo sguardo
sospettoso alla vetta
fatal, che nulla mai fatta piú mite
ancor siede tremenda, ancor minaccia
a lui strage ed ai figli ed agli averi
lor poverelli. E spesso
il meschino in sul tetto
dell’ostel villereccio, alla vagante
aura giacendo tutta notte insonne,
e balzando piú volte, esplora il corso
del temuto bollor, che si riversa
dall’inesausto grembo
sull’arenoso dorso, a cui riluce
di Capri la marina
e di Napoli il porto e Mergellina.
E se appressar lo vede, o se nel cupo
del domestico pozzo ode mai l’acqua
fervendo gorgogliar, desta i figliuoli,
desta la moglie in fretta, e via, con quanto
di lor cose rapir posson, fuggendo,
vede lontan l’usato
suo nido, e il picciol campo,
che gli fu dalla fame unico schermo,
preda al flutto rovente,
che crepitando giunge, e inesorato
durabilmente sovra quei si spiega.
Torna al celeste raggio
dopo l’antica obblivion, l’estinta
Pompei, come sepolto
scheletro, cui di terra
avarizia o pietá rende all’aperto;
e dal deserto fòro
diritto infra le file
de’ mozzi colonnati il peregrino
lunge contempla il bipartito giogo
e la cresta fumante,
ch’alla sparsa ruina ancor minaccia.
E nell’orror della secreta notte
per li vacui teatri,
per li templi deformi e per le rotte
case, ove i parti il pipistrello asconde,
come sinistra face
che per vòti palagi atra s’aggiri,
corre il baglior della funerea lava,
che di lontan per l’ombre
rosseggia e i lochi intorno intorno tinge.
Cosí, dell’uomo ignara e dell’etadi
ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno
dopo gli avi i nepoti,
sta natura ognor verde, anzi procede
per sí lungo cammino
che sembra star. Caggiono i regni intanto,
passan genti e linguaggi: ella nol vede:
e l’uom d’eternitá s’arroga il vanto.
E tu, lenta ginestra,
che di selve odorate
queste campagne dispogliate adorni,
anche tu presto alla crudel possanza
soccomberai del sotterraneo foco,
che ritornando al loco
giá noto, stenderá l’avaro lembo
su tue molli foreste. E piegherai
sotto il fascio mortal non renitente
il tuo capo innocente:
ma non piegato insino allora indarno
codardamente supplicando innanzi
al futuro oppressor; ma non eretto
con forsennato orgoglio inver’ le stelle,
né sul deserto, dove
e la sede e i natali
non per voler ma per fortuna avesti;
ma piú saggia, ma tanto
meno inferma dell’uom, quanto le frali
tue stirpi non credesti
o dal fato o da te fatte immortali.
 Un acquerello del XIX secolo con Villa Ferrigni presso Torre del Greco, dove Giacomo Leopardi compose La Ginestra.
Un acquerello del XIX secolo con Villa Ferrigni presso Torre del Greco, dove Giacomo Leopardi compose La Ginestra.
Qui sulle aride pendici del terribile vulcano distruttore, il Vesuvio, che non sono rallegrate da nessun albero né fiore, tu spargi i tuoi rami solitari, o profumata ginestra, felice di trovarti nei deserti. Ti ho già vista abbellire con i tuoi steli le campagne disabitate che circondano la città (Roma) che un tempo fu dominatrice degli esseri umani, e sembra che questi luoghi col loro aspetto cupo e silenzioso testimonino e ricordino a chi passa il grande impero perduto. Ti rivedo ora su questo suolo, tu che sei amante di luoghi tristi e abbandonati dal mondo, e sempre compagna di grandezze decadute. Questi terreni, cosparsi di ceneri sterili, e ricoperti dalla lava solidificata, che risuona sotto i passi del viandante; dove si annida e si contorce sotto al sole il serpente, e dove il coniglio torna all’abituale tana tra le caverne; furono città ricche e campi coltivati, biondeggiarono di campi di grano, e risuonarono di muggiti delle mandrie; furono giardini e ville sontuose, un gradito rifugio per l’ozio dei potenti; e furono città famose che il vulcano indomabile, eruttando dalla bocca di fuoco torrenti di lava distrusse insieme con i loro abitanti. Ora qui intorno la rovina avvolge tutto, là dove tu hai radici, o fiore gentile e, quasi compiangendo le miserie altrui, verso il cielo emani un profumo assai dolce, che allieta il paesaggio desertico. A questi luoghi deserti si rechi chi è solito esaltare ed elogiare la nostra umana condizione, e veda quanto la natura benigna si preoccupa dell’uomo. E in maniera opportuna potrà anche valutare la potenza del genere umano, che la natura, crudele nutrice, quando l’uomo meno se l’aspetta, con una scossa impercettibile distrugge in parte in un solo momento, è può con moti poco meno lievi all’improvviso annientare del tutto. // Qui guardati e ammira la tua immagine riflessa, secolo superbo e stolto, che hai abbandonato la strada segnata sin qui dal pensiero rinascimentale, e tornato sui tuoi passi, ti vanti del tuo procedere all’indietro, e lo chiami addirittura progresso. Tutti gli ingegni, di cui una sorte malvagia ti ha reso padre, sono intenti ad adulare il tuo atteggiamento infantile, benché a volte, tra di loro, si facciano beffe di te. Io non verrò sotterrato macchiandomi di una simile vergogna; ma piuttosto avrò mostrato chiaramente il disprezzo nei tuoi confronti che è rinchiuso nel mio cuore: benché io sappia che all’oblio è destinato chi troppo ha biasimato il proprio tempo. Di questo male, che sarà in comune tra me e te, finora ne rido molto. Vai sognando la libertà, e nel frattempo vuoi che il pensiero sia di nuovo servo, (quel pensiero) in virtù del quale soltanto risorgemmo in parte dalla barbarie, e per cui solo si può crescere in civilizzazione, che da sola guida i destini dei popoli verso il meglio. Perciò ti ha infastidito la verità sulla sorte amara e sul mondo infelice che la natura ci ha assegnato. Per questo motivo, vigliaccamente hai voltato le spalle al pensiero che ci ha mostrato queste cose: e, mentre fuggi, chiami vile chi segue quella via, e definisci magnanimo solo chi, astuto o stolto, illudendo se stesso o gli altri, esalta fin sopra le stelle la condizione umana. // Un uomo di umile condizione e salute cagionevole, che abbia grandezza d’animo e nobili sentimenti, non definisce né reputa se stesso ricco di beni o di vigore fisico, e non ostenta ridicolmente tra la gente la sua vita lussuosa o il suo bell’aspetto; ma senza vergogna si mostra privo di forza fisica e di beni materiali, e chiama apertamente le cose col loro nome, e stima le sue cose in modo aderente alla verità. Non penso che sia un essere magnanimo, ma sciocco chi, nato per morire, nutrito di sofferenze, afferma: “Sono stato creato per essere felice”, e di nauseante orgoglio riempie i suoi scritti, promettendo in terra a quei popoli che un’onda di un mare in tempesta, una pestilenza, un terremoto possono distruggere in modo che ne sopravviva a stento il ricordo, un destino esaltante e straordinarie felicità, che il cielo stesso ignora. Nobile spirito è quello che ha il coraggio di sollevare i propri occhi mortali contro il destino comune, e che con parole oneste, senza nulla togliere alla verità, confessa il male che ci è stato assegnato, e la nostra insignificante e fragile condizione; quello che si mostra coraggioso e forte nella sofferenza, e che non aggiunge alle sue sciagure né gli odi né le ire fraterne, più gravi ancora di ogni altro danno, dando la responsabilità all’uomo del suo dolore, ma dà la colpa a colei che è davvero responsabile (la natura), che per gli uomini è madre perché li ha generati e matrigna per come li tratta. Chiama nemica costei (la natura); e pensando di essere, com’è vero, unita e schierata contro di lei, la società umana ritiene che tutti gli uomini siano alleati tra loro e tutti li stringe in un abbraccio con vera partecipazione, offrendo ed aspettando un valido e rapido aiuto nelle alterne difficoltà e nelle sofferenze della comune lotta. E crede che sia cosa stolta armarsi e porre insidie per contrastare un proprio simile, così come sarebbe stupido, in un campo di battaglia circondato dai nemici, nel momento più feroce dell’assalto, dimenticando i nemici, aprire aspre ostilità contro i propri compagni e disseminare la fuga o tirare colpi di spada tra i propri guerrieri. Quando considerazioni di questo tipo saranno, come lo sono state in passato, evidenti al popolo; e quel terrore che per primo unì gli uomini contro la natura malvagia in una catena di solidarietà, sarà ricondotto in parte a una vera sapienza, allora l’onestà e la rettitudine degli esseri umani e la giustizia e la pietà, avranno un’altra radice che non l’ottusa fiducia, sulle cui fondamenta la mentalità del popolo è solita star in equilibrio come può stare chi ha il proprio fondamento nell’errore. // Spesso siedo nottetempo su questi luoghi, che, deserti, la lava solidificata, e sembra muoversi ancora, ricopre di un colore marrone scuro; e sul triste paesaggio, sotto un cielo terso e pulitissimo vedo risplendere le stelle nel cielo, alle quali il mare, da lontano, fa da specchio, e tutto il mondo brilla di scintille per l’universo sereno. E fissando con gli occhi quelle luci, che a loro paiono solo dei puntini, e invece sono talmente grandi, che in realtà terra e mare sono solo un punto al loro cospetto; alle quali non solo l’uomo, ma questa stessa Terra dove l’uomo vale nulla, è del tutto sconosciuto; e quando ammiro quelle lontane e infinite costellazioni di stelle, che ci sembrano come una nebbia, alle quali non l’uomo, non la terra soltanto, ma tutte insieme le nostre stelle, infinite per numero e per mole, insieme col sole dorato o sono sconosciute o appaiono come loro sembrano alla Terra, e cioè un punto di luce fioca; allora come appari al mio pensiero, o stirpe umana? E ricordando il tuo stato sulla terra, di cui è testimonianza il suolo vulcanico che io calpesto; e d’altra parte (ricordando) che ti reputi padrona e fine ultimo dell’universo; e (ricordando) quante volte ti è piaciuto fantasticare su come i creatori (gli dei) del mondo siano scesi su questo oscuro granello di sabbia, che ha nome Terra, per causa tua, e su come spesso abbiano conversato piacevolmente con i tuoi simili; e (ricordando) che perfino la presente età, che per conoscenza e costume civile sembra essere così superiore alle età precedenti, insulta i saggi, raccontando di nuovo sogni già derisi in passato; che sentimento o che pensiero, o umanità infelice, assale alla fine il mio cuore nei tuoi confronti? Non so se prevale il riso o la pietà. // Come un piccolo frutto cadendo dall’albero, che nell’autunno inoltrato la maturazione fa precipitare a terra senza altra forza, schiaccia, annienta e sommerge in un attimo gli accoglienti nidi di un popolo di formiche, scavati nel terreno molle con gran lavoro, e le gallerie e le riserve di cibo che con lunga fatica le infaticabili formiche in gara tra loro hanno raccolto con previdenza nella stagione estiva; così, piombando dall’alto, dalle viscere rumorose del vulcano scagliate in alto verso il cielo, le tenebre fatte di cenere, pomice e sasso, mescolate ai bollenti ruscelli, oppure un’immensa piena di massi liquefatti di metalli e di sabbia infuocata, che scende furiosa tra l’erba, lungo il fianco del monte sconvolse, distrusse e ricoprì in pochi attimi le città che il mare bagnava sulla costa: così ora su quelle città pascola la capra, e nuove città sorgono all’esterno della colata, a cui fanno da sgabello le città sepolte, e l’alto monte quasi calpesta col suo piede le mura crollate. La natura non nutre per il genere umano maggiore stima o cura che per la formica: e se la strage avviene più raramente tra quelli (gli uomini) che tra queste (le formiche), ciò avviene d’altra solo perché la stirpe degli uomini è meno feconda. // Sono passati ben mille e ottocento anni da quando scomparirono, sepolti dalla forza della lava infuocata, le affollate città e il contadino intento a lavorare nei vigneti, che la terra arida e bruciata, nutre a fatica in questi campi, alza tuttora lo sguardo sospettoso verso la cima del vulcano portatore di morte, che per nulla resa più mite, ancora lo sovrasta tremenda, ancora minaccia una strage a lui (il contadino), ai suoi figli e ai loro miseri averi. E spesso il poverello sul tetto della sua rustica casa, trascorrendo insonne tutta la notte all’aperto, e sobbalzando più volte (per la paura), osserva ansioso il procedere del temuto ribollire, che cola dalle inesauribili viscere sul pendio sabbioso, al cui bagliore risplende la marina di Capri e il porto di Napoli e il quartiere Mergellina. E se lo vede avvicinarsi, o se sente per caso gorgogliare in fermento nel profondo del pozzo di casa, sveglia i figli, sveglia la moglie in fretta, e subito va via, con quanto delle loro cose possono prendere e, fuggendo, vede da lontano la quotidiana abitazione, e il modesto campo, che costituì per lui l’unica difesa alla fame, preda della colata incandescente che avanza con mille crepitii, e inesorabile si stende per sempre sopra quelli (campo e casa). Alla luce del sole torna, dopo un oblio secolare, l’estinta Pompei, come uno scheletro sepolto, che dalla terra viene all’aperto per desiderio di ricchezza o pietà; e dal foro deserto dritto in mezzo alle fila dei colonnati diroccati il pellegrino contempla da lontano la doppia cima (il Vesuvio e il monte Somma) e il pennacchio di fumo, che ancora minaccia le rovine sparse (di Pompei). E nell’orrore della notte oscura per i teatri abbandonati, per i templi crollati e le case devastate, dove il pipistrello nasconde i propri figli, come una fiaccola misteriosa che si aggiri lugubre tra i palazzi vuoti, corre il bagliore della lava assassina, che da lontano in mezzo all’ombra rosseggia e colora i luoghi tutt’intorno. Così, del tutto indifferente all’uomo e alle ere che egli chiama antiche, e del susseguirsi delle generazioni umane, la natura rimane sempre giovane e vigorosa, ed anzi procede per un cammino così lungo che ella pare immobile. Nel frattempo, crollano i governi, passano le genti e le culture: ella non se ne accorge: e l’uomo pretende il diritto all’eternità. // E tu, flessibile ginestra, che con i tuoi cespugli odorosi adorni queste campagne desertificate, anche tu presto soccomberai alla potenza crudele della lava in eruzione, che ritornando ai luoghi già colpiti, stenderà sui tuoi molli rami il suo mantello avido di morte. E piegherai sotto la colata mortale senza opporre resistenza il tuo capo innocente: ma senza averlo piegato fino a quel momento, con suppliche inutili e codarde al futuro oppressore; e senza averlo alzato con forsennato orgoglio contro le stelle, né sul deserto, dove tu sei nata e hai dimora non per scelta ma per gioco del caso; ma più saggia, e tanto meno debole ed insensata dell’uomo, poiché non hai mai creduto che la tua specie fosse stata resa immortale o dal destino o da te stessa.
La Ginestra, come già detto, rappresenta la summa del pensiero leopardiano, ma forse è meglio dire, l’approdo ultimo del suo tragitto speculativo, che ci permette di definire il poeta recanatese, come dice il Timpanaro “un progressivo”.
Già tale definizione sembra contraddire la visione “politica” di Leopardi, e questa poesia sembra ne sia la dimostrazione: l’attacco contro il liberismo cattolico allora rivolto alla lotta per la liberazione della patria è teso, reso forte dal sarcasmo con cui il poeta sembra invitare, sulla falde del Vesuvio, colui che disegna per l’uomo Le magnifiche sorti e progressive. Ma egli va oltre, stringendo in un forte crescendo logico la loro inattualità.
Potremo partire dall’opposizione che vi è, sin da principio, tra il luogo, definito con l’avverbio qui, a disegnare l’intera desolazione de l’arida schiena e l’odorosa ginestra: l’antinomia è presente sin nei primi quattro versi: il primo a simboleggiare la natura, la seconda l’io poetico. E ancora nella stessa strofa il richiamo al glorioso passato che, nella sua distruzione ci indica l’inesorabilità della natura. Di fronte a tale “inesorabilità” l’illusione di un futuro migliore è pura illusione.
Nella seconda strofa l’accusa si fa diretta: il secolo romantico, richiamandosi al sentimento religioso, ha voltato le spalle a quella cultura che dal Rinascimento fino all’Illuminismo aveva tentato di liberare l’uomo dalla schiavitù del pensiero. Il dire a questa intellettualità che la loro modernità è frutto di un recupero “vergognoso” dell’ideologia liberale, non può che procuragli quella damnatio memoriae di cui sa già d’essere condannato.
Nella terza strofe l’io poeta s’identifica con l’uomo di povero stato e l’identificazione va oltre il dato metaforico per raggiungere quello reale (effettivamente Leopardi era povero e malato). Egli non cesserà di incolpare la natura per la condizione disperata dell’uomo: ma facendo in modo che questa verità (basata sulla ragione) venga diffusa ai più e togliendo loro l’illusione di un premio ultraterreno che svilirebbe il loro impegno, riuscirà a creare quella solidarietà che va oltre la compassione per abbracciare una forte volontà di lotta contro colei che madre è di parto e di voler matrigna (si noti il significativo chiasmo)
La quarta strofe sembra richiamare L’infinito: il poeta che si siede e osserva il cielo ed il mare. Ed anche qui la presenza del luogo sembra rimandarlo, per assenza, all’universo intero. Ma l’atto si capovolge e il poeta immagina che da quel vuoto si possa osservare il nostro mondo; l’equazione è semplice: se a noi le stelle del cielo immenso sembrano delle piccole luci sarà altrettanto vero che da loro questo mondo apparirà come un piccolo mondo; zoomando ancora all’interno di questo piccolo mondo, agli occhi delle stelle l’uomo sarà nulla. E’ evidente che il pensiero, per cui un ipotetico Dio possa aver fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza, appaia ridicolo e pietoso (Non so se il riso o la pietà prevale).
La quinta strofe sembra esemplificare, con la descrizione del destino delle formiche la condizione dell’uomo ed il fatto che a metaforizzarla scelga proprio l’insetto non è senza significato. Conclude, quasi irridendo gli avversari, che se a questi piccoli animali capitano più stragi rispetto all’umanità è per la loro numerosità.
La sesta strofe sottolinea la caducità dell’uomo rifacendosi alle recenti scoperte archeologiche di Ercolano e di Pompei: la loro grandezza inconsapevole un tempo, la loro cancellazione improvvisa, sono la dimostrazione di come la natura possa, in un solo attimo, distruggere senza alcuna pietà. Ne consegue, logicamente, che la natura sta, l’uomo trascorre: il dramma è che l’uomo arroga lo stare a se stesso.
L’ultima chiude la canzone in modo circolare. La ginestra, fiore forse povero e non bello, che riesce a “vivere” nonostante l’aridità del terreno, è la dimostrazione della capacità che l’uomo avrebbe se ardisse a riconoscere la sua fragilità: anche la ginestra, forse un giorno verrà seppellita dalla lava espulsa dal Vesuvio; anche il poeta un giorno verrà cancellato dalla malattia che lo perseguita, ma sia l’una che l’altro, non cercheranno favole consolatorie, ma sceglieranno con dignità il loro destino.
Opere private
Lettere
L’epistolario leopardiano è molto nutrito: in esso compaiono circa mille lettere, scritte tra il 1815 ed il 1837. Molte di esse sono rivolte ad intellettuali, ma molte sono anche quelle scritte ai familiari, soprattutto ai fratelli Carlo e Paolina. Esse costituiscono una preziosa testimonianza non solo sulla biografia, ma anche sul suo percorso concettuale, poetico, psicologico, politico e culturale. Leopardi non ha mai pensato ad una sua pubblicazione, ma esse conservano una vivacità espressiva dettata dalla sincerità di quanto viene espresso.
Zibaldone
Con questo termine Leopardi intese una raccolta, su appositi quaderni, di appunti e pensieri di più svariata natura, che egli riportò dal 1817 al 1832. In quindici anni si accumulò, in quei quaderni un’incredibile quantità di materiale che vanno a costituire la bellezza di 4526 pagine. Decidendo di farne un indice Leopardi lo divise per argomenti e questo permette di seguire il suo lavoro “passo passo”, quasi fosse un libro “parallelo” alle grandi opere che andava componendo.