Sembra quasi naturale che la cultura positivista, figlia dello “scientismo” più che della “teorizzazione” e della “riflessione sul sé”, abbia come principale sbocco culturale la pittura e la letteratura romanzesca. Per quest’ultima è ben evidente che tale movimento trovi maggior sfogo là dove un romanzo d’ambientazione contemporanea era già nato e che aveva preso il nome generico di “realismo”: Dickens in Inghilterra e Stendhal, Balzac e Flaubert in Francia, l’esplosione della grande narrativa russa.
Francia

Stendhal
Stendhal è lo pseudonimo di Henry Beyle, nato nel 1783 e morto piuttosto giovane nel 1841. E’ autore di due importantissimi romanzi Il rosso e il nero del 1830 e La Certosa di Parma del 1839. L’essere nel passaggio che condurrà la letteratura dall’attenzione verso l’io nei rapporti con la realtà, sia essa naturale che reale (la lirica leopardiana, il romanzo manzoniano) al modo in cui la realtà influenza l’uomo, lo rende un autore estremamente importante.
Julien Sorel de Il rosso e il nero è ancora un uomo “eccezionale”, al centro dell’attenzione nella cui ottica si muove la narrazione, ma è anche determinato dall’ambiente in cui si trova ad agire; l’ammirazione per Napoleone all’inizio, che gli fa tentare la scalata sociale attraverso la carriera militare, la Restaurazione che gli fa spostare le sue armi verso le donne per la sua strategia d’affermazione, sembrano già adombrare un conflitto di classe. Dirà infatti ai giudici, che lo condannano per un omicidio:
DIFESA DI JULIEN SOREL
Signori giurati
L’orrore del disprezzo che, al momento di morire, credevo di poter sfidare, mi fa prendere la parola. Signori, non ho l’onore di appartenere alla vostra classe: voi vedete in me un contadino che si è ribellato contro la bassezza del proprio destino.
Non vi chiedo nessuna grazia, non mi faccio nessuna illusione, la morte mi attende; essa sarà giusta. Ho potuto attentare ai giorni di una donna di ogni rispetto, di ogni omaggio. La signora era stata per me come una madre. Il mio delitto è atroce, esso è “premeditato”. Ho perciò meritato la morte, signori giurati. Ma quand’anche fossi meno colpevole, vedrei degli uomini che, senza esser trattenuti da quel che la mia giovinezza può meritare di pietà, vorranno punire in me e scoraggiare quella classe di giovani che, nati in una condizione inferiore e oppressi in qualche modo dalla povertà, hanno avuto la fortuna di procurarsi una buona educazione e l’audacia di mescolarsi a quella che l’orgoglio dei ricchi chiama società.
Ecco il mio delitto, signori; ed esso sarà punito con tanta più severità, in quanto io non sono affatto giudicato dai miei pari. Non scorgo sui banchi dei giurati qualche contadino arricchito, ma soltanto borghesi indignati…
Ma non bisogna dimenticare l’asciuttezza della narrazione, fatta di concretezza, che lui definisce da “codice civile”, ad allontanarlo da ogni forma d’immaginifico, come nell’Ivanhoe di Walter Scott o di lirismo, come, appunto, I Promessi Sposi, manzoniani.

Honoré De Balzac
Honoré De Balzac (1799 – 1850) è certamente uno dei più prolifici narratori francesi e ciò non soltanto a fini economici (per recuperare denaro in avventure finanziare fallimentari), ma anche per una forma, oseremo dire con un termine moderno, “compulsiva”, quella di voler rappresentare l’intera società francese del suo periodo. Comédie humaine (Commedia umana) è il progetto letterario in cui vuole descrivere ogni aspetto sociale del suo tempo. Egli li divide in tre “studi”: il primo Studi di costume del XIX secolo, il secondo, Studi filosofici ed il terzo Studi analitici. Il primo di essi si suddivide a sua volta in sottogeneri ed avrà descrizioni di vita privata, vita militare, politica e di campagna.
Insomma nella mente di Balzac vi era l’intenzione di scrivere un’opera-mondo in cui venisse racchiuso tutto il reale: per questo userà il termine dantesco; così come quest’ultimo ha rappresentato ha rappresentato l’intera umanità nell’aldilà, egli vuole descrivere in un al di qua di spazio (la Francia della Restaurazione) e di tempo (la prima metà dell’800).
In tale messe di opere (ben 137 romanzi), tuttavia si può scorgere un disegno comune che tutte le sottende:
- il romanzo sociale è credibile soltanto se lo sono i personaggi che lo compongono; la loro plausibilità è dato dalla definizione dei rapporti con l’ambiente in cui vivono, condizionandoli nel loro essere e nel loro agire;
- da qui un’attenzione estrema per gli elementi esterni in cui il protagonista è inserito. Egli li impregna di sé e ne è a sua volta impregnato.
- descrizione degli ingranaggi che sottendono la società: egli arriva a capire fondamentalmente quali sono meccanismi che determinano la ricchezza, l’avidità, l’astuzia che una società sottomessa al denaro attua per affermare se stessa;
- la creazione di una miriade di personaggi che non terminano la loro azione in un solo romanzo, ma possono riapparire in altri, denotando l’onnicomprensività e la ciclicità della propria narrazione.
E’ difficile scegliere in tale grande massa di romanzi quelli che potremo definire capolavori di Balzac: certamente non si possono dimenticare La cugina Bette, Papà Goriot, Il colonello Chabert. Ma certamente uno dei più celebrati è Eugenie Grandet:
Quest’ultimo narra la storia di Eugenia Grandet, vittima di una società che nel denaro e nel profitto individua i valori fondamentali. Suo padre, la cui abilità nei commerci è pari all’avarizia, ha realizzato una grossa fortuna ma fa vivere nelle più meschine ristrettezze la sua famiglia. L’amore di Eugenia per il cugino Carlo non può realizzarsi perché questi a causa dei dissesti familiari del padre, parte per le Indie a cercare fortuna. Eugenia lo attende con devoto e romantico affetto per cinque anni, ma quando, arricchito, Carlo ritorna, sposa una giovane di nobile famiglia. Eugenia, che intanto è rimasta orfana e ricca ereditiera accetta rassegnata un matrimonio puramente formale (cioè a condizione che non venga consumato) con un anziano pretendente. Rimasta ben presto vedova, passa le sue solitarie giornate dedicandosi ad opere di beneficenza.
LA FAMIGLIA GRANDET
Nel vano della finestra più vicina alla porta stava una sedia di paglia montata su una predella, allo scopo di elevare la signora Grandet a un’altezza che le permettesse di vedere i passanti. Un tavolino da lavoro di legno di ciliegio scolorito riempiva il vano, e la poltroncina di Eugenia Grandet era lì accanto. Da quindici anni, tutte le giornate della madre e della figlia trascorrevano tranquillamente in quell’angolo, in un lavoro assiduo; dal mese di aprile sino al mese di novembre. Il primo giorno di questo mese, esse potevano prendere il loro domicilio invernale accanto al camino: soltanto quel giorno, infatti, Grandet permetteva che si accendesse il fuoco nella sala: e lo faceva spegnere il trentun marzo, senza badare né ai primi freddi della primavera né a quelli dell’autunno. Uno scaldapiedi, alimentato con la brace del fuoco della cucina che Nanon riserbava alle padrone giocando d’astuzia, aiutava la signora e la signorina Grandet a trascorrere le mattine o le serate più fresche dei mesi di aprile e di ottobre.
Madre e figlia rammendavano tutta la biancheria della casa, e dedicavano tanto coscienziosamente le loro giornate a quell’umile lavoro da operaie che, se Eugenia voleva ricamare un collettino per la madre, era costretta a sacrificare le ore del sonno, ingannando il padre per avere un po’ di luce, poiché da molto tempo l’avaro misurava le candele alla figlia e a Nanon, così come la mattina dosava il pane e le provviste necessarie al consumo giornaliero.
La grande Nanon era forse l’unica creatura umana capace di accettare il dispotismo del suo padrone. Tutta la città invidiava ai Grandet l’erculea Nanon, la quale, così chiamata per la sua statura di cinque piedi e due pollici, apparteneva alla famiglia da trentacinque anni, e, benché ricevesse soltanto sessanta lire di salario, era considerata la più ricca domestica di Saumur. Infatti quelle sessanta lire, accumulate per trentacinque anni, le avevano consentito recentemente di accendere un vitalizio di quattromila lire presso il notaio Cruchot. Quel risultato delle lunghe e persistenti economie di Nanon era sembrato enorme, e tutte le altre serve, vedendo assicurato alla povera sessantenne il pane per la vecchiaia, ne provavano invidia, senza pensare a qual prezzo di duro servaggio esso era stato conquistato.
A ventidue anni la povera ragazza era così repellente che non si era potuta collocare presso alcuno, e quella ripugnanza era certo molto ingiusta, poiché il suo viso sarebbe stato assai ammirato sulle spalle di un granatiere della guardia; ma in ogni cosa occorre, come si suol dire, l’opportunità.
Costretta a lasciare una fattoria incendiata dove sorvegliava le mucche, essa venne a Saumur in cerca di un posto, animata da quel robusto coraggio che non si rifiuta a niente. Grandet, il quale pensava allora di prender moglie e voleva già metter su casa, notò quella ragazza che tutti respingevano e, poiché nella sua qualità di bottaio era buon conoscitore della forza fisica, intuì quali vantaggi si sarebbero potuti trarre da una creatura femminile dalla statura erculea, ben piantata sui propri piedi come una quercia di sessant’anni sulle proprie radici, dai fianchi robusti, dal dorso quadrato, dalle mani da carrettiere e dall’onestà vigorosa quanto la sua intatta virtù. Né le verruche che ornavano quel viso marziale, né il colorito rossiccio, né le braccia nerborute, né i cenci della Nanon spaventarono il bottaio, che era ancora nell’età in cui si ha il cuore sensibile; anzi, egli vestì, calzò, nutrì la povera ragazza, le diede un salario e la fece lavorare senza maltrattarla troppo.
Vedendosi così accolta, Nanon pianse di gioia in segreto e si affezionò sinceramente al bottaio, il quale, d’altronde, la sfruttò feudalmente. Infatti Nanon faceva tutto: rigovernava la cucina, faceva il bucato, andava a lavare la biancheria alla Loira, la riportava sulle spalle; si levava appena era giorno, si coricava tardi; faceva da mangiare per tutti i vendemmiatori durante i raccolti, sorvegliava i braccianti, difendeva come un cane fedele la proprietà del padrone; infine, ciecamente fiduciosa in lui, obbediva senza commenti ai suoi più assurdi capricci. Nel famoso anno 1811, il cui raccolto costò pene inaudite, dopo vent’anni di servizio Grandet decise di regalare a Nanon il suo vecchio orologio, unico dono che essa mai ricevette da lui; infatti, benché egli le passasse le proprie scarpe vecchie (essa poteva portarle), era impossibile considerare come un regalo il profitto trimestrale delle scarpe di Grandet, tanto erano logore. Insomma la necessità rendeva talmente avara quella povera ragazza, che Grandet finì col volerle bene come si vuol bene a un cane, e Nanon si era lasciata mettere al collo un collare guarnito di aculei le cui punzecchiature non la ferivano più. Se Grandet affettava il pane con troppa parsimonia, essa non se ne lagnava; anzi partecipava allegramente ai vantaggi igienici derivanti dal severo regime di quella casa, dove mai nessuno era malato.
Eppoi Nanon faceva parte della famiglia: rideva quando Grandet, si rattristava, gelava, si riscaldava, lavorava con lui. E quante dolci ricompense in quel cameratismo! Il padrone non aveva mai rimproverato alla serva né le pesche primaticce o le peschenoci, né le prugne o le susine mangiate sotto l’albero.
«Su, fanne una scorpacciata, Nanon» le diceva nelle annate in cui i rami piegavano sotto il peso dei frutti, che i fattori erano costretti a gettare ai maiali.
Il piccolo brano presentato non fa che confermare l’oggettività ricercata dall’autore; nessun commento, ma poche notazioni a renderci il clima. Descrizioni della mobilia, degli alimenti, della fisicità degli stessi personaggi ci dicono molto più dei rapporti personali, ad esempio, tra la madre e la figlia rispetto a papà Grandet e di quest’ultimo verso Nanon, di quanto ci possa dire un intervento chiarificatore dell’autore.
Un’importante notazione sull’intera produzione balzacchiana ce la lascia Engels, coautore con Marx del Manifesto: “Balzac, che io ritengo maestro del realismo di gran lunga maggiore di tutti gli Zola del passato, del presente e dell’avvenire, ci dà nella Comèdie humaine un’eccellente storia realista della società francese, poiché, sotto forma di una cronaca, egli descrive quasi anno per anno, dal 1816 al 1848, la spinta sempre crescente della borghesia in ascesa contro la società nobiliare che, dopo il 1815, si era ricostituita ed era ritornata a inalberare, nei limiti delle sue possibilità, il vessillo della vieille politesse française (vecchia eleganza francese). Egli descrive come gli ultimi avanzi di questa società, per lui esemplare, andavano a poco a poco soggiacendo all’assalto del ricco e volgare villan rifatto o venivano da lui corrotti (…) e intorno a questo quadro centrale raggruppa una storia completa della società francese dalla quale io, perfino nelle particolarità economiche (ad esempio la ridistribuzione della proprietà reale e personale dopo la Rivoluzione francese) ho imparato più che da tutti gli storici, gli economisti, gli statisti di professione di questo periodo messi insieme.”
Perché tale giudizio è importante? Perché ci fa riflettere sul rapporto tra ideologia e letteratura: Balzac era politicamente un legittimista, eppure descrive i meccanismi economici molto meglio di qualsiasi “rivoluzionario” intento a cambiare la società.
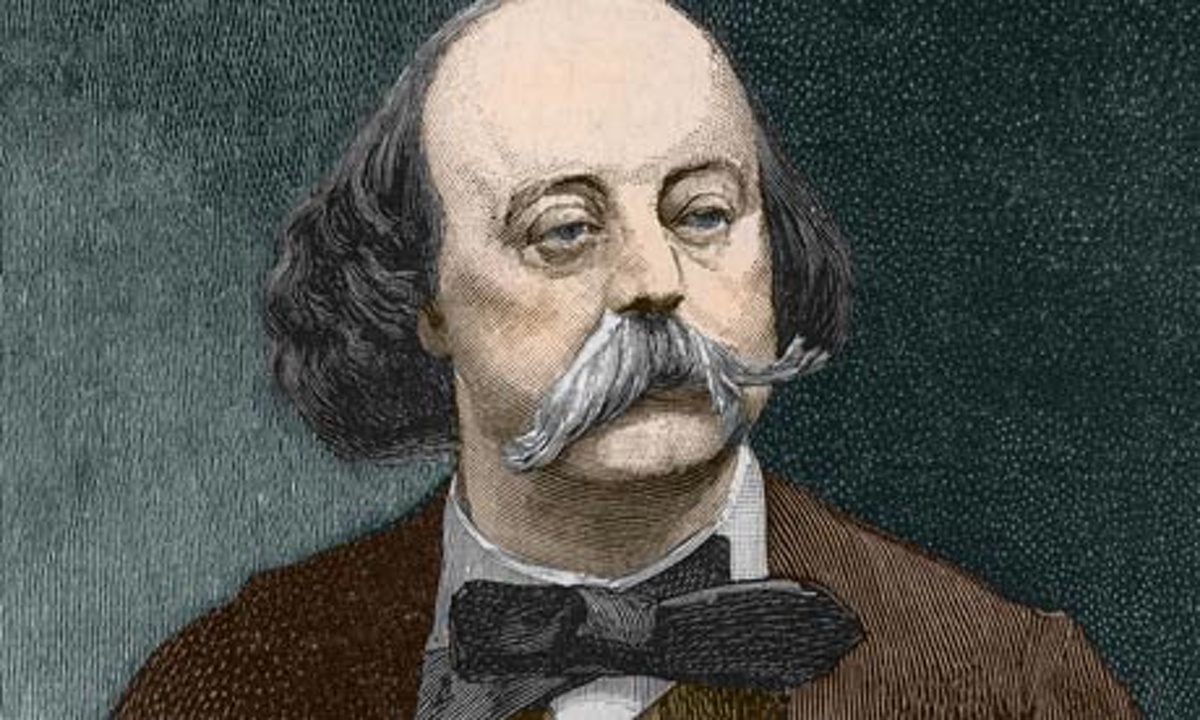
Gustave Flaubert
Gustave Flaubert (1921 – 1880) è certamente colui che meglio di qualunque altro ha saputo rappresentare il passaggio tra l’idealismo ed il realismo. Figlio della generazione successiva a quella di Stendhal e di Balzac egli vive pienamente le speranze e la seguente delusione della rivoluzione borghese del ’48 francese, la Restaurazione sotto Luigi Filippo e quindi il secondo Impero di Napoleone III, l’espansione economica e lo sviluppo delle forze democratiche e la nascita della filosofia positivista.
Sul piano culturale, gli anni ’50, vedono la reazione di un gruppo di intellettuali verso la libertà “stilistica e contenutistica” della letteratura romantica e realizzano una poesia in cui torna in auge la perfezione formale cercando un dettato di cristallina bellezza e di oggettiva descrizione, dove proprio al lirismo si contrappone il dettato di un oggettivo realismo depurato da ogni incrostazione sentimentale. Sono questi i cosiddetti “Parnassiani”. Questo può in parte spiegare la ricercatezza, oseremo dire, quasi maniacale verso la forma di scrittura di Flaubert, ma non ne limita la sua importanza quasi rivoluzionaria sul piano del romanzo europeo. Tale importanza è derivata proprio da un atteggiamento tipico della sua “personalità”. Attenti studi hanno rivelato che il sottofondo delle sue aspirazioni è prettamente romantico e questo si accorda in un primo momento con la sua giovinezza: la famiglia, le idee, la rivoluzione; poi la morte delle persone a lui molto care, il padre e la sorella (1846), l’involuzione ed il neo cesarismo napoleonico lo portano ad una forma di nevrosi che lo condurrà ad analizzare l’inevitabile scontro tra sogno e realtà, vivificandolo nella figura di Emma Bovary. Ma l’incapacità del personaggio è la sua, se arriverà a dire “Madame Bovary c’est moi”.
Charles Bovary, modesto medico di provincia, sposa in seconde nozze Emma Rouault, figlia di un proprietario terriero. Emma, il cui temperamento sognatore è stato nutrito dalle letture romantiche dell’adolescenza, è presto delusa dalla mediocrità del marito, che pure l’ama profondamente e dalla vita che gli offre. Comincia a intristire: Bovary, preoccupato del suo stato, si traferisce a Yonville, nella speranza che il cambiamento d’aria le giovi. A Yonville Emma è corteggiata da Léon, praticante notaio: ma il giovane non osa dichiararsi e parte per Parigi. Emma si lascia sedurre da Rodolphe Boulanger, un banale dongiovanni di provincia, e ha un breve periodo di felicità; ma non tarda a stancare l’amante con i suoi eccessi. Rodolphe, spaventato dall’idea di fuggire insieme, l’abbandona. Emma ne è sconvolta, e cerca freneticamente di stordirsi. A Rouen ritrova Léon, più ardito dopo il soggiorno parigino; convinta di riuscire a legarlo a sé, ben presto stanca anche lui. Comincia così la sua degradazione: si indebita con un usuraio, all’insaputa del marito e non sa come pagarlo. Chiede inutilmente aiuto a Léon e a Rodolphe; poi, disperata, si uccide. Charles Bovary, assillato dal ricordo della moglie, alla quale ha perdonato i tradimenti, si lascia lentamente morire.
IL CARCERE QUOTIDIANO
Per tenersi al corrente, si abbonò all’ “Alveare medico”, un giornale nuovo di cui gli erano pervenuti i prospetti; lo leggeva, in parte, dopo cena, ma il tepore della stanza, insieme con la fatica della digestione, facevano sì che in capo a cinque minuti, fosse addormentato; rimaneva là, con il mento appoggiato alle mani e i capelli arruffati come una criniera che arrivavano fino al piede della lampada. Emma lo guardava e alzava le spalle. Perché non aveva almeno per marito uno di quegli uomini accesi di taciturno fervore che lavorano di notte in mezzo ai libri e che, giunti ai sessant’anni, l’età dei reumatismi, portano finalmente una piccola spilla a forma di croce sull’abito nero di cattivo taglio? Emma avrebbe desiderato che il nome di Bovary, ora il suo nome, fosse illustre, le sarebbe piaciuto vederlo nelle librerie, leggerlo nei giornali, noto in tutta la Francia. Ma Charles non aveva ambizioni! Un medico di Yvetot, con il quale si era trovato ultimamente per un consulto, lo aveva quasi mortificato addirittura al capezzale del paziente e davanti a tutti i parenti riuniti. Quando Charles, la sera, raccontò il fatto, Emma si accalorò molto contro il collega del marito. Quest’ultimo fu intenerito dall’atteggiamento di sua moglie: la baciò sulla fronte con gli occhi pieni di lacrime. Ma Emma era esasperata e piena di vergogna, lo avrebbe preso volentieri a schiaffi. Andò nel corridoio, aprì la finestra e rimase a respirare l’aria fresca per calmarsi.
«Che disgraziato! Povero disgraziato!» ripeteva, mordendosi le labbra.
Si sentiva sempre più irritata dal suo modo di comportarsi. Con il passare degli anni Charles prendeva abitudini grossolane; alla fine del pranzo era solito tagliuzzare i tappi delle bottiglie vuote; dopo aver mangiato si passava la lingua sui denti. Sorbiva il brodo producendo gorgoglii chioccianti a ogni cucchiaiata, e, poiché cominciava a ingrassare, gli occhi, già piccoli, sembravano spostarsi verso le tempie, spinti verso l’alto dalle gote gonfie di adipe.
A volte Emma gli ricacciava nel panciotto il bordo rosso delle maglie, gli raddrizzava la cravatta o buttava via i guanti consumati che egli stava per infilare. Ma non faceva questo per lui, bensì per se stessa, per una specie di estensione del suo egoismo, di irritazione nervosa. Altre volte gli parlava di ciò che aveva letto, un brano di un romanzo, una nuova commedia o l’ultimo aneddoto sul gran mondo riportato dal giornale; dopotutto, Charles era qualcuno, un orecchio sempre disposto ad ascoltare, un’approvazione sempre pronta. La cagnolina stessa riceveva le sue confidenze ed ella ne avrebbe fatte anche ai ceppi del caminetto e al bilanciere della pendola.
In fondo al cuore continuava a sperare che accadesse qualcosa di diverso. Come i marinai in pericolo, volgeva sguardi disperati sulla solitudine della sua vita, cercando di scorgere una vela bianca lontana fra le brume dell’orizzonte. Non sapeva che cosa stava aspettando, quale vento avrebbe spinto verso di lei l’avvenimento desiderato, a quale lido l’avrebbe fatta approdare, se si sarebbe trattato di una scialuppa o di un vascello a tre ponti carico di angosce o pieno di felicità fino ai boccaporti. Ogni mattino, al risveglio, sperava che ciò avvenisse, proprio quel giorno, e ascoltava ogni rumore, si alzava di soprassalto, e si stupiva che ancora non accadesse nulla; poi, al tramonto, sempre più triste, desiderava di essere all’indomani.
Tornò la primavera. Emma provò a volte un senso di soffocamento, ai primi calori, quando fiorirono i peri. Fin dai primi giorni di luglio, cominciò a contare sulle dita quante settimane mancavano per arrivare al mese di ottobre, nella speranza che il marchese di Andervilliers forse avrebbe dato ancora un ballo alla Vaubyessard. Ma tutto il mese di settembre trascorse senza che giungessero lettere o visite.
Dopo quella delusione, il suo cuore rimase vuoto ancora una volta, e la serie delle giornate tutte uguali ricominciò.
Ormai si sarebbero susseguite dunque, così, tutte in fila, monotone, anonime, e senza portare con sé proprio nulla? Le altre esistenze, per quanto piatte fossero, avevano almeno la probabilità di un avvenimento imprevisto, e gli avvenimenti imprevisti provocano talora peripezie senza fine, e tutto cambia. Soltanto per lei non succedeva mai niente, Dio aveva voluto così! L’avvenire si presentava come un corridoio nero in fondo al quale v’era una porta sprangata.
Non si interessò più di musica. Perché sonare? Chi l’avrebbe ascoltata? Dal momento che non avrebbe mai potuto esibirsi con un abito di velluto con le maniche corte, a un concerto, su un pianoforte Erard, facendo correre le dita leggere sui tasti d’avorio, e sentire intorno a sé, circondarla come una brezza, un mormorio estatico, non valeva la pena di annoiarsi a studiare. Lasciò in fondo a un cassetto anche i fogli da disegno e i ricami. A che serviva? A che serviva? E poi, cucire la innervosiva.
“Ho già letto tutto” si diceva.
E restava lì a far arroventare le molle nella brace del camino o a guardar cadere la pioggia.
Che tristezza, la domenica, quando sonava il vespro! Ascoltava con una concentrazione attonita battere a uno a uno i rintocchi sordi della campana. Sul tetto un gatto camminava lentamente facendo la gobba, sotto i raggi di un pallido sole. Il vento sollevava nugoli di polvere sulla strada maestra. Di tanto in tanto, un cane lontano ululava: e la campana, a intervalli regolari, continuava i suoi rintocchi monotoni che si perdevano nella campagna.
Intanto la gente usciva di chiesa. Le donne avevano gli zoccoli lucidati, i contadini le bluse nuove, i bambini piccoli, senza cappello, saltellavano davanti a loro; tutti si avviavano verso casa. E fino a notte cinque o sei uomini, sempre gli stessi, restavano a giocare al turacciolo, davanti alla porta dell’osteria.
Fu un inverno freddo. I vetri, la mattina, erano coperti da uno strato di gelo e la luce che filtrava attraverso essi, biancastra come quella dei vetri smerigliati, si manteneva talvolta uguale per tutta la giornata. Alle quattro del pomeriggio bisognava già accendere il lume.
Nelle belle giornate, Emma scendeva in giardino. La brina aveva posato sui cavoli merletti d’argento con lunghi fili chiari che andavano da un cespo all’altro. Gli uccelli tacevano, tutto sembrava addormentato, la spalliera coperta di paglia, e la vigna, simile a un grande serpente malato sotto la sporgenza del muro, dove, avvicinandosi, era possibile scorgere i centopiedi trascinarsi sulle innumerevoli gambe. In mezzo agli abeti nani, il curato con il tricorno, che leggeva il breviario, aveva perduto il piede destro e il gesso, sfaldandosi con il gelo, gli aveva coperto di croste bianche il viso.
Poi rientrava, chiudeva la porta, attizzava il fuoco e abbandonandosi al calore del caminetto sentiva ripiombare su di sé, ancora più pesante, la noia. Desiderava scendere in cucina a chiacchierare con la domestica, ma una specie di pudore la tratteneva.
Tutti i giorni alla stessa ora il maestro di scuola, la berretta nera di seta sul capo, apriva le imposte di casa sua e la guardia campestre passava con la sciabola sul camiciotto. La sera e la mattina, i cavalli della posta, a tre a tre, attraversavano la strada per andare a bere al fontanile. Di tanto in tanto la campanella della porta di un’osteria tintinnava e quando c’era vento si sentiva cigolare sui ganci che lo reggevano il catino d’ottone che serviva da insegna alla bottega del barbiere. Questa bottega era decorata da una vecchia illustrazione di un giornale di moda incollata contro un vetro e da una testa femminile di cera dai capelli gialli. Anche il parrucchiere si lamentava della sua vocazione soffocata, del suo avvenire rovinato, e sognava una bottega in qualche grande città, come Rouen, per esempio, sul porto, vicino al teatro, e intanto passeggiava su e giù tutto il giorno, fra la chiesa e il municipio, imbronciato e in attesa di clientela.
Quando la signora Bovary alzava gli occhi, lo vedeva sempre là, come una sentinella, di guardia con la papalina di traverso e una giacca di raso.
Nel pomeriggio, talvolta, dietro i vetri della sala, nella via, compariva una testa d’uomo, dai favoriti neri e dal volto abbronzato, sul quale si stendeva lentamente un largo sorriso dolce che scopriva i denti bianchi. Subito si facevano sentire le note di un valzer e sopra l’organino, in una minuscola sala da ballo, ballerini alti un dito, dame in turbante rosa, tirolesi in giacchettino, scimmie in marsina nera, cavalieri in pantaloni a coscia giravano e giravano fra le poltrone, i divani, le mensole, moltiplicandosi nei pezzetti di specchio tenuti insieme da una carta d’oro. L’uomo girava la manovella guardando a destra e a sinistra e verso le finestre. Di tanto in tanto lanciava contro un paracarro un lungo getto di saliva scura e appoggiava su un ginocchio il suo strumento, la cui cinghia dura gli stancava la spalla; ora triste e lenta, ora gioiosa e veloce, la musica dell’organino si diffondeva attraverso una tendina di taffetà rosa o una grata di ottone ad arabeschi. Erano motivi in voga nei teatri, motivi che venivano cantati nei saloni, che accompagnavano, la sera, le danze sotto i lampadari splendenti, echi del mondo dai quali Emma veniva raggiunta. E allora sarabande senza fine si srotolavano nella sua mente: come una baiadera su un tappeto a fiori il suo pensiero saltellava con le note, ondeggiava di sogno in sogno, di malinconia in malinconia. L’uomo, dopo aver ricevuto l’elemosina che gli veniva gettata nel berretto, copriva l’organino con una vecchia coperta turchina, se lo passava sulla schiena e si allontanava con passo pesante. Emma lo guardava andar via.
Soprattutto all’ora dei pasti sentiva di non poterne più: in quella stanzetta al pianterreno, dove la stufa faceva fumo, la porta cigolava, i muri trasudavano e i pavimenti erano sempre umidi, le sembrava che tutta l’amarezza della sua esistenza le venisse servita nel piatto e, come il fumo del bollito, salivano dal fondo dell’anima sua altrettante zaffate di tedio insulso. Charles mangiava con lentezza, Emma sgranocchiava qualche nocciolina o si divertiva, appoggiata a un gomito, a disegnare linee con la punta del coltello, sulla tela cerata.
E’ evidente nel passo come, attraverso la tecnica del punto di vista interno, senza passare all’io narrante, egli riesca, con incredibile “precisione” a leggere i pensieri della sua giovane protagonista: tutto è visto attraverso gli occhi di lei, l’autore sparisce completamente, alienando da sé qualsiasi forma di commento. Probabilmente questo fece accusare l’autore di aver scritto un’opera amorale, in quanto legittimava l’adulterio, ma egli non invita ad alcuna azione: è talmente “preciso” nell’identificazione che si perde la capacità di distinguere tra autore e personaggio. E’ proprio questa capacità che fa di Emma una donna il cui nome diventa una vera e propria tipologia a cui si attribuisce, appunto, il nome di “bovarismo”: Insoddisfazione spirituale; tendenza psicologica a costruirsi una personalità fittizia, a sostenere un ruolo non corrispondente alla propria condizione sociale; desiderio smanioso di evasione dalla realtà, soprattutto in riferimento a particolari situazioni ambientali, sociologiche e sim. (Enciclopedia Treccani)
Se una forma di realismo che, grazie all’opera di Flaubert, affina sempre più le sue armi nella capacità di descrizione oggettiva è con i fratelli Edmond e Jules de Goncourt che trova la teorizzazione di un nuovo sentire che prenderà, appunto, il nome di “naturalismo”.
Questi due scrittori (Edmond, 1822-1896), Jules (1830 – 1870), nel romanzo Germanie Lacertaux (1865), programmano un nuovo compito che una narrazione deve assumere, quello di rappresentare scientificamente il degrado della società nei suoi strati più umili. Infatti la loro opera narra la storia di una serva, malata di isteria, che si degrada progressivamente, fino alla morte, per una passione amorosa. E’ ispirato ad un caso vero, quello di una domestica dei due fratelli.
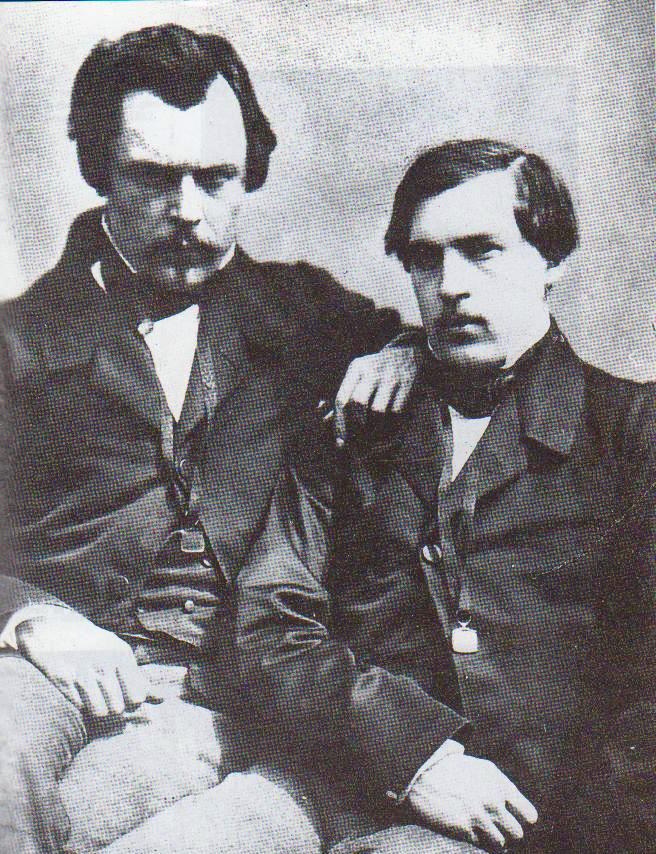
Fratelli de Goncourt
LA PREFAZIONE A GERMAINE LACERTAUX
Dobbiamo chiedere scusa al pubblico per questo libro che gli offriamo e avvertirlo di quanto vi troverà. Il pubblico ama i romanzi falsi: questo è un romanzo vero.
Ama i romanzi che dànno l’illusione di essere introdotti nel gran mondo: questo libro viene dalla strada.
Ama le operette maliziose, le memorie di fanciulle, le confessioni d’alcova, le sudicerie erotiche, lo scandalo racchiuso in un’illustrazione nelle vetrine di librai: il libro che sta per leggere è severo e puro. Che il pubblico non si aspetti la fotografia licenziosa del Piacere: lo studio che segue è la clinica dell’Amore.
Il pubblico apprezza ancora le letture anodine e consolanti, le avventure che finiscono bene, le fantasie che non sconvolgono la sua digestione né la sua serenità: questo libro, con la sua triste e violenta novità, è fatto per contrariare le abitudini del pubblico, per nuocere alla sua igiene.
Perché mai dunque l’abbiamo scritto? Proprio solo per offendere il lettore e scandalizzare i suoi gusti? No.
Vivendo nel diciannovesimo secolo, in un’epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo, ci siamo chiesti se le cosiddette «classi inferiori» non abbiano diritto al Romanzo; se questo mondo sotto un mondo, il popolo, debba restare sotto il peso del «vietato» letterario e del disdegno degli autori che sino ad ora non hanno mai parlato dell’anima e del cuore che il popolo può avere. Ci siamo chiesti se possano ancora esistere, per lo scrittore e per il lettore, in questi anni d’uguaglianza che viviamo, classi indegne, infelicità troppo terrene, drammi troppo mal recitati, catastrofi d’un terrore troppo poco nobile. Ci ha presi la curiosità di sapere se questa forma convenzionale di una letteratura dimenticata e di una società scomparsa, la Tragedia, sia definitivamente morta; se, in un paese senza caste e senza aristocrazia legale, le miserie degli umili e dei poveri possano parlare all’interesse, all’emozione, alla pietà, tanto quanto le miserie dei grandi e dei ricchi; se, in una parola, le lacrime che si piangono in basso possano far piangere come quelle che si piangono in alto.
Queste meditazioni ci hanno indotto a tentare l’umile romanzo di “Suor Filomena”, nel 1861; e adesso ci inducono a pubblicare “Le due vite di Germinia Lacerteux”.
Ed ora, questo libro venga pure calunniato: poco c’importa. Oggi che il Romanzo si allarga e ingrandisce, e comincia ad essere la grande forma seria, appassionata, viva, dello studio letterario e della ricerca sociale, oggi che esso diventa, attraverso l’analisi e la ricerca psicologica, la Storia morale contemporanea, oggi che il Romanzo s’è imposto gli studi e i compiti della scienza, può rivendicarne la libertà e l’indipendenza. Ricerchi dunque l’Arte e la Verità; mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi; faccia vedere alla gente della buona società quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere, quello che una volta le regine facevano sfiorare appena con gli occhi, negli ospizi, ai loro figli: la sofferenza umana, presente e viva, che insegna la carità; il Romanzo abbia quella religione, che il secolo scorso chiamava con il nome largo e vasto di Umanità; basterà questa coscienza: ecco il suo diritto.
Nello scrivere il romanzo i fratelli de Gouncourt si fondano su una ricerca rigorosa che vuole fare delle loro pagine un “documento umano”, cui le tecniche scientifiche di allora offrivano gli strumenti per renderlo, secondo le loro parole “vero”. Ma non è solo questo il loro intento. Si tratta, infatti, di trovare un nuovo soggetto per le classi popolari nel quale riflettersi. Sino ad allora esse erano state “abbindolate” da storie tardo romantiche dei feuilletons che apparivano sulle pagine dei giornali, creando falsi sogni (gli stessi di cui si era abbeverata Emma). Si trattava ora di prendere coscienza della loro triste condizione anche se gli argomenti, per tale scopo, dovevano essere degradati e brutti. Ciò fa del romanzo naturalista francese un’arma politica “progressista” legata alle lotte della popolazione sfruttata.
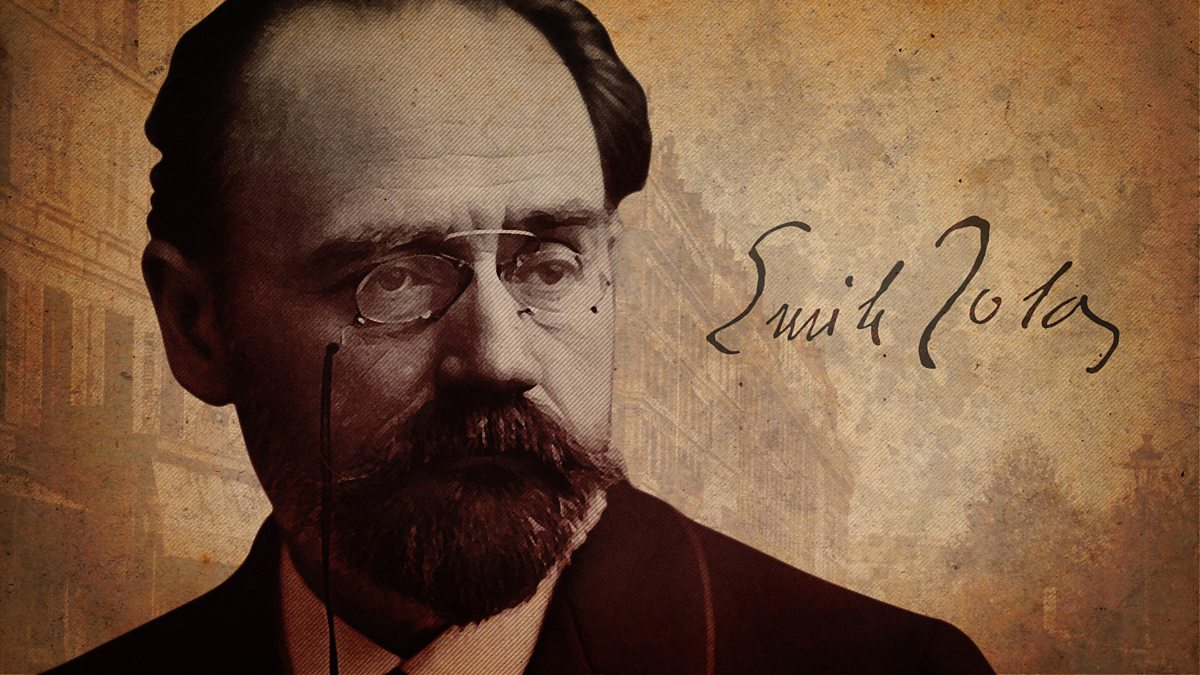
Émile Zola
Émile Zola (1840 – 1902) è il più grande narratore rappresentante della narrativa naturalista francese e non solo. Egli, prima di diventare scrittore, visse nella miseria, conoscendo a fondo la “reale” difficoltà economica che i ceti popolari dovevano subire. Lavora dapprima nella casa editrice Hachette, all’inizio come fattorino, poi con sempre maggiori responsabilità. Quindi si dedica alla professione di giornalista, che continua, poi, per tutta la vita. La pubblicazione di Teresa Raquin (1867) gli reca una certa popolarità e progetta, sulla scorta di Balzac, di scrivere un ciclo di romanzi cui rappresentare l’intera società francese, dalla degradazione più abietta alla società ricca borghese: tale ciclo prende il nome di I Rougon-Macquart, storia naturale e sociale di una famiglia sotto il secondo impero, che iniziato nel 1871 termina nel 1893 e comprende venti volumi. Tra questi i più importanti sono:
- Il ventre di Parigi (1873): descrizione della degradazione della popolazione povera parigina;
- L’Assomair (L’ammazzatoio) (1877): romanzo in cui si affronta il tema dell’alcolismo;
- Nanà (1880): rappresentazione della ricca e corrotta borghesia tramite la vita di una cortigiana;
- Germinal (1885): grandioso affresco della vita dei minatori;
- La bestia umana (1890): che ha per sfondo il mondo ferroviario.
Per esemplificare il “progressismo zoliano” e per sottolineare l’opera che è universalmente considerata come il capolavoro verista, scegliamo una pagina da Germinal:
La vicenda si svolge nel Nord della Francia tra il 1866 e il 1869. Stefano Lantier viene licenziato dall’officina meccanica in cui lavora per aver preso a schiaffi il suo principale. Arriva alla miniera del Voreux e viene assunto come minatore nella squadra di Maheu, di cui fanno parte anche tre dei suoi figli, Zaccaria, Caterina e il giovane Gianlino. Stefano subisce presto il fascino del “soffio di rivolta” che proviene dalla miniera, nonché della bella Caterina, ma essendo timido non riesce a esprimere i propri sentimenti alla ragazza, la quale inizia una relazione con il violento Chaval. A contatto con il miserabile mondo dei minatori, oppresso dallo sfruttamento e dalla miseria, Stefano si forma una propria coscienza politica. Le sue idee, vicine al socialismo riformista, si scontrano con quelle anarchico-rivoluzionarie dell’operaio russo Souvarine che, contrario a ogni forma di autorità, sogna l’abolizione dello Stato borghese e una nuova fratellanza tra gli uomini, da raggiungere anche attraverso la violenza. Quando la compagnia mineraria manifesta l’intenzione di ridurre i già magri salari, su incitamento di Stefano i minatori scendono in sciopero. Per vincere la resistenza degli operai, la compagnia assume manodopera dal Belgio e chiama l’esercito a difesa della miniera. Dopo due mesi la situazione precipita: i soldati sparano sulla folla dei minatori e delle loro famiglie, uccidendo tredici persone, tra le quali anche Maheu, il padre di Caterina. Sconfitti, gli operai sono costretti a tornare al lavoro. Chi non si arrende è l’anarchico Souvarine, che incurante del fatto che centinaia di operai stiano lavorando all’interno della miniera, sabota le impalcature; nel crollo muoiono molti minatori e tra essi anche Caterina. Stefano, rimasto illeso, decide di partire per Parigi per continuare lì la sua lotta politica, sicuro che un giorno le idee di giustizia e di uguaglianza possano trionfare.
I SOLDATI SPARANO SUGLI SCIOPERANTI
Allora, come a un segnale, la folla esplose in insulti, in imprecazioni. I pochi gridi che s’elevavano ancora di “Evviva i soldati! a morte l’ufficiale!” naufragarono presto nel clamore generale: “Abbasso le brache rosse!”
Ma sotto la gragnuola degli insulti, la truppa, irrigidita nella consegna, manteneva la stessa impassibilità, lo stesso silenzio con cui aveva accolto gli inviti a fraternizzare, gli amichevoli tentativi di insubordinazione.
Alle sue spalle, il capitano aveva sguainato la spada; e siccome la folla premeva sempre di più addosso agli uomini, minacciando di schiacciarli contro il muro, ordinò di incrociare le baionette. Una doppia siepe di punte d’acciaio accolse i petti dei dimostranti.
Arrestata: «Ah i mangiapani a ufo!» imprecò l’Abbruciata. Ma già, dopo aver indietreggiato un istante la folla si ributtava avanti, sprezzante della morte e come esaltata dal rischio.
Più di tutti s’esponevano le donne, incitate dalla Maheu e dalla Levaque che strillavano: «Uccideteci, uccideteci dunque! Vogliamo i nostri diritti.»
Levaque, a rischio di tagliarsi, aveva abbrancato tre baionette in una volta e dava strattoni, tirava a sé per disinastarle; con una forza che l’ira moltiplicava, le storceva, per spezzarle, le lame; mentre, pentito d’essersi lasciato indurre a seguirlo, placido Bouteloup lo guardava fare, tenendosi a rispettosa distanza.
«Fate, che vediamo! fate un po’ se ne avete il coraggio!» li sfidava Maheu; e si sbottonava la giacca, tirava via la camicia, offriva nudo il petto villoso. E spaventoso di insolenza e di coraggio si spingeva contro le baionette obbligando, per non infilzarlo, i soldati ad arretrare. E siccome la punta di una l’aveva ferito, come pazzo proprio contro quella incalzava: gli entrasse dentro, gli si conficcasse nel costato.
«Vigliacchi, non osate, eh! Dietro a noi ce ne sono diecimila come noi. Uccideteci pure; ve ne resteranno sempre da uccidere! Siccome i soldati avevano l’ordine di non sparare se non in caso di assoluta necessità, la loro situazione si faceva critica».
(…)
Ormai i dimostranti erano oltre cinquecento; ma a quelli che facevano sul serio s’erano mescolati dei curiosi che si divertivano a stare a vedere. Tra questi Zaccaria e la moglie, venuti lì come a uno spettacolo, al punto che s’eran tirati dietro i figlioli. Con un nuovo gruppo proveniente da Réquillart, arrivò col fratello la Mouquette; lui, adocchiato l’amico Zaccaria, sogghignando venne a dargli una manata sulle spalle; mentre la sorella, accesissima, correva a mettersi in prima fila coi più scalmanati.
Il capitano intanto lanciava continue occhiate sulla strada di Montsou; prevedendo che si troverebbe presto a malpartito se i rinforzi non arrivavano, l’ufficiale, per intimorire la folla, ordinò ai soldati di caricare i fucili. Ma la coperta minaccia ottenne solo di esasperare maggiormente gli animi; i dimostranti risposero al gesto con parole di sfida e di dileggio.
«Vedi?» le donne sghignazzavano. «Partono per i tiri, questi conigli vestiti da soldati!»
La Maheu si buttò avanti con tanto impeto che il sergente le chiese che ci venisse a fare lì con quel marmocchio in braccio; Estella infatti s’era svegliata e ora si aggrappava piangendo al seno della madre.
«Che te ne importa a te?» rispose lei. «Spara adesso, se n’hai il coraggio!»
Sprezzanti, gli uomini scotevano il capo: macché, non un colpo partirebbe. «Hanno cartucce a salve,» asserì Levaque. E Maheu: «Vorrei vedere anche questa! Che siam mica cosacchi? Non si tira sui compatrioti, perdìo!»
Altri osservavano che comunque, non facevano soggezione le pallottole a chi tornava, come loro, dalla campagna di Crimea. Per cui tutti seguitavano a buttarsi sui fucili, così pigiati che se in quel momento una scarica fosse partita, ne sarebbe seguìto un macello.
Alla Mouquette l’idea, l’idea sola, che dei soldati potessero sparare su delle donne, faceva veder rosso.
(…)
Allora, per calmare l’evidente nervosismo dei suoi uomini, il capitano procedette all’arresto dei più scalmanati; ma la Mouquette si sottrasse, sgattaiolando fra le gambe dei compagni. Levaque e altri due vennero condotti nella stanza dei capisquadra e lì guardati a vista. Di lassù intanto si sporgevano Négrel e Danseart e invitavano il capitano a far rientrare la truppa e a chiudersi dentro; ma l’ufficiale si rifiutò di farlo: le porte d’accesso alla ricevitoria non presentavano alcuna garanzia di resistenza a un assalto e a lui toccherebbe l’onta di vedersi disarmare.
Gli stessi soldati, d’altronde, avrebbero sentito come un disonore ritirarsi davanti a dei poveracci calzati di zoccoli.
Questo gesto di forza fece alla prima una certa impressione; ma un’impressione che durò poco. Bentosto un clamore s’alzò: la folla protestava contro l’arresto, esigeva l’immediato rilascio dei prigionieri; ai quali – già qualche voce gridava – si stava facendo la pelle. E, come al segnale d’un’azione concertata in anticipo, tutti, a un tratto, obbedendo a un impulso collettivo, corsero ad armarsi, da un cumulo lì vicino, di mattoni; i bambini recandone uno alla volta, le donne riempiendosene la sottana. In breve ogni dimostrante n’ebbe ai suoi piedi una provvista e il tiro cominciò. In testa alle donne si piantò l’Abbruciata; la vecchia spezzava i mattoni sull’ossuto ginocchio, e con la destra e la sinistra a vicenda li lanciava. A tirare, la Levaque si sfiancava: grassa com’era, disponeva di così poca forza che, per non mancare tutti i colpi, doveva esporsi; invano, nella speranza di ricondurla a casa, ora che il marito era all’ombra, Bouteloup la tirava indietro. Alla sassaiola, tutte si eccitavano. La Mouquette che a spezzare i mattoni sulla ciccia delle cosce se le era insanguinate, adesso li lanciava interi. Anche i ragazzi s’erano uniti alle donne; e Berto insegnava a Lidia come si tirava meglio, lanciando di sotto in su a gomito piegato. E i proiettili fioccavano, grandinavano, abbattendosi con sordi tonfi. Trascinata dall’esempio, tutto a un tratto anche Caterina si trovò in prima fila, a lanciare anche lei tra quelle furie i suoi spezzoni con tutta la forza delle magre braccia.
(…)
Sotto il grandinare dei mattoni, la poca truppa spariva. Fortuna che i proiettili passavano quasi tutti sopra le teste; di colpi, lì dietro, il muro era sforacchiato. Un attimo l’idea di ritirarsi, fece salire il sangue al viso dell’ufficiale ma per farlo era tardi; al minimo cenno di ripiegamento, la folla gli avrebbe fatto gli uomini a pezzi. Lui perdeva sangue dalla fronte, per un mattone che gli aveva spaccato la visiera. Nelle file, parecchi erano i feriti; l’esasperazione era giunta al limite oltre il quale l’istinto di conservazione prende il sopravvento sul sentimento di disciplina. A una mazzata che quasi gli aveva slogato la spalla, il sergente aveva smozzicato una bestemmia. La recluta, col viso scorticato in due punti e un pollice stritolato, non poteva più reggersi su un ginocchio senza vedere le stelle; che ci si sarebbe prestati ancora un pezzo a fare i fantocci da tiro a segno? Un colpo di rimbalzo aveva raggiunto all’inguine il veterano, che, dallo spasimo, s’era quasi lasciato sfuggir di mano lo schioppo. Più di una volta già il capitano era stato lì per ordinare il fuoco e tutte le volte era riuscito sinora a dominarsi. E solo adesso, davanti all’infierire dei forsennati, apriva per farlo la bocca, quando i fucili spararono da sé: prima tre colpi; poi cinque; poi una scarica intera; infine, un colpo in ritardo, che echeggiò isolato nel sepolcrale silenzio.
Lo sbalordimento impietrò un attimo la folla. La truppa aveva dunque sparato? A bocca aperta, ne dubitava ancora, quando, con lo squillo di cessato fuoco, lacerarono l’aria le grida dei feriti. Allora, allo stupore, sottentrò il panico; fu un impazzito sbandarsi, un fuggi fuggi generale. Ai primi tre colpi, Berto e Lidia s’erano afflosciati uno sull’altro: la piccina, colpita al viso; lui, attraversato da una pallottola sotto la clavicola sinistra. Lidia, fulminata, non si moveva più; lui invece si trascinava, cercava, nelle convulsioni dell’agonia, di prendere fra le braccia l’altra, quasi a rinnovare il loro unico abbraccio. E Gianlino che, arrivato finalmente da Réquillart, sgambettava gonfio di sonno tra il fumo degli spari, capitò giusto in tempo per assistere a quell’abbraccio e veder Berto spirare. I cinque successivi colpi avevano abbattuto l’Abbruciata e Richomme. Questi, ferito al dorso e caduto in ginocchio, s’era rovesciato su un fianco; e ora rantolava per terra, col pianto ancora negli occhi. La vecchia, con la gola squarciata, era crollata da ritta con un sinistro scricchiolio di vecchia carcassa; uno sbocco di sangue le aveva strozzato in bocca l’ultima bestemmia A questo punto lo scroscio di fucileria aveva spazzato il terreno e falciato nel raggio di cento passi i capannelli di curiosi che ridevano alla battaglia. Una pallottola era entrata in bocca a Mouquet, che, stramazzando ai piedi di Zaccaria e Filomena, aveva spruzzato di sangue i due bambini. Nello stesso istante, la Mouquette riceveva due pallottole nel ventre. Vedendo i soldati spianare il fucile, istintivamente la ragazza, nel suo buoncuore, s’era buttata davanti a Caterina, gridandole di ripararsi; il colpo ricevuto in sua vece, con un urlo l’aveva fatta cadere lunga distesa sulle reni. Stefano accorse per rialzarla; ma lei d’un segno gli fece capire che non ne valeva la pena. E finché non ebbe finito di rantolare, seguitò a sorridere a lui e a Caterina, come se, andandosene, fosse felice di vederli insieme.
Tutto pareva finito, anche l’eco dello scroscio s’era perduto lassù contro la facciata delle case operaie, quando partì quell’ultimo sparo isolato. Colpito in pieno cuore, Maheu girò su se stesso e cadde bocconi con la faccia in una pozzanghera. Senza capire, la moglie si chinò: «Ehi, vecchio, che fai? Sta’ su! Non hai mica niente, eh?» Per voltargli la faccia, dovette mettersi Estella sotto il braccio: «Parla, dunque! hai male da qualche parte?» Maheu aveva lo sguardo vacuo; alla bocca, una schiuma sanguigna. Allora la donna capì. Si calò nel fango a sedere; e tenendo sotto il braccio la bambina come un involto, restò a guardare il suo uomo inebetita.
Lo spiazzo davanti alla miniera era sgombro. Livido, ma senza dare altrimenti a divedere turbamento per il disastro della sua vita, il capitano s’era tolto, poi rimesso d’un gesto secco il chepì sfondato; mentre con la stessa impassibilità i suoi uomini ricaricavano i fucili. Alla finestra della ricevitoria, s’erano sporte un attimo le facce sgomente di Négrel e di Danseart; e dietro di loro s’era intravisto Souvarine: una ruga gli sbarrava la fronte, come a ribadirvi il chiodo d’un’idea fissa. All’imbocco lassù del borgo operaio, Bonnemort pareva una statua; calava una mano sul bastone, con l’altra si faceva schermo agli occhi, come per non perdere nulla del massacro dei suoi.
I feriti urlavano; i morti si irrigidivano, marionette cui s’è rotto il filo tra le pozzanghere e le chiazze di carbone che il disgelo scopriva. E in mezzo a quei cadaveri d’uomini rattrappiti e come rimpiccioliti, magri dell’atroce magrezza della fame, – sinistro ammasso di carname, spiccava la carogna di Trombetta. A fianco di Caterina, Stefano, rimasto illeso, aspettava ancora che la ragazza, venuta meno per il dolore e la stanchezza, fosse in grado di alzarsi, quando il tonare d’una voce lo fece trasalire. Era il reverendo Ranvier che tornava da dir messa; e che, agitando le braccia in aria, invocava sugli assassini la punizione del Cielo. Come invaso da furore profetico, annunziava prossimo sulla terra l’avvento del regno della giustizia, la scomparsa della borghesia, sterminata dal fuoco celeste; di quella borghesia che metteva il colmo alla sua iniquità facendo massacrare i lavoratori e i diseredati di questo mondo.
Germinal, il cui titolo riprende il nome dato al mese di aprile dalla Rivoluzione Francese, descrive le brutali condizioni di sfruttamento nelle quali vivevano i minatori francesi a fine Ottocento. Per farlo, Zola si documenta sulla vita di miniera e su alcuni scioperi svoltisi nel 1869, sfociati in scontri tra minatori e soldati. Per poter descrivere in maniera oggettiva la vita dei minatori, Zola trascorre con loro alcuni giorni nelle baracche e scende perfino nei pozzi minerari.
Egli vede nei minatori la forza che potrà far sorgere una nuova epoca e una nuova forza, quella “proletaria”, con il compito di cambiare il mondo.
Il brano coglie i minatori del centro minerario di Montsou nel momento cruciale di uno sciopero che dura da due mesi: a difesa della miniera è stato schierato l’esercito, davanti al quale si agita una folla composita e urlante, piena d’odio nei confronti dei padroni della miniera e dei soldati posti lì a loro difesa. Prevale la descrizione dei comportamenti collettivi dei due gruppi che si fronteggiano. La massa dei minatori si infiamma in maniera compatta, a gara contrasta i soldati in un miscuglio incontenibile di voci, urla, spintoni. A loro volta i soldati si trovano di fronte a una situazione senza via d’uscita: non vogliono sparare su dei civili, ma non vogliono neanche subire la loro furia (molti militari sono rimasti feriti da un lancio di mattoni). Espressione di questa difficile scelta è il comportamento del capitano e dei suoi uomini: il primo non si decide a «ordinare il fuoco», ma quando sta per dare l’ordine «i fucili spararono da sé». La descrizione dell’eccidio, cruda e violenta, punteggiata di dettagli brutali, è particolarmente potente e realistica.
Anche qui troviamo applicate da Zola messe in pratica le teorie del Naturalismo: l’impersonalità, che prevede l’assenza di commenti da parte dell’autore, per non alterare l’oggettività della narrazione; le parole dei personaggi sono riportate per lo più attraverso il discorso diretto; mentre le parti narrative sono caratterizzate da un linguaggio analitico, preciso nelle descrizioni.
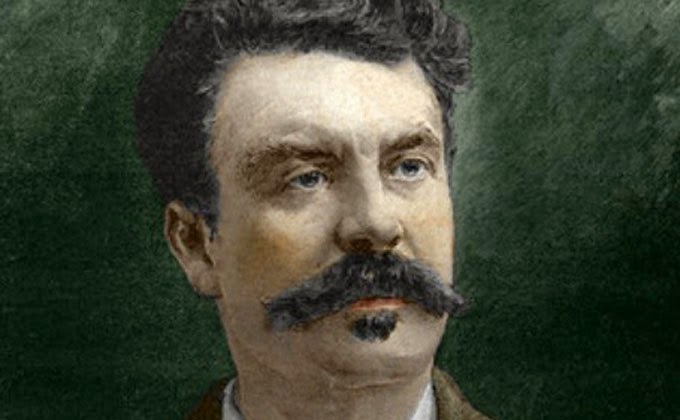
Guy De Maupassant
Guy De Maupassant (1850 – 1893) è l’autore naturalista francese che sviluppò la sua capacità narrativa nel genere “racconto”, arrivando ad esiti straordinari che tanta fortuna hanno poi avuto nello sviluppo della narrazione breve.
Figlio di un padre violento e di una madre nevrotica ebbe una vita difficile, rattristata per di più dalla follia del fratello. Divenne amico di Flaubert che lo introdusse nei salotti letterati e trascorreva il tempo dividendosi tra giornalismo e le gite sulla Senna in compagnia di amici e canottieri. Le sue composizioni letterarie si esercitarono, come già detto, in più di trecento novelle, che divise in più raccolte; ma compose anche due famosi romanzi Una vita (1883) e Bel-Ami (1885). Morì nel 1893, dopo esser stato colpito da una crisi di follia, in una clinica psichiatrica. Il suo primo racconto Boule de suif, pubblicato nel 1800, è considerato, ancora oggi, il suo capolavoro:
La storia racconta la vicenda di una di quelle che vengon chiamate allegre, Palla di sego (questo il soprannome della protagonista), durante l’occupazione prussiana viaggia in diligenza verso Le Havre, con rispettabili signori borghesi, un “democratico”, due suore; il viaggio però viene interrotto da un ufficiale prussiano che minaccia di non far proseguire il convoglio se Palla di sego non gli si concede. Dopo un giorno intero di discussioni, i viaggiatori riescono a convincere la prostituta a sacrificarsi. Ma quando il viaggio riprende, si crea il vuoto intorno a lei: le suore pregano, le signore dell’alta società la osservano con occhi di condanna, il democratico fischietta la Marsigliese.
PALLA DI SEGO
Finalmente, appena la diligenza fu attaccata, con sei cavalli al posto di quattro, a causa del tiro più faticoso, una voce dal di fuori chiese: «Son saliti tutti?» Una voce da dentro rispose: «Sì.» La diligenza partì.
Andavano avanti piano piano, di passo. Le ruote affondavano nella neve, tutta l’ossatura gemeva tra sordi scricchiolii: le bestie scivolavano, soffiavano, fumavano; e la gigantesca frusta del cocchiere schioccava incessantemente, volteggiando da ogni lato, e svolgendosi come un sottile serpente, d’improvviso attorcigliandosi sulle groppe piene, che si tendevano in uno sforzo più violento.
A poco a poco la luce aumentava. I leggeri fiocchi, che un viaggiatore – autentico figlio di Rouen – aveva paragonato ad una pioggia di cotone, non cadevano più. Una sporca luce filtrava attraverso i nuvoloni scuri e pesanti che facevano apparire più splendida la bianchezza della campagna dove ogni tanto appariva una fila di grandi alberi coperti di brina, o una capanna incappucciata di neve.
Nella diligenza i passeggeri si guardavano incuriositi al triste chiarore dell’alba.
In fondo, ai posti migliori, sonnecchiavano uno di fronte all’altro i coniugi Loiseau, venditori di vino all’ingrosso in via Grand-Pont.
Già commesso d’un mercante che s’era rovinato con gli affari, Loiseau ne aveva comprato il magazzino, e aveva fatto fortuna. Vendeva a pochissimo prezzo dei vini pessimi ai piccoli minutanti di campagna, ed era considerato, dai conoscenti e dagli amici, un furbo di tre cotte, un vero normanno astuto e gioviale.
La sua fama di mariolo era così salda, che una sera, alla Prefettura, il signor Tournel, rinomato autore di barzellette e di canzoncine, spirito sottile e mordace, una celebrità locale, vedendo le signore un po’ insonnolite, aveva proposto di giocare a “Loiseau vole”: la freddura attraversò i salotti del prefetto, arrivò in quelli di città, e fece ridere per un mese tutte le ganasce della provincia.
Loiseau, inoltre, era famoso per i suoi scherzi d’ogni genere, per le sue spiritosaggini buone e cattive; e nessuno parlava di lui senza aggiungere: «Quel Loiseau, non ce n’è un altro come lui».
Basso di statura, aveva la pancia a pallone sormontata da un viso rubicondo tra le fedine brizzolate.
Sua moglie, alta, robusta, risoluta, forte di voce e rapida nel decidere, rappresentava l’ordine e la contabilità della ditta, che animava con la sua allegra attività.
Accanto ad essi, più dignitoso, perché appartenente ad una casta superiore, stava il signor Carré-Lamadon, persona ragguardevole, ben collocato nei cotoni, proprietario di tre filande, ufficiale della Legion d’Onore e membro del Consiglio generale. Finché era durato l’Impero, era stato a capo dell’opposizione benevola, soltanto per farsi pagar più cara la sua adesione alla causa che egli – per usare la sua espressione – combatteva ad armi cortesi. La signora Carré-Lamadon, assai più giovane di lui, era la consolazione degli ufficiali di buona famiglia mandati di guarnigione a Rouen. Stava di fronte al marito, molto vezzosa, molto carina, raggomitolata nella pelliccia, e guardava con occhio afflitto l’interno desolato della diligenza.
I suoi vicini, il conte e la contessa Hubert de Bréville, portavano uno dei nomi più antichi e più nobili di Normandia. Il conte, vecchio gentiluomo di grande stile, cercava di accentuare con palesi accorgimenti la sua naturale somiglianza con il re Enrico IV il quale, secondo una gloriosa leggenda di famiglia, avrebbe ingravidato una signora di Bréville per cui il marito di quest’ultima fu fatto conte e governatore di una provincia.
Collega di Carré-Lamadon al Consiglio generale, il conte Hubert rappresentava nel dipartimento il partito orleanista. La storia del suo matrimonio con la figlia d’un piccolo armatore di Nantes era sempre rimasta misteriosa. Ma siccome la contessa aveva gran tono, sapeva ricevere meglio di chiunque, – si diceva pure che fosse stata benvoluta da un figlio di Luigi Filippo – era ricercata dalla nobiltà e il suo salotto era il primo della regione, l’unico dove fosse sopravvissuta l’antica cortesia e dove fosse difficile entrare.
Si dice che il patrimonio dei Bréville, tutto in beni immobili, fruttasse cinquecentomila lire di rendita.
Queste sei persone, che occupavano il fondo della carrozza, rappresentavano la parte della società fornita di rendite, serena e forte, la gente onesta provvista di Religione e di Principii.
Per una strana combinazione tutte le donne stavano sullo stesso sedile; le altre vicine della contessa erano due suore che sgranavano lunghi rosari biascicando paternostri e avemarie. La prima era vecchia, e aveva il viso butterato dal vaiolo, come se le avessero sparato una scarica di mitraglia a bruciapelo. L’altra, dall’aria molto patita, aveva una testina graziosa e malaticcia su un petto da tisica consumata dalla fede divorante che crea i martiri e gli esaltati.
Di fronte alle due suore, un uomo e una donna attiravano tutti gli sguardi.
L’uomo, assai noto, era Cornudet il democratico, il terrore delle persone perbene. Da vent’anni egli inzuppava il suo barbone fulvo nella birra di tutti i caffè democratici. S’era mangiato, insieme ai fratelli e agli amici, un bel gruzzolo, ereditato dal padre pasticciere, e aspettava con impazienza la venuta della repubblica per ottenere finalmente il posto che s’era meritato con tante bevute rivoluzionarie.
Il quattro di settembre, forse in seguito a uno scherzo, credette d’essere stato nominato prefetto, ma quando tentò d’insediarsi, gli uscieri, rimasti arbitri della situazione, si rifiutarono di riconoscerlo, costringendolo ad andarsene. Buon compagnone, d’altronde, inoffensivo e servizievole, s’era incaricato, con ardore senza pari, d’organizzare la difesa. Aveva fatto scavare delle buche, nelle pianure, aveva fatto abbattere i giovani alberi delle foreste vicine, aveva seminato trappole su tutte le strade, e all’avvicinarsi del nemico, soddisfatto dei suoi preparativi, aveva ripiegato in fretta verso la città. Pensava, ora, di essere più utile a Le Havre, dove sarebbero state necessarie nuove fortificazioni.
La donna, una di quelle che vengon chiamate allegre, era rinomata per la sua floridezza, che le aveva procurato il soprannome di Pallina. Piccina, tutta tonda, grassa grassa, con le dita rigonfie strozzate alle falangi, simili a rosari di salsicciotti, aveva la pelle lustra e tesa, un enorme seno che le gonfiava il vestito: pure, era appetitosa e desiderata, tanto piacevole a vedersi era la sua freschezza. Il suo viso era una mela rossa, un bocciolo di peonia vicino a schiudersi; vi si aprivano, in alto, due magnifici occhi neri ombreggiati da lunghe e folte ciglia, e sotto una bella bocca piccola, umida, da baci, guarnita di dentini lucenti e microscopici.
Ella aveva inoltre – si diceva – moltissime inestimabili qualità.
Appena la riconobbero, indignati bisbiglii corsero tra le donne oneste, e le parole «prostituta», e «vergogna pubblica» furono pronunciate così forte ch’ella alzò il capo, e fece scorrere sui vicini uno sguardo così ardito e provocante che subito si fece un gran silenzio, e tutti abbassarono gli occhi, eccettuato Loiseau, il quale la guardava eccitato.
 Paul Emile Boutigny: illustrazione per Boule de Suif (titolo originale della novella)
Paul Emile Boutigny: illustrazione per Boule de Suif (titolo originale della novella)
E’ la parte centrale, quella che qui viene riportata, in cui, con un tratto di penna l’autore ci descrive l’insensatezza e l’ipocrisia di ciò che quel piccolo microcosmo dentro la diligenza, ma che sembra rappresentare, agli occhi dell’autore, l’intera società, considera il bene ed il male. Nel brano su riportato è la posizione all’interno della diligenza a diventare sintomatica: i piccolo borghesi che abitano la carrozza si siedono prepotentemente dalla parte dei buoni e lasciano dal lato opposto la ragazza che per vivere usa il suo corpo, ma che ha energia, ideali e altruismo da vendere. L’iniziale illusione di poter entrare a far parte della schiera dei “giusti” (offre da mangiare ai compagni di viaggio che non vi avevano provveduto, acconsente a giare con l’ufficiale prussiano, per permettere loro un viaggio sicuro) è seguita da una brusca ricaduta, Palla di sego torna a essere una reietta. Guy De Maupassant lascia parlare i fatti: non è la posizione sociale, il lavoro che troppe volte – per necessità – ci si trova a svolgere…non è il privilegio di nascita, il conto in banca, la casa, gli abiti, gli oggetti…sono altre le cose che qualificano una persona! I cosiddetti “giusti”, spesso, sono più meschini e ipocriti, decisamente più deplorevoli e detestabili di coloro che sono costretti a viaggiare sulla corsia opposta.
Inghilterra
L’Ottocento inglese non vede trascolorare vari periodi culturali ben definiti, come abbiamo visto in Francia che, senza soluzione di continuità passa da un realista “romantico” come Stendhal ad un naturalista come Zola. Infatti tale periodo è quasi tutto interamente dominato dalla regina Vittoria, che permea di sé quasi l’intero secolo. Durante il suo regno, l’Inghilterra vede un incremento del già avviato processo industriale, ottenuto anche attraverso lo sfruttamento di un sempre crescente uso di manodopera infantile. Sarà proprio questo l’argomento che sarà materia del più grande ed esemplare narratore inglese, Charles Dickens.
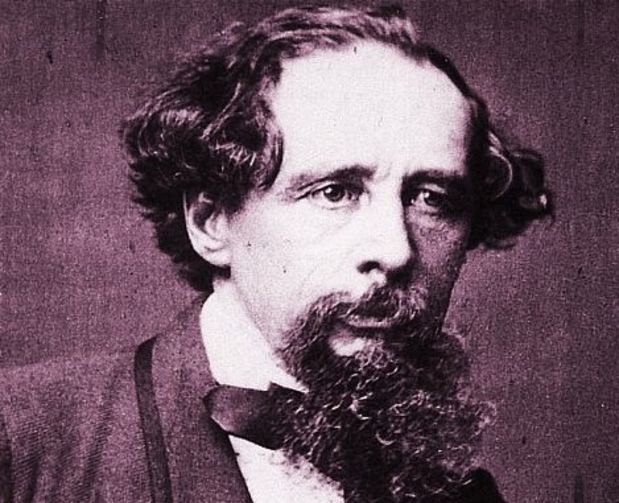
Charles Dickens
Charles Dickens (1812 – 1870), la cui infanzia e adolescenza passa da avide letture a lavori degradanti, non può non conservare che un vivido ricordo delle sue condizioni da bambino e di tutti gli altri minori occupati nelle fabbriche. Riscattatosi grazie alla sue capacità, farà di essi l’oggetto della sua narrativa, ma non riuscirà mai né radicalizzare i racconti, tanto da farli diventare grimaldelli con cui incentivare una lotta sociale, in quanto la sua cifra (e quella della stessa regina Vittoria) si ferma ad un umanitarismo riformistico, ben lontano dalle quelle che saranno le denunce zoliane. Tale caratteristica è forse anche dovuta al modo di fruizione dei romanzi di Dickens: quasi l’intera sua produzione uscì a puntate in riviste, dapprima di altrui proprietà, poi edite da lui stesso. Ciò fa sì che il suo pubblico non possa che essere piccolo-borghese, ben consapevole di un necessario aiuto alle classe inferiori, ma ben lontano da qualsiasi rigurgito ribellistico.
Uno dei suoi romanzi più famosi è certamente il David Copperfield, del 1849:
La storia ripercorre per intero la vita di David. Nel 1820 sei mesi dopo la morte del padre, David vive felicemente solo con la madre e la buona governante Peggotty. Quando ha ormai compiuto sette anni, la madre, sentendosi sola, si risposa con Mr. Murdstone, un uomo severo, freddo e inflessibile; ancora più intrattabile e crudele è sua sorella zitella Jane Murdstone, che viene a vivere con loro. Il bambino non prova alcuna simpatia né per il patrigno né per la sorella di lui, e costoro non accettano il suo atteggiamento. Murdstone, con la scusa che il figliastro non è abbastanza diligente negli studi, non esita a picchiarlo, affermando che ciò non può fargli altro che bene. Tuttavia, a seguito di una di queste frequenti punizioni corporali, David gli morde una mano e a quel punto, per infliggergli un ulteriore castigo, il patrigno allontana il bambino dalla madre mandandolo in un collegio privato gestito da un suo conoscente. Qui David fa la conoscenza di Steerforth, un ragazzo più grande ammirato dalla maggior parte degli alunni, e il compagno Traddles, che rimarrà uno dei suoi migliori amici. Il severo e spietato preside Creakle è autore di continue angherie contro i ragazzi e, spesso e volentieri, fa anch’egli ricorso alle punizioni corporali. Tornato a casa per le vacanze, David trova un nuovo fratellino e una madre completamente oppressa dal marito, succube e priva di volontà, che muoiono entrambi poco tempo dopo. Poco dopo inizia a subire pressioni e violenze psicologiche attuate nei suoi confronti da Mr. Murdstone e sua sorella. David è di conseguenza costretto a lasciare il collegio: viene mandato a lavorare come garzone in una fabbrica situata a Blackfriars, il cui proprietario è un commerciante di vini amico e socio d’affari di Mr. Murdstone. Intanto, la ex governante Peggotty si sposa con Mr. Barkis. In questo periodo, il giovane David alloggia presso la famiglia Micawber. Mr. Micawber (tanto buono e innocuo quanto finanziariamente inetto), non essendo in grado di badare alle spese di casa, è arrestato per debiti, dove rimane parecchi mesi prima d’essere rilasciato trasferendosi con l’intera famiglia a Plymouth. David decide di scappare da Londra per raggiungere la casa della zia a Dover. Dopo mille avventure raggiunge l’abitazione di questa, l’unica parente che gli è rimasta, l’eccentrica e capricciosa ma affettuosa Betsey Trotwood (maritata, pur vivendo separata dal marito); costei ospita in casa uno strano coinquilino chiamato Mr. Dick e una giovane domestica, Janet. Nonostante il tentativo perpetrato da Murdstone di riottenere la custodia del figliastro, la vecchia zia lo accoglie con sé. Col prezioso aiuto di Mr. Dick, Mrs. Betsey riesce a pagare a David gli studi e l’affitto di una stanza presso l’avvocato Wickfield, dove il ragazzo diventa confidente della figlia di lui, Agnes. Rivede anche l’amico Steerforth, al quale, durante una visita compiuta insieme da Peggotty, presenta l’amica d’infanzia Emily, nipote adottata della sua ex governante. Il romantico ma egoista Steerforth seduce a insaputa dell’amico la giovane Emily: la ragazza era promessa al cugino Ham e poco tempo prima delle nozze i due amanti fuggono nella notte, portando la disperazione in casa Peggotty. Peggotty si dedica a lungo a ricercare le tracce della nipote, che alla fine viene ritrovata grazie ad un’amica (una prostituta di nome Martha Endell). Emigrano in Australia con i Micawber, ma Emily non si sposa più. Terminati gli studi, David incomincia il tirocinio presso lo studio legale “Spenlow e Jorkins” e conosce la figlia di Spenlow, Miss Dora, finendo per innamorarsene. Deve al contempo guardarsi dal subdolo, viscido, arrivista e fraudolento impiegato Uriah Heep, i cui misfatti vengono alla fine rivelati grazie all’aiuto del provvidenziale Micawber. David diventa cronista parlamentare e sposa la bella ma ingenua Dora. Dopo qualche anno la moglie muore a causa d’un aborto spontaneo, e David si ritrova da solo nei momenti più difficili. In questo frangente David scopre le virtù di Agnes e inizia a provare un intenso e sincero affetto per lei. Alla fine del libro David sposa Agnes, che da sempre era segretamente innamorata di lui. Troveranno così la felicità: avranno quattro figli, e alla bambina daranno il nome della zia Betsey.
LA DURA SCUOLA DELLA VITA
Sono ora così esperto del mondo, che quasi non so più meravigliarmi di nulla; ma pure mi fa una certa sorpresa pensare che si potesse a quell’età così facilmente abbandonarmi. Ragazzo pieno d’intelligenza e dotato di acute facoltà d’osservazione, vivo, ardente, delicato, estremamente sensibile fisicamente e mentalmente, sembra strano che nessuno si scomodasse a muovere un dito per aiutarmi. Ma nessuno si scomodò; ed io diventai, a dieci anni, un piccolo lavorante, in servizio della ditta Murdstone e Grinby.
Il magazzino di Murdstone e Grinby era sulla riva del fiume, giù a Blackfriars. I moderni restauri hanno cambiato la faccia ai luoghi; ma era nell’ultima casa in fondo a una stradetta angusta, che s’incurvava e discendeva sino al fiume, con alcuni scalini all’estremità, per chi doveva pigliare una barca. Vecchia e decrepita costruzione, con una banchina propria che si sporgeva sull’acqua quando la marea era alta, e nel fango quando la marea era bassa, era tutta quanta invasa letteralmente dai topi. Le stanze coi pannelli scolorati dal sudiciume e dal fumo, forse, d’un centinaio d’anni; i pavimenti e le scale in rovina; le strida acute e le mischie dei vecchi topi grigi nei sotterranei, e il sudicio e il putridume di quel luogo son nel mio spirito cose non di molti anni fa, ma di questo momento. Mi son tutte presenti innanzi, come nella mala ora che le vidi la prima volta, con la mano tremante in quella del signor Quinion.
Il commercio della ditta Murdstone e Grinby comprendeva varie specie di traffici, ma il più importante era costituito dalla fornitura di vini e liquori a una certa Compagnia di battelli, che non so dove andassero principalmente, ma dei quali alcuni di certo approdavano alle Indie Orientali e Occidentali. So che un effetto di quel commercio era una gran quantità di bottiglie vuote, che certi uomini e certi ragazzi erano occupati ad esaminare contro luce e, dopo aver messe da parte le incrinate, a risciacquarle e lavarle. Quando non c’erano bottiglie vuote, c’era da incollar le etichette sulle piene, o da ficcare i turaccioli adatti, o da suggellare i turaccioli, o da schierare in cassette le bottiglie coi turaccioli già suggellati. Tutto questo io dovevo fare, e fui uno dei ragazzi così occupati. Ve n’erano tre o quattro, con me. Il mio posto di lavoro fu fissato in un angolo del magazzino, dove il signor Quinion poteva vedermi, se gli piaceva di salire sull’ultimo piolo del suo sgabello, attraverso una finestra a fianco del tavolino. Ed ivi fu chiamato, la prima mattina di quella mia nuova vita, che cominciava sotto così favorevoli auspici, il maggiore dei ragazzi, perché m’insegnasse il mestiere. Si chiamava Mick Walker, e portava un grembiule sbrindellato e un berretto di carta. Mi raccontò che suo padre era battelliere, e prendeva parte, con un berretto di velluto, alla processione del Lord Mayor. M’informò inoltre che noi avevamo come compagno un altro ragazzo, e me lo presentò col nome straordinario di Fecola di Patate. Scopersi, però, che quel nome non gli era stato dato a battesimo, ma appiccicato nel magazzino, per il color del suo viso, che era pallido d’un bianco di farina. Il padre di Fecola era barcaiuolo, ma anche pompiere in un gran teatro, dove una giovane parente di Fecola – forse la sorellina – rappresentava i folletti nelle pantomime. Non c’è parola che possa esprimere la mia segreta angoscia nell’ora che mi trovai precipitato fra quella gente. Confrontavo quelli che oramai sarebbero diventati i miei compagni d’ogni giorno con quelli della mia infanzia più felice – per non dire con Steerforth, Traddles, e gli altri; e sentivo crollar tutte le speranze che avevo vagheggiate, d’istruirmi e di segnalarmi un giorno.
(…)
La sera, all’ora stabilita, m’apparve il signor Micawber. Mi lavai le mani e la faccia, per far maggior onore alla sua dignità; e prendemmo insieme la via di casa, come credo debba ora chiamarla. Il signor Micawber s’occupò di farmi apprendere i nomi delle vie e notare l’aspetto delle case alle cantonate, mentre s’andava innanzi, perché potessi dirigermi facilmente la mattina appresso. Arrivati alla sua casa (la quale al pari di lui era frusta; ma, come lui anche, sfoggiava la maggior pompa possibile), egli mi presentò alla signora Micawber, una donna pallida e appassita, non più giovane, che sedeva nel salotto (il primo piano era assolutamente sfornito di mobili, e aveva le tendine abbassate per gli occhi dei vicini) con un bambino al petto. Il bambino era uno di due gemelli; e posso dire qui che non una volta, nel tempo della mia dimora colà, mi accadde di vedere entrambi i gemelli distaccati contemporaneamente dalla signora Micawber. Uno era sempre occupato a sorbire un rinfresco. V’erano altri due bambini; il signorino Micawber, di circa quattro anni, e la signorina Micawber di circa tre. Questi, e una servetta di color bruno, che aveva il vizio di sbuffar col naso, come i cavalli, e m’informò, dopo mezz’ora, che era orfana ed era uscita dal vicino ospizio di San Luca, completavano la famiglia. La mia camera era di sopra, al di dietro, piccola, molto poveramente arredata e parata di certa carta che rappresentava alla mia immaginazione infantile una gran quantità di ciambelle azzurre. – Non pensavo mai – disse la signora Micawber, dopo esser salita su, gemello e tutto, a mostrarmi la camera, e sedendosi per riprender fiato – non pensavo mai prima di maritarmi, quando ero con papà e mamma, che un giorno avrei dovuto appigionare delle camere in casa mia. Ma mio marito è adesso in condizioni difficili, e ogni considerazione del nostro sentimento intimo si deve far tacere.
Io dissi: «Sì, signora.»
(…)
Il centro del portone di casa era interamente coperto da una gran targa di ottone su cui era inciso: «Istituto per Signorine della signora Micawber»: ma non mi risultò che alcuna signorina avesse mai frequentato quel collegio, o lo frequentasse, o si proponesse di frequentarlo, né che fosse mai stato fatto il minimo preparativo per riceverne una. Gli unici visitatori che io vidi, o di cui udii parlare, erano i creditori. Quelli arrivavano a tutte le ore e alcuni di essi erano decisamente feroci. Un certo tale dalla faccia sporca, credo che fosse un calzolaio, era solito infilarsi nel corridoio già alle sette del mattino e gridare dalle scale al signor Micawber: «Venite fuori! Non siete ancora uscito, lo sapete bene. Volete pagarmi o no? Non nascondetevi; lo sapete che è una bassezza. Se fossi in voi non sarei così meschino. Mi pagate o no? Dovete pagarmi, mi sentite? Venite fuori!» Non ricevendo risposta a queste intimazioni, passava pieno di furia alle espressioni: «Imbroglioni» e «ladri»; e poiché anche queste rimanevano senza effetto, ricorreva a volte all’estremo espediente di attraversar la strada e tuonare verso le finestre del secondo piano, dove sapeva che c’era il signor Micawber. In queste occasioni il signor Micawber era trascinato dal dolore e dall’umiliazione (me ne accorsi una volta dalle strida di sua moglie) fino al punto di mostrar di agire contro se stesso con un rasoio; ma mezz’ora dopo si puliva con estrema cura le scarpe e usciva mugolando un motivetto con un’aria più aristocratica che mai. La signora Micawber possedeva una non minore elasticità. L’ho vista cadere in deliquio alle tre, davanti alla cartella delle tasse, e, alle quattro, mangiare cotolette di vitello impanate e bere birra calda, il tutto pagato con due cucchiai da tè portati al monte dei pegni.
(…)
In questa casa e con questa famiglia trascorrevo le mie ore di libertà. Provvedevo da solo alla mia colazione con una pagnottina da un penny e un penny di latte. Tenevo un’altra pagnottina e un pezzetto di formaggio su di un particolare scaffale di una particolare credenza per farne la mia cena quando tornavo la sera. Tutto ciò apriva un vuoto nei miei sei o sette scellini, lo so fin troppo; stavo nel magazzino tutto il giorno e dovevo mantenermi con questa somma per tutta la settimana. Dal lunedì mattina al sabato sera non avevo consigli, né guida, né incoraggiamento, né conforto, né assistenza, né aiuto di alcun genere né da parte di alcuno che possa ricordare, quanto è vero che spero di andare in paradiso!
(…)
So di non esagerare, inconsciamente e involontariamente, la scarsità delle mie risorse e le difficoltà della mia vita. So che, se mai il signor Quinion mi dava uno scellino, in qualsiasi momento, lo spendevo in un desinare o in una merenda. So che lavoravo dalla mattina alla sera, cencioso fanciullo, con uomini e ragazzi volgari. So che vagabondavo per le strade nutrito scarsamente e male. So che, se non fosse stato per la grazia divina, sarei potuto facilmente divenire, tanta era la cura che ci si prendeva di me, un ladroncello o un piccolo vagabondo.

David Copperfield in fabbrica
E’ evidente la distanza di un brano come questo, non dico col romanzo zoliano, più tardo, ma anche col romanzo flaubertiano: in primo luogo la mozione degli affetti, ovvero sia il sentimentalismo (… mi abbiano cacciato via, nonostante gli anni che avevo), ciò non toglie alla pagine una certa attenzione al dato sociale, la vita della fabbrica, ma, ancora (ricordiamo che il romanzo uscì a puntate) un “dato” più leggero, che può spingere fino al sorriso (l’episodio del calzolaio). A tale proposito non mi sembra inopportuno ricordare che Dickens divenne famoso con un romanzo “comico” come Il Circolo Pickwick.
Un altro grande romanzo è Tempi difficili del 1854:
Thomas Gradgrind è un ricco mercante in pensione che vive nella città industriale di Coketown, in Inghilterra, che dedica la sua vita alla filosofia del razionalismo, dell’interesse personale e della realtà. Cresce i figli maggiori, Louisa e Tom, secondo questa filosofia e non permette loro di impegnarsi in attività di fantasia. Fonda una scuola e prende in simpatia uno degli studenti, il fantasioso Sissy Jupe che, dopo la scomparsa del padre, è diventato intrattenitore al circo. Ma i figli di Gradgrind, crescendo, diventano infelici: Tom è un egoista; Louisa ha una profonda confusione interiore e si sente come se mancasse qualcosa di importante nella sua vita. Alla fine Louisa sposa l’amico di Gradgrind, Josiah Bounderby, proprietario di una fabbrica e ricco e banchiere, anche se è molto più grande di lei. Tom diventa apprendista nella banca Bounderby, e Sissy rimane alla casa di Gradgrind per prendersi cura dei bambini più piccoli. Nel frattempo, Stephen Blackpool, un operaio povero degli stabilimenti di Coketown, lotta contro il suo amore per Rachael: lui è già sposato con un’orribile donna alcolizzata che sparisce per mesi almeno una volta all’anno. Consultando Bounderby per un parere legale, Stephen scopre che il divorzio è concesso solo ai ricchi. Fuori casa di Bounderby, incontra la signora Pegler, una strana vecchia con una devozione inspiegabile verso Bounderby. James Harthouse, un giovane ricco londinese, arriva a Coketown per intraprendere la carriera politica come discepolo di Gradgrind, che è anche membro del Parlamento. Il giovane mostra subito interesse per Louisa e decide di sedurla con l’aiuto della signora Sparsit, un’ex aristocratica che è caduta in disgrazia e che lavora per Bounderby. Gli operai, esortati da un portavoce, Slackbridge, cercano di formare un sindacato a cui solo Stephen rifiuta di aderire perché sente che uno sciopero sindacale non farebbe altro che aumentare le tensioni tra datori di lavoro e dipendenti. Ma, quando si rifiuta di spiare i suoi compagni, viene licenziato da Bounderby. Louisa, colpita dall’integrità di Stephen, va a trovarlo prima che lasci Coketown e lo aiuta dandogli dei soldi. Stephen lascia Coketown sperando di trovare lavoro agricolo nel paese ma dopo un po’ di tempo la banca dove era stato visto bighellonare viene derubata e lui viene accusato di rapina. La signora Sparsit, testimone dell’amore di Harthouse per Louisa, accetta di incontralo a Coketown in tarda notte. Louisa si rifugia in casa del padre e gli confida che la sua educazione l’ha portata a sposare un uomo che non ama, freddo e infelice e che lei, invece, ama Harthouse. La donna è disperata e Gradgrind, ammutolito, inizia ad avere dubbi sulla sua filosofia fondata sulla razionalità e l’interesse personale. Sissy, follemente innamorato di Louisa, convince Harthouse a lasciare Coketown per sempre. Bounderby, furioso perchè sua moglie lo ha lasciato, raddoppia gli sforzi per catturare Stephen. Quando Stephen cerca di ritornare in città, cade in un pozzo minerario chiamato Old Hell Shaft. Rachael e Louisa lo ritrovano ma lui muore dopo uno struggente addio a Rachael. Gradgrind e Louisa si rendono conto che è il vero responsabile della rapina in banca. Con l’aiuto di amici circensi, cercano di ritrovarlo ma vengono fermati da Bitzer, un giovane che ha frequentato la sua scuola e che incarna tutte le qualità del razionalismo indipendente che Gradgrind aveva sposato per anni. Sleary, il titolare del circo, aiuta Tom a fuggire dall’Inghilterra. La signora Sparsit, ansiosa di aiutare Bounderby a trovare i ladri, trascina la signora Pegler, nota socia di Stephen Blackpool, da Bounderby, pensando che possa essere una potenziale testimone. Dopo aver scoperto che la signora Pegler è la sua vera madre, con rabbia, Bounderby spara contro la signora Sparsit e la manda via. Cinque anni dopo, morirà da solo per le strade di Coketown. Gradgrind abbandona la sua filosofia della razionalità e impiega il suo potere politico per aiutare i poveri. Tom capisce il suo errore ma muore senza mai vedere di nuovo la sua famiglia. Sissy si sposa e crea una grande e affettuosa famiglia. Louisa, invece, rimarrà tutta la vita senza marito né figli ma verrà accolta e amata dalla famiglia di Sissy, scoprendo finalmente l’affetto tra esseri umani.

Illustrazione di Coketown
COKETOWN, LA CITTA’-FABBRICA
Coketown, verso la quale dirigevano i loro passi Gradgrind e Bounderby, era un trionfo di fatti; non c’era la benché minima traccia di fantasia lì, non più di quanto ce ne fosse nella signora Gradgrind. Prima di eseguire l’intera melodia, facciamo risuonare la nota dominante: Coketown. Era una città di mattoni rossi o, meglio, di mattoni che sarebbero stati rossi, se fumo e cenere lo avessero consentito. Così come stavano le cose, era una città di un rosso e di un nero innaturale come la faccia dipinta di un selvaggio; una città piena di macchinari e di alte ciminiere dalle quali uscivano, snodandosi ininterrottamente, senza mai svoltolarsi del tutto, interminabili serpenti di fumo. C’era un canale nero e c’era un fiume violaceo per le tinture maleodoranti che vi si riversavano; c’erano vasti agglomerati di edifici pieni di finestre che tintinnavano e tremavano tutto il giorno; a Coketown gli stantuffi delle macchine a vapore si alzavano e si abbassavano con moto regolare e incessante come la testa di un elefante in preda a una follia malinconica. C’erano tante strade larghe, tutte uguali fra loro, e tante strade strette ancora più uguali fra loro; ci abitavano persone altrettanto uguali fra loro, che entravano e uscivano tutte alla stessa ora, facendo lo stesso scalpiccio sul selciato, per svolgere lo stesso lavoro; persone per le quali l’oggi era uguale all’ieri e al domani, e ogni anno era la replica di quello passato e di quello a venire.
Questi attributi di Coketown erano in gran parte inseparabili dall’industria che dava da vivere alla città; su questo sfondo, in contrasto, c’erano gli agi del vivere che si diffondevano in tutto il mondo; c’erano la raffinatezza e la grazia del vivere che contribuivano – non indaghiamo in quale misura – a creare quella gentildonna elegante che storceva il nasino al solo sentir nominare il luogo or ora descritto.
Non c’era nulla a Coketown che non stesse a indicare una industriosità indefessa. Se i seguaci di una setta religiosa decidevano di erigere una chiesa – cosa che avevano fatto i seguaci di diciotto sette – ne saltava fuori un pio magazzino di mattoni rossi, sormontato, a volte (ma soltanto negli esemplari più raffinati), da una campana racchiusa in una specie di gabbia per uccelli. Unica eccezione era la Chiesa Nuova: un edificio intonacato che, sopra alla porta principale, aveva un campanile quadrato con in cima quattro pinnacoli simili a robuste gambe di legno. In città tutte le insegne degli edifici pubblici erano negli stessi identici austeri caratteri bianchi e neri. La prigione avrebbe potuto essere l’ospedale, l’ospedale avrebbe potuto essere la prigione, il municipio avrebbe potuto essere o l’uno o l’altro oppure tutti e due, o anche qualsiasi altra cosa, perché nulla, nelle linee aggraziate di quegli edifici, serviva a identificarli. Fatti, fatti, fatti dappertutto nell’aspetto materiale della città; fatti, fatti, fatti dappertutto in quello immateriale. Era un fatto la scuola di M’Choakumchild, era un fatto la scuola di disegno, erano fatti i rapporti fra padrone e operaio; solo fatti si estendevano fra l’ospedale in cui si veniva alla luce e il cimitero, e quello che non si poteva esprimere in cifre, che non si poteva comperare al prezzo più basso e vendere a quello più alto, non esisteva, non sarebbe esistito mai, nei secoli dei secoli, Amen.
In una città così dedita al fatto, così trionfalmente sicura della sua supremazia, naturalmente tutto andava a gonfie vele, vero? Be’, non proprio. No? Povero me!
No. Dai suoi altiforni la città non usciva splendente e radiosa come un pezzo d’oro purificato dal fuoco. C’era innanzitutto un mistero imbarazzante: chi erano i seguaci delle diciotto sette religiose? Di chiunque si trattasse non erano certamente gli operai. Strana sensazione quella che si provava alla domenica mattina, quando, passeggiando per le strade, ci si rendeva conto quanto fossero pochi coloro che, rispondendo al barbaro richiamo della campana che faceva impazzire la gente con i nervi a pezzi o ammalata, lasciavano i loro alloggi, le loro anguste stanze, gli angoli delle strade dove indugiavano con aria svogliata, guardando quelli che si recavano in chiesa o alla cappella, come se la cosa non li riguardasse affatto. Non erano soltanto i forestieri a notare tanta indifferenza; a Coketown stessa era sorta un’associazione i cui membri, a ogni sessione della camera dei Comuni, inoltravano indignate petizioni, sollecitando l’emanazione di una legge che imponesse con la forza a quella gente di diventare religiosa. Veniva poi la Lega della Temperanza, la quale protestava perché quella stessa gente si ubriacava, – che si ubriacasse era certo, tanto di statistiche lo provavano – e dimostrava (durante l’ora del tè) che nessun argomento umano o divino (tranne una medaglia) l’avrebbe persuasa a non farlo. Veniva poi il chimico e farmacista il quale, statistiche alla mano, dimostrava che, quando quella gente non si ubriacava, si metteva a fumare oppio. Seguiva il cappellano della prigione, uomo di vasta esperienza, che con una mole di statistiche superiore a tutte le precedenti, dimostrava che quella stessa gente frequentava luoghi ignobili, nascosti ai più, dove ascoltava ignobili canzoni e guardava ignobili danze e, chissà?, magari anche ci partecipava.
(…)
Venivano poi i signori Gradgrind e Bounderby, i due gentiluomini che in quel momento attraversavano Coketown, entrambi eminentemente pratici, che, se necessario, avrebbero potuto fornire altre statistiche, frutto della loro personale esperienza e confermate da casi che loro stessi avevano visto e conosciuto; da tutto questo risultava chiaro – anzi era l’unica cosa chiara – che questa era tutta gentaglia, signori, che non sarebbe mai stata riconoscente per quello che si faceva per il loro bene; che era sempre in subbuglio, che non sapeva quello che voleva, che viveva di quanto c’era di meglio e comperava burro fresco; che insisteva nel volere vero caffè e non voleva sentirne parlare di carne che non fosse di prima scelta e che, nonostante tutto questo, era sempre scontenta e intrattabile. In breve era la morale della vecchia filastrocca:
C’era una vecchietta: sapete cosa faceva?
Da mangiar e da bere in tavola metteva;
Mangiare e bere erano tutta la sua dieta,
Eppur la vecchietta non se ne stava mai quieta.
Coketown è una tipica città industriale, una città moderna, efficiente, concreta, dove tutto è finalizzato al lavoro, alla produttività: è quindi uno dei luoghi dove l’Inghilterra costruisce la sua ricchezza e la sua potenza. Tutto ciò ha però dei costi: gli edifici di Coketown sono privi di colori, i vicoli sono angusti e bui e, inoltre, la città stessa è uniformità, tutta uguale (era un trionfo del fatto, poiché non si era lasciata corrompere dalla fantasia). Da notare è anche l’uniformità dei suoi abitanti, dei loro pensieri e comportamenti meccanicizzati: operosa, ordinata, è diventata come la merce che produce, anonima e sempre uguale.
I toni con cui Dickens ritrae questa realtà non hanno la crudezza e la violenza di quelli del naturalista francese Émile Zola, per cui provocare il lettore è parte del gioco: qui la realtà passa attraverso il filtro dell’umorismo, del sorriso sarcastico che deforma. (Barberi Squarotti).
Russia
La letteratura russa si era già affacciata in Europa con forza e capacità durante il primo Ottocento, grazie a personalità come Puškin e Lermontov. E saranno proprio costoro i “padri” della grandissima fioritura del secondo Ottocento che farà della narrativa russa, insieme alla francese, un punto di riferimento imprescindibile della cultura europea (non ci sembra inopportuno segnalare che sarà proprio il paese transalpino a fare da mediatore).

Nikolaj Vasil’evič Gogol’
Alla base del realismo russo sta la “narrativa umanitaria” la cui attenzione è rivolta alle miserrime condizioni della servitù della gleba e la nascita del relativo movimento per la loro emancipazione. A tale narrativa parteciperà anche Nikolaj Vasil’evič Gogol’, che sebbene in modo non esaustivo, tocca tale tematica soprattutto nel romanzo Anime morte (1842).
Pavel Ivanovič Čičikov viaggia attraverso la Russia comprando a poco prezzo “anime morte”, cioè i nomi dei contadini (“anime” nella Russia zarista”) morti dopo l’ultimo censimento e sui quali i proprietari erano tenuti a pagare la tassa governativa sino al censimento successivo. Il suo piano è di servirsi di quelle “anime” (vive solo per la legge) per ottenere le assegnazioni di terre concesse a chi dimostrava di possedere un certo numero di servi della gleba. Il romanzo è un vasto affresco della Russia rurale e provinciale quale si offre agli occhi di Čičikov attraverso i proprietari, le case, le locande, i cocchieri, i contadini, i notabili di provincia. Spiccano tra i molti personaggi appunto i proprietari con cui conduce le trattative: lo sdolcinato Manilov, pigro e distratto; la vecchia Korobočka, avida e calcolatrice; l’invadente Nozdriov, mitomane e beone, l’unico che intravede la truffa e non gli vende “anime morte”; Sobakevič, l’uomo alla buona ma accorto negli affari; l’avarissimo Pliuškin. Čičikov a un certo punto riesce a passare per milionario nella piccola città dove ha preso dimora, viene adulato, vezzeggiato e ogni porta gli è aperta. Ma lentamente affiora la verità e Čičikov si affretta a partire.
LE ANIME MORTE
«Permetta che le chieda di accomodarsi su questa poltrona» disse Manilov. «Qui starà più comodo.» «Permetta, mi siederò sulla sedia.» «Permetta che non glielo permetta» disse Manilov con un sorriso. «Quella poltrona è riservata ai miei ospiti: volente o nolente vi si deve sedere.» Čičikov si sedette. «Permetta che le offra una pipetta.» «Grazie, non fumo» rispose Čičikov teneramente e quasi con aria di rammarico. «Come mai?» chiese Manilov, pure teneramente e con aria di rammarico. «Non ho mai preso l’abitudine, ho paura; dicono che la pipa faccia male.» «Permetta che le faccia osservare che si tratta di un pregiudizio. Anzi ritengo che fumare la pipa sia molto più salutare che fiutare tabacco. Nel nostro reggimento c’era un tenente, ottima persona, di grande cultura, che non si toglieva mai la pipa di bocca non solo a tavola, ma anche, con licenza parlando, in qualsiasi altro posto. Ed ecco che ha già più di quarant’anni, ma, ringraziando Dio, finora è sano come un pesce.» Čičikov osservò che infatti eran cose che capitavano e che in natura si riscontravano molti fenomeni inspiegabili anche per una mente aperta. «Ma permetta prima una domanda…» disse con una voce in cui si sentiva un’espressione strana o quasi strana, e subito dopo chissà perché si guardò alle spalle. Anche Manilov chissà perché si guardò alle spalle. «Quanto tempo fa ha consegnato la lista per il censimento?» «Oh, è ormai molto tempo; o per meglio dire non ricordo.» «E quanti contadini le sono morti da allora?» «Non lo saprei dire; credo che occorra chiederlo al fattore. Ehi, ragazzo! chiama il fattore, oggi dovrebbe essere qui.» Comparve il fattore. Era un uomo sulla quarantina, sbarbato, che portava la finanziera ed evidentemente conduceva una vita assai pacifica, perché la sua faccia era di una grassezza soffice, mentre il colore giallastro della pelle e gli occhi piccini mostravano che sapeva fin troppo bene cosa fossero trapunte e piumini. Si vedeva subito che aveva fatto carriera come la fanno tutti i fattori dei signori; era stato prima semplicemente un ragazzetto di casa capace di leggere e scrivere, poi aveva sposato una qualche Agaška-dispensiera, favorita del padrone, era diventato lui stesso dispensiere, e poi anche fattore. E divenuto fattore agiva, chiaramente, come tutti i fattori; se la intendeva con i più ricchi del villaggio e oberava di tributi i più poveri, si svegliava dopo le otto del mattino, aspettava il samovar e beveva il tè. «Ascolta, mio caro, quanti contadini ci sono morti da quando abbiamo consegnato la lista?» «Come sarebbe a dire quanti? Ne son morti tanti da allora» disse il fattore con un colpo di singhiozzo, che cercò di dissimulare coprendosi un po’ la bocca con la mano. «Sì, confesso che lo pensavo anch’io» intervenne Manilov, «proprio così, ne sono morti moltissimi!» Qui si rivolse a Čičikov e aggiunse ancora: «Infatti, moltissimi.» «E pressappoco in che numero?» domandò Čičikov. «Sì, in che numero?» ripeté Manilov. «E come si fa a dire il numero? Non si sa mica quanti ne sono morti, nessuno li ha contati.» «Già, infatti» disse Manilov, rivolgendosi a Čičikov, «anch’io supponevo che ci fosse un’alta mortalità; non si sa proprio quanti ne siano morti.» «Per favore, contali» disse Čičikov, «e fa’ una bella lista dettagliata con tutti i nomi.» «Sì, con tutti i nomi» disse Manilov. Il fattore disse: «Sissignore!» e se ne andò. «E per quali motivi le occorre?» domandò Manilov quando fu uscito il fattore. Questa domanda sembrò mettere in difficoltà l’ospite, sul suo viso apparve una certa espressione tesa, che lo fece perfino arrossire: era la tensione per esprimere qualcosa che mal si piegava alle parole. E in effetti Manilov finì coll’udire cose così strane e insolite, quali orecchio umano non aveva mai sentito prima. «Lei domanda per quali motivi? Ecco quali: vorrei comprare dei contadini…» disse Čičikov, s’impappinò e non finì il discorso. «Ma permetta che le domandi» disse Manilov, «come desidera comprare i contadini: con la terra o semplicemente per trasferirli, cioè senza terra?» «No, non è che voglia proprio dei contadini» disse Čičikov, «voglio avere i morti…» «Come? Mi scusi… sono un po’ duro d’orecchio, mi è parso di sentire una parola alquanto strana…» «Intendo acquistare i morti che però sulla lista del censimento figurino come vivi» disse Čičikov. Manilov lasciò subito cadere a terra il cannello con la pipa turca, aprì la bocca, e così restò, a bocca aperta, per diversi minuti. I due amici, che avevano ragionato dei piaceri dell’amicizia, restarono immobili a fissarsi negli occhi, come quei ritratti che nei tempi andati si appendevano uno di fronte all’altro ai due lati di uno specchio. Finalmente Manilov raccolse la pipa col cannello e lo guardò in viso di sotto in su, cercando di scoprire se non ci fosse qualche sorrisetto sulle sue labbra, se non avesse scherzato; ma non si vedeva nulla di simile, anzi il suo viso sembrava perfino più serio del solito; poi si chiese se l’ospite non fosse per caso impazzito di colpo, e con terrore lo guardò intensamente; ma gli occhi dell’ospite erano perfettamente limpidi, in essi non c’era il fuoco selvaggio, inquieto, che guizza negli occhi di un pazzo, tutto era normale e a posto. Per quanto Manilov si scervellasse pensando a come doveva comportarsi e a cosa doveva fare, non trovò niente di meglio che soffiare dalla bocca il fumo che vi era rimasto, in un filo sottilissimo. «E così, desidererei sapere se lei mi può cedere, o vendere, o quel che riterrà più opportuno, questi soggetti che non sono vivi in realtà, ma lo sono formalmente per la legge.» Ma Manilov era così confuso e imbarazzato che lo guardava e basta. «Mi pare che lei faccia qualche difficoltà?…» osservò Èièikov. «Io?… no, non è questo» disse Manilov, «ma non riesco a capire… mi scusi… io, naturalmente, non ho potuto ricevere un’educazione così brillante come quella che, per così dire, trapela da ogni suo gesto; non sono maestro nell’arte di esprimermi… Forse qui… nella spiegazione da lei ora enunciata… si cela dell’altro… Forse ha voluto esprimersi così per amor del bello stile?» «No» riprese Èièikov, «no, intendo la cosa così com’è, cioè proprio le anime che sono già morte.» Manilov si smarrì completamente. Sentiva che doveva fare qualcosa, porre qualche domanda, ma quale domanda? Il diavolo lo sapeva. Andò a finire che soffiò nuovamente il fumo, però non più dalla bocca, bensì attraverso le narici. «E così, se non ci sono ostacoli, con l’aiuto di Dio si potrebbe passare a stipulare un contratto di compravendita» disse Èièikov. «Come, un contratto di vendita di anime morte?» «Ah, no!» disse Èièikov. «Scriveremo che sono vive, così come effettivamente risulta dalla lista del censimento. Sono abituato a non scostarmi in nulla dalle leggi civili, benché per questo abbia sofferto nella mia carriera, ma deve scusarmi: il dovere per me è cosa sacra, la legge… io ammutolisco dinanzi alla legge.» Queste ultime parole piacquero a Manilov, ma il senso della faccenda in sé continuava a sfuggirgli, e invece di rispondere si mise a succhiare così forte il suo cannello, che questo alla fine cominciò a gorgogliare come un fagotto. Sembrava che volesse tirarne fuori un parere rispetto a una circostanza così inaudita; ma il cannello gorgogliava e basta. «Forse lei ha dei dubbi?» «Oh! per carità, niente affatto. Non dico questo perché abbia, sì insomma, dei pregiudizi critici su di lei. Ma mi permetta di chiedere se questa transazione o, per meglio esprimersi, per così dire, questo negozio, se dunque questo negozio non sarà in contrasto con la legislazione civile e gli ulteriori intenti della Russia?» Qui Manilov, fatto un lieve cenno col capo, guardò in faccia Èièikov con aria molto significativa, mostrando in tutti i lineamenti del suo viso e nelle labbra serrate un’espressione così profonda che, forse, non si era mai vista su volto
umano, tranne forse nel caso di qualche ministro troppo intelligente, e anche lì solo di fronte alla questione più intricata. Ma Èièikov disse semplicemente che una tale transazione, o negozio, non sarebbe stata affatto in contrasto con la legislazione civile e gli ulteriori intenti della Russia, e un minuto dopo aggiunse che l’erario ne avrebbe tratto addirittura profitto, poiché avrebbe incassato l’imposta di registro prevista dalla legge. «Dunque lei ritiene?…» «Ritengo che sarà una buona cosa.» «Ah, se sarà buona, allora è un’altra faccenda: non ho nulla in contrario» disse Manilov e si tranquillizzò del tutto. «Ora non resta che accordarsi sul prezzo.» «Come sul prezzo?» disse nuovamente Manilov e si fermò. «Davvero lei crede che prenderò denaro per delle anime che in un certo senso hanno concluso la loro esistenza? Se le è venuto questo desiderio, per così dire, fantasioso, da parte mia gliele cedo gratis e mi assumo gli oneri del contratto di compravendita.» Sommamente riprovevole sarebbe lo storico degli avvenimenti qui presentati, se tralasciasse di dire che l’ospite fu invaso dalla contentezza dopo tali parole pronunciate da Manilov. Per quanto fosse posato e riflessivo, a questo punto per poco non fece un saltello a somiglianza di un caprone, il che, come è noto, avviene soltanto nei più forti accessi di gioia. Si voltò così impetuosamente sulla poltrona, che si squarciò il tessuto di lana che ricopriva il cuscino; perfino Manilov lo guardò con una certa perplessità. Mosso dalla riconoscenza, Èièikov si mise a snocciolare tanti ringraziamenti, che l’altro si confuse, arrossì tutto, fece un cenno di diniego col capo e solo alla fine riuscì a dire che era una cosa da nulla, che egli avrebbe voluto davvero dimostrare in qualche modo l’inclinazione del suo cuore, il magnetismo dell’anima, mentre le anime morte in un certo senso erano un’assoluta inezia.
La parte riportata dal romanzo ci descrive, in un quadretto, la tecnica con cui Čičikov circuisce i notabili cui si rivolge. E’ certamente una pagina che strappa il sorriso, ma il sorriso è amaro quando ci si accorge che ciò che di cui realmente parla è una società arcaica nella quale i servi, legati alla terra e al possidente, erano considerati alla stregua degli altri animali domestici, venduti, comprati e sfruttati. Un mondo in cui l’aristocrazia e la burocrazia zarista dominavano senza intralci un popolo che viveva nella miseria. Il sarcasmo che attraversa l’intero romanzo, denuncia una forte critica sociale e un rigoroso atto di accusa contro un sistema profondamente iniquo. Sotto il titolo Le Anime morte bisognava quindi riconoscere non i servi deceduti ma i gretti personaggi della buona società, incapaci di umanità.
Tutto questo Gogol’ lo affronta con un’accentuata volontà satirica che porta alla caricatura, all’accentuazione delle linee di carattere, spinte fino al grottesco. Cifra stilistica che conserva anche nell’altro suo capolavoro, I racconti di Pietroburgo, pubblicati dopo la sua morte, di cui ci piace ricordare perlomeno Il cappotto ed Il naso.
Il secondo grande autore russo su cui ci soffermiamo è Ivan Aleksandrovič Gončarov (1812 -1891), la cui fama è legata soprattutto al romanzo Oblomov (1859).

Ivan Aleksandrovič Gončarov
Oblomov è un uomo di non comuni qualità di cuore e di intelligenza, che vive nell’indolenza più assoluta. Il suo amico, Štol’c chiama il suo vivere di rendita, sonnecchiare, contemplare “oblomovismo”. Per Štol’c il lavoro è vita, energia; per Oblomov un impaccio. Servito dal fedele e rozzo Zachàr, Oblomov vegeta e sogna, ogni specie di sogni, nei quali domina Oblomovka, la proprietà dei suoi avi, che, per pigrizia, sta lasciando andare in rovina. Ama la giovane Ol’ga, si fidanza con lei, ma la lascia, atterrito dalla richiesta di lei di un radicale mutamento di vita, di una più attiva partecipazione alla gestione del patrimonio. Ol’ga sposerà poi Štol’c, Oblomov la sua padrona di casa, Agafja Matveena, semplice e rozza, ma brava massaia. Štol’c amministrando Oblomovka l’ha fatta rifiorire e ha salvato Oblomov da una truffa che rischiava di rovinarlo. Ma è troppo tardi per scuoterlo dal torpore in cui è caduto. Poco dopo Oblomov muore, lasciando un figlio, di cui si occuperà Štol’c, e un ricordo incancellabile quanto conturbante della sua mitezza d’animo.
OBLOMOV
Ma che cosa faceva in casa? Leggeva? Scriveva? Studiava?
Sì: se gli capitava fra le mani un libro o un giornale, lo leggeva.
Se sentiva parlare di una qualche opera degna di nota, gli veniva voglia di conoscerla; cercava, chiedeva il libro e, se glielo portavano presto, ci si buttava a capofitto, cominciava a farsi un’idea del soggetto… ma quando gli bastava ancora un passo per impadronirsene completamente, lo vedevi già sdraiato, con lo sguardo apatico fisso al soffitto e con il libro abbandonato, lasciato a mezzo, incompreso.
Il disinteresse si impadroniva di Il’ja Il’ič ancor più in fretta dell’entusiasmo, ed egli non tornava mai più al libro interrotto.
A suo tempo aveva studiato, come gli altri, come tutti, cioè fino a quindici anni in collegio; poi i genitori, dopo lunga lotta, avevano deciso di mandare Iljuša a Mosca, dove il giovane, volente o nolente, aveva seguito i corsi sino alla fine. Il carattere timido e apatico gli aveva impedito di manifestare appieno la sua ignavia e la sua incostanza nella scuola, dove non si facevano eccezioni per i figli viziati. Dacché era obbligato, in classe restava composto, ascoltava ciò che dicevano gli insegnanti perché non era possibile fare altrimenti, e con fatica, sudando e sospirando, imparava le lezioni.
Egli considerava tutto ciò come un castigo del cielo per i nostri peccati.
Non guardava al di là della riga sotto la quale l’insegnante, nell’assegnare il compito, aveva lasciato un segno con l’unghia; non faceva domande, non chiedeva spiegazioni.
Gli bastava ciò che era scritto nel quaderno, e non manifestava curiosità importune nemmeno quando non comprendeva quello che ascoltava e imparava. Se in qualche modo riusciva ad arrivare in fondo a un testo di statistica, di storia, di economia politica, era più che soddisfatto.
Ma quando Stolz gli portava dei libri che riteneva bisognasse leggere, oltre quelli di scuola, Oblomov lo guardava a lungo, in silenzio.
«Anche tu, Bruto, sei contro di me?», concludeva con un sospiro prendendo i libri. Queste eccessive letture gli sembravano gravose e contro natura.
A che servivano tutti quei quaderni, buoni solo a far sprecare carta, tempo e inchiostro? A che servivano i libri di scuola? A che servivano, infine, sei o sette anni di clausura, la severità, le punizioni, il tormento di assistere alle lezioni, il divieto di correre, di scatenarsi, di divertirsi prima di aver finito i compiti?
«Ma quando potrò vivere?», ripeteva a se stesso. «Quando farò finalmente fruttare questo capitale di conoscenze, la maggior parte delle quali, ci scommetto, non mi serviranno a niente nella vita? L’economia politica, per esempio, l’algebra, la geometria… a che mi serviranno nelle mie terre?».
(…)
Dopo la morte dei vecchi, l’economia del villaggio non solo non migliorò, ma, come è dato vedere dalla lettera dello starosta, andò peggiorando. Era chiaro che Il’ja Il’ič doveva andare di persona sul posto per ricercare le cause del calo progressivo del suo reddito.
Egli si proponeva di farlo, ma poi rimandava sempre, in parte perché un viaggio era per lui un’impresa quasi nuova e sconosciuta. In tutta la sua vita aveva fatto un solo viaggio, lentissimo, senza cambiar cavalli, in mezzo a piumini, cofani, valigie, prosciutti, panini, arrosti e bolliti di ogni genere, in compagnia di alcuni servitori.
Così aveva fatto il suo unico viaggio dal paese natio a Mosca, viaggio che considerava come il modello di tutti i viaggi.
E adesso aveva sentito dire che non si viaggiava più così: si galoppava a rotta di collo!
Il’ja Il’ič aveva rimandato il viaggio anche perché non era preparato ad occuparsi dei suoi affari.
Non era davvero come il padre e come il nonno, lui. Aveva studiato, conosceva il mondo: tutto ciò lo aveva portato a diverse considerazioni che a loro erano estranee. Comprendeva che non solo il profitto non era un peccato, ma che era dovere di ogni cittadino contribuire con un lavoro onesto al benessere generale. Per questo la maggior parte del disegno di vita che egli tracciava nella sua solitudine era dedicata a un progetto nuovo di zecca, aderente alle esigenze dei tempi, riguardante la riorganizzazione della proprietà e il governo dei suoi contadini.
Egli aveva ben chiara in testa l’idea fondamentale del progetto, le sue suddivisioni e parti principali: rimanevano solo i particolari, i preventivi e le cifre.
Già da alcuni anni lavora infaticabilmente al suo progetto, ci pensa, ci riflette quando è in piedi, quando è coricato, quando è fra la gente; ora completa, ora modifica diversi paragrafi, ora cerca di farsi tornare in mente ciò che aveva pensato il giorno prima e dimenticato durante la notte; ma a volte, improvvisamente, come una folgore, gli balena in testa un’idea nuova e inaspettata… e il lavoro ricomincia.
Egli non è un qualsiasi piccolo esecutore di un’idea altrui, già pronta: è il creatore e l’esecutore delle sue proprie idee. Non appena si alza dal letto la mattina, dopo aver preso il tè, si stende subito sul divano, appoggia il capo sulle mani, e medita, senza risparmio di forze, fino al momento in cui si sente il cervello pesante per l’eccessiva fatica e la coscienza gli dice: hai lavorato abbastanza, oggi per il bene comune. Solo allora egli decide di riposarsi e abbandona l’atteggiamento solerte per assumerne un altro sollecito e severo, e più consono alle fantasticherie e al piacere. Liberatosi dalle preoccupazioni degli affari, Oblomov amava ripiegarsi in se stesso e vivere nel mondo che si era creato.
Era in grado di apprezzare il godimento che procurano i pensieri elevati; non era estraneo alle afflizioni del genere umano. A volte piangeva amaramente, nel fondo del cuore, per le sventure dell’umanità, provava sofferenze sconosciute, pene indicibili, e anche lo struggimento e il desiderio di luoghi lontani, forse in quel mondo nel quale avrebbe voluto trascinarlo Stolz…
Dolci lacrime gli scorrevano sulle gote.
Gli capita anche di provare disprezzo per i vizi umani, per la calunnia, per il male di cui è pieno il mondo, e si infiamma del desiderio di spronare l’uomo a guardare le sue piaghe, e d’improvviso si accendono in lui vividi pensieri che si muovono e si accavallano come le onde del mare, poi si sviluppano in propositi, gli bruciano il sangue; i muscoli cominciano a guizzare, le vene si tendono, i propositi si trasformano in aspirazioni: mosso da una forza morale, cambia posizione due o tre volte in un minuto, con gli occhi scintillanti si alza a metà sul letto, tende una mano, gira attorno uno sguardo ispirato… Ecco, ecco che la sua aspirazione si realizza, diventa azione… e allora, Signore! Quali miracoli, quali felici conseguenze ci si potrebbero attendere da uno sforzo così grande!
Ma, attenzione, il mattino è passato in un baleno, il giorno già declina, e con esso declinano e tendono al riposo le forze esauste di Oblomov: tempeste ed emozioni si placano nell’anima, la testa si svuota dei pensieri, il sangue scorre più lento nelle vene. Assorto, Oblomov si gira adagio sulla schiena e, fissando afflitto la finestra e il cielo, segue tristemente con gli occhi il sole che si corica maestoso dietro un palazzo di quattro piani.
E quante, quante volte aveva accompagnato così il calar del sole!
L’inettitudine di Oblomov, che qui viene presentata attraverso l’“indifferenza” culturale e l’“incapacità” economica del protagonista, secondo un critico russo, Dobroljubov, è lo specchio di quella generazione, i russi colti della prima metà dell’Ottocento, che era stata forse la prima generazione di russi ad avere contatti frequenti con l’Occidente, avevano vinto Napoleone, si erano spinti fino a Parigi, avevano letto gli illuministi, avevano frequentato le lezioni dei filosofi tedeschi, e, le teste piene di libertà, uguaglianza, fratellanza e idealismo, la notte stellata sopra di loro, la forza morale dentro di loro, erano tornati in Russia, la loro patria, dove c’era ancora la servitù della gleba, e uno stato corrotto e arretrato e avevano scoperto infine che non potevano far niente. Tutto il loro sapere, tutta la loro scienza non serviva a niente, perché c’era un apparato statale piramidale, con a capo lo zar, che decideva lui, cosa bisognava fare, loro dovevano solo servire, si diceva così, vale a dire ubbidire, e, se non volevano servire, ritirarsi in campagna e non dare troppo fastidio.
Ma forse non è solo questo: possono leggersi in lui echi fatalistici, o nuovo Candide che rifiuta la brutalità del presente o forse ancora, un’attitudine innata (qui portata alle estreme conseguenze) dell’animo umano, a cui, guarda caso, è stato dato il nome di “oblomovismo”.

Ivan Sergeevič Turgenev
Ivan Sergeevič Turgenev (1818-1883) è quello che forse meglio rappresenta la situazione della Russia dello zar Alessandro che, liberando i servi della gleba, mise in difficoltà i grandi proprietari terrieri, ma anche gli stessi contadini che si trovarono così liberi, ma, fuori dalla campagna, privi di qualsiasi possibilità. All’interno di questa situazione in movimento, nacquero vari gruppi di contestazione radicale, che cercavano di far recuperare alla Russia tutto quel tempo perduto in uno inamovibile sinora sistema feudale. Ma tale opposizione non sa ancora essere propositiva, forme d’anarchismo o di socialismo marxista si mescolavano in battagliere minoranze. Tra queste il nichilismo.
A descrivere tale movimento fu proprio Turgenev nel suo romanzo Padri e figli del 1862:
Quando nella casa di campagna del proprietario terriero Nikolaj Kirsànov arriva il figlio Arkadij, appena laureato, con l’amico Evvegnij Bazàrov, si delinea subito il conflitto fra le nuove e le vecchie generazioni. Bazàrov è un giovane medico, fiducioso nella sola realtà delle scienze sperimentali: un nichilista, come lo definisce l’autore, usando un termine che avrebbe poi avuto grande fortuna. Le sue idee hanno il potere di turbare il buon Kirsànov e di irritare suo fratello, lo scettico ed elegante Pavel. In una città vicina i due giovani incontrano la bella vedova Anna Odincova e Bazàrov prova per lei una passione che diventa disperata quando ella, pur attratta da lui, gli fa capire che non vuole imprevisti nella sua calma esistenza. Rifugiatosi, dopo un duello con Pavel, nella fattoria dei suoi genitori che lo ammirano devotamente, Bazàrov, poco dopo, facendo un’autopsia, contrae un’infezione mortale che non vuole curare, e decide di lasciarsi morire. La Odincova, accorsa, lo assiste nelle ultime ore con pietà, ma senza amore.
CONSERVATORI E NICHILISTI
Lo scontro avvenne quel giorno stesso al tè della sera. Pavel Petròvič venne in salotto, già pronto per la battaglia, irritato e risoluto. Aspettava soltanto un pretesto per slanciarsi sul nemico; ma il pretesto si fece aspettare a lungo. Bazàrov, in generale, parlava poco in presenza dei «vecchietti Kirsànov» (così egli chiamava i due fratelli) e quella sera non si sentiva in vena e beveva in silenzio una tazza dopo l’altra. Pavel Petròvič ardeva tutto d’impazienza; i suoi desideri furono alla fine appagati.
Il discorso cadde su uno dei possidenti vicini. «Porcheria, aristocratuccio», osservò tranquillamente Bazàrov, il quale lo aveva incontrato a Pietroburgo.
«Permettetemi di domandarvi» cominciò Pavel Petròvič e le labbra gli tremarono, «secondo le vostre convinzioni le parole “porcheria” e “aristocratico” indicano la stessa cosa?»
«Ho detto “aristocratuccio”», proferì Bazàrov, bevendo pigramente un sorso di tè.
«Precisamente; ma suppongo che siate dello stesso parere anche sugli aristocratici come sugli aristocratucci. Considero mio dovere dichiararvi che io non condivido codesta opinione. Oso dire che mi conoscono tutti come liberale e amante del progresso; ma è appunto per questo stimo gli aristocratici, quelli autentici. Ricordatevi, egregio signore» a queste parole Bazàrov alzò gli occhi su Pavel Petròvič «ricordatevi, egregio signore», ripeté egli con insistenza, «gli aristocratici inglesi. Essi non cedono un iota dei propri diritti, e perciò rispettano i diritti degli altri; esigono l’adempimento dei doveri verso di loro, e perciò compiono i propri doveri. L’aristocrazia ha dato la libertà all’Inghilterra e la sostiene.»
«Abbiamo sentito questo ritornello molte volte»; replicò Bazàrov; «ma cosa volete dimostrare?»
«Con “questo” voglio dimostrare, egregio signore» Pavel Petròvič, quando si arrabbiava, diceva con intenzione “questo” e “quello”, benché sapesse che la grammatica non ammette tali parole. In questa bizzarria si rivelava un residuo delle tradizioni dell’epoca di Alessandro. I pezzi grossi d’allora, in rare occasioni, quando parlavano la lingua materna, adoperavano alcuni “questo” altri “quello”; come a dire siamo russi di puro sangue, e nello stesso tempo siamo magnati, ai quali è concesso trascurare le regole scolastiche, «con “questo” voglio dimostrare che senza un sentimento della propria dignità, senza il rispetto di se stessi (ma nell’aristocratico tali sentimenti sono sviluppati) non c’è nessuna solida base per il… “bien public”… per l’edificio sociale. La personalità, egregio signore, ecco l’importante; la personalità umana dev’essere forte, poiché su di essa si costruisce tutto. So benissimo, ad esempio, che trovate ridicole le mie abitudini, il mio abbigliamento, la mia pulizia, infine; ma tutto ciò deriva dal sentimento del rispetto che ho per me stesso, dal sentimento del dovere, sissignore, sì, del dovere. Vivo in campagna, nella solitudine, ma non mi disprezzo, ma rispetto in me l’uomo».
«Permettete, Pavel Petròvič», profeì Bazarov, «voi rispettate voi stesso, e intanto ve ne state lì con le mani in mano; quale utili ne deriva per il «bien public»? Se non vi rispettate, fareste lo stesso».
Pavel Petròvič impallidì.
«Questa è un’altra questione. Non mi tocca affatto di spiegarvi ora perché me ne sto qui con le mani in mano, come vi siete espresso. Voglio solo dire che l’aristocricismo è un “principe”, e che senza “principes” ai nostri giorni possono vivere solo persone amorali e vuote. L’ho detto ad Arkadij il giorno dopo il suo arrivo e lo ripeto ora a voi. Non è così, Nikolaj? Nikolaj Petròvič annuì col capo.
«Aristocraticismo, liberalismo, progresso, principi», diceva intanto Bazàrov. «A pensarci bene, quante parole straniere e… inutili! A un uomo russo non occorrono neanche gratis».
«E che cosa allora gli occorre, secondo voi? A sentir voi, ci troviamo fuori dell’umanità, fuori delle sue leggi. Abbiate pazienza, la logica della storia esige… »
«Ma a che ci occorre questa logica? Noi possiamo benissimo farne a meno».
«Come?»
«Ma sì. Voi, spero, non avete bisogno della logica per mettervi in bocca un pezzo di pane, quando avete fame. A che ci servono queste astrazioni?» Pavel Petròvič agitò le mani.
«Non vi capisco proprio. Voi offendete il popolo russo. Io non capisco come si possa non riconoscere i “principes”, le regole! In forza di che cosa, dunque, agite voi?»
«Io vi ho già detto, zio, che noi non riconosciamo alcuna autorità.» s’intromise Arkadij.
«Agiamo in forza di ciò che riconosciamo utile», proferì Bazàrov. «Nell’epoca attuale, la cosa più utile è la negazione: e noi neghiamo.»
«Tutto?»
«Tutto.»
«Come! non solo l’arte, la poesia…. ma anche…. è pauroso dirlo….»
«Tutto» ripetè con inesprimibile calma Bazàrov.
Pavel Petròvič lo guardò fisso. Non si aspettava tanto, mentre Arkadij arrossiva addirittura per la soddisfazione.
«Tuttavia, permettete», disse Nikolaij Petròvič. «Voi negate tutto e, più esattamente, demolite tutto… Ma bisogna pure costruire.»
«Questo non è affar nostro…. Prima bisogna far piazza pulita.»
«La condizione attuale del popolo lo esige» soggiunse con sussiego Arcadij, «noi dobbiamo soddisfare queste esigenze, non abbiamo il diritto di abbandonarci all’esaurimento dell’egoismo personale.»
Quest’ultima frase, evidentemente, non piacque a Bazàrov; sapeva di filosofia, cioè, di romanticismo, poiché Bazarov chiamava romanticismo anche la filosofia; ma non trovò confutare il suo giovane discepolo.
«No, no» esclamò con uno slancio improvviso Pavel Petròvič, «non voglio credere che voi, signori, conosciate esattamente il popolo russo, che siate i rappresentanti delle sue esigenze, delle sue aspirazioni! No, il popolo russo non è quale lo immaginiate. Esso rispetta santamente le tradizioni, è patriarcale, non può vivere senza la fede…»
«Non ho intenzione di discutere su questo argomento»: interruppe Bazàrov, «sono anzi pronto ad ammettere che in questo voi abbiate ragione».
«Ma se ho ragione…»
«Questo non dimostra niente lo stesso.»
«Non dimostra proprio niente» ripeté Arkadij con la sicurezza di un esperto giocatore di scacchi che abbia previsto una mossa, evidentemente pericolosa, dell’avversario e non sia perciò punto confuso.
«Come non dimostra niente?» borbottò Pavel Petròvič stupito. «Voi dunque andate contro il vostro stesso popolo?»
«E se fosse anche così?» esclamò Bazàrov. «Il popolo suppone che quando romba il tuono sia il profeta Elia che viaggia in cielo sul carro. E che? devo dargli ragione? E poi, s’egli è russo, non sono russo anch’io?»
«No, non siete russo dopo tutto quello che avete detto ora! Io non posso riconoscervi come russo».
«Mio nonno arava la terra» rispose con altera fierezza Bazàrov. «Domandava a chiunque dei vostri stessi contadini: in chi di noi, in voi o in me, egli riconoscerebbe meglio il proprio connazionale. Voi non sapete nemmeno parlare con lui».
«Mentre voi gli parlate e lo disprezzate nel tempo stesso».
«E perché no, se merita disprezzo? Voi censurate la mia tendenza; ma chi vi ha detto che essa sia in me casuale, che non sia provocata dallo stesso spirito popolare, in nome del quale così vi battete?»
«E come no? Sono proprio indispensabili i nichilisti?»
«Se siamo indispensabili o no, non tocca a voi il decidere. Nemmeno voi vi considerate inutile.»
«Signori, signori, senza casi personali, vi prego!» esclamò Nikolàj Petròvič, e si alzò.
Pavel Petròvič sorrise, e messa una mano sulla spalla del fratello, lo costrinse a seder di nuovo.
«Non inquietarti» proferì. «Non mi lascerò trasportare, proprio in seguito a quel sentimento di dignità, che il signor… il signor dottore schernisce così crudelmente. Permettete», continuò rivolgendosi di nuovo a Bazàrov «voi, forse, pensate che la vostra dottrina sia una novità? Ve lo immagine inutilmente. Il materialismo, che voi predicate, è stato in circolazione più di una volta ed è sempre risultato inconsistente…»
«Un’altra parola straniera!» interruppe Bazàrov. Cominciava a stizzirsi e il suo viso aveva assunto un color rame, grossolano. «In primo luogo, noi non predichiamo nulla; non è nelle nostre abitudini».
«Che cosa fate allora?»
«Ecco quel che facciamo. Prima, in un’epoca abbastanza recente, noi dicevamo che i nostri funzionari si fanno corrompere col denaro, che non abbiamo né strade, né commercio, né una giusta magistratura…»
«Ma sì, sì, voi siete coloro che smascherano i colpevoli, dli accusatori; vi chiamate così, se non mi sbaglio. Con molte delle vostre accuse convengo anch’io, ma…»
«E poi ci siamo accorti che chiacchierare, chiacchierare sempre solo delle nostre piaghe non valeva la pena, che ciò conduce solo alla volgarità e al dottrinarismo; abbiamo visto che anche i nostri sapientoni, i cosiddetti uomini d’avanguardia e accusatori non sono buoni a nulla, che ci occupiamo delle sciocchezze, discutiamo di non so che arte, di creazione incosciente, di parlamentarismo, di avvocatura, e il diavolo sa di cos’altro, quando si tratta del pane quotidiano, quando la più grossolana superstizione ci soffoca, quando tutte le nostra società per azioni vanno a gambe all’aria, unicamente per assenza di uomini onesti, quando la libertà stessa, di cui si preoccupa il governo, difficilmente ci farà pro’, perché il nostro contadino si contenta di derubare se stesso, pur d’ubriacarsi in osteria».
«Così» proruppe Pavel Petròvič «così: vi siete persuasi di tutto ciò e avete deciso di non occuparvi seriamente di nulla nemmeno voi».
«E abbiamo deciso di non occuparci di nulla» – ripeté cupo Bazàrov. Provò a un tratto contro se stesso il dispetto di essersi tanto dilungato dinanzi a quel signore..
«Ma solo d’ingiuriare?»
«Anche d’ingiuriare».
«E’ questo si chiama nichilismo?»
«E questo si chiama nichilismo», – ripeté di nuovo Bazàrov stavolta con particolare insolenza.
(…)
«Noi demoliamo, perché siamo una forza» osservò Arkadij.
Pavel Petròvič guardò il nipote e sorrise.
«Sì, e la forza non è tenuta a render conto» proferì Arkadij e s’impettì.
«Disgraziato!» – strillò Pavel Petròvič, che, decisamente, non era più in grado di trattenersi oltre, «almeno tu pensassi che cosa tu sostieni in Russia con la tua sciocca e volgare sentenza! No, questo può far perdere la pazienza anche a un angelo! La forza! Anche nel selvaggio calmucco, anche nel mongolo, c’è la forza; ma che ci serve? A noi preme la civiltà, sissignore; sì, egregio signore; a noi ci premono i suoi frutti. E non ditemi che questi frutti sono meschini; l’ultimo imbrattatele, un “barbouilleur”, uno strimpellatore, a cui danno un soldo per sera, anche quelli sono più utili di voi, perché rappresentano la civiltà, e non la rozza forza mongola! Vi immaginate di essere uomini d’avanguardia, ma stareste bene in un carro calmucco! La forza! Ma ricordatevi alla fine, o forti signori, che siete quattro uomini e mezzo in tutto; mentre gli altri sono milioni, i quali non vi permetteranno di calpestare le proprie sacrosante credenze, i quali vi schiacceranno!
«Se ci schiacceranno, ne trarremo le conseguenze» proferì Bazàrov. «Solo non è detta l’ultima parola. Non siamo così pochi come voi supponete».
La pagina è costruita come un vero e proprio scontro generazionale, in cui si affrontano due modi differenti, per storia e per cultura, d’affrontare il mondo. Il vecchio Pavel Petròvič raffigura, oserei dire, quasi romanticamente, l’ideale in cui si concentra il concetto di patria, fatto di storia e tradizioni, che permettono di essere russi in quanto penetrato in esse; di fronte Bazàrov, colui che “materialisticamente” non crede più in nulla (nihil) e che costituisce quella intellighenzia giovanile, fortemente moralistica e ribellistica, che pur provenendo dalla piccola borghesia ne ripudiava completamente i valori.
Ma l’importanza del romanzo non sta solo nella precisione realistica, quasi “scientifica”, con cui si cercano d’individuare le motivazioni che stanno dietro i due mondi, ma nella capacità di dare spessore ai personaggi, facendo di essi non dei meri rappresentanti di una ideologia. Così vedremo in Bazàrov, il ribelle, il cui atteggiamento può apparire a volte supponente, quanta sofferenza nasconda.
Ma certamente i due narratori russi di questo periodo che diventeranno veri e propri punti di riferimento per tutti coloro che dovranno scrivere un romanzo, sono Lev Nikolaevič Tolstoj e Fëdor Michajlovič Dostoevskij.

Lev Nikolaevič Tolstoj
Lev Nikolaevič Tolstoj (1828 – 1910) fu un uomo dall’apparente vita tranquilla: nato da una antica famiglia nobiliare compì studi regolari, fece una brillante vita mondana, partecipò come ufficiale ad una guerra contro popolazioni ribelli, sposò la donna amata da cui ebbe 13 figli e si avviò verso una vecchiaia avendo creato una “bella” e “tradizionale” famiglia patriarcale. Tuttavia non fu un uomo sereno: sempre alla continua ricerca di qualcosa che riuscisse in qualche modo a placarlo, approdò ad una concezione cristiano-evangelica e mistico-populista che lo portarono a scelte radicali che gli misero contro la famiglia. Allontanatosi da casa, ormai vecchio, si ammala e muore. Scrisse numerose opere, ma qui si analizzeranno i romanzi Guerra e pace (1869) e Anna Karenina (1877).
Guerra e pace si apre con un quadro dell’alta società di Mosca nel 1805, alla vigilia della guerra contro Napoleone. In mezzo a una folla mondana, preoccupata da intrighi personali, emergono alcuni personaggi dall’anima inquieta e viva: Pierre Bezuchov, goffo e sensibile, appena tornato dall’estero dove lo ha mandato a istruirsi il padre naturale, il vecchio principe Bezuchov; il suo amico, il principe Andrej Bolkonskij, sarcastico, orgoglioso, intelligente, già deluso dal suo recente matrimonio con l’infantile Lisa; i giovanissimi ragazzi Rostov, cioè Vera, Nikolaj, Petja, e soprattutto la gaia, appassionata, tenera Nataša. Molto diversi dalla loro fredda e compassata sorella maggiore, i tre fratelli le preferiscono la cuginetta Sonja, che vive con loro e ama Nikolaj. Alla vita moscovita è contrapposta la vita in campagna, osservata dalla casa dei Bolkonslij (Lysye Gory), nella quale vive in volontario esilio il vecchio e dispotico padre di Andrej, che esercita il suo potere sulla figlia Marja, dolcissima e profondamente religiosa e su tutti gli abitanti della casa: dal vecchio cameriere Tichon a Mlle Bourienne, dama di compagnia di Marja, dall’intendente Alpatič, all’architetto Michail Ivanovič, ammesso per capriccio alla sua tavola. La guerra arriva, turbando quel mondo. Le battaglie si susseguono, e sembrano inutili. A Napoleone, che prepara piani secondo la logica bellica, si oppone Kutuzov, comandante delle armate russe, che preferisce adattare la sua strategia al mutare delle circostanze, passando a volte, agli occhi dei brillanti ufficiali, per debole. Andrej, arruolatosi, dimentica le vicende personali cercando un significato alla tempesta che lo trascina insieme a tanti. Pierre, rimasto a Mosca, è divenuto ricco alla morte del padre che lo ha nominato suo erede universale, e il bel mondo gli ha scoperto improvvisamente brillanti qualità. Il principe Vasilij Kuragin, con abili intrighi, riesce a fargli sposare la figlia Hélene, bellissima, presuntuosa e corrotta. Scoperte le indedeltà della moglie, Pierre si batte col rivale Dolochov, si separa da Hélene, e crede di trovare sollievo alla profonda inquietudine che lo tormenta nella massoneria, progettando l’emancipazione dei servi. Andrej, ferito ad Austerlitz, torna in licenza a Lysye Gory. La sera stessa la moglie muore dando alla luce un bambino. L’enigma di quella morte lo restituisce a un’angosciosa insoddisfazione, finché non incontra a un ballo Nataša, della quale si innamora profondamente. Ella accetta di sposarlo, ma le nozze vengono differite per l’opposizione del padre di Andrej. Questo ritardo offende e turba Nataša, e mentre Andrej è in viaggio, si lascia affascinare dal vanitoso e bello Anatolij Kuragin, fratello di Hélene. Fallito il progetto di venir rapita da lui, grazie all’intervento di un’energica zia, Marja Dmitrevna, rotto il fidanzamento con Andrej, Nataša è come spenta. Andrej, gravemente ferito a Borodino, riconoscerà nell’infermeria Anatolij, appena amputato di una gamba. Cade in quel momento il suo rancore verso di lui e Nataša, che ritroverà, più di prima, tenera, seria e innamorata, mentre lo trasportano ormai morente, durante la grande ritirata che precede l’incendio di Mosca. Andrej muore ormai rappacificato con se stesso, assistito da Nataša e da Marja, fuggita da Lysye Gory di fronte all’avanzare delle truppe, dopo la morte del padre. Vedovo, dopo la morte misteriosa di Hélene, Pierre è rimasto a Mosca, col vago progetto di uccidere Napoleone. Fatto prigioniero dai francesi, incontra tra gli altri prigionieri l’uomo che gli indica la via spirituale da seguire: il sorridente, paziente, pio soldato-contadino Platon Karataev. La vita dei Rostov ha subito mutamenti: Vera ha sposato Boris Berg; Petja è morto, appena arruolato; è finito l’idillio tra Sonja e Nikolaj. Alla fine della guerra Pierre rivede Nataša a Mosca: l’ama da tempo, ma esita a dichiararsi. Nataša accetterà con gioia di sposarlo. Si uniscono infine anche Nikolaj e Marja, ch’egli amava da quando l’aveva salvata da un ammutinamento di contadini a Lysye Gory durante la guerra. Le nuove famiglie vengono mostrate, nell’epilogo, nel 1820: i protagonisti sono invecchiati, Nataša, assorbita dai suoi compiti di madre e moglie, ha perso molto del fascino poetico di un tempo. Marja e Pierre sono i personaggi spiritualmente più forti. Simbolo delle generazioni future, fa una breve e significativa apparizione Nikolen’ka, il figlio del principe Andrej.
E’ questo testo uno dei più complessi e più importanti di tutta la letteratura europea. I temi presenti in esso non vogliono soltanto “raccontare” realisticamente un periodo storico ben definito, ma presentarcelo nella sua multiforme varietà. La sua caratteristica, infatti, è quella di offrirci un’epica rappresentazione della totalità della vita nei suoi vari aspetti, che va dall’alterigia dei generali di guerra alla semplice paura del soldato appena arruolato, dalle sale bellamente arredate alla povera casupola del contadino, e pur ruotando attorno alla nobiltà, ci mostra come essa possa essere ben influenzata da un pio contadino. Per meglio dire non esiste “realtà” che non sia in relazione con tutte le altre “realtà” e con la storia più in generale.
La concezione della storia tolstojana la possiamo leggere in una famosa pagina:
L’OCCUPAZIONE E L’INCENDIO DI MOSCA
Sebbene laceri, affamati, esausti, e ridotti alla metà degli effettivi iniziali, i soldati francesi che entrarono in Mosca formavano ancora un esercito ben ordinato. Era un esercito esausto, spossato, ma ancora combattivo e pericoloso. Ma fu tale solo fino al momento in cui i suoi soldati non si sistemarono negli appartamenti. Non appena gli uomini dei vari reggimenti cominciarono a sparpagliarsi nelle ricche case vuote, l’esercito, da allora, si dissolse per sempre e al suo posto si formò qualcosa cui non si poteva dare il nome né di abitanti né di soldati, qualcosa di mezzo fra i due: un’accozzaglia di saccheggiatori. Quando, dopo cinque settimane, quegli stessi uomini uscirono da Mosca, non esisteva più un esercito. C’era invece una moltitudine di saccheggiatori, ciascuno dei quali si portava via, sui veicoli o indosso, un mucchio di cose che gli sembravano preziose e necessarie. Lo scopo di tutti quegli uomini, nel lasciare Mosca, non consisteva più, come prima, nel conquistare con la forza delle armi, ma unicamente nel conservare quanto avevano arraffato. Come la scimmia che, ficcata la mano nella stretta imboccatura di una brocca e afferrata una manciata di noci, non apre più il pugno per non perdere ciò che ha agguantato e con ciò segna la propria rovina, così i francesi, nel lasciare Mosca, dovevano evidentemente andare incontro alla rovina poiché portavano via con sé ciò che avevano rubato; ma abbandonare quanto avevano rubato per loro era impossibile com’è impossibile per la scimmia aprire il pugno pieno di noci. Dieci minuti dopo l’entrata in città di tutti i reggimenti francesi, non restava più un solo soldato o un solo ufficiale. Dalle finestre delle case si scorgevano uomini in cappotto e ghette che, ridendo, passeggiavano all’interno degli appartamenti; nelle cantine, negli interrati, altri la facevano da padroni con le provviste; nei cortili, altri ancora aprivano o sfondavano le porte dei depositi e delle scuderie; nelle cucine accendevano fuochi, con le maniche rimboccate friggevano, impastavano; spaventavano, facevano ridere e vezzeggiavano le donne e i bambini. E dappertutto, nelle botteghe e nelle case, di quegli uomini ce n’era un gran numero: quello che non c’era più, ormai, era l’esercito.
In quella stessa prima giornata i comandanti francesi impartirono ordini su ordini vietando alle truppe di sparpagliarsi per la città, proibendo severamente ogni violenza contro gli abitanti e ogni saccheggio, convocando l’esercito, per quella sera stessa, a un appello generale; ma ad onta di qualsiasi provvedimento, quegli uomini che finora avevano costituito un esercito si disperdevano per la ricca città deserta, ricca di comodità e di provviste. Come una mandria affamata procede unita per una campagna spoglia, ma subito si sbanda e si disperde, irrefrenabilmente, non appena capita su ricchi pascoli, in modo altrettanto irrefrenabile si sparpagliava qua e là per la città opulenta quell’esercito.
Abitanti, a Mosca, non ce n’erano e i soldati venivano assorbiti dalla città come l’acqua dalla sabbia e, irraggiandosi a stella dal Cremlino dove erano dapprima entrati, si allontanavano, disperdendosi, in tutte le direzioni. I soldati di cavalleria, entrando in una casa di mercanti abbandonata con tutte le suppellettili, e trovandovi stalle sufficienti non solo per i loro cavalli, ma anche per altri, andavano comunque a occupare un’altra casa accanto perché sembrava loro migliore. Molti occupavano un certo numero di case, segnando col gesso sulla porta il nome di chi le aveva occupate, litigavano, e persino si azzuffavano con gli altri reparti. Ancora prima di essersi sistemati a dovere, i soldati correvano in strada a vedere la città e, sentendo dire che tutto era stato abbandonato, si precipitavano dove si poteva fare man bassa di cose preziose. I comandanti andavano in giro per fermare i soldati e senza volerlo erano trascinati anche loro nel saccheggio. Al Karetnyj Rjad erano rimaste intatte le botteghe dei carrozzai, e là si affollavano i generali per scegliersi carrozze e calessi. I pochi abitanti rimasti invitavano nelle loro case i comandanti sperando, in tal modo, di sottrarsi al saccheggio. Di ricchezze ce n’erano un’infinità e non se ne vedeva la fine; dappertutto, tutt’intorno ai luoghi occupati dai francesi, si stendevano altri luoghi non ancora esplorati, non ancora occupati, in cui ai francesi sembrava dovessero esserci ancor maggiori ricchezze. E così Mosca li attirava e li assorbiva sempre più lontano, sempre più lontano. Allo stesso modo in cui versando dell’acqua sulla terra arida, insieme all’acqua scompare anche la terra, così per il fatto che un esercito affamato era entrato in una città ricca e vuota, rimase distrutto l’esercito e andò distrutta la ricca città: ne nacque fango, ne nacquero incendi e saccheggi.
I francesi hanno attribuito l’incendio di Mosca “au patriotisme féroce de Rastopchine”; i russi al fanatismo dei francesi. In realtà, cause dell’incendio di Mosca – nel senso di poter attribuire le responsabilità di tale incendio a una o più persone – non c’erano e non ci potevano essere. Mosca bruciò perché era stata messa in condizioni tali in cui qualsiasi città di legno si sarebbe incendiata, a parte che in città vi siano o non vi siano centotrenta malconce pompe da incendio. Mosca doveva andare a fuoco a seguito del fatto che gli abitanti ne erano partiti, con la stessa necessità con cui deve prender fuoco un mucchio di trucioli sui quali, per parecchi giorni di fila, cadano scintille di fuoco. Una città tutta di legno, in cui, anche quando sono presenti i legittimi proprietari delle case e la polizia, quasi ogni giorno, d’estate, scoppiano degli incendi, non può non andare a fuoco quando in essa gli abitanti non ci sono, e al loro posto vivono soldati che fumano le pipe, accendono falò sulla Piazza del Senato con le sedie del Senato stesso e si cuociono da mangiare due volte al giorno. Basta che, anche in tempo di pace, delle truppe si accampino nei villaggi di una data contrada, perché il numero degli incendi di quella contrada diventi subito più alto. In che misura doveva allora aumentare la probabilità di incendi in una deserta città di legno in cui si era accampato un esercito straniero? Le patríotisme féroce de Rastopèin e il fanatismo dei francesi non hanno, qui, proprio nessuna colpa. Mosca prese fuoco per le pipe, per le cucine, per i falò, per la negligenza dei soldati nemici, che abitavano nelle case ma non ne erano i proprietari. Se pure vi furono degli incendi dolosi (cosa peraltro dubbia, perché nessuno aveva motivo di appiccare fuoco e, in ogni caso, si sarebbe trattato di azioni rischiose e complesse), non è possibile cercare in essi la causa di tutto, perché anche senza questi i fatti sarebbero andati nello stesso modo.
Per quanto attraente fosse per i francesi far ricadere la colpa sulla ferocia di Rastopèin, e, per i russi, accusare il criminale Bonaparte, per poi mettere, in un secondo momento, una fiaccola eroica nelle mani del loro popolo, non si può non vedere che una causa immediata di questo genere non poté esistere alle origini di questo incendio, perché Mosca doveva bruciare, come deve bruciare ogni villaggio, ogni fabbrica, ogni casa che i proprietari abbandonano e in cui entra gente estranea a farla da padrone a cucinarsi i pasti. Mosca fu incendiata dagli abitanti, è vero; ma non da quelli che vi erano restati, bensì da quelli che ne erano partiti. Mosca, occupata dal nemico, non restò intatta – come Berlino, Vienna e altre città – soltanto perché i suoi abitanti non avevano fatto gli onori di casa, non avevano consegnato le chiavi ai francesi, ma l’avevano abbandonata.
Non è una vera e propria pagina di storia, ma di riflessione morale sulla stessa. Tolstoj infatti vuole qui riflettere sul perché di fronte alla presa francese della città, si siano sviluppati così tanti incendi e perché l’esercito vincitore risultasse, infine, così debole e vulnerabile. La motivazione è una sola: l’arrivo di un esercito affamato da giorni e giorni di digiuno e l’allontanamento dei moscoviti dalla città. L’esercito napoleonico un tempo forte e disciplinato, diventa rilassato e saccheggiatore. La ricchezza della città ha indebolito l’uomo: ecco la riflessione morale. Vi è infatti quasi un senso di giustizia che sovrasta l’episodio: il vincitore risulterà poi essere vinto dalla sua grettezza e avidità. Non manca un’ultima notazione, legata dall’imprescindibile legge della causalità: date determinate premesse (il vuoto della città e la prepotenza degli uomini) non ne può che derivare una sola ed inevitabile conseguenza, la distruzione, attraverso il fuoco, della città stessa.
Uno dei personaggi centrali dell’immensa epopea russa è certamente il principe Andrej:
LA MORTE DEL PRINCIPE ANDREJ
Il principe Andrej rimase in piedi, indeciso. La granata roteava fumando, come una trottola, fra di lui e l’aiutante disteso a terra, sull’orlo del campo e del prato, vicino a un cespuglio d’assenzio.
«Possibile che sia la morte?» pensò il principe Andrej guardando con uno sguardo assolutamente nuovo e invidioso l’erba, l’assenzio e la striscia di fumo che si avvolgeva uscendo dalla nera palla roteante. «lo non posso, non voglio morire, io amo la vita, amo questa erba, la terra, l’aria…» Pensava a questo e nello stesso tempo si ricordò che lo stavano guardando.
«Vergogna, signor ufficiale!» disse all’aiutante. «Che…» ma non terminò la frase.
Nello stesso istante si udì uno scoppio, come un tintinnio di vetri infranti, l’odore soffocante della polvere, e il principe Andrej fu proiettato da una parte; e, sollevando in aria un braccio, cadde bocconi.
Alcuni ufficiali corsero verso di lui. Dalla parte destra del ventre si allargava sull’erba una grande macchia di sangue.
Chiamati, i militi si fermarono con la barella dietro gli ufficiali. Il principe Andrej giaceva bocconi, il volto abbandonato fra l’erba, e respirava con un rantolo affannoso.
«Be’, perché state lì fermi, venite qui!»
I contadini si avvicinarono e lo presero per le spalle e per le gambe, ma egli emise un gemito doloroso e, guardandosi fra loro, i contadini lo deposero di nuovo a terra.
«Sollevatelo, adagiatelo, tanto è lo stesso!» gridò una voce.
Lo sollevarono per le spalle e lo deposero sulla barella.
«Ah, Dio mio! Dio mio! Che è?… Il ventre? E’ la fine! Ah, Dio mio!» si udirono delle voci fra gli ufficiali.
«Ha sibilato rasente il mio orecchio,» disse l’aiutante.
I contadini, caricatasi la barella sulle spalle, si avviarono in fretta verso il posto di medicazione lungo il sentiero calpestato dai loro stessi passi.
«Andate al passo… Eh!… zoticoni!» gridò un ufficiale, fermando per le spalle i contadini che camminavano in modo irregolare e facevano sussultare la barella.
«Mettiti al passo, su, Chvedor, oh Chvedor,» disse un contadino davanti.
«Ecco, così, bene,» disse con gioia il contadino che reggeva la barella da dietro, prendendo il passo.
«Eccellenza? Eh? Principe?» disse con una voce tremante Timochin che era accorso, guardando la barella.
Il principe Andrej aprì gli occhi e, dalla barella in cui la sua testa era sprofondata, guardò chi parlava, e poi abbassò di nuovo le palpebre.
I militi portarono il principe Andrej verso la foresta dove stavano i furgoni e dove si trovava il posto di medicazione. Il posto di medicazione consisteva in tre tende montate al margine d’un boschetto di betulle e con le cortine rialzate. Nel boschetto di betulle c’erano furgoni e cavalli. I cavalli mangiavano l’avena nei sacchi, e i passerotti svolazzavano intorno e beccavano i granelli che cadevano. I corvi, sentendo l’odore del sangue, svolazzavano fra le betulle, gracchiando impazienti. Intorno alla tenda, su un’estensione di terreno di più di due ettari, stavano sdraiati, seduti, in piedi, uomini insanguinati vestiti nei modi più disparati. Intorno ai feriti, con facce meste e attente, facevano cerchio gruppi di soldati-barellieri, che gli ufficiali addetti a mantenere l’ordine invano scacciavano da quel luogo. Senza dare ascolto agli ufficiali, i soldati stavano appoggiati alle barelle e guardavano attentamente ciò che succedeva davanti a loro, come se cercassero di comprendere il significato dello spettacolo. Dalle tende giungevano ora lamenti alti e rabbiosi, ora gemiti pietosi. Ogni tanto ne uscivano di corsa gli infermieri per cercare acqua e indicavano quei feriti che si dovevano portar dentro. Aspettando presso la tenda il loro turno, i feriti rantolavano, gemevano, piangevano, gridavano, imprecavano, chiedevano vodka. Alcuni deliravano.
Camminando fra i feriti non ancora medicati, i militi portarono il principe Andrej, in quanto comandante di reggimento, vicino a una delle tende, e quindi si fermarono in attesa di ordini. Il principe Andrej aprì gli occhi e per un pezzo non riuscì a capire che cosa succedesse intorno a lui. Si ricordò del prato, dell’assenzio, del campo, della nera palla roteante e del suo appassionato slancio d’amore per la vita. A due passi da lui, parlando forte e attirando su di sé l’attenzione generale, stava un bel sottufficiale, alto e scuro di capelli, con la testa fasciata, che si appoggiava a un ramo secco. Era stato ferito alla testa e a una gamba da pallottola di fucile. Intorno a lui si era raccolta una folla di feriti e di barellieri che ascoltavano avidamente ciò che egli diceva.
«Quando li abbiamo cacciati di là, quelli hanno piantato tutto, persino il re gli abbiamo preso!» gridava il militare, guardandosi attorno con gli occhi neri scintillanti. «Se soltanto le riserve fossero arrivate al momento giusto, fratello mio, non ne restava neanche il segno, perché te lo dico io…»
Come tutti gli altri che ascoltavano il racconto, anche il principe Andrej guardava il sottufficiale con uno sguardo scintillante e provava un senso di consolazione. «Ma non è forse tutto eguale ormai?» pensava. «E che cosa succederà di là e che cos’è successo qui? Perché mi dispiaceva tanto separarmi dalla vita? C’era qualcosa in questa vita che io non ho capito e non capisco.»
Uno dei medici, con il camice insanguinato, e con le piccole mani insanguinate, in una delle quali teneva un sigaro fra il mignolo e il pollice (per non insudiciarlo); questo medico, uscì dalla tenda, sollevò il capo e si mise a guardare intorno, ma al di sopra dei feriti. Evidentemente aveva voglia di riposarsi un po’. Dopo aver girato lo sguardo per un certo tempo, a destra e a sinistra, sospirò e abbassò gli occhi.
«Sì, subito,» rispose alle parole dell’infermiere che gli indicava il principe Andrej, e diede ordine di portarlo nella tenda.
Tra la folla dei feriti che aspettavano si levò un mormorio.
«Si vede che anche nell’altro mondo soltanto i signori hanno diritto di vivere,» proferì uno di loro.
Il principe Andrej fu portato dentro e deposto su un tavolo appena ripulito dal quale un infermiere faceva scolare via qualcosa. Il principe Andrej non poté distinguere in tutti i particolari ciò che c’era nella tenda. Lo distraevano i gemiti lamentosi che venivano da varie parti e un lancinante dolore alla coscia, al ventre e alla schiena. Tutto quello che vedeva intorno a sé si fondeva per lui in un’unica impressione generale di corpi umani nudi e insanguinati che sembravano riempire tutta la tenda bassa, come alcune settimane prima, in quella calda giornata d’agosto, gli stessi corpi riempivano lo stagno fangoso lungo la strada di Smolensk. Sì, erano quegli stessi corpi, quella stessa chair à canon, la cui vista già allora, come un presagio del presente, gli aveva suscitato orrore.
Nella tenda c’erano tre tavoli. Due erano occupati, sul terzo fu deposto il principe Andrej. Per un certo tempo lo lasciarono solo ed egli vedeva involontariamente ciò che si faceva sugli altri tavoli. Sul tavolo più vicino c’era un tartaro, probabilmente un cosacco a giudicare dalla divisa gettata lì accanto. Lo tenevano quattro soldati. Un medico con gli occhiali gli tagliava qualcosa nella schiena, bruna e muscolosa.
«Uh, uh!…» grugniva il tartaro, e a un tratto, sollevando in su la sua nera faccia camusa dai larghi zigomi, scoprendo i denti bianchi, cominciò a dibattersi, a contorcersi e a stridere con un urlo prolungato, lacerante e acuto. Su un altro tavolo, vicino al quale si affollavano molte persone, giaceva supino un uomo grande e robusto con la testa abbandonata indietro (i suoi capelli ricciuti, il loro colore e la forma stessa della testa parvero stranamente noti al principe Andrej). Alcuni infermieri facevano forza sul petto di quell’uomo e lo tenevano fermo. Un grande piede robusto, con movimenti rapidi e frequenti, si contraeva senza posa con febbrili trasalimenti. Quest’uomo singhiozzava in modo convulso e quasi soffocava. Due medici, uno dei quali era pallido, e tremava, facevano in silenzio qualcosa sull’altra gamba, rossa di sangue, di quell’uomo. Finito di operare il tartaro, sopra il quale fu gettato un cappotto, il dottore con gli occhiali si avvicinò al principe Andrej, pulendosi intanto le mani.
Gettò uno sguardo alla faccia del principe Andrej e si voltò in fretta.
«Svestitelo! Che cosa aspettate?» gridò con ira agli infermieri.
Quando l’infermiere gli sbottonò i bottoni e gli tolse gli abiti con mani frettolose dalle maniche rimboccate, il principe Andrej si ricordò della prima e più lontana infanzia. Il dottore si chinò proprio sopra la ferita, la tastò e sospirò profondamente. Poi fece un segno a qualcuno. E un dolore lancinante nelle viscere fece perdere i sensi al principe Andrej. Quando si riebbe, le ossa spezzate del femore erano state estratte, dei lembi di carne erano stati recisi e la ferita bendata. Gli spruzzarono dell’acqua in viso. Non appena il principe Andrej aprì gli occhi, il dottore si chinò su di lui, lo baciò senza dire una parola sulle labbra e si allontanò in fretta.
Dopo la sofferenza patita, il principe Andrej provava un senso di beatitudine che da tempo non provava. Alla sua immaginazione si presentavano, non come passato, ma come realtà presente, tutti i momenti migliori e più felici della sua vita, specialmente la più remota infanzia, quando lo spogliavano e lo mettevano sul lettino, quando la njanja lo cullava cantando, quando, coprendosi la testa col cuscino, egli si sentiva felice per il solo fatto di essere vivo.
Intorno a quel ferito, la forma della cui testa sembrava nota al principe Andrej, si davano da fare i dottori: lo sollevavano e lo calmavano.
«Fatemi vedere… Oooooh! Oh! Oooooh!» si sentiva il suo gemito rotto da singhiozzi, atterrito e rassegnato dalla sofferenza.
Ascoltando quei gemiti, al principe Andrej veniva voglia di piangere. Forse perché moriva senza gloria, forse perché gli dispiaceva lasciare la vita, quegli irrevocabili ricordi d’infanzia, forse perché soffriva, perché gli altri soffrivano e quell’uomo gemeva così pietosamente davanti a lui, gli veniva voglia di piangere lacrime infantili, buone, quasi liete.
Mostrarono al ferito la gamba amputata dentro uno stivale sporco di sangue raggrumato.
«Oh! Oooooh!» singhiozzò come una donna.
Il dottore che stava davanti al ferito, nascondendone la faccia, si allontanò.
«Dio mio! Che è questo? Perché è qui?» disse il principe Andrej.
Nell’uomo infelice, che singhiozzava privo di forze, a cui avevano appena amputato la gamba, egli riconobbe Anatole Kuragin. Sorreggevano a braccia Anatole e gli offrivano dell’acqua in un bicchiere di cui egli non riusciva ad afferrare l’orlo con le labbra tremanti e gonfie.
«Sì, è lui; sì, quell’uomo che è legato a me cosi intimamente da un qualche cosa,» pensò il principe Andrej senza capire ancora chiaramente chi fosse l’uomo che stava davanti a lui. «In che cosa consiste il legame di quest’uomo con la mia infanzia, con la mia vita?» Si domandava senza trovare risposta. E a un tratto al principe Andrej si presentò un nuovo, inaspettato ricordo che veniva dal mondo dell’infanzia, della purezza, dell’amore. Ricordò Nataša come l’aveva vista la prima volta a un ballo nel 1810, con l’esile collo e le braccia sottili, col suo viso pronto all’entusiasmo, spaventato, felice, e l’amore e la tenerezza per lei si risvegliarono nella sua anima più vivi e forti che mai. Adesso ricordava quale legame esistesse fra lui e quell’uomo che lo stava guardando attraverso le lacrime che riempivano i suoi occhi gonfi. Il principe Andrej ricordò tutto, e una compassione esultante e piena d’amore per tutti gli uomini riempirono il suo cuore felice.
Egli non seppe più contenersi e pianse lacrime tenere, d’amore per gli uomini, per se stesso e per i propri e i loro sbagli.
«La commiserazione, l’amore per i fratelli, per coloro che ci amano; l’amore per coloro che ci odiano, l’amore per i nemici, sì, quell’amore che Dio ha predicato sulla terra, che mi ha insegnato la principessina Mar’ja e che io non capivo; ecco perché mi dispiaceva di lasciare la vita, ecco quello che ancora mi restava, se fossi vissuto. Ma adesso è troppo tardi. Lo so!»
L’episodio della morte del principe Andrej ci porta verso la profonda religiosità che anima lo scrittore russo. Il momento in cui è strutturato il racconto è decisamente giocato tra l’eroismo di Andrej e l’incredibile felicità che prova nel percepire l’essere ancora in vita. Ha bisogno di sentire la morte, per apprezzare la vita, per amarla, per riviverla nel passato e nel presente. Il presente è Anatole Kuragin, personaggio decisamente negativo nel romanzo, ma che qui acquista un valore che va al di là della sua vita, strumento di un amore universale che trascende il contingente che rende l’uomo simile a Dio.
L’altro grande romanzo di Tolstoj è Anna Karenina:
Anna, moglie insoddisfatta dell’alto funzionario Karenin, si innamora del bell’ufficiale Vronskij. Il marito le impone il rispetto delle formalità sociali, ma Anna, rimasta incinta dell’amante, fugge con lui in Italia. La società pietroburghese mette al bando l’adultera, il marito non le concede il divorzio e le impedisce di vedere il figlio nato da loro matrimonio: disperata per l’isolamento in cui viene a trovarsi, per la crescente incomprensione con l’amante di cui è gelosa senza ragione, Anna si uccide buttandosi sotto il treno. Altro protagonista del romanzo è il potente Levin, ansioso di trovare una fede autentica e deciso a costruirsi una vita familiare e serena e austera con la moglie Kitty, lontano dalle fatue beghe della società moscovita. Troverà nelle semplici parole di un contadino la spinta verso un rinnovamento interiore di tipo evangelico.
IL SUICIDIO DI ANNA
«Sì, mi agita molto, e la ragione è data per liberarsene; perciò bisogna liberarsene. E perché non spegnere la candela, quando non c’è più nulla da guardare, quando fa ribrezzo guardare tutto? Ma come? Perché questo capotreno è passato di corsa sulla traversa? perché gridano quei giovani, in quello scompartimento? Perché parlano, perché ridono? Tutto è menzogna, tutto inganno, tutto malvagità…».
Quando il treno entrò in stazione, Anna uscì tra la folla degli altri passeggeri e, allontanandosi da loro come da lebbrosi, si fermò sulla banchina, cercando di ricordare perché era arrivata là e cosa avesse intenzione di fare. Tutto quello che prima le sembrava possibile, adesso era così difficile a considerarsi, specialmente tra la folla rumoreggiante di tutte quelle persone deformi, che non la lasciavano in pace. Ora i facchini accorrevano da lei, offrendole i loro servigi, ora dei giovani, battendo coi tacchi le assi della banchina e discorrendo forte, la esaminavano, ora quelli che venivano incontro si facevano di lato non dalla parte giusta. Ricordatasi che voleva proseguire, se non ci fosse stata risposta, fermò un facchino e domandò se era venuto un cocchiere con un biglietto per il conte Vronskij.
«Il conte Vronskij? Per incarico suo sono stati qui proprio ora. Venivano incontro alla principessa Sorokina con la figlia. E il cocchiere com’è?»
Mentre ella parlava col facchino, Michajla, rosso e allegro, con un elegante pastrano turchino e la catena, evidentemente orgoglioso d’avere eseguito così bene la commissione, le si avvicinò e le porse un biglietto. Ella aprì e il cuore le si strinse ancor prima di leggere.
«Mi dispiace molto che il biglietto non m’abbia trovato. Verrò alle dieci» scriveva Vronskij con una scrittura trascurata.
«Ecco! Me l’aspettavo!» si disse con un sorriso cattivo.
«Va bene, allora va’ a casa» disse piano, rivolta a Michajla. Ella parlava piano perché la rapidità dei battiti del cuore le impediva di respirare.
«No, non ti permetterò di tormentarmi» ella pensò, rivolta con minaccia, non a lui, né a se stessa, ma a chi le imponeva di tormentarsi, e si incamminò per la banchina lungo la stazione.
Due cameriere che camminavano sulla banchina si voltarono a guardarla, facendo ad alta voce qualche apprezzamento sul suo vestito: «sono veri» dissero dei pezzi ch’ella aveva addosso. I giovani non la lasciavano in pace. Di nuovo le passarono accanto, guardandola in viso e gridando fra le risa qualcosa con voce contraffatta. Il capostazione, passando, le domandò se partiva. Un ragazzo, venditore di kvas, non le toglieva gli occhi di dosso.
«Dio mio, dove andare?» ella pensava, allontanandosi sempre più sulla banchina.
Alla fine si fermò. Le signore e i bambini, che erano venuti a incontrare un signore con gli occhiali e che ridevano e parlavano forte, tacquero, esaminandola, quand’ella giunse alla loro altezza. Ella affrettò il passo e si allontanò da loro verso l’orlo della banchina. Si avvicinava un treno merci. La banchina si mise a tremare e a lei parve d’essere di nuovo in viaggio.
E a un tratto si ricordò dell’uomo schiacciato al suo primo incontro con Vronskij e capì quello che doveva fare. Dopo essere scesa con passo veloce, leggero, per i gradini che andavano verso le rotaie, si fermò accanto al treno che le passava vicinissimo. Guardava la parte sottostante dei carri, le viti e le catene e le ruote alte di ghisa del primo carro che scivolava lento, e cercava di stabilire con l’occhio il punto mediano fra le ruote anteriori e le posteriori e il momento in cui questo punto mediano sarebbe stato di fronte a lei.
«Là» si diceva, guardando nell’ombra del carro la sabbia mista a carbone di cui erano sparse le traverse «là, proprio nel mezzo, e lo punirò, e mi libererò da tutti e da me stessa».
Voleva cadere sotto il primo vagone che giungesse alla sua altezza nel punto mediano; ma il sacchetto rosso che aveva preso a togliere dal braccio, la trattenne, ed era già tardi; il punto mediano le era passato accanto. Bisognava aspettare il vagone seguente. Un sentimento simile a quello che provava quando, facendo il bagno, si preparava a entrar nell’acqua, la prese, ed ella si fece il segno della croce. Il gesto abituale della croce suscitò nell’anima sua tutta una serie di ricordi verginali e infantili, e a un tratto l’oscurità che per lei copriva tutto si lacerò, e la vita le apparve per un attimo con tutte le sue luminose gioie passate. Ma ella non staccava gli occhi dalle ruote del secondo vagone che si avvicinava. E proprio nel momento in cui il punto mediano fra le ruote giunse alla sua altezza, ella gettò indietro il sacchetto rosso, ritirò la testa fra le spalle, cadde sulle mani sotto il vagone e con movimento leggero, quasi preparandosi a rialzarsi subito, si lasciò andare in ginocchio. E in quell’attimo stesso inorridì di quello che faceva. «Dove sono? che faccio? perché?». Voleva sollevarsi, ripiegarsi all’indietro, ma qualcosa di enorme, di inesorabile le dette un urto nel capo e la trascinò per la schiena. «Signore, perdonami tutto!» ella disse, sentendo l’impossibilità della lotta. Un contadino, dicendo qualcosa, lavorava su del ferro. E la candela, alla cui luce aveva letto il libro pieno di ansie e di inganni, di dolore e di male, avvampò di una luce più viva che mai, le schiarì tutto quello che prima era nelle tenebre, crepitò, prese ad oscurarsi e si spense per sempre.
Non diverso dal trapasso del principe Andrej è la morte di Anna. Qui il tutto è visto nei singoli istanti, come se l’occhio del narratore si soffermasse non solo sulle cose, ma sulle sensazioni “deformare” della protagonista. L’ambiente che la circonda è “uno schifo”, le altre persone, nella stazione, sono “come lebbrosi” e “deformi”. La realtà in cui si trova è straniata, tanto da portarla fuori da sé. Quindi Anna la cerca la morte, indaga il punto in cui lasciarsi andare, ma solo allora, nel momento di cadere, si sente invasa da un senso d’illuminazione sulla bellezza dell’esistere.
Nell’intero romanzo non troviamo una semplice storia d’amore e tradimento; vi è in esso l’intrecciarsi di vari filoni della narrazione, i differenti modi di vivere il ruolo di moglie o l’istituzione familiare, la contemporanea rappresentazione di ambienti sociali diversi tra loro trasformano la storia di un adulterio in una globale visione del mondo moscovita e dei problemi morali sul destino dell’uomo che il credente Tolstoj poneva come centrali nella sua riflessione.

Fëdor Michajlovič Dostoevskij
Contemporaneo a Tolstoj, con cui condivide l’importanza letteraria, è Fëdor Michajlovič Dostoevskij (1821 1881). Tuttavia i temperamenti, le tematiche e le strategie narrative sono molto differenti tra loro. Autore di numerosi romanzi, scritti per ottemperare i numerosi debiti, dovuti anche alla sua passione per il gioco, l’autore russo parte, in un primo momento, dalla descrizione degli ambienti degradati, mostrando pietà verso gli uomini subalterni ed emarginati dalla società. Un fatto biografico, piuttosto importante, oltre a minarlo psicologicamente, determinerà un profondo mutamento nella sua produzione. Nei romanzi della seconda fase, infatti, procede ad un’analitica e spietata analisi dell’uomo, che lo porta a superare il cosiddetto realismo per inaugurare il romanzo psicologico novecentesco e, in qualche modo, anticipare le teorie freudiane.
Tipico di questa seconda fase è il romanzo Memorie del sottosuolo (1865):
Il romanzo è diviso in due parti: la prima s’intitola “Il sottosuolo”, la seconda “A proposito della neve fradicia”. Tutto il romanzo ha la struttura di un lungo monologo. Nella prima parte il protagonista, rivolgendosi a un ipotetico interlocutore, parla di se stesso, dell’educazione ricevuta, della formazione del proprio carattere, del complesso di qualità e difetti da lui definito “sottosuolo”, che costituiscono la personalità nascosta, celata a tutti, affiorante solo a seguito di una dettagliata analisi. Nella seconda parte il narratore ripercorre alcuni episodi della sua vita, dove con più evidenza gli si è manifestato il “sottosuolo”. Solitudine, malinconia lo spingono a seguire, non invitato e non desiderato, alcuni compagni di studi a una cena. Umiliato dal loro atteggiamento, oltraggiato pubblicamente, vendica l’offesa subita su Liza, una prostituta incontrata in una casa di tolleranza: le fa un quadro del destino degradante e spaventoso che l’attende tra debiti, malattie e percosse. Dopo qualche giorno Liza ricompare, con la nostalgia di una vita pura. Accolta con volgarità e violenza, rimane ugualmente convinta della sofferenza profonda dell’uomo che la maltratta. Egli la caccia, mettendogli in mano un biglietto di cinque rubli per umiliarla. Ella fugge, e solo dopo la sua scomparsa il narratore scopre il biglietto sul tavolo, testimonianza della sua meschinità e della profonda dignità di Liza.
L’UOMO DEL SOTTOSUOLO
Sono un uomo malato… Sono un uomo cattivo. Un uomo sgradevole. Credo di avere mal di fegato. Del resto, non capisco un accidente del mio male e probabilmente non so di cosa soffro. Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se rispetto la medicina e i dottori. Oltretutto sono anche estremamente superstizioso; be’, almeno abbastanza da rispettare la medicina. (Sono abbastanza colto per non essere superstizioso, ma lo sono.) Nossignori, non voglio curarmi per cattiveria. Ecco, probabilmente voi questo non lo capirete. Be’, io invece lo capisco. Io, s’intende, non saprei spiegarvi a chi esattamente faccia dispetto in questo caso con la mia cattiveria; so perfettamente che neppure ai medici potrò farla non curandomi da loro; so meglio di chiunque altro che con tutto ciò nuocerò unicamente a me stesso e a nessun altro. E tuttavia, se non mi curo, è per cattiveria. Il fegato mi fa male, e allora avanti, che faccia ancor più male! È già da molto tempo che vivo così: una ventina d’anni. Ora ne ho quaranta. Prima lavoravo, ma adesso non lavoro. Ero un impiegato cattivo. Ero villano e ne ricavavo piacere. Infatti non prendevo bustarelle, dunque dovevo pur gratificarmi in qualche modo. (Pessima battuta; ma non la cancellerò. L’ho scritta pensando che sarebbe risultata molto arguta; ma ora che mi son reso conto che volevo soltanto pavoneggiarmi in modo disgustoso, apposta non la cancellerò!) Quando alla scrivania a cui lavoravo si avvicinavano dei postulanti per chiedere informazioni, io digrignavo i denti contro di loro e provavo un indicibile godimento, quando mi riusciva di dare un dispiacere a qualcuno. Mi riusciva quasi sempre. Per la maggior parte era gente timida; si sa: postulanti. Ma fra i bellimbusti non potevo sopportare soprattutto un ufficiale. Lui non voleva in nessun modo sottomettersi e faceva un abominevole baccano con la sciabola. Per un anno e mezzo fra me e lui ci fu una guerra per quella sciabola. Finalmente la spuntai. Egli smise di far baccano. Del resto, questo accadeva ancora nella mia giovinezza. Ma lo sapete, signori, in che consisteva il punto fondamentale della mia cattiveria? Proprio lì stava tutto il nocciolo, proprio lì era racchiusa l’infamia peggiore: che in ogni momento, perfino nel momento della rabbia più accesa, vergognosamente riconoscevo dentro di me che non solo non ero un uomo cattivo, ma neppure ero inasprito, che spaventavo soltanto inutilmente i passeri e così mi consolavo. Ho la schiuma alla bocca, ma portatemi un bambolotto, datemi una tazza di tè con un po’ di zucchero, e magari mi calmerò. Anzi, il mio animo s’intenerirà, anche se poi, probabilmente, digrignerò i denti contro me stesso e per la vergogna soffrirò d’insonnia per diversi mesi. Ormai ci ho fatto l’abitudine. Poco fa ho mentito sul mio conto, dicendo che ero un impiegato cattivo. Ho mentito per cattiveria. Facevo solo i capricci, tanto con i postulanti che con l’ufficiale, ma in realtà non ho mai potuto diventare cattivo. In ogni momento riconoscevo in me molti, moltissimi elementi quanto mai in contrasto con ciò. Sapevo che fermentavano in me, questi elementi contrastanti. Sapevo che per tutta la vita avevano fermentato in me e che cercavano di uscire all’esterno, ma io non lasciavo, non lasciavo, apposta non lasciavo che si sprigionassero. Mi torturavano fino a farmi vergognare; mi conducevano fino alle convulsioni e alla fine mi sono venuti in odio, come mi sono venuti in odio! Ora non vi sembra, signori, ch’io mi stia pentendo di qualcosa dinanzi a voi, che vi chieda perdono di qualcosa?… Sono certo che ne avete l’impressione… Ma, del resto, vi assicuro che per me fa lo stesso, se anche ne avete l’impressione… Non solo cattivo, ma proprio nulla sono riuscito a diventare: né cattivo, né buono, né furfante, né onesto, né eroe, né insetto. E ora vegeto nel mio cantuccio, punzecchiandomi con la maligna e perfettamente vana consolazione che l’uomo intelligente non può diventare seriamente qualcosa, ma diventa qualcosa soltanto lo sciocco. Sissignori, l’uomo intelligente del diciannovesimo secolo deve ed è moralmente obbligato a essere una creatura essenzialmente priva di carattere; mentre l’uomo di carattere, l’uomo d’azione, dev’essere una creatura essenzialmente limitata. Questa è la mia quarantennale convinzione. Ora ho quarant’anni, e quarant’anni sono tutta una vita; sono la più decrepita vecchiezza. Vivere più di quarant’anni è indecente, volgare, immorale! Chi vive oltre i quarant’anni? Rispondete sinceramente, onestamente. Ve lo dirò io chi: gli sciocchi e i mascalzoni. Lo dirò in faccia a tutti i vecchi, a tutti quei vecchi venerandi, a tutti quei vegliardi profumati e dalle chiome d’argento! Lo dirò in faccia a tutto il mondo! Ho il diritto di dirlo, perché io stesso camperò fino a sessant’anni. Fino a settant’anni, vivrò! Fino a ottant’anni, vivrò!.. Aspettate! Lasciatemi riprender fiato… Probabilmente pensate, signori, che voglia farvi ridere? Vi siete sbagliati anche in questo. Non sono affatto l’uomo allegro che credete o che forse credete; del resto, se voi, irritati da tutte queste chiacchiere (io già lo sento, che siete irritati), avrete l’idea di domandarmi chi sono, in fin dei conti, allora vi risponderò: sono un assessore di collegio. Lavoravo per avere qualcosa da mangiare (ma unicamente per questo), e quando l’anno scorso un mio lontano parente mi lasciò seimila rubli per testamento, diedi subito le dimissioni e mi sistemai nel mio angolo. Anche prima vivevo in quest’angolo, ma adesso mi ci sono sistemato. La mia stanza è squallida, brutta, ai confini della città. La mia serva è una donna di campagna, vecchia, cattiva per stupidità, e per giunta sempre puzzolente. Mi dicono che il clima pietroburghese mi diventa nocivo e che con i miei scarsi mezzi è troppo costoso vivere a Pietroburgo. Tutto questo lo so, lo so meglio di tutti questi esperti e savissimi consiglieri dall’aria saccente. Ma resterò a Pietroburgo; non me ne andrò da Pietroburgo! Non me ne andrò perché… Uff! Ma è assolutamente indifferente che me ne vada oppure no. E del resto: di che può parlare un uomo perbene con il maggior piacere? Risposta: di sé. E dunque anch’io parlerò di me.
E’ evidente che tale passo è difficilmente inquadrabile nello sviluppo narrativo di un “realismo”: l’uso dell’io narrante, lo sguardo sulla psiche, sulla definizione e sulla negazione della cattiveria, lo scontrarsi con la malattia deformante, non un fisico (Fosca di Tarchetti) ma una mente, sembrano allontanare Dostoevskij dai canoni dell’oggettività: già la scelta del monologo, di per sé estremamente soggettivo, la nega. Ma a mutare radicalmente è l’oggetto della narrazione, non più una realtà esterna, ma l’animo umano, i cui meccanismi non sono, “scientificamente” determinabili. Eppure al di là della pagina la strutturazione può essere ancora inserita in un al di qua della scoperta freudiana dell’inconscio: si è che il comportamento è sempre causato da un qualcosa avvenuta nella sua giovinezza, riconfermando, forse anche in modo problematico, quel milieu che determina il personaggio. Ciò non toglie nulla alla sua grandissima capacità innovativa.
Passa un anno e Dostoevskij dà alle stampe Delitto e castigo (1866):
A Pietroburgo lo studente Raskolnikov cerca una via d’uscita dalla miseria, anche per aiutare la madre e la sorella Dunja che vivono poveramente in provincia e lo mantengono mandandogli quel che Dunja guadagna come istitutrice presso la famiglia Svidrigajlov. Egli è dominato dall’idea di libertà cui ha diritto l’uomo superiore: non esita quindi a uccidere, dopo aver progettato minuziosamente il delitto, una vecchia usuraia e la sua mite sorella Elisavjeta per derubarle. Ma benché un concorso di circostanze favorevoli svii le indagini, dal giorno del delitto Raskolnikov diventa l’implacabile giudice di se stesso. Combattuto tra il ricordo dell’uccisione e il timore ossessivo di venire scoperto, è assalito da eccessi di delirio: il suo ignaro amico Razumichin, onesto e ottimista, cerca invano di dargli sollievo. Nell’ansia di avere notizia sulle indagini, ma anche per provare la sua superiorità, gioca d’astuzia con la polizia, sfidandola: e il giudice Porfirij finisce per sospettare la sua colpevolezza, ma lo lascerà andare libero, ben calcolando che finirà lui stesso per consegnarsi alle sue mani. Nei suoi vagabondaggi Raskolnikov incontra molti relitti umani, come lui tesi a uscire dalla loro degradazione: l’impiegato ubriacone Marmeladov, la tisica Katerina Ivanovna, sua moglie, che per fame ha spinto la figliastra Sonja alla prostituzione, Sonja stessa, la cui dolcezza di vittima finirà per dominare Raskolnikov. Ma da loro, per cui prova amore e pietà, lo separa l’atto commesso. Sarà Sonja che riceverà la confessione di Raskolnikov, che gli indicherà il valore della vita umana secondo il Cristo, e che lo spingerà, anche se ancora ribelle in cuor suo, a costituirsi. Solo in Siberia, accanto a Sonja che lo ha seguito, Raskolnikov si libererà dal senso di sconfitta che gli grava addosso.
SEI TU L’ASSASSINO
Se ne stava lì soprappensiero, e un sorriso strano, contrito, quasi insensato, gli errava sulle labbra. Alla fine prese il berretto e uscì piano dalla stanza. Aveva le idee confuse. Tutto assorto, scese fino al portone.
«Eccolo, in persona!» esclamò una voce forte; egli sollevò il capo.
Il portinaio stava accanto alla porta del suo stambugio e lo indicava a un uomo piuttosto basso, simile nell’aspetto a un artigiano, che indossava una specie di camice e un panciotto e somigliava moltissimo, da lontano, a una donna. La sua testa, sotto il berretto unto e bisunto, pendeva in avanti, e tutta la sua figura appariva curva. Il volto floscio e rugoso faceva supporre che avesse passato la cinquantina; gli occhietti minuscoli, affondati nel grasso, avevano uno sguardo arcigno, scontento e severo.
«Che c’è?» domandò Raskòlnikov, avvicinandosi al portinaio.
L’artigiano lo guardò di sottecchi esaminandolo con insistente attenzione, senza fretta; poi si volse adagio e, senza dire una sola parola, uscì nella strada.
«Ma che significa tutto ciò?» esclamò Raskòlnikov.
«È venuto un tizio a chiedere se abita qui un certo studente, cioè voi; ha chiesto da chi abitate. Intanto siete sceso, io vi ho indicato, e lui se n’è andato via. Che roba, però…»
Anche il portinaio era un po’ perplesso; non troppo, però: e dopo averci pensato su ancora qualche istante, si voltò e si infilò di nuovo nel suo bugigattolo.
Raskòlnikov corse dietro all’artigiano e subito lo vide che camminava dal lato opposto della via, col passo regolare e lento di prima, lo sguardo fisso a terra come se stesse meditando qualcosa. Ben presto lo raggiunse, ma per un po’ gli rimase alle calcagna; infine, giunto alla sua altezza, gli gettò uno sguardo di fianco, proprio in viso. L’altro si accorse subito di lui, lo squadrò rapidamente, ma tornò ad abbassare gli occhi, e così procedettero per circa un minuto, l’uno accanto all’altro, senza spiccicar parola.
«Avete chiesto di me… al portinaio?» riuscì finalmente a dire Raskòlnikov, ma, chissà perché, a voce molto bassa.
L’artigiano non gli diede risposta, e nemmeno lo guardò. Seguì un altro silenzio.
«Ma perché… venite a chiedere… e poi non parlate? Che state cercando, insomma?» La voce di Raskòlnikov continuava a spezzarsi, sembrava che le parole non volessero uscirgli chiare di bocca.
Questa volta l’artigiano alzò gli occhi, e fissò Raskòlnikov con uno sguardo sinistro e cupo.
«Assassino!» disse a un tratto con voce sommessa, ma ben distinta…
Raskòlnikov stava camminando al suo fianco. Di colpo sentì che gli si piegavano le gambe, mentre un brivido freddo gli correva giù per la schiena. Per un istante, fu come se il suo cuore cessasse di pulsare; ma poi prese a battere come impazzito. Fecero così un centinaio di passi, l’uno accanto all’altro, di nuovo in perfetto silenzio. L’artigiano non lo guardava.
«Ma che dite?… Che cosa…? Chi è un assassino?» mormorò Raskòlnikov con voce appena percettibile.
«Tu sei l’assassino,» fece l’altro, pronunciando le parole ancor più distintamente e in tono più grave; e con un sorriso come di odio e di trionfo tornò a guardar dritto Raskòlnikov nel volto esangue e negli occhi vitrei. Insieme, nel frattempo, erano giunti a un crocicchio. L’artigiano scantonò in una strada a sinistra e proseguì senza più voltarsi.
Raskòlnikov, rimasto immobile, lo seguì a lungo con lo sguardo. Vide che l’altro, dopo aver fatto una cinquantina di passi, si voltava a guardare verso di lui, sempre inchiodato allo stesso posto. Non era possibile vederlo bene in viso, ma Raskòlnikov ebbe l’impressione di scorgervi ancora quel sorrisetto freddo, spirante odio e trionfo.
A passo lento e fiacco, con le ginocchia tremanti, e sentendosi come intorpidito, Raskòlnikov tornò indietro e salì nella sua topaia. Si tolse il berretto e lo depose sul tavolino; poi rimase una decina di minuti senza fare un gesto, immobile. Alla fine, sfinito e indolenzito si coricò sul divano, stendendosi con un gemito fioco. Aveva gli occhi chiusi; e così rimase per circa mezz’ora.
Non pensava a niente. Gli passavano per il capo certi pensieri, o meglio brandelli di pensieri, certe immagini disordinate e sconnesse: volti di persone viste nell’infanzia, o incontrate chissà dove una sola volta e delle quali non si era mai ricordato prima; il campanile della chiesa di V.; il biliardo di una taverna e, accanto ad esso, un ufficiale sconosciuto; l’odore di sigari in una tabaccheria situata in un sotterraneo, una bettola, una scala di servizio completamente buia, tutta cosparsa di rifiuti e gusci d’uovo, mentre chissà da dove giungeva un suono di campane a festa… queste visioni si alternavano vorticando come un turbine. Certe gli piacevano perfino, ed egli vi si aggrappava, ma ben presto svanivano; in generale c’era qualcosa che l’opprimeva da dentro, ma neanche tanto, e a momenti si sentiva addirittura bene. Un lieve brivido di febbre lo scuoteva di continuo, e anche questo gli dava una sensazione quasi piacevole.
A un tratto udì i passi precipitosi di Razumìchin e la sua voce; chiuse gli occhi e finse di dormire. Razumìchin aprì la porta e rimase per qualche tempo sulla soglia come meditando sul da farsi. Poi entrò pian piano, avvicinandosi a passi felpati al divano. Sentì Nastàsja bisbigliare:
«Non disturbarlo; lascialo dormire finché vuole; mangerà dopo.»
«Hai ragione,» rispose Razumìchin.
Entrambi uscirono senza far rumore e si richiusero la porta alle spalle. Trascorse un’altra mezz’ora. Aperti gli occhi, Raskòlnikov si mise di nuovo supino, con le mani incrociate dietro la testa…
«Chi è quello? Chi è quel tipo sbucato di sottoterra? Dove si trovava, e che cosa ha visto? Ha visto tutto, questo è fuori discussione. Ma dove sarà stato in quel momento, da dove guardava? Perché salta fuori soltanto adesso? E come ha fatto a vedere? Com’è possibile? Mmh…» seguitò Raskòlnikov rabbrividendo. «E l’astuccio che Nikolàj ha trovato dietro la porta, allora? Anche questo, com’era possibile?… Indizi?… Ma basta trascurare un particolare insignificante, ed eccoti un indizio grande come una piramide d’Egitto! C’era una mosca che volava, e ha veduto. Ma com’è possibile?»
A un tratto, sentì con ribrezzo fino a qual punto fosse indebolito, fisicamente indebolito.
«Dovevo saperlo,» pensava con un sorriso amaro. «Come ho osato, conoscendomi, presentendo me stesso, brandire la scure e sporcarmi di sangue? Dovevo saperlo in anticipo…! E, del resto, lo sapevo in anticipo!…» mormorò disperato.
A tratti un pensiero lo colpiva, tratteneva per qualche istante la sua attenzione.
«No, quegli uomini sono d’un’altra pasta; quegli uomini non sono fatti così. Un vero distruttore, al quale tutto è lecito, mette a sacco Tolone, compie una strage a Parigi, dimentica l’esercito in Egitto, spreca mezzo milione di uomini nella spedizione di Mosca, se la cava con un gioco di parole a Vilna; e dopo che è morto gli innalzano statue; tutto gli è lecito, dunque. Si vede proprio che uomini così non sono fatti di carne, ma di bronzo!»
Un pensiero improvviso, diverso, lo fece quasi ridere:
«Napoleone, le piramidi, Waterloo… e la grama, sordida vedova di un impiegato del registro, una vecchietta, un’usuraia, con un forziere rosso sotto il letto… Come potrebbe, anche un Porfìrij Petròvič, ingoiare un rospo del genere?… Come potrebbero?… L’estetica non lo consente, Napoleone, andarsi a ficcare sotto il letto di quella vecchietta! Eh, che schifo!…»
A momenti gli sembrava quasi di delirare; era in uno stato di esaltazione febbrile.
«Ma la vecchietta è ancora niente!» pensava in modo eccitato, frammentario. «La vecchia, magari, è stata uno sbaglio, ma non è lei che conta! La vecchia è stata solo una malattia… Io volevo superare al più presto l’ostacolo… non è una persona, quella che ho ucciso, ma un principio! Già: il principio l’ho ucciso però l’ostacolo non l’ho superato, sono rimasto al di qua… Soltanto di uccidere sono stato capace, e, a quanto pare, nemmeno questo mi è riuscito molto bene… Un principio? Perché mai, poco fa, quel balordo di Razumìchin se la prendeva con i socialisti? Gente laboriosa, industriosa; si interessano della felicità generale… No, la vita mi vien data una volta sola, e non me la restituiranno mai più: non voglio aspettare la felicità universale, io… Voglio vivere davvero se no è meglio non vivere affatto. E allora? Semplicemente, non ho voluto più passare davanti a mia madre affamata stringendo in tasca il mio rublo, in attesa della felicità universale. Porto, dicono quelli, il mio granello di sabbia alla costruzione della felicità universale, e perciò mi sento la coscienza a posto. Ah, ah! Ma perché mi lasciate da parte? Ho una vita sola da vivere, e anch’io vorrei… Ba’! sono un pidocchio estetizzante, e basta,» aggiunse, scoppiando a ridere di colpo, come un matto. «Sì, sono davvero un pidocchio,» ripeté, aggrappandosi con acre gioia a quell’idea, frugandovi dentro e compiacendosene, «e questo, in primo luogo, già per il semplice fatto che sto dicendomi che sono un pidocchio; in secondo luogo, perché ho stancato la divina Provvidenza per un mese intero, chiamandola a testimonio che non per la mia carne o per la mia lussuria mi cacciavo in questa faccenda, ma in vista di uno scopo grandioso e piacevole, ah, ah!; in terzo luogo, perché mi ero prefisso di procedere, nell’esecuzione, con la maggiore giustizia possibile, un solo peso e una sola misura, una questione matematica: fra tutti i pidocchi avevo scelto il più inutile; e, dopo averlo ucciso, volevo portargli via giusto quel che mi serviva per il primo passo, ne più né meno, e il resto, quindi, sarebbe andato a un monastero, per testamento, ah ah!… Per questo, per questo sono irrimediabilmente un pidocchio!» aggiunse digrignando i denti. «Io stesso, forse, sono peggiore e più sordido del pidocchio che ho ucciso, e presentivo perfino che mi sarei dette queste cose dopo aver ucciso! C’è forse qualcosa di paragonabile a questo orrore? Che volgarità, che cosa ignobile!… Oh, come capisco il profeta a cavallo, con la scimitarra in pugno: è Allah che lo vuole, e a te, tremante creatura, non resta che obbedire! Ha ragione, ha ragione il profeta, quando piazza in mezzo alla strada una buo-o-ona batteria di cannoni e ci dà dentro su innocenti e su colpevoli, senza degnarsi nemmeno di dare una spiegazione! Obbedisci, tremante creatura, e non aver desideri, perché queste non sono cose per te!… Oh, per niente al mondo perdonerò a quella vecchia…»
Aveva i capelli zuppi di sudore, le labbra tremanti e riarse, lo sguardo inchiodato al soffitto.
«Mia madre, mia sorella, quanto le amavo! Perché adesso le odio? Sì, le odio, le odio fisicamente, non me le posso sentire vicino… Poco fa mi sono avvicinato a mia madre e l’ho baciata, e ricordo… Abbracciarla e, intanto, pensare che se sapesse… Ma allora… non sarà meglio che glielo dica? Uno come me ne sarebbe capace… Mmh… Lei dev’essere fatta come me,» aggiunse pensando a fatica, quasi lottando col delirio che a poco a poco si impadroniva di lui. «Oh, come odio, adesso, quella vecchietta! Non ci penserei due volte a ucciderla di nuovo, se tornasse in vita! Povera Lizavèta! Perché me la sono trovata fra i piedi?… Strano, però, che il pensiero di lei mi sfiori appena, come se neanche l’avessi uccisa! … Lizavèta! Sònja! Povere, dolci creature dagli occhi mansueti… Care! Perché non piangono? Perché non gemono ? … Danno via tutto ciò che possiedono… Hanno lo sguardo mite e placido… Sònja, Sònja! Dolce Sònja!…»
La pagina ci offre la straordinaria possibilità di analizzare come Dostoevskij riesca con mirabile capacità ad anticipare il monologo interiore. In questo caso, modernamente, lo spazio viene dilatato e all’interno di esso si confrontino una pluralità di voci che a volte sembrano contraddirsi. E’ il concetto che il critico russo Bachtin chiama “polifonia” che egli stesso individua nella struttura romanzesca di Dostoevskij.
Raskolnikov (come se volesse riprendere il concetto di “nichilismo” di Bazànov in Padri e figli di Turgenev) parte dal concetto d’impunità per l’uomo superiore, e per questo uccide. Ma matura un incredibile senso di colpa, che è frutto di una scissione dell’animo: lui “innocente”, in quanto superiore; lui “colpevole” in quanto essere reietto: questa duplice natura lo porterà alla sfida con la polizia, modo direi quasi “psicoanalitico” di consegnarsi ad essa, per espiare il peccato.
Non possiamo tacere l’ultimo, e forse più importante, romanzo di Dostoevskij, I fratelli Karamazov (1880):
Fedor Karamazov ha tre figli: Dmitrj, Ivan e Aleša. Ha anche un figlio illegittimo, l’epilettico Smerdiakov, che tiene in casa come servo. Fedor è un vecchio libertino, cinico e dissoluto, poco amato dai figli: in particolare Dmitrj, detto Mitja, lo odia perché è innamorato di Grušenka, una bella mantenuta che il vecchio, forte del suo denaro, vuole fare sua. L’altro fratello Ivan è un raffinato intellettuale e filosofo dell’ateismo; il più giovane, Aleša, è novizio nel convento di padre Zosima, che lo guida sulla via del perfezionamento spirituale ma lo obbliga a ritornare nel mondo, che ha bisogno della sua carità cristiana. Infatti, poco dopo, il vecchio Karamazov viene trovato ucciso. Tutti i sospetti cadono su Mitja, difeso solo dalla generosa Grušenka. Anche Ivan crede nella colpevolezza del fratello, fino al giorno in cui Smerdiakov gli confessa di essere lui l’assassino, plagiato dalle teorie atee di Ivan. Subito dopo la confessione Smerdiakov si impicca e Ivan non può provare al processo la verità delle sue rivelazioni. Così Mitja viene condannato ai lavori forzati, Ivan cade in preda ad una febbre cerebrale, mentre Aleša con la sua purezza, purtroppo impotente, guida un gruppo di ragazzi, raccolti in fraterna solidarietà, verso una vita migliore.
LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE
La mia azione si svolge in Spagna, a Siviglia, al tempo più pauroso dell’inquisizione quando ogni giorno nel paese ardevano i roghi per la gloria di Dio e con grandiosi autodafè si bruciavano gli eretici.
Oh, certo, non è cosi che Egli scenderà, secondo la Sua promessa, alla fine dei tempi, in tutta la gloria celeste, improvviso “come folgore che splende dall’Oriente all’Occidente”. No, Egli volle almeno per un istante visitare i Suoi figli proprio là dove avevano cominciato a crepitar i roghi degli eretici. Nell’immensa Sua misericordia, Egli passa ancora una volta fra gli uomini in quel medesimo aspetto umano col quale era passato per tre anni in mezzo agli uomini quindici secoli addietro.
Egli scende verso le “vie roventi” della città meridionale, in cui appunto la vigilia soltanto, in un “grandioso autodafé”, alla presenza del re, della corte, dei cavalieri, dei cardinali e delle più leggiadre dame di corte, davanti a tutto il popolo di Siviglia, il cardinale grande inquisitore aveva fatto bruciare in una volta, ad majorem Dei gloriam, quasi un centinaio di eretici. Egli è comparso in silenzio, inavvertitamente, ma ecco – cosa strana – tutti Lo riconoscono. Spiegare perché Lo riconoscano, potrebbe esser questo uno dei più bei passi del poema. Il popolo è attratto verso di Lui da una forza irresistibile, Lo circonda, Gli cresce intorno, Lo segue. Egli passa in mezzo a loro silenzioso, con un dolce sorriso d’infinita compassione. Il sole dell’amore arde nel Suo cuore, i raggi della Luce, del Sapere e della Forza si sprigionano dai Suoi occhi e, inondando gli uomini, ne fanno tremare i cuori in una rispondenza d’amore. Egli tende loro le braccia, li benedice e dal contatto di Lui, e perfino dalle Sue vesti, emana una forza salutare.
Ecco che un vecchio, cieco dall’infanzia, grida dalla folla: «Signore, risanami, e io Ti vedrò», ed ecco che cade dai suoi occhi come una scaglia, e il cieco Lo vede.
Il popolo piange e bacia la terra dove Egli passa..
Il popolo si agita, grida, singhiozza; ed ecco in questo stesso momento passare accanto alla cattedrale, sulla piazza, il cardinale grande inquisitore in persona. E’ un vecchio quasi novantenne, alto e diritto, dal viso scarno, dagli occhi infossati, ma nei quali, come una scintilla di fuoco, splende ancora una luce… Ha visto tutto… Aggrotta le sue folte sopracciglia bianche e il suo sguardo brilla di una luce sinistra. Egli allunga un dito e ordina alle sue guardie di afferrarlo.
Le guardie conducono il Prigioniero sotto le volte di un angusto e cupo carcere nel vecchio edificio del Santo Uffizio e ve Lo rinchiudono. Passa il giorno, sopravviene la scura, calda, “afosa” notte di Siviglia. L’aria “odora di lauri e di limoni”. In mezzo alla tenebra profonda si apre a un tratto la ferrea porta del carcere, e il grande inquisitore in persona con una fiaccola in mano lentamente si avvicina alla prigione. E’ solo, la porta si richiude subito alle sue spalle. Egli si ferma sulla soglia e considera a lungo, per uno o due minuti, il volto di Lui. Infine si accosta in silenzio, posa la fiaccola sulla tavola e Gli dice:
«Sei Tu, sei Tu?» Ma, non ricevendo risposta, aggiunge rapidamente: «Non rispondere, taci. E che potresti dire? So troppo bene quel che puoi dire. Del resto, non hai il diritto di aggiunger nulla a quello che Tu già dicesti una volta. Perché sei venuto a disturbarci? Sei infatti venuto a disturbarci, lo sai anche Tu. Ma sai che cosa succederà domani? lo non so chi Tu sia, e non voglio sapere se Tu sia Lui o soltanto una Sua apparenza, ma domani stesso io Ti condannerò e Ti farò ardere sul rogo, come il peggiore degli eretici, e quello stesso popolo che oggi baciava i Tuoi piedi si slancerà domani, a un mio cenno, ad attizzare il Tuo rogo, lo sai? Si, forse Tu lo sai», aggiunse, profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo Prigioniero.
Non dicevi Tu allora spesso: «Voglio rendervi liberi?». Ebbene, adesso Tu li ha veduti, questi uomini “liberi”, – aggiunge il vecchio con un pensoso sorriso. «Sì, questa faccenda ci è costata cara», continua, guardandolo severo, «ma noi l’abbiamo finalmente condotta a termine, in nome Tuo. Per quindici secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l’opera è compiuta e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della Tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi, e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà, e l’hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo, ma è questo che Tu desideravi, è una simile libertà?».
«lo torno a non comprendere», interruppe Aljòsa, egli fa dell’ironia, scherza?»
«Niente affatto. Egli fa un merito a sé ed ai suoi precisamente di avere infine soppresso la libertà e di averlo fatto per rendere felici gli uomini. “Ora infatti per la prima volta (egli parla, naturalmente, dell’inquisizione) è diventato possibile pensare alla felicità umana. L’uomo fu creato ribelle; possono forse dei ribelli essere felici? Tu eri stato avvertito, – Gli dice, – avvertimenti e consigli non Ti erano mancati, ma Tu non ascoltasti gli avvertimenti. Tu ricusasti l’unica via per la quale si potevano render felici gli uomini, ma per fortuna, andandotene, rimettesti la cosa nelle nostre mani. Tu ci hai promesso, Tu ci hai con la Tua parola confermato, Tu ci hai dato il diritto di legare e di slegare, e certo non puoi ora nemmeno pensare a ritoglierci questo diritto. Perché dunque sei venuto? Sai Tu che passeranno i secoli e l’umanità proclamerà per bocca della sua sapienza e della sua scienza che non esiste il delitto, e quindi nemmeno il peccato, ma che ci sono soltanto degli affamati? “Nutrili e poi chiedi loro la virtù!”. Oh, mai, mai essi potrebbero sfamarsi senza di noi! Nessuna scienza darà loro il pane, finché rimarranno liberi, ma essi finiranno per deporre la loro libertà ai nostri piedi e per dirci: «Riduceteci piuttosto in schiavitù ma sfamateci». Comprenderanno infine essi stessi che libertà e pane terreno a discrezione per tutti sono fra loro inconciliabili, giacché mai, mai essi sapranno ripartirlo fra loro! Si convinceranno pure che non potranno mai nemmeno esser liberi, perché sono deboli, viziosi, inetti e ribelli.
Essi sono viziosi e ribelli, ma finiranno per diventar docili. Essi ci ammireranno e ci terranno in conto di dèi per avere acconsentito, mettendoci alla loro testa, ad assumerci il carico di quella libertà che li aveva sbigottiti e a dominare su loro, tanta paura avranno infine di esser liberi! Ma noi diremo che obbediamo a Te e che dominiamo in nome Tuo. Li inganneremo di nuovo, perché allora non Ti lasceremo più avvicinare a noi. E in quest’inganno starà la nostra sofferenza, poiché saremo costretti a mentire. Ecco ciò che significa quella domanda che Ti fu fatta nel deserto, ed ecco ciò che Tu ricusasti in nome della libertà, da Te collocata più in alto di tutto. In quella domanda tuttavia si racchiudeva un grande segreto di questo mondo. Acconsentendo al miracolo dei pani, Tu avresti dato una risposta all’universale ed eterna ansia umana, dell’uomo singolo come dell’intera umanità: “Davanti a chi inchinarsi?”. Non c’è per l’uomo rimasto libero più assidua e più tormentosa cura di quella di cercare un essere dinanzi a cui inchinarsi. Ma l’uomo cerca di inchinarsi a ciò che già è incontestabile, tanto incontestabile, che tutti gli uomini ad un tempo siano disposti a venerarlo universalmente. Perché la preoccupazione di queste misere creature non è soltanto di trovare un essere a cui questo o quell’uomo si inchini, ma di trovarne uno tale che tutti credano in lui e lo adorino, e precisamente tutti insieme. E questo bisogno di comunione nell’adorazione è anche il più grande tormento di ogni singolo, come dell’intera umanità, fin dal principio dei secoli. E’ per ottenere questa adorazione universale che si sono con la spada sterminati a vicenda. Essi hanno creato degli dèi e si sono sfidati l’un l’altro: «Abbandonate i vostri dèi e venite ad adorare i nostri, se no guai a voi e ai vostri dèi!». E cosi sarà fino alla fine del mondo, anche quando gli dèi saranno scomparsi dalla terra: non importa, cadranno allora in ginocchio davanti agli idoli. Tu conoscevi, Tu non potevi non conoscere questo fondamentale segreto della natura umana, ma Tu rifiutasti l’unica irrefragabile bandiera che Ti si offrisse per indurre tutti a inchinarsi senza discussione dinanzi a Te;…
Tu volesti il libero amore dell’uomo, perché Ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da Te. In luogo di seguire la salda legge antica, l’uomo doveva per l’avvenire decidere da sé liberamente, che cosa fosse bene che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola Tua immagine; ma non avevi Tu pensato che, se lo si fosse oppresso con un cosi terribile fardello come la libertà di scelta, egli avrebbe finito per respingere e contestare perfino la Tua immagine e la Tua verità?…
Sappi che io non Ti temo. Sappi che anch’io fui nel deserto, che anch’io mi nutrivo di cavallette e di radici, che anch’io benedicevo la libertà di cui Tu letificasti gli uomini, che anch’io mi ero preparato ad entrare nel numero dei Tuoi eletti, nel numero dei potenti e dei forti, con la brama di “completare il numero”. Ma mi ricredetti e non volli servire la causa della follia. Tornai indietro e mi unii alla schiera di quelli che hanno corretto l’opera Tua. Lasciai gli orgogliosi e tornai agli umili per la felicità di questi umili. Ciò che Ti dico si compirà e sorgerà il regno nostro. Ti ripeto che domani stesso Tu vedrai questo docile gregge gettarsi al primo mio cenno ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale Ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei Tu. Domani Ti arderò. Dixi».
Ivàn, si fermò. Egli si era accalorato e aveva parlato con fervore; quando poi ebbe finito, fece improvvisamente un sorriso.
Aljòsa, che l’aveva sempre ascoltato in silenzio e verso la fine, in preda a straordinaria agitazione, molte volte aveva voluto interrompere il discorso del fratello, ma si era visibilmente trattenuto, si mise d’un tratto a parlare, come scattando: «Ma… è un assurdo!» esclamò, arrossendo. «Il tuo poema è l’elogio di Gesù e non la condanna… come tu volevi. E come termina il tuo poema?…»
«lo volevo finirlo cosi: l’inquisitore, dopo aver taciuto, aspetta per qualche tempo che il suo Prigioniero gli risponda. Il Suo silenzio gli pesa. Ha visto che il Prigioniero l’ha sempre ascoltato, fissandolo negli occhi col suo sguardo calmo e penetrante e non volendo evidentemente obiettar nulla. Il vecchio vorrebbe che dicesse qualcosa, sia pure di amaro, di terribile. Ma Egli tutt’a un tratto si avvicina al vecchio in silenzio e lo bacia piano sulle esangui labbra novantenni. Ed ecco tutta la Sua risposta. Il vecchio sussulta. Gli angoli delle labbra hanno avuto un fremito; egli va verso la porta, la spalanca e Gli dice: «Vattene e non venir più… non venire mai più… mai più!». E Lo lascia andare per “le vie oscure della città”. Il Prigioniero si allontana.
«E il vecchio?»
«Il bacio gli arde nel cuore, ma il vecchio persiste nella sua idea.»
Ivan Karamazov, seduto al tavolo di una locanda, di fronte al fratello Alëša, decide di narrargli l’unica opera da lui concepita (e mai messa per iscritto) che ha intitolato La Leggenda del Grande Inquisitore. E’ una storia ambientata nel XVI secolo in Spagna, a Siviglia, nel periodo più terribile dell’Inquisizione. In quell’epoca e in quel luogo, Gesù ritorna ancora una volta tra gli uomini. Tutti lo riconoscono, tutti sono attratti da Lui. Anche il cardinale Grande Inquisitore, un vecchio novantenne dagli occhi infossati, lo riconosce e subito lo fa arrestare per mandarlo al rogo il giorno dopo, come il peggiore degli eretici. Il suo peccato, il più grave che si potesse compiere, è quello di essersene andato senza fare in modo che gli uomini avessero delle regole sicure e fossero obbligati a seguirle. L’umanità sarebbe stata ben felice d’essere schiava e servire un Dio. Il grave peccato di questo Dio è di averla lasciata libera, trattandola alla pari, con la dignità di un figlio. Per questo, loro, i custodi di quel lascito, hanno dovuto provvedere a fare ciò che Lui non aveva fatto. Il finale di questa storia, con il confronto nella cella tra Il Grande Inquisitore e Cristo, è ancora più sorprendente; così come la replica di Alëša a fine racconto.
Ma quello che a noi interessa di più è l’argomento religioso-filosofico di Dostoevskij, l’“insopportabile libertà” dell’uomo, accordatagli da Colui che l’uomo stesso voleva suo padrone, da servire alla maniera degli schiavi. Nei Karamazov Dostoevskij studia il destino dell’uomo lasciato in libertà. Lo interessa solo l’uomo che incede sulla via della libertà, il destino dell’uomo sulla libertà e della libertà sull’uomo.

Anton Pavlovič Čechov
Non possiamo concludere il nostro discorso se non con un grande novellista, un letterato russo che, insieme al francese Guy De Maupassant e al nostro Giovanni Verga, portano l’arte del racconto breve ad altissimi livelli. Anton Pavlovič Čechov, (1960 – 1904) d’origine umile, medico non assiduo, passerà gran parte della sua breve vita a scrivere racconti. Grande è anche la sua straordinaria arte che riuscirà ad esprimere nelle opere teatrali. Riportiamo qui un breve racconto:
UNO SCHERZETTO
E’ un sereno meriggio d’inverno… Il gelo è rigido, la neve scricchiola e a Nàden’ka, che mi ha preso per il braccio, si coprono di una brina argentea i riccioli sulle tempie e la lanugine sul labbro superiore. Siamo sulla cima di una montagnola. Dai nostri piedi fino al piano si stende una superficie levigata, in cui il sole si mira come in uno specchio. Accanto a noi è una piccola slitta foderata di panno vermiglio.
«Andiamo giù, Nadeˇzda Petrovna!» imploro io. «Una sola volta! Vi assicuro, arriveremo sani e salvi». Ma Nàden’ka ha paura. Lo spazio che corre dalle sue piccole calosce fino ai piedi della montagnola di ghiaccio le sembra spaventoso, un abisso d’insondabile profondità. Quando guarda in giù, si sente morire e le si mozza il respiro, non appena le propongo di sedersi nella slitta: e che cosa accadrà quando si arrischierà di volare in quell’abisso! Morirà, impazzirà. «Vi supplico!» dico io. «Non dovete aver paura! Non capite che è debolezza, viltà?» Finalmente Nàden’ka cede, e dal suo volto vedo che cede con la paura di rischiare la vita. L’aiuto, pallida, tremante a sedersi nella slitta; le cingo con il braccio la vita, e con lei mi precipito nell’abisso. La slitta vola come un proiettile. L’aria tagliata frusta i nostri visi, ulula, fischia nelle orecchie, tira, punge dolorosamente di rabbia, sembra voglia strappare la testa dalle spalle. La violenza del vento non dà forza di respirare. Pare che il diavolo stesso ci abbia afferrati con le sue zampe e urlando ci trascini all’inferno. Gli oggetti intorno si confondono in una unica striscia lunga che corre vertiginosamente… Ecco, ecco, ancora un istante, e sarà, sembra, la nostra rovina! «Vi amo, Nadja!» dico sottovoce.
La slitta comincia a scivolare sempre più lentamente, e l’urlo del vento e il ronzio dei pattini non sono più così spaventosi, il respiro non è più mozzato, e finalmente, siamo arrivati in basso. Nàden’ka non è né viva né morta. E’ pallida, respira appena… L’aiuto ad alzarsi. «Per nulla al mondo ci tornerei un’altra volta» dice guardandomi con occhi sbarrati, pieni di terrore. «Per nulla al mondo! Per poco non morivo». Poco tempo dopo si è rimessa e già comincia a guardarmi negli occhi con una espressione interrogativa, come volesse accertarsi, se ho detto quelle tre parole veramente, o se le è sembrato soltanto di udirle nel frastuono del turbine. Ed io me ne sto accanto a lei, fumo e osservo attentamente il mio guanto. Mi prende sottobraccio, e a lungo passeggiamo accanto alla montagnola. L’enigma, evidentemente, non le dà requie. Sono state pronunciate quelle parole, oppure no? Sì o no? Sì o no? E’ una questione d’amor proprio, d’onore, di vita, di felicità, una questione molto importante, la più importante del mondo. Nàden’ka mi guarda in viso impaziente, triste, con uno sguardo scrutatore, non risponde a tono, aspetta che io mi metta a parlare. O come variano le espressioni su quel volto caro, come variano! Vedo che essa lotta con se stessa, che ha bisogno di dirmi qualcosa, di chiedermi qualcosa, ma non trova le parole, si sente impacciata, atterrita, la gioia la turba… «Sapete che cosa?» dice senza guardarmi in viso. «Che cosa?» domando io. «Facciamolo ancora una volta… scendiamo in slitta». Ci arrampichiamo per la scala sulla vetta del pendio. Di nuovo aiuto Nàden’ka pallida, tremante ad accomodarsi nella slitta, di nuovo voliamo nel terribile abisso, di nuovo urla il vento e ronzano i pattini, e di nuovo quando la slitta ha raggiunto la sua massima velocità io dico sottovoce nel frastuono: «Vi amo, Nàden’ka!» Quando la slitta si ferma, Nàden’ka abbraccia con uno sguardo la montagnola sul dorso della quale siamo or ora discesi, poi scruta a lungo il mio viso, ascolta la mia voce indifferente e spassionata, e tutta, tutta, perfino il suo manicotto e il cappuccio, tutta la sua figurina esprime una estrema perplessità. Sul suo viso sta scritto: “Che succede? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui, oppure mi è parso soltanto sentirle?” Questa incertezza la rende inquieta, la impazientisce. La povera fanciulla non risponde alle domande, si fa scura in viso. E’ sul punto di scoppiare in lacrime. «Dobbiamo forse tornare a casa?» domando io. «Ma, a me… a me piace questo scendere in slitta» dice arrossendo. «Non potremmo forse scendere un’altra volta?» Le “piace” questo scendere, e tuttavia, mentre si siede nella slitta, è pallida come le prime volte, respira appena dal terrore, trema. Facciamo la discesa una terza volta, e mi accorgo, come mi guarda in viso, fissa le mie labbra. Ma io accosto alle labbra un fazzoletto, tossisco e, quando raggiungiamo la metà della discesa, faccio in tempo a sussurrare: «Vi amo, Nadja!» L’enigma rimane tale! Nàden’ka tace, pensa a qualcosa… La riaccompagno a casa, essa cerca di camminare più adagio, rallenta i passi e aspetta sempre che le dica di nuovo quelle parole. E vedo, quanto soffre la sua anima, come sta facendo uno sforzo su se stessa, per non dire: «Non può essere che le abbia dette il vento! E non voglio che le abbia dette il vento!» Il giorno dopo ricevo la mattina un biglietto: “Se oggi andate alla pista delle slitte, passate a prendermi. N.” E da quel giorno comincio ad andare quotidianamente con Nadja alla pista e, mentre voliamo giù sulla slitta, pronuncio ogni volta sottovoce quelle stesse parole: «Vi amo, Nadja!» Ben presto Nàden’ka s’avvezza a questa frase, come ci si avvezza al vino o alla morfina. Non può più vivere senza di essa. E’ vero che le fa sempre molta paura volar giù dalla cima della montagna, ma ormai il terrore e il pericolo conferiscono un fascino speciale alle parole d’amore, alle parole che come prima formano un enigma e fanno languire l’anima. Il sospetto cade sempre sugli stessi due: su me e sul vento… Chi dei due le faccia la dichiarazione d’amore, essa non sa, ma ormai evidentemente per lei è lo stesso; non importa da quale recipiente si beva, basta che ci si inebrii. Un pomeriggio mi recai da solo alla pista; mescolatomi con la folla, vedo che Nàden’ka si avvicina alla montagnola, che mi cerca con gli occhi… Poi timidamente si arrampica su per la scaletta… E’ terribile far la discesa da sola, oh com’è terribile. E’ pallida come la neve, trema, cammina come se andasse al patibolo, ma cammina, cammina senza guardare indietro, decisamente. Ha deciso, si vede, di provare finalmente se sarà possibile udire quelle parole dolci, stupefacenti, quando non ci sono io. Vedo come pallida, la bocca aperta per lo spavento, si siede nella slitta, chiude gli occhi e, detto per sempre addio alla terra, si mette in moto… “ssss”… ronzano i pattini. Ode Nàden’ka quelle parole? Non lo so… Vedo soltanto come si alza debole, sfinita, dalla slitta. E dal suo volto si capisce che essa stessa non sa se abbia o no udito qualcosa. Il terrore, mentre scivolava, le ha tolto la facoltà di udire, di distinguere i suoni, di capire… Ma ecco che viene il mese primaverile di marzo… il sole si fa più carezzevole. La nostra montagnola di ghiaccio diventa più scura, smette di luccicare e finalmente si scioglie. Smettiamo di andare in slitta. Per la povera Nàden’ka non c’è più possibilità di sentire quelle parole, eppoi chi le può ormai pronunciare? Il vento non si ode più e io mi accingo a partire per Pietroburgo, per lungo tempo, probabilmente per sempre. Una volta, due o tre giorni prima della partenza, me ne sto seduto, al crepuscolo, nel giardino, che uno steccato alto sormontato da chiodi separa dal cortile, dove vive Nàden’ka… Fa ancora piuttosto freddo, sotto il concime c’è ancora la neve, gli alberi sono morti, ma c’è già odor di primavera e, mentre si preparano a dormire, le cornacchie gracchiano rumorosamente. Mi avvicino allo steccato e guardo a lungo attraverso una fessura. Vedo Nadja che esce sulla soglia e volge uno sguardo mesto, nostalgico al cielo… Il vento primaverile le soffia diritto nel viso pallido, abbattuto… Le ricorda quell’altro vento, che allora ci urlava in viso sulla montagna, quando udiva quelle parole, e il suo volto si fa triste, triste, e lungo la guancia scende lenta una lacrima… E la povera fanciulla protende tutte e due le braccia, come volesse pregare il vento di recarle ancora una volta quelle parole. Ed io, dopo avere atteso che il vento soffi di nuovo, dico sottovoce: «Vi amo, Nadja!» Dio mio, che succede ora! Lancia un grido, sorride con tutto il viso e protende incontro al vento le braccia, beata, felice, così bella. E io torno a far le valigie… Questo è accaduto molto tempo fa. Ora Nàden’ka è già maritata; l’hanno data in sposa, o s’è data lei stessa, non importa, al segretario della Camera di tutela nobiliare, e ormai ha già tre bambini. Ma il ricordo di quando andavamo in slitta e il vento le recava le parole “vi amo, Nàden’ka”, non si è spento; per lei è il ricordo più felice, più commovente e splendido della sua vita… Mentre io ora che mi sono fatto più vecchio, non riesco più a capire perché dicessi quelle parole, a che scopo scherzassi…
I racconti Di Checov hanno una sostanziale povertà di intreccio e scarsità d’azione e lasciano spazio all’interesse dello scrittore russo nel tratteggiare esperienze psicologiche o stati d’animo fatti di poco (un ricordo, un gesto, un’atmosfera). Una visione pessimistica della realtà, destinata a diventare sempre più amara con il passare degli anni, traspare nei suoi racconti, popolati da uomini e donne qualunque, che potremmo incontrare ogni giorno, delusi e frustrati nei desideri più intimi, incapaci di comunicare e di vivere con pienezza grandi sentimenti.
Anche in Uno scherzetto possiamo ritrovare questi temi: dalla mancata realizzazione di sé all’amore vissuto come amaro e doloroso rimpianto, fino all’impossibilità di giungere a certezze definitive. La realtà, anzi, sembra farsi sempre più labile e sfuggente per i due personaggi: travolti dallo scorrere del tempo e dall’inafferrabilità della vita, né il narratore-protagonista né Nadja, sua compagna di giochi in un pomeriggio invernale, riusciranno a realizzare pienamente se stessi, capaci solo di fissare per sempre nella memoria l’attimo di un’avventura in slitta, contemplata con nostalgia come un’occasione perduta.