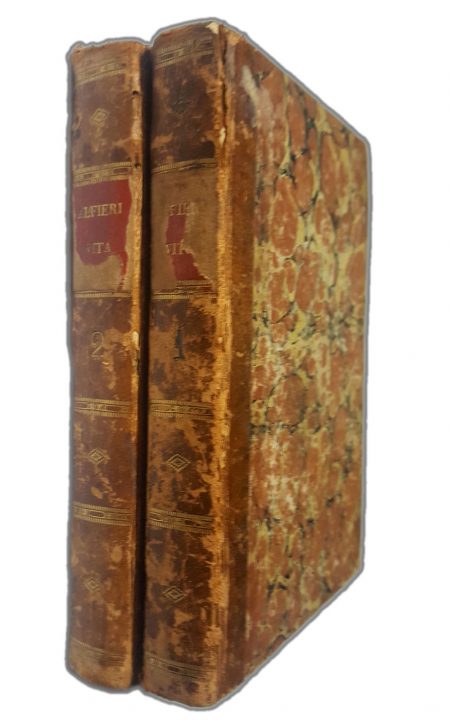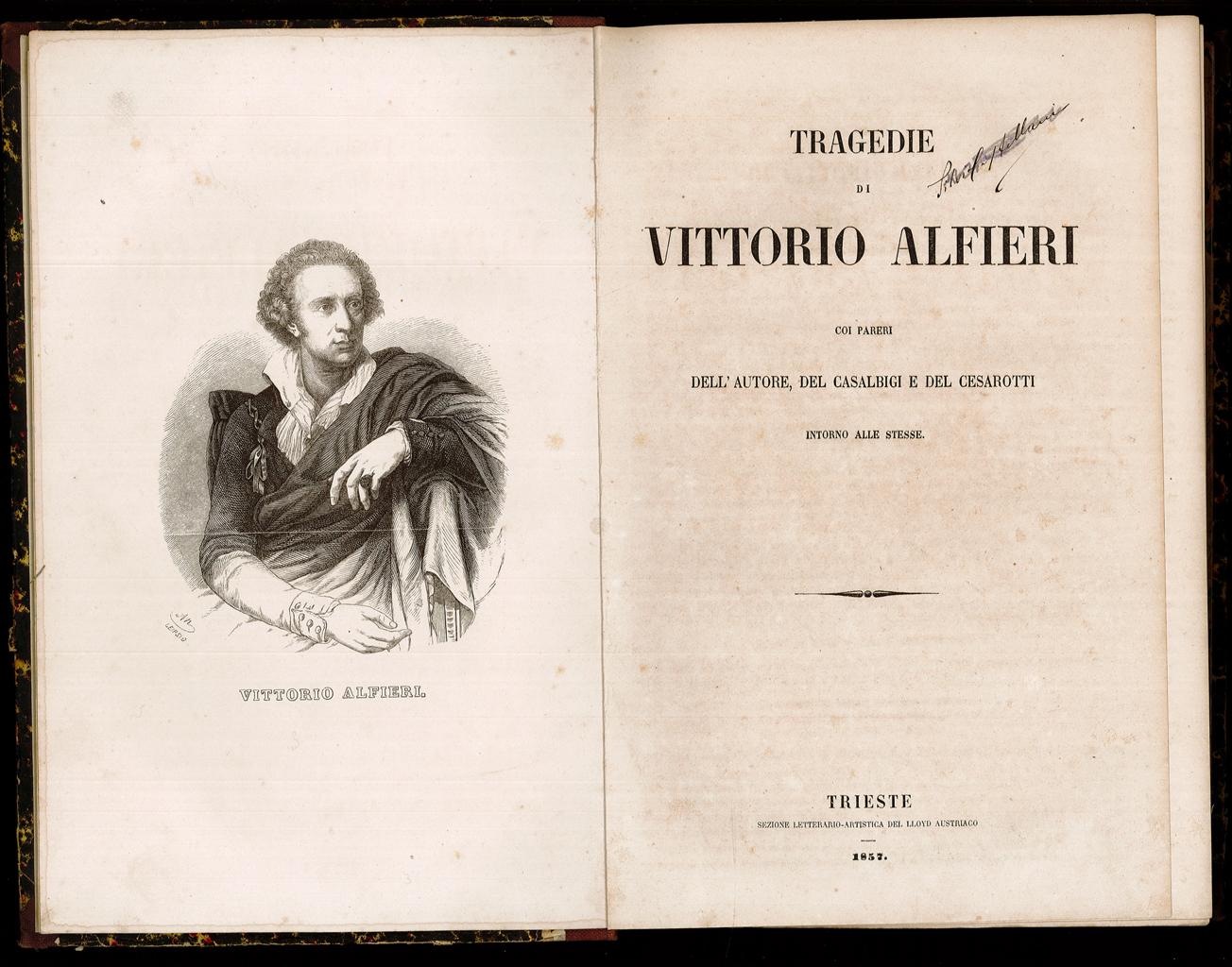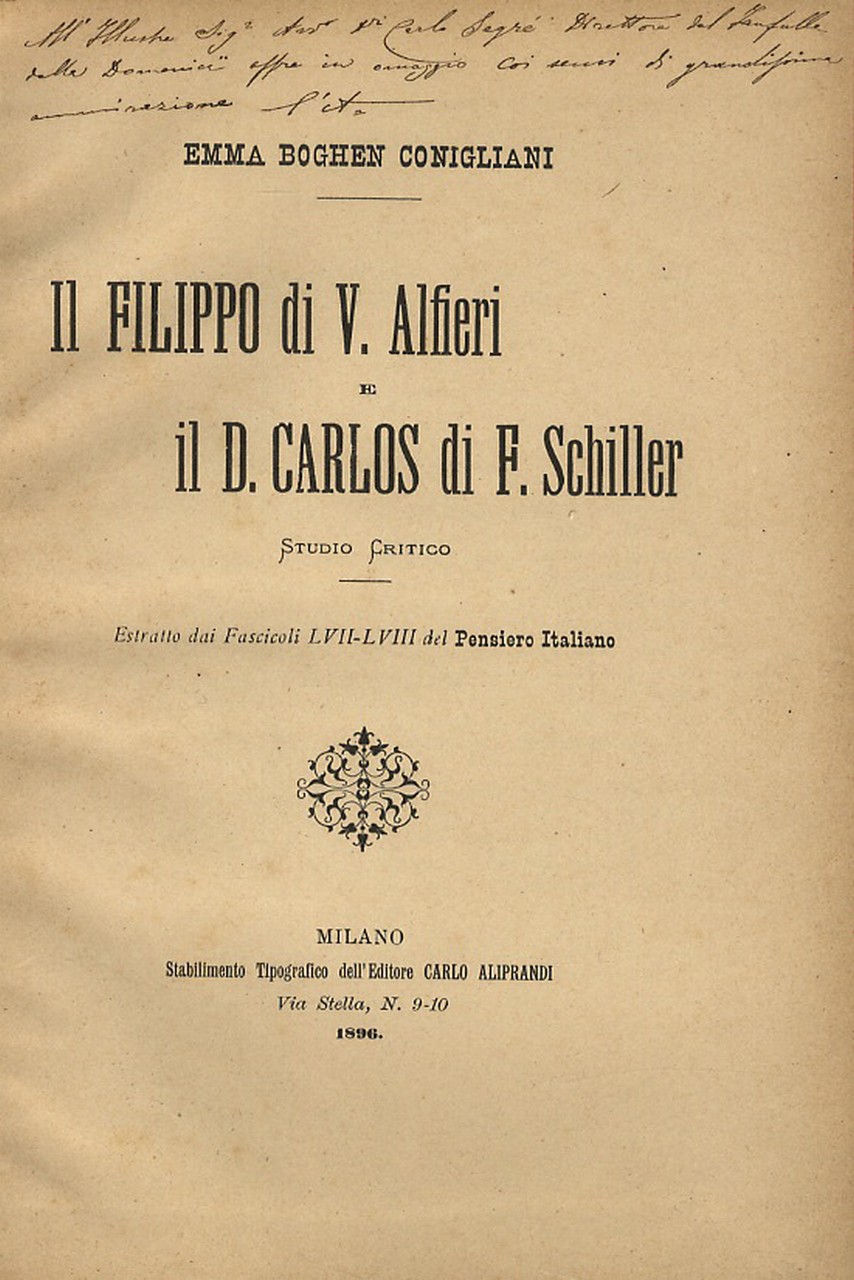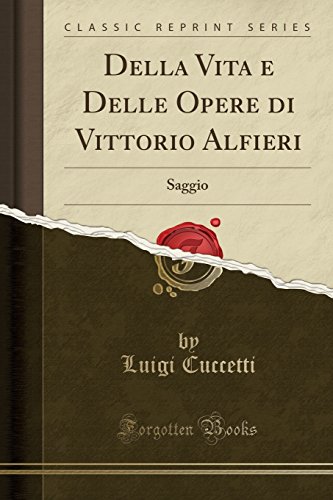L’Europa nel 1815
Nel 1815 il Congresso di Vienna restituiva all’Europa una fisionomia che, da punto di vista politico e geografico, tentava di ripristinare la situazione presente prima della Rivoluzione Francese. I grandi ministri, tuttavia, stettero attenti a non umiliare completamente la Francia, affinché non si alterasse troppo il peso di ogni nazione all’interno del continente. Con la Grande Alleanza (Austria, Prussia e Russia) le potenze cercarono di ripristinare le legittime dinastie all’interno degli stati: la loro politica tuttavia mirava a rafforzarsi, ritagliandosi zone di influenza su cui operare: la Russia voleva sbalzare l’Impero Ottomano e aver mano libera nel Bosforo; la Francia e l’Inghilterra – che si era tenuta al di fuori dall’accordo, mantenendo la monarchia costituzionale – aiutarono la Grecia nell’ottenere l’indipendenza (quindi il controllo sul Mediterraneo), mentre la Prussia rinforzava la sua politica all’interno della sfera germanica. Anche l’Italia subì la stessa sorte, con poche modificazioni rispetto all’assetto politico precedente, fra le quali le più importanti furono il passaggio delle Repubbliche di Venezia e di Genova rispettivamente ai domini austriaci e al regno di Sardegna.
Tuttavia questo “ritorno al passato” non poteva avvenire senza alcuna conseguenza: non era possibile, infatti, cancellare con un tratto di penna l’esperienza napoleonica, tanto più che essa aveva mostrato, pur con tutti i limiti e le contraddizioni “insite” nel sistema stesso, i benefici di uno stato amministrativamente forte ed accentrato. Si creava così, da parte dell’intellettualità più preparata e progressista, una nostalgia tanto più forte rispetto all’immobilismo e alla pochezza dei sistemi restaurati; ma un altro fattore, non meno importante del primo, contribuiva a creare quel clima di risentimento che darà vita ad insurrezioni d’ispirazione liberale che coinvolsero i paesi meridionali del Mediterraneo: la Spagna, il Regno delle Due Sicilie e, come già detto, la Grecia. In Italia tale fermento liberale costituirà la base del nostro Risorgimento formato da uomini che esprimevano l’esigenza di una crescita economica e civile della nostra borghesia, di nuovo censurata e mortificata dallo spezzettamento territoriale e dal clima autoritario che in ciascuno dei vecchi stati s’era costituito.
Già durante i primi decenni il dibattito politico/ideologico si era concentrato sul costituzionalismo, il riformismo e l’identità nazionale: dalle lotte per l’affermazione di questi principi si giunse alla proclamazione d’indipendenza greca del ’30 e al regno di Filippo d’Orleans che diede vita in Francia ad una monarchia costituzionale. Anche in Italia, a livello ideologico, si affermano le esigenze di libertà e di difesa nazionale, che stanno alla base dei primi moti insurrezionali che costellano la nostra storia tra il ’20 e il ’48 e che fanno della “questione italiana” un aspetto della “questione europea” delle nazionalità oppresse (polacchi, serbi, ungheresi) che rappresenta uno dei problemi politici più scottanti del nostro Ottocento.
 Diploma di filiazione alla Carboneria (1820)
Diploma di filiazione alla Carboneria (1820)
Tra il 1820 ed il 1831, in Italia le cospirazioni sono in gran parte organizzate dalla Carboneria che in varie forme e filiazioni ereditano le esperienze delle leggi massoniche già operanti nel ‘700 e durante il periodo napoleonico. Essa esprime, grosso modo, l’esigenza di quella impostazione di stampo liberale e costituzionale già avvertita, negli anni precedenti, ad esempio da Vincenzo Cuoco: il suo programma consiste nel tentare d’imporre ai sovrani, attraverso l’attività segreta e la ribellione, una costituzione che garantisca le libertà fondamentali senza mettere in discussione, tuttavia, né l’assetto istituzionale (la monarchia), né quello sociale dello Stato.

Giuseppe Mazzini
L’opposizione ferma e decisa dei governi locali e degli austriaci, se da un lato frustrano le aspettative, dopotutto moderate, della borghesia, dall’altra radicalizzano le opposizioni favorendo il costituirsi di un’ala democratica e repubblicana, egemonizzata all’inizio da Giuseppe Mazzini e dalla sua organizzazione, la Giovane Italia.
Su questo quadro s’innesta la politica dei Savoia che protesa nella prosecuzione di una politica espansionistica, intravede la possibilità di sfruttare l’aspirazione alla nazionalità e all’indipendenza per un aumento di potere della propria casata. Accolgono, infatti, all’interno dei loro confini, i settori più moderati dell’opinione pubblica nazionale i quali, pur essendo contro i sovrani restaurati, temono che un rivolgimento politico possa determinare anche un rivolgimento sociale.

Felice Dondi: Le cinque giornate di Milano (1845)
Su questo sfondo s’inseriscono le rivoluzioni francesi del 1830 e del 1848, la guerra regia del Piemonte contro l’Austria (1848/1849) e l’esperienza delle Repubbliche popolari di Roma e di Venezia, caratterizzate, soprattutto la prima, dalla predicazione mazziniana.
 Caspar David Friedrich: Uomo e donna di fronte alla luna (1820)
Caspar David Friedrich: Uomo e donna di fronte alla luna (1820)
Il Romanticismo, prima di essere italiano, fu prima di tutto un aspetto della cultura europea.
Germania
In Germania il Romanticismo nacque ufficialmente nel 1799, grazie al filosofo Schlegel, al poeta Novalis e soprattutto la rivista Athenäum quando a Berlino lo stesso Schlegel indicherà con romantik un aspetto della sensibilità moderna in antitesi a quella legata al mondo classico.
WILHELM AUGUST VON SCHLEGEL
POESIA CLASSICA E POESIA ROMANTICA
Alcuni filosofi, i quali però s’accordano con noi nella nostra maniera di riguardare il genio particolare de’ Moderni hanno creduto che il carattere distintivo della poesia del Nord fosse la melancolia; la quale opinione, dove sia chi bene la intenda, non s’allontana dalla nostra. Appo i Greci, la natura umana bastava a se stessa, non presentiva alcun vòto, e si contentava d’aspirare al genere di perfezione che le sue proprie forze possono realmente farle conseguire. Ma quanto a noi, una più alta dottrina c’insegna che il genere umano, avendo perduto per un gran fallo il posto che gli era stato originariamente destinato, non ha sulla terra altro fine che di ricuperarlo; al che tuttavia non può giugnere, s’egli resta abbandonato alle sue proprie forze. La religione sensuale de’ Greci non prometteva che beni esteriori e temporali. L’immortalità, se pur vi credevano, non era da essi che appena appena scorta in lontananza, come un’ombra, come un leggier sogno che altro non presentava se non una languida immagine della vita, e spariva dinanzi alla sua luce sfolgoreggiante. Sotto il punto di vista cristiano, tutto è precisamente l’opposito; la contemplazione dell’infinito ha rivelato il nulla di tutto ciò che ha de’ limiti; la vita presente si è sepolta nella notte, ed oltre alla tomba soltanto brilla l’interminabile giorno dell’esistenza reale. Una simile religione risveglia tutti i presentimenti che riposano nel fondo dell’anime sensitive, e li mette in palese; ella conferma quella voce segreta la qual ne dice che noi aspiriamo ad una felicità cui non si può aggiugnere in questo mondo, che nessun oggetto caduco può mai riempire il vòto del nostro cuore, che ogni piacere non è quaggiù ch’una fugace illusione. Allorché dunque, simile agli schiavi Ebrei, i quali prostesi sotto i salci di Babilonia facevano risonare dei loro lamentevoli canti le rive straniere, la nostr’anima esiliata sulla terra sospira la sua patria, quali possono mai essere i suoi accenti, se non quelli della melanconia? E però la poesia degli Antichi era quella del godimento, la nostra è quella del desiderio; l’una si stabiliva nel presente, l’altra si libra fra la ricordanza del passato e il presentimento dell’avvenire. Nondimeno non bisogna credere che la melanconia si vada al continuo esalando in monotone querimonie, né ch’ella si esprima sempre distintamente. Nella stessa maniera che la tragedia fu sovente appresso de’ Greci energica e terribile ad onta dell’aspetto sereno sotto cui essi riguardavano la vita, anche la poesia romantica, come l’abbiamo pur anzi dipinta, può passare per tutti i tuoni, da quello della tristezza infino a quello della gioia; ma sempre trovasi in essa un certo che d’indefinibile che dinota l’origine sua; il sentimento è in essa più intimo, l’immaginazione meno sensuale, il pensiero più contemplativo. Contuttociò in realtà i limiti si confondono alcuna volta, e gli oggetti non si mostrano mai interamente distaccati gli uni dagli altri, e quali siamo costretti di rappresentarceli per averne un’idea distinta. I Greci vedevano l’ideale della natura umana nella felice proporzione delle facoltà e nel loro armonico accordo. I Moderni all’incontro hanno il profondo sentimento d’una interna disunione, d’una doppia natura nell’uomo che rende questo ideale impossibile ad effettuarsi: la loro poesia aspira di continuo a conciliare, ad unire intimamente i due mondi, fra’ quali ci sentiamo divisi, quello de’ sensi e quello dell’anima: ella si compiace tanto di santificare le impressioni sensuali coll’idea del misterioso vincolo che le congiugne a’ sentimenti più elevati, quanto di manifestare a’ sensi i movimenti più inesplicabili del nostro cuore e le sue più vaghe percezioni. In una parola, essa dà anima alle sensazioni, corpo al pensiero. Non è dunque maraviglia che i Greci ne abbiano lasciato, in tutti i generi, de’ modelli più finiti. Essi miravano ad una perfezione determinata, e trovarono la soluzione del problema che s’avevano proposto: i Moderni a riscontro, il cui pensiero si slancia verso l’infinito, non possono mai compiutamente soddisfare se stessi, e rimane alle loro opere più sublimi un non so che d’imperfetto, che l’espone al pericolo d’essere male apprezzate.

August Wilhelm Schlegel
Vi è nel passo di Schlegel la consapevolezza di superare quella dicotomia che ancora era presente nella cultura di fine Settecento tra cultura classica e cultura romantica. Egli lo sottolinea nel passo (riportato in una traduzione ottocentesca) in cui contrappone la “finitezza” della cultura classica contro “l’infinitezza” della cultura romantica: la prima era determinata dall’imminenza, dal proiettarsi nel presente terreno, in quello che egli definisce “godimento” e quindi soddisfazione del proprio io nel mondo; il secondo dal “vuoto” verso cui si tende, quindi da quella “melanconia” che si produce nella proiezione verso un infinito indeterminato. Schlegel ne fa quasi una distinzione di paesaggio connotativo dell’essere: alla solarità del primo che porta l’uomo classico alla percezione dell’armonia del creato o della possibilità di esso (d’altra parte le stesse speculazioni filosofiche di Aristotele e di Platone vertevano sull’idea di un “di qua”) al notturno della sensibilità moderna, che vede appunto nei paesaggi lunari sia il senso dell’indefinito, come detto, sia il senso del mistero e del non conoscibile, come in parte la stessa filosofia kantiana aveva presagito.
La cultura tedesca conosce, sia a livello lirico che sull’arte del racconto dei veri e propri capolavori romantici. Uno degli più rappresentativi, anche alla luce della sua esperienza biografica, è certamente Friedrich Hölderlin. Nato a Lauffen in Svezia, studia a Tubinga, avendo come condiscepoli, e quindi amici, Schelling e Hegel. Traferitosi dapprima a Jena, quindi a Weimer, diviene precettore nella casa di un banchiere, ma s’innamora di sua moglie, che canta col nome di Diotima, come una fanciulla greca. Vaga dapprima in Svizzera, quindi a Bordeaux, facendo sempre il precettore; ma saputo della morte della musa, attraversa la Francia a piedi, cercando di tornare in Germania. Comincia a soffrire di malattia mentale, che lo portò dapprima in una clinica psichiatrica che lo affida ad un falegname, che lo alloggia in una torre sulla riva di un fiume. Lì vive per 37 anni, suonando il pianoforte e componendo liriche e strani versi, che firma con il nome di Scardanelli.
DA ICH EIN KNABE WAR
Da ich ein Knabe war,
Rettet’ ein Gott mich oft
Vom Geschrei und der Rute der Menschen,
Da spielt’ ich sicher und gut
Mit den Blumen des Hains,
Und die Lüftchen des Himmels
Spielten mit mir.
Und wie du das Herz
Der Pflanzen erfreust,
Wenn sie entgegen dir
Die zarten Arme strecken,
So hast du mein Herz erfreut,
Vater Helios! und, wie Endymion,
War ich dein Liebling,
Heilige Luna!
O all ihr treuen,
Freundlichen Götter!
Dall ihr wüsstet,
Wie euch meine Seele geliebt!
Zwar damals rief ich noch nicht
Euch mit Namen, auch ihr
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen,
Als kennten sie sich.
Doch kannt’ ich euch besser
Als ich je die Menschen gekannt,
Ich verstand die Stille des Äthers,
Der Menschen Worte verstand ich nie.
Mich erzog der Wohllaut
Des säuselnden Hains
Und lieben lernt’ ich
Unter den Blumen.
In Arm der Götter wuchs ich gross.
Quand’ero un fanciullo / spesso un dio mi salvava / dalle verghe e dagli urli dei grandi. / Sicuro e buono giocavo / coi fiori del bosco, / e le aurette del cielo / giocavano con me. / E come tu allieti / il cuor delle piante, / quand’esse ti protendono / le tenere braccia, / così allietavi me pure, / Elio padre! e al par di Endimione / ero il tuo beneamato, / o santa Luna. / O voi tutti, fedeli, Amici iddii! / Quanto più siete deserti, / più vi ama l’anima mia! / Né allora io vi chiamavo / coi vostri nomi, né voi / davate un nome a me, come gli uomini fanno / se tra lor si conoscono. / Pure, io vi conoscevo / assai meglio che gli uomini; / comprendevo il silenzio dell’etere: / le umane parole mai non compresi. / Mi allevò l’armonia / del susurrante bosco, / e appresi ad amare / tra i fiori. / Crescevo in braccio agli dèi.
E’ una poesia giovanile di Hölderlin, dove, anche attraverso la cultura dello Sturm und Drang egli vede il mondo greco come mondo mitico, così come avevamo già visto in Keats e nel nostro Foscolo. Ma qui il poeta tedesco mette qualcosa in più che non è il concetto di “armonia perduta” quanto qualcosa che si rivolge all’assoluto: alla negatività del mondo degli uomini egli contrappone il mondo assoluto della divinità al di fuori dell’umano, quell’accordo universale “naturale” quindi, a-razionale che permette al giovane di vivere l’esperienza della totalità, grazie al Sole che gli permette di “sentire l’afflato divino” che grazie alla luna che aveva dato il sonno (sospensione della vita) al suo amato (Endemione) gli permette di continuare a vivere. Il romanticismo, nel giovane Hölderlin sta nel riuscire a capire il cielo ma non gli uomini.

Franz Carl Hiemer: Friedrich Hölderlin (1794)
Altro importantissimo rappresentante del Romanticismo tedesco è il poeta Novalis (pseudonimo di Friedrich Leopold von Hardemberg), nato nel 1772 in Baviera e morto giovanissimo, a soli 29 anni, a causa della tisi. Influenzato dal pietismo (visione profondamente religiosa che ha del luteranesimo “tradizionale” una visione maggiormente mistica) egli vedeva nella ripresa del Cristianesimo la base della modernità, come afferma in un saggio Cristianità o Europa e soprattutto negli Inni alla notte, raccolta poetica nella quale auspica il ritorno non di un semplice Dio, ma di un Dio capace di risollevare misticamente il mondo degli uomini.
HYMNEN AN DIE NACHT (VI)
Hinunter in der Erde Schooß,
Weg aus des Lichtes Reichen,
Der Schmerzen Wuth und wilder Stoß
Ist froher Abfahrt Zeichen.
Wir kommen in dem engen Kahn
Geschwind am Himmelsufer an.
Gelobt sey uns die ewge Nacht,
Gelobt der ewge Schlummer.
Wohl hat der Tag uns warm gemacht,
Und welk der lange Kummer.
Die Lust der Fremde ging uns aus,
Zum Vater wollen wir nach Haus.
Was sollen wir auf dieser Welt
Mit unsrer Lieb’ und Treue.
Das Alte wird hintangestellt,
Was soll uns dann das Neue.
O! einsam steht und tiefbetrübt,
Wer heiß und fromm die Vorzeit liebt.
Die Vorzeit wo die Sinne licht
In hohen Flammen brannten,
Des Vaters Hand und Angesicht
Die Menschen noch erkannten.
Und hohen Sinns, einfältiglich
Noch mancher seinem Urbild glich.
Die Vorzeit, wo noch blüthenreich
Uralte Stämme prangten,
Und Kinder für das Himmelreich
nach Quaal und Tod verlangten.
Und wenn auch Lust und Leben sprach,
Doch manches Herz für Liebe brach.
Die Vorzeit, wo in Jugendglut
Gott selbst sich kundgegeben
Und frühem Tod in Liebesmuth
Geweiht sein süßes Leben.
Und Angst und Schmerz nicht von sich trieb,
Damit er uns nur theuer blieb.
Mit banger Sehnsucht sehn wir sie
In dunkle Nacht gehüllet,
In dieser Zeitlichkeit wird nie
Der heiße Durst gestillet.
Wir müssen nach der Heymath gehn,
Um diese heilge Zeit zu sehn.
Was hält noch unsre Rückkehr auf,
Die Liebsten ruhn schon lange.
Ihr Grab schließt unsern Lebenslauf,
Nun wird uns weh und bange.
Zu suchen haben wir nichts mehr –
Das Herz ist satt – die Welt ist leer.
Unendlich und geheimnißvoll
Durchströmt uns süßer Schauer –
Mir däucht, aus tiefen Fernen scholl
Ein Echo unsrer Trauer.
Die Lieben sehnen sich wohl auch
Und sandten uns der Sehnsucht Hauch.
Hinunter zu der süßen Braut,
Zu Jesus, dem Geliebten –
Getrost, die Abenddämmrung graut
Den Liebenden, Betrübten.
Ein Traum bricht unsre Banden los
Und senkt uns in des Vaters Schooß.
 Franz Gareis: Novalis (1799)
Franz Gareis: Novalis (1799)
Laggiù nel suo grembo, lontano / dai regni della luce, ci accolga / la terra! Furia di dolori e spinta / selvaggia è segno di lieta partenza. / Dentro l’angusta barca è veloce / l’approdo alla riva del cielo. // Sia lodata da noi l’eterna notte, sia lodato il sonno eterno. / Ci ha riscaldati il torrido giorno, / ci ha fatto avvizzire il lungo affanno. / Non ci attraggono più le terre straniere, / vogliamo tornare alla terra del Padre. // Qui nel mondo che fare se la nostra / fedeltà più non conta né l’amore? / L’antico è già da tutti abbandonato / e noi del nuovo siamo incuranti. / Sta solitario, in preda allo sconforto, / chi ardente e devoto ama il passato. // Il tempo in cui gli spiriti ardevano / luminosi in altissime fiamme, / e gli uomini conoscevano ancora / la mano e il volto del Padre. / Qualche nobile spirito incorrotto / alla sua prima immagine era eguale. // Il tempo, in cui fiorivano ancora, / smaglianti i ceppi antichissimi, / e per il regno del cielo i fanciulli / si votavano al martirio, alla morte. / E se anche parlavano vita e piacere, / più di un cuore si spezzò per amore. // Il tempo, in cui Dio stesso agli uomini / si è rivelato in giovane ardore, / e ha consacrato la sua dolce vita / per forza d’amore a morte immatura. / E angoscia e dolore non ha respinto / da sé, soltanto per esserci caro. // Con ansia struggente vediamo il passato / avvolto in notte profonda, / non sarà mai placata l’ardente / sete nel nostro tempo caduco. / E noi dovremo tornare in patria / per vedere questo sacro tempo. // Che cosa indugia il nostro ritorno? / Già riposano in pace i più cari. / Conclude il corso della nostra vita / la loro tomba: siamo ansiosi e tristi. / Più nulla abbiamo qui da cercare – il cuore è sazio – il mondo è vuoto. // Per ogni vena ci trascorre un dolce / brivido, misterioso e infinito – mi sembra di udire, da lontananze / profonde, un’eco del nostro lutto. / Per noi sospirano anche gli amati, / ci mandano il soffio del loro anelito. // Laggiù ci accolga la sposa / soave, e Gesù prediletto – / Consolato spunta il crepuscolo / per gli amanti i cuori afflitti. / un sogno spezza i nostri legami / e ci immerge nel grembo del Padre.
Il testo è tratto dagli Inni alla notte; opera che potremo definire diseguale (alcuni Inni scritti in versi, altri in prosa ritmica), composta nel 1800 a seguito della morte dell’amata Sophie von Kuhn e del prediletto fratello Erasmus. Essi costituiscono una riflessione filosofico/religiosa, in cui il poeta tedesco riflette sulla morte e sul significato che essa ha come ricongiungimento alla vera vita che è quella del ritorno al Padre (Vater). Da qui la profonda nostalgia verso il mondo antico in cui questo rapporto si viveva nel mondo, in modo diretto, (paragonato qui al vivere fanciullesco) e la necessità di restaurarlo in una contemporaneità che lo ha dimenticato. Non dimentichiamo che tale riflessione nasce anche da una profonda esperienza biografica: la morte dei cari e il suo essere malato: non solo una riflessione romantica ma anche una biografia romantica.
Figura importantissima della cultura tedesca fu certamente quella di Friedrich Schiller (1759 – 1805). Figlio di un modesto ufficiale, studiò giurisprudenza e medicina, ma sin da giovane provò una forte attrazione per la letteratura. Frutto di questo amore è l’opera teatrale I Masnadieri – opera da inserire più allo Sturm und Drang che al Romanticismo – la cui rappresentazione ebbe un successo straordinario. Il contenuto rivoluzionario dell’opera gli alienò gli appoggi politici che lo costrinse a rifugiarsi a Tubinga: qui, grazie all’amicizia con Goethe, Hölderlin si avvicinò anche alla riflessione estetica e filosofica, il cui frutto è il saggio del 1800 Sulla poesia ingenua e sentimentale. Nella maturità si diede al dramma storico, tra cui spiccano il Don Carlos e la Maria Stuarda. Interessante è il Guglielmo Tell dove tenta, anche secondo i dettami della cultura romantica, di unire il dramma storico al sentimento popolare. Ci piace ricordare che gli appartiene anche l’Inno alla gioia del 1785, musicato da Ludwig van Beethoven. Muore per la tubercolosi a soli 46 anni.
Il suo capolavoro è universalmente individuato nel dramma Maria Stuarda (1801):
Maria Stuarda, rinchiusa nel castello di Fotheringhay sotto l’accusa di aver congiurato contro la regina Elisabetta, è condannata a morte. innocente della colpa che le è stata attribuita per sbarazzarsi di lei – legittima pretendente al trono e sostenitrice della fede cattolica – Maria è oppressa dal senso di colpa per l’antica debolezza di concedersi al conte di Bothwell, uccisore di suo marito, Lord Darnely. Il conte di Leicester , favorito di Elisabetta ma segretamente innamorato della bella e affascinante rivale della regina, propone un incontro di pacificazione, mentre un altro ammiratore di Maria, Mortimer, trama per liberarla. Nel colloquio, dapprima Maria si piega fino a chiedere grazia; ma davanti all’atteggiamento beffardo di Elisabetta, piena di sdegno, le rinfaccia la sua nascita illegittima. Con ciò la sua fine è irrevocabilmente segnata. Frattanto il complotto a favore di Maria viene svelato e Leicester, che lo appoggiava, si salva gettando tutte le accuse su Mortimer. Questi si uccide col nome di Maria sulle labbra. Si sparge voce di un nuovo complotto contro la regina. Il popolo reclama la punizione dei colpevoli. Elisabetta si risolve a firmare, su istigazione di Burleigh, l’esecuzione immediata della sentenza capitale. Maria, che ora appare animata da una volontà tragicamente priva di speranza, si avvia nobilmente al patibolo come alla liberazione di una condizione umiliante per la sua regalità e, nello stesso tempo, a una necessaria espiazione.
L’ULTIMO COLLOQUIO TRA MARIA E ELISABETTA
Atto III, scena 4
Elisabetta, Maria, Shrewsbury e Leicester […]
Maria si fa forza e vuole avvicinarsi ad Elisabetta, ma a metà strada si ferma rabbrividendo. I suoi gesti tradiscono la lotta più violenta.
ELISABETTA: Ma come, signori? Chi mi parlava di una donna prostrata e sottomessa. Io vedo una donna altera, per nulla piegata dalla sventura.
MARIA: E sia! Mi assoggetterò anche a queste! Vattene, inutile fierezza dell’animo! Dimenticherò chi sono e tutto quello che ho patito, mi abbasserò di fronte a chi mi ha gettato in questa vergogna. (Si rivolge alla regina) Il cielo è dalla tua parte, sorella! La vittoria incorona il tuo capo fortunato e io adoro in te la divinità che ti innalza. (Le cade ai piedi) Ma ora sii generosa, sorella! Non lasciarmi qui vergognosamente prostrata, tendi la mano, la tua destra regale, e rialzami dalla mia caduta.
ELISABETTA: (ritraendosi) Siete al posto che vi siete meritata, Lady Maria, e io lodo la grazia del mio Dio, che non ha permesso che giacessi io ai vostri piedi come voi ora ai miei!
MARIA: (con crescente intensità) Pensa all’instabilità di tutto ciò che è umano. C’è una divinità che punisce l’orgoglio! Venerala e temila, questa terribile forza divina che mi getta ora ai tuoi piedi… Ma per gli estranei che ci guardano, onora in me te stessa, non sconsacrare, non esporre alla vergogna il sangue dei Tudor, che scorre nelle mie vene, come nelle tue! O Dio del cielo! Non rimanere rigida e inaccessibile, come lo scoglio a cui il naufrago cerca invano, lottando, di aggrapparsi! Tutto per me, la mia vita, il mio destino, dipende dalle mie parole, dalla forza delle mie lacrime: scioglimi il cuore che possa toccare il tuo! Se mi fissi con quello sguardo di ghiaccio, il cuore mi si stringe rabbrividendo, le lacrime indurite non scorrono più, e lo sgomento trattiene la supplica nel petto raggelato.
ELISABETTA: (fredda e severa) Cos’avete da dirmi, Lady Stuard? Volevate parlarmi? Io ora dimentico di essere la regina che avete gravemente offeso, per adempiere solo ad un compito pietoso di sorella e vi concedo la consolazione della mia presenza. Per ascoltare l’invito della generosità, mi espongo ad un giusto biasimo per essere scesi così in basso… sapete bene che volevate farmi uccidere.
MARIA: Come posso cominciare, come posso disporre, le mie parole, perché ti tocchino il cuore, ma non l’offendano. O Dio, da’ forza alle mie parole e togli loro ogni aculeo che potrebbe ferire! Non posso parlare in mio favore senza accusarti duramente, e proprio questo non voglio… Mi hai trattata ingiustamente, perché io sono una regina come te, e tu mi hai tenuta prigioniera; io sono venuta a te supplicando e tu hai sprezzato le sante leggi dell’ospitalità e il sacro diritto delle genti e mi hai rinchiuso tra le mura di un carcere. Mi hanno sottratto crudelmente amici e servitori, mi hanno costretta a indegna privazione e infine trascinata davanti ad un tribunale vergognoso… Ma non ne voglio parlare più! Un eterno oblio ricopra tutte le crudeltà che ho patito. Ma sì, attribuirò tutto al destino; tu non sei colpevole, e neppure io lo sono, uno spirito maligno è salito dagli abissi e ha acceso nei nostri cuori quell’odio che fece di noi, ancor fanciulle, due nemiche. Esso è cresciuto con noi, e uomini malvagi hanno attizzato col fiato l’infausta fiamma. Pazzi fanatici si sono armati, non richiesti, di spada e pugnale. È il destino dei sovrani: le loro discordie precipitano nell’odio il mondo intero e ogni loro dissidio scatena le furie. Ora non c’è più tra di noi una bocca estranea (le si avvicina confidenzialmente e le parla in tono accarezzante), ora siamo solo noi, una di fronte all’altra. Parla ora, sorella! Dimmi la mia colpa, voglio dartene piena soddisfazione. Ah, mi avessi prestato orecchio allora, quando imploravo di vederti! Non si sarebbe giunti a questo punto, e non sarebbe questo triste parco il luogo del nostro doloroso incontro.
ELISABETTA: La mia buona stella mi ha preservata, allora dal mettermi la serpe in seno con le mie stesse mani. Non accusate le stelle, ma la vostra anima nera e la selvaggia ambizione della vostra casa. Fra noi non c’era ombra di discordia, allorquando vostro zio, quel prete superbo e avido di dominare, che non cessa di allungare la mano verso le corone degli altri, mi lanciò la sfida, e indusse voi ad assumere il mio stemma, ad impossessarvi del mio titolo regale e ad iniziare con me un duello all’ultimo sangue. E chi non ha cercato di aizzare contro di me? La lingua dei preti e la spada dei popoli, e tutte le armi terribili del fanatismo religioso, perfino qui, nella pace del mio impero, ha attizzato le fiamme della sommossa… Ma Dio è con me, e quel prete superbo non è padrone del campo… Il suo colpo mirava al mio capo, ma sarà il vostro a cadere!
MARIA: Sono nelle mani di Dio. Non approfitterai in modo così cruento della tua potenza.
ELISABETTA: E chi mi lo impedirà? Vostro zio ha mostrato a tutti i re del mondo come si fa la pace coi propri nemici: la mia scuola sia la notte di San Bartolomeo! Che m’importa dei vincoli del sangue e dei diritti dei popoli? La chiesa affranca da ogni legame, la chiesa santifica regicidio e spergiuro. Io non faccio che applicare gli insegnamenti dei vostri preti. Ma dite, su, che pegno garantirebbe per voi, se generosa vi togliessi le catene? Quale serratura terrebbe custodita la vostra parola, che le chiavi di San Pietro non possano aprire? Nella forza sta la mia sola sicurezza, non si può scendere a patti con i viscidi serpenti.
MARIA: Oh, credimi, sei tu la causa del nostro dissidio, con questa tua triste, cupa diffidenza! Vedesti sempre in me un’estranea, una nemica: se tu mi avessi dichiarata tua erede, come mi spetta, amore e gratitudine avrebbero fatto di me una fedele amica e una cara parente.
ELISABETTA: Non son qui i vostri amici, Lady Stuard, la vostra casa è il papato, vostri fratelli i monaci… Voi mia erede! Volete mettermi in trappola! E io dovrò permettere che voi, mentre sono ancora in vita, seduciate il mio popolo con le vostre arti da Armida, e irretiate la nobile gioventù del mio regno nei vostri lacci lascivi; dovrò sopportare che tutti si volgano al nuovo astro che sorge, mentre io…
MARIA: Governa in pace! Rinuncio ad ogni mia pretesa su questo regno. Ahimè, le ali del mio spirito sono spezzate, la grandezza non mi attira più. Ci sei riuscita: non sono che l’ombra della Maria di un tempo. L’orgoglio del mio animo ha ceduto all’onta del lungo carcere… Hai raggiunto lo scopo, mi hai distrutto in piena fioritura. Ma ora poni fine al tormento, sorella! Dilla, la parola per la quale sei venuta, ché non posso credere che tu sia qui di fronte alla tua vittima solo per beffarti di lei. Pronuncia questa parola! Dimmi: «Sei libera, Maria! Hai provato la mia forza, ora venera la mia grandezza d’animo». Dillo, e io riceverò vita e libertà come un dono dalle tue mani… Una parola, e il passato è cancellato. L’attendo, oh, non farmela aspettare troppo a lungo! Guai a te se non la pronuncerai! Ché se non te ne andrai via da me come una splendente divinità apportatrice di salvezza, sorella!, né per tutta questa terra ricca e benedetta, né per tutte le terre che il mare circonda, vorrei mai star io davanti a te, come tu ora davanti a me!
ELISABETTA: Così vi riconoscete vinta, finalmente? Avete finito di tessere intrighi? Non ci sono assassini in agguato? Non ci sono più avventurieri che si addossino il triste compito di essere vostri paladini? Sì, è finita, Lady Maria, non sedurrete più nessuno. Il mondo ha altri crucci. Non alletta nessuno la prospettiva di essere il vostro quarto marito, perché, mariti o pretendenti, voi li uccidete tutti!
MARIA: (sussultando) Sorella! Sorella! Oh Dio, fa’ che possa trattenermi!
ELISABETTA: (la guarda a lungo con disprezzo e alterigia) Così, Lord Leicester, queste sarebbero le seduzioni che nessun uomo può contemplare impunemente, con cui nessuna donna può osare confrontarsi! Eh, certo… È una fama conquistata a buon mercato: non costa nulla essere per tutti una bellezza, se si accetta di essere la bellezza di tutti.
MARIA: Questo è troppo!
ELISABETTA: (ridendo sprezzante) Ora mostrate il vostro vero viso, finora non era che una maschera.
MARIA: (infiammata dall’ira, ma con dignità) Ho errato come errano gli esseri umani. Ero giovane, allora, e il potere mi seduceva. Ma non l’ho mai tenuto nascosto: ho sempre amato la lealtà e sdegnato le false apparenze. Il mondo conosce il peggio di me, ma io posso dire: sono migliore della mia fama. Guai a te, invece, se un giorno alzerai il mantello di onorabilità che ricopre le tue azioni e sotto il quale nascondi ipocritamente l’ardore sfrenato di passioni clandestine! Non è certo l’onore l’eredità di tua madre: tutti sanno per quali virtù Anna Bolena salì il patibolo!
SHREWSBURY: (s’intromette tra le due regine) Dio del cielo! A questo punto si doveva arrivare! È questo la moderazione, l’umiltà, Lady Maria?
MARIA: Moderazione! Umiltà! Ho sopportato tutto quello che un essere umano può sopportare. Ora vattene, calma pecorile, torna al cielo, paziente sopportazione, spezza finalmente i vincoli che ti trattengono, vieni fuori dal tuo nascondiglio, ira troppo a lungo repressa… Tu, che desti al basilisco infuriato lo sguardo che uccide, concedi alla mia lingua la freccia avvelenata…
SHREWSBURY: È fuori di sé! Perdona le sue smanie, è stata provocata!
LEICESTER: (tenta agitatissimo di condur via Elisabetta) Non ascoltarla, è fuor di senno! Via, via da questo luogo infausto!
MARIA: Il trono d’Inghilterra è sconsacrato da una bastarda, il nobile popolo inglese ingannato da un’astuta ciarlatana! Se regnasse giustizia saresti tu ora davanti a me nella polvere, perché io sono la tua regina.
Elisabetta esce in fretta. I lords la seguono coi segni del più profondo sgomento.
 Gerhard von Kügelgen: Friedrich Schiller (1808)
Gerhard von Kügelgen: Friedrich Schiller (1808)
La storia di Maria Stuarda non era certo nuova per Schiller: gli esempi gli venivano dalla letteratura italiana, durante il ‘600 da Della Valle, più recentemente per lui, certo l’opera di Alfieri. Ci sono tuttavia nella tragedia di Schiller alcuni elementi che lo fanno apparire all’interno della poetica romantica:
- l’abolizione delle tre unità aristoteliche
- la riflessione tra amore e potere, che, con altre declinazioni, come libertà e potere, tanta parte ebbero nella sua riflessione letteraria.
In questo brano tratto dal terzo atto del dramma, che è nella realtà storica non è mai avvenuto, s’immagina che Maria, spinta da Leicester, s’incontri con Elisabetta per indurla ad un atto pietoso. Ciò serve all’autore per mettere a confronto le figure di due donne che non rappresentano più, come nelle opere precedenti, la riflessione sulla fredda ragione di stato e la cristiana umiltà, ma su due forti passioni; la scena è costruita come se ci fosse un combattimento tra le due: all’inizio Maria è sulla difensiva, cerca di non offendere Elisabetta, la chiama sorella per sottolineare il legame di sangue che le unisce. La regina, tratta forse in inganno dall’atteggiamento sottomesso di Maria, ne approfitta per attaccare: le sue parole sono sempre più sferzanti e non concedono nulla all’avversaria; la sovrana sembra acquietarsi solo quando Maria si dice vinta e disposta a rinunciare al trono, non più attirata dalla grandezza politica. Nemmeno con la dichiarazione di sconfitta e dopo l’ennesima richiesta di conciliazione, però, la regina si sente appagata e passa addirittura agli insulti. La situazione allora si capovolge, l’ira di Maria rimonta e le sue parole, estremamente dignitose, rivendicano la sua sincerità e smascherano l’ipocrisia di Elisabetta, che non è più sorella, ma bastarda e ciarlatana. Schiller, nel costruire la scena mantiene la tensione costantemente alta, lasciando nel dubbio lo spettatore circa la volontà di Elisabetta di perdonare o meno: quindi lo scontro avverrà sulle capacità oratorie delle due donne. Il tutto è costruito con la tecnica del crescendo: alle parole di umiliazione di Maria e quindi all’atteggiamento sprezzante di Elisabetta viene sapientemente ribaltato fino alla “quasi” fuga di Elisabetta: attraverso l’espediente scenico del capovolgimento, che avviene sempre al culmine di un’azione e la rende più tragica, Schiller risolve il conflitto tra le due protagoniste e ci suggerisce la sua tesi, secondo cui l’eroe è puro e nobile, mentre chi vuole occuparsi di politica deve per forza risultare impuro, rinunciando all’integrità morale. Alla fine dell’incontro le due donne raggiungono ognuna uno scopo, una sul piano umano, l’altra su quello politico.
 Scipione Vannutelli: Maria Stuarda si avvia al patibolo (1861)
Scipione Vannutelli: Maria Stuarda si avvia al patibolo (1861)
Sul versante della prosa romantica tedesca, l’autore maggiormente rappresentativo è Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, scrittore e musicista. Nasce nel 1776, rimasto orfano, è avviato dallo zio a studi giuridici. Ma sin da giovane si sentì attratto dalla letteratura e dalla musica. Fece da giovane vita dissipata, cercando di far coincidere biografia e arte: ciò lo percepiva soprattutto nella composizione musicale, cui sentiva quasi un rapimento trascendentale che lo portava a considerare la musica stessa quasi una forza diabolica, capace di rapire l’animo. Tale concezione lo portò ad approfondite temi legati al mistero, l’occulto, il diabolico, arrivando nella sua produzione a preconizzare l’inconscio. Per questo atteggiamento egli fu amato da scrittori come Poe e Baudelaire, ma non è un caso che un attento studioso della sua arte fu, un secolo dopo, Sigmund Freud, che, proprio dal racconto Sandmann (L’uomo della sabbia) elaborò la teoria del perturbante.
Il racconto prende l’avvio da una lettera che Nathaniel scrive all’amico Lotatio, narrandogli che, durante la fanciullezza, sovente veniva evocato “l’uomo della sabbia” per spaventare i bambini che non avevano voglia di andare a dormire. Chiesta la motivazione di questo nome, la mamma risponde che tale nome non è che la metafora degli occhi che non riescono a stare aperti, “come se vi avessero gettato della sabbia”; mentre la fantesca gli riferisce di una figura spaventosa che, a bambini restii ad andare a letto, rubava gli occhi e li offriva ai suoi figli che li beccavano con il becco ricurvo come quello delle civette. Il bambino ne rimase a tal punto impressionato da non passare le notto in preda al terrore. Ma la curiosità fu più forte. Egli lo identifica con un ospite, figura assai inquietante, che, quando giunge in casa, si avvia direttamente nello studio paterno senza che i bimbi, comandati di andare nelle loro camere, possano vederlo. Un giorno Nathaniel decide di nascondersi nello studio del padre, per “vedere” l’uomo della sabbia. Lo riconosce in un vecchio amico di famiglia, dott. Coppelius, ma la cui figura è fortemente significante. Mentre l’uomo ordina al padre di aprire un vecchio armadio si disvela una camera oscura per ricerche scientifiche: all’interno sicuramente un fuoco, l’evocazione inquietante “A me gli occhi” e la scoperta della sua presenza; Coppeluis lo afferra, quasi gli disarticola e avvicina i suoi occhi alla fiamma; solo la preghiera accorata del padre lo salva. In una successiva visita il padre di Nathaniel rimane ucciso, e della figura dello strambo scienziato si perdono le tracce. Passano gli anni e Nathaliel diventa studente universitario. Gli sembra di aver riconosciuto in un venditore ambulante Giuseppe Coppola, il vecchio Coppelius, facendogli risvegliare l’incubo. In questo periodo s’innamora di Olimpia, figlia del suo professore di scienze, prof. Spallanzani, ma la ragazza ha qualcosa di strano: sguardo vitro e gesti meccanici: Per lei dimentica la sua fidanzata, Clara. Un giorno vede terrorizzato il corpo di Olimpia disputato da Spallanzani e Coppola: tale corpo non è che un automa, costruito dal professore con gli occhi applicati dal venditore ambulante. Nathaliel, a seguito della visione, viene colto da un accesso di follia, rimane a lungo ricoverato. Guarito decide di sposare Clara; insieme a lei e a suo fratello vanno su un’alta torre per osservare il panorama. Narthaliel, affacciatosi, rivede Coppola e, preso da raptus folle, tenta di gettare nel vuoto Clara, che viene salvata dal fratello, mentre lui cade nel vuoto gridando “Begli occhi!”.
 Autoritratto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Autoritratto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
L’UOMO DELLA SABBIA
Durante tutta la giornata, all´infuori del pranzo, io e mia sorella vedevamo molto di rado nostro padre. Doveva essere molto occupato nel suo lavoro. Dopo cena, che secondo una vecchia abitudine si consumava già alle sette, noi tutti con la mamma andavamo nel suo studio e ci sedevamo intorno a un tavolo rotondo. Il babbo fumava e beveva un grosso bicchiere di birra. Spesso ci raccontava storie meravigliose e vi si entusiasmava talmente da lasciar spegnere la pipa, e io dovevo riaccendergliela con un pezzo di carta a cui avevo dato fuoco: il che era per me un vero divertimento. Spesso invece ci metteva dinanzi dei libri illustrati, sedeva muto e pensieroso nella sua poltrona e soffiava attorno a sé dense nuvole di fumo, tanto che ci sembrava di nuotare nella nebbia. In quelle sere la mamma era molto triste e appena battevano le nove ci diceva: «Su, ragazzi, a letto, a letto! Viene l’uomo della sabbia, già mi pare di vederlo!». E io ogni volta sentivo veramente un passo lento e pesante che saliva su per le scale: doveva essere l’uomo della sabbia! Una volta quel camminare cupo e rintronante mi fece venire i brividi e alla mamma che ci conduceva via chiesi: «Mamma, chi è mai quel cattivo uomo della sabbia che ci allontana sempre dal babbo? Che aspetto ha?».
«Non esiste nessun uomo della sabbia, figliolo mio» rispose la mamma «quando io vi dico che viene l’uomo della sabbia, voglio solo dire che voi siete assonnati e che non potete tenere più aperti gli occhi, come se vi avessero gettato della sabbia.»
La risposta della mamma non mi soddisfece; anzi, nella mia mente infantile sempre più chiaro si fece il pensiero che la mamma volesse negare l’esistenza dell’uomo della sabbia solo perché noi non dovessimo averne paura, tanto è vero che lo sentivo sempre salire le scale. Desideroso di voler vedere più da vicino questo uomo della sabbia e di sapere quali erano i suoi rapporti con i bambini, chiesi infine alla vecchia cui era affidata la mia sorellina minore chi mai esso fosse.
«Oh, Niele» rispose costei «non lo sai ancora? È un uomo cattivo, che viene dai bambini che non vogliono andare a letto e butta loro negli occhi manciate di sabbia sino a farglieli schizzare sanguinanti fuori dal capo; poi li prende, li mette in un sacco e li porta sulla luna in pasto ai suoi figlioletti; questi stanno lassù in un nido e hanno il becco ricurvo come le civette e con questo beccano gli occhi dei bambini cattivi.»
L’orribile immagine di quell’uomo crudele si impresse così nella mia mente, e quando alla sera io lo sentivo salire le scale, tremavo dall’angoscia e dal terrore. Mia madre riusciva solo a cavarmi dalla bocca questo grido balbettato tra le lacrime: «L’uomo della sabbia! L’uomo della sabbia!». Correvo quindi nella camera da letto e tutta la notte ero torturato dalla paurosa visione dell’uomo della sabbia.
Quando fui abbastanza grande per comprendere che tutto ciò che mi era stato raccontato dalla governante dell’uomo della sabbia e della sua nidiata di figlioli sulla luna non aveva nessun fondamento, l’uomo della sabbia per me continuava a essere un fantasma pauroso ed ero sempre preso da vero terrore quando lo sentivo non solo salire le scale ma anche aprire la porta dello studio di mio padre ed entrarvi. Qualche volta non si faceva vivo per molto tempo, ma poi veniva più volte di seguito. La cosa durò parecchi anni, e io non riuscivo ad abituarmi all’idea di quel fantasma la cui immagine odiosa non riuscì a impallidire nella mia mente. I suoi rapporti con mio padre finirono con l’ossessionare la mia fantasia. Avrei voluto interrogare mio padre, ma un terrore invincibile me lo impediva. Io stesso, io solo, dovevo indagare nel mistero, dovevo vedere il favoloso uomo della sabbia: questo fu il mio più vivo desiderio che col passare degli anni sempre più si radicò in me. L’uomo della sabbia mi aveva messo sulla strada dell’avventura, del meraviglioso, che così facilmente si annida nell’animo dei fanciulli. Niente mi attirava di più che ascoltare o leggere le paurose storie di folletti, di streghe, di gnomi, ma in cima a tutti stava sempre l’uomo della sabbia, che io andavo ovunque, con il gesso o con il carbone, disegnando nei più strani e orribili atteggiamenti su tavoli, su armadi e pareti.
Quando ebbi dieci anni, mia madre mi fece passare dalla camera dei fanciulli in una piccola stanza che si apriva sul corridoio vicino a quella di mio padre. Come sempre quando battevano le nove e si sentiva lo sconosciuto in casa nostra, noi dovevamo in tutta fretta allontanarci. Dalla mia cameretta lo sentivo entrare dal babbo e subito dopo mi sembrava che per la casa si diffondesse un vapore dall’odore strano. Con la curiosità, sempre più cresceva in me il coraggio di fare in qualche modo la conoscenza dell’uomo della sabbia. Spesso, appena la mamma era già passata oltre, dalla mia cameretta sgusciavo nel corridoio, ma non riuscivo a vedere nulla perché l’uomo della sabbia, quando raggiungevo il punto da dove avrei potuto vedere, era già entrato nella camera del babbo. Alla fine, spinto da un impulso irresistibile, decisi di nascondermi proprio nella camera del babbo per aspettarvi l’uomo della sabbia.
Una sera, dal silenzio del babbo e dalla tristezza della mamma, compresi che l’uomo della sabbia sarebbe venuto. Con la scusa che ero molto stanco, lasciai prima delle nove la stanza e mi nascosi in un nascondiglio vicino alla porta.
Il portone di casa cigolò: dal vestibolo, su, verso la scala, rintronarono i passi lenti e pesanti. La mamma mi passò dinanzi con la sorellina. Piano piano aprii la porta della stanza del babbo. Egli come al solito se ne stava seduto muto e rigido, volgendo le spalle alla porta e non si accorse di me. Fui subito dentro e mi cacciai dietro la tendina, che era tesa su un armadio aperto, vicino alla porta, dove il babbo teneva i suoi abiti. Sempre più vicino… sempre più vicino risuonavano i passi… ecco!… di fuori un tossire, uno scalpicciare, un borbottio strano. Nell’attesa angosciosa il cuore mi tremava. Ecco, proprio vicino alla porta un passo serrato… un colpo violento sulla maniglia… la porta si spalanca con rumore! Facendomi animo, con cautela sporgo la testa. L’uomo della sabbia sta nel mezzo della stanza, davanti a mio padre: la luce chiara delle candele gli illumina il viso! L’uomo della sabbia, il tanto temuto uomo della sabbia, è il vecchio avvocato Coppelius, che qualche volta a mezzogiorno viene a mangiare da noi.
Ma nessuna figura più mostruosa avrebbe potuto atterrirmi come quella di Coppelius. Immaginati un uomo alto, dalle spalle larghe, con una grossa testa informe, il viso terreo, le sopracciglia grigie e cespugliose, sotto le quali lampeggiano due occhi da gatto verdastri e pungenti e un naso grande e grosso cadente sopra il labbro superiore. La sua bocca si torce spesso in un sorriso malvagio; si vedono allora sulle guance due macchie scarlatte e uno strano sibilo gli passa attraverso i denti stretti. Coppelius compariva sempre con una giacca color cenere di taglio antiquato, il panciotto e i calzoni dello stesso colore, ma portava calze nere e le scarpe con piccole fibbie ornate di pietre. La piccola parrucca gli copriva a stento il cocuzzolo, i cernecchi gli stavano appiccicati sopra le grandi orecchie rosse e una larga reticella per i capelli saltava fuori dalla nuca, lasciando vedere il fermaglio d´argento che teneva fissata la cravatta pieghettata. Tutto il suo aspetto era stomachevole e odioso; ma soprattutto a noi bambini facevano senso le sue mani pelose e nodose tanto che rifiutavamo tutto ciò che toccava. Egli se ne era accorto e si divertiva a toccare con un pretesto qualsiasi ora un pezzo di torta, ora un frutto dolce che la nostra buona mamma ci aveva messo sul piatto, cosicché, piangendo per lo schifo e per il ribrezzo, rinunciavamo a quelle ghiottonerie che dovevano darci gioia. La stessa cosa faceva nei giorni di festa, quando il babbo ci mesceva un bicchierino di vino dolce: allora egli subito vi posava la mano oppure si portava addirittura il bicchiere alle labbra e rideva diabolicamente quando non riuscivamo a manifestare la nostra rabbia se non attraverso sommessi singhiozzi. Era abituato a chiamarci bestiole. Lui presente, non dovevamo dire neppure una parola e non potevamo fare altro che maledire quel cattivo, odioso uomo che ci rovinava apposta anche il piacere più innocente. Anche la mamma sembrava che odiasse quel ripugnante Coppelius appena infatti egli appariva, tutta la sua serenità, la sua natura gaia e semplice si mutava in una cupa tristezza. Mio padre invece di fronte a lui si comportava come davanti a un essere superiore di cui si devono sopportare le scortesie e che occorre mantenere a ogni costo di buonumore. Bastava che quello vi accennasse perché subito si preparassero cibi prelibati e si servissero vini scelti.
Quando dunque vidi Coppelius, provai orrore e raccapriccio, perché solo lui poteva essere l´uomo della sabbia. Ma l´uomo della sabbia per me non era certo lo spauracchio delle fole della governante, quello che veniva a prendersi in pasto gli occhi dei bambini per le civette sulla luna, no, certo: era un mostro orribile che, dove arrivava, portava con sé dolori e miserie, momentanei o perpetui.
Ero come affascinato. Con il pericolo di essere scoperto e quindi severamente punito, rimasi dove ero, e origliavo sporgendo la testa dalla tendina. Mio padre accolse Coppelius con molto rispetto. «Su, al lavoro» fece questi, con voce stridula, deponendo la giubba. Il babbo cupo e silenzioso si tolse la veste da camera, ed entrambi indossarono lunghe tuniche nere. Dove le avessero prese non riuscii a vedere. Mio padre aprì le ante di un armadio a muro; ma vidi che quello che per tanto tempo avevo creduto un armadio era una caverna nera in cui stava un piccolo focolare. Coppelius si avvicinò e vi accese una fiamma azzurra e scoppiettante. Attorno vi stavano vari e strani oggetti. Dio mio! come era mutato mio padre mentre si chinava sul fuoco! Si sarebbe detto che un dolore tremendo e lancinante avesse trasfigurato i suoi lineamenti dolci e nobili in quelli di un demonio brutto e riluttante. Ora assomigliava a Coppelius. Questi con tenaglie arroventate toglieva dal denso fumo materiali sfavillanti che poi con grande energia martellava. Mi sembrava di vedere tutto attorno visi umani, ma senza occhi, e al posto di questi impressionanti cavità nere. «Qua gli occhi, qua gli occhi» gridava Coppelius con voce cupa e tonante.
Preso da una paura selvaggia, mandai un grido e saltai fuori dal mio nascondiglio. Coppelius mi afferrò: «Bestiola, bestiola!» belò digrignando i denti… Mi sollevò, mi buttò nel fuoco e la fiamma cominciò a bruciarmi i capelli. «Ora abbiamo gli occhi, gli occhi… un bel paio di occhi di fanciullo.» Così sussurrava Coppelius e con le mani prese dalla fiamma alcuni granelli incandescenti che voleva buttarmi negli occhi. Mio padre implorando alzò le mani e gridò: «Maestro, maestro, lascia gli occhi al mio piccolo Nataniele, lasciaglieli».
Coppelius rise in modo stridulo e disse: «Li tenga pure gli occhi il ragazzo per frignare nel mondo; ma ora osserviamo un po´ il meccanismo delle mani e dei piedi». E mi afferrò con violenza, le giunture scricchiolarono, mi svitò mani e piedi che andava poi rimettendo a posto: «Non tutti vanno bene, era meglio prima! Il vecchio aveva capito bene!» così sibilava e bisbigliava Coppelius, ma intorno a me vi erano le tenebre: una specie di spasmo mi attraversò i nervi e le ossa e non sentii più nulla.
Un dolce alito caldo mi accarezzò il viso. Mi ripresi come da un sonno mortale, la mamma stava china su di me. «È ancora qui l’uomo della sabbia?» balbettai.
«No, figliolo caro: ormai se ne è andato, non può più farti del male» così diceva la mamma accarezzando e baciando il suo caro figliolo ritrovato.
Ma perché annoiarti oltre, mio carissimo Lotario? Perché raccontarti così estesamente ogni particolare, quando mi rimane ancora tanto da dire? Basta. Fui scoperto a origliare e maltrattato da Coppelius. La paura e l’angoscia mi fecero venire un febbrone per cui me ne stetti a letto qualche settimana. «L’uomo della sabbia è ancora qui?» Queste furono le mie prime parole sensate, e furono il segno della mia guarigione, della mia salvezza.

Disegno a penna dello Stesso Hoffmann per L’uomo della sabbia
Su tale racconto commenta lo studioso di letteratura tedesca, prof. Luigi Forte: “Sdoppiamenti e dissociazioni, travestimenti e metamorfosi, che testimoniano la problematica presenza dell’uomo nel carcere terreno e la distanza tra io e natura, attingono con dovizia all’armamentario del fantastico: alberi tramutati in uccelli, pappagalli in maggiordomi, serpi in fanciulle, salamandre in archivisti… Mentre un armadio a muro, come nell’Uomo della sabbia, può d’improvviso dilatarsi in una nera caverna dove si celebrano riti alchemici (…) Già Freud, fornendo un’interessante e classica interpretazione dell’Uomo della sabbia, insisteva sulla dualità del suo mondo: di qui l’incertezza nel definire la consistenza reale o fantastica dei personaggi. La paura originaria del bambino Nataniele, che teme di essere derubato dei propri occhi dal mago sabbiolino, che secondo il racconto della nutrice li porterebbe in un lontano nido sulla luna per offrirli in pasto ai suoi figlioletti dal becco ricurvo come le civette, si condensa, col passare del tempo, in un’ossessione, di cui Hoffmann scandisce, con ritmo impareggiabile le varie tappe. L’Uomo della sabbia vuole essere non solo l’analisi dell’anima di un alienato, ma, secondo i suggerimenti freudiani, la registrazione dei movimenti di un meccanismo innestato dal complesso di castrazione: come se tutto – mago sabbiolino alias avvocato Coppeluis, a sua volta aspetto negativo dell’imago paterna che confluisce nell’ottico Coppola e nel professor Spallanzani – germinasse nell’identità incrinata di Nataniele, dal suo fissarsi su un’immagina narcisistica (la bambola Olimpia) che lo distoglie da un reale oggetto d’amore (la fidanzata Clara). Hoffmann, utilizzando uno spezzone di romanzo epistolare, tratteggia magistralmente, la regressione di Nataniele, la sua resistenza a crescere e maturare psicologicamente e la conseguente attrazione verso il feticcio Olimpia, che sempre più gli appare come una promesse du bonheur (promessa di felicità) non inficiata dalla inconciliabilità di sogno e realtà.”
Inghilterra
L’Inghilterra, ufficialmente, precede la Germania nella nascita del Romanticismo, ma la nuova sensibilità presente nel paese tedesco con lo Sturm und Drang, nonché la poesia ossianica dello scozzese Macpherson fanno sì che in esso si concentrino le nuove istanze che troveranno la loro sintesi nell’opera Lyrical Ballads (Ballate liriche) pubblicate nel 1798 da William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge.
 Benjamin Robert Haydon: Wordsworth sull’Helvellyn
Benjamin Robert Haydon: Wordsworth sull’Helvellyn
William Wordsworth nasce nel 1770 a Cockermouth, nella regione dei laghi (non per niente, sia lui che Coleridge vennero definiti, all’inizio per spregio, poeti “laghisti”). Da giovane viaggia in Francia, durante la Rivoluzione, ma rimane sfavorevolmente impressionato e quando ritorna in Inghilterra si ritira, insieme alla sorella, a vita appartata insieme alla sorella, consumando anche il rapporto amicale che aveva, da giovane, instaurato con Coleridge. Dopo il matrimonio si avvicina sempre più ad un liberalismo di tipo conservatore, aderendo, quindi in età matura, alla politica della regina Vittoria. Muore nel 1850.
Dalle Ballate liriche, prendiamo la fondamentale prefazione, opera di Wordsworth:
UNA POESIA DI SANGUE E CARNE
Lo scopo principale che ho avuto scrivendo queste poesie è stato quello di rendere interessanti gli avvenimenti di tutti i giorni, rintracciando in essi, fedelmente ma non forzatamente, le leggi fondamentali della nostra natura, specialmente per quanto riguarda il modo in cui noi associamo le idee in uno stato di eccitazione. La vita umile e rurale è stata scelta generalmente perché, in questa condizione, le passioni essenziali del cuore trovano un terreno più adatto alla loro maturazione, sono soggette a minori costrizioni, e parlano un linguaggio più semplice ed enfatico; perché in questa condizione i nostri sentimenti elementari esistono in uno stato di maggiore semplicità e di conseguenza possono essere contemplati più accuratamente e comunicati con più forza; perché il comportamento della vita rurale nasce da questi sentimenti elementari, e, dato il carattere di necessità delle attività rurali, è più facilmente compreso ed è più durevole; e, finalmente, perché in questa condizione le passioni degli uomini fanno tutt’uno con le forme stupende e imperiture della natura. Si è pure adottato il linguaggio di questi uomini, (certo purificato da quelle che appaiono le sue reali improprietà e da tutte le permanenti e ragionevoli cause di avversione o di disgusto), perché proprio essi comunicano continuamente con le cose migliori, dalle quali proviene originariamente la parte migliore della lingua, e anche perché, a causa della loro posizione sociale e della uniformità e ristrettezza dei loro rapporti interpersonali, soggiacendo in minor misura all’azione della vanità sociale, essi comunicano i loro sentimenti e le loro idee con espressioni semplici e non elaborate. (…) Le poesie di questo volume si distingueranno almeno per un elemento, cioè per il fatto che ciascuna di esse ha un nobile intento. Non dico d’aver ogni volta cominciato a scrivere con un chiaro progetto compiutamente delineato, ma credo che la mia propensione meditativa abbia a tal punto plasmato i miei sentimenti, che la mia descrizione di quegli oggetti che suscitano questi intensi sentimenti recherà con sé, assieme ad essi, un intento. Se in ciò mi sbaglio ho allora ben pochi diritti di chiamarmi un poeta. Tutta la buona poesia è infatti spontaneo traboccare di forti emozioni, ma benché ciò sia vero, nessuna poesia di un qualche valore fu mai scritta su un qualsivoglia argomento se non da un autore che, dotato di una sensibilità organica superiore al comune, avesse anche pensato a lungo e profondamente. Le nostre ininterrotte effusioni di sentimento sono infatti modificate e guidate dai nostri pensieri, che sono invero i rappresentanti di tutti i nostri passati sentimenti. (…) Dopo questo lungo discorso sui temi e sugli scopi di queste poesie, chiedo al lettore di poter informarlo di alcune particolarità che si riferiscono al loro stile, per non essere accusato, tra le tante cose, di aver fatto ciò che non ho mai cercato di fare. Ad eccezione di pochissimi esempi, il lettore non troverà personificazioni di idee astratte in questo volume. Non che io intenda criticare le personificazioni: esse possono essere certo adatte a taluni generi poetici, ma in queste poesie mi sono proposto di imitare, e per quanto mi è stato possibile di adottare, il linguaggio proprio degli uomini, e non penso che tali personificazioni facciano parte naturale di questo linguaggio. Voglio che il lettore rimanga in compagnia della carne e del sangue, convinto che così facendo posso meglio interessarlo. Ciò non significa affermare che altri poeti che battono strade diverse lo interessino meno: non voglio interferire con i loro propositi, voglio solo preferirne uno diverso e tutto personale. Si troveranno inoltre ben pochi esempi in questo libro di quella che viene normalmente chiamata « dizione poetica »: mi sono sforzato di evitarla tanto quanto altri poeti si sforzano di adottarla, e ho fatto questo per la ragione già detta, che è di avvicinare la mia lingua a quella degli uomini, e poi perché il piacere che mi sono riproposto di comunicare è di una natura molto differente da quello che molti suppongono lo scopo primario della poesia.
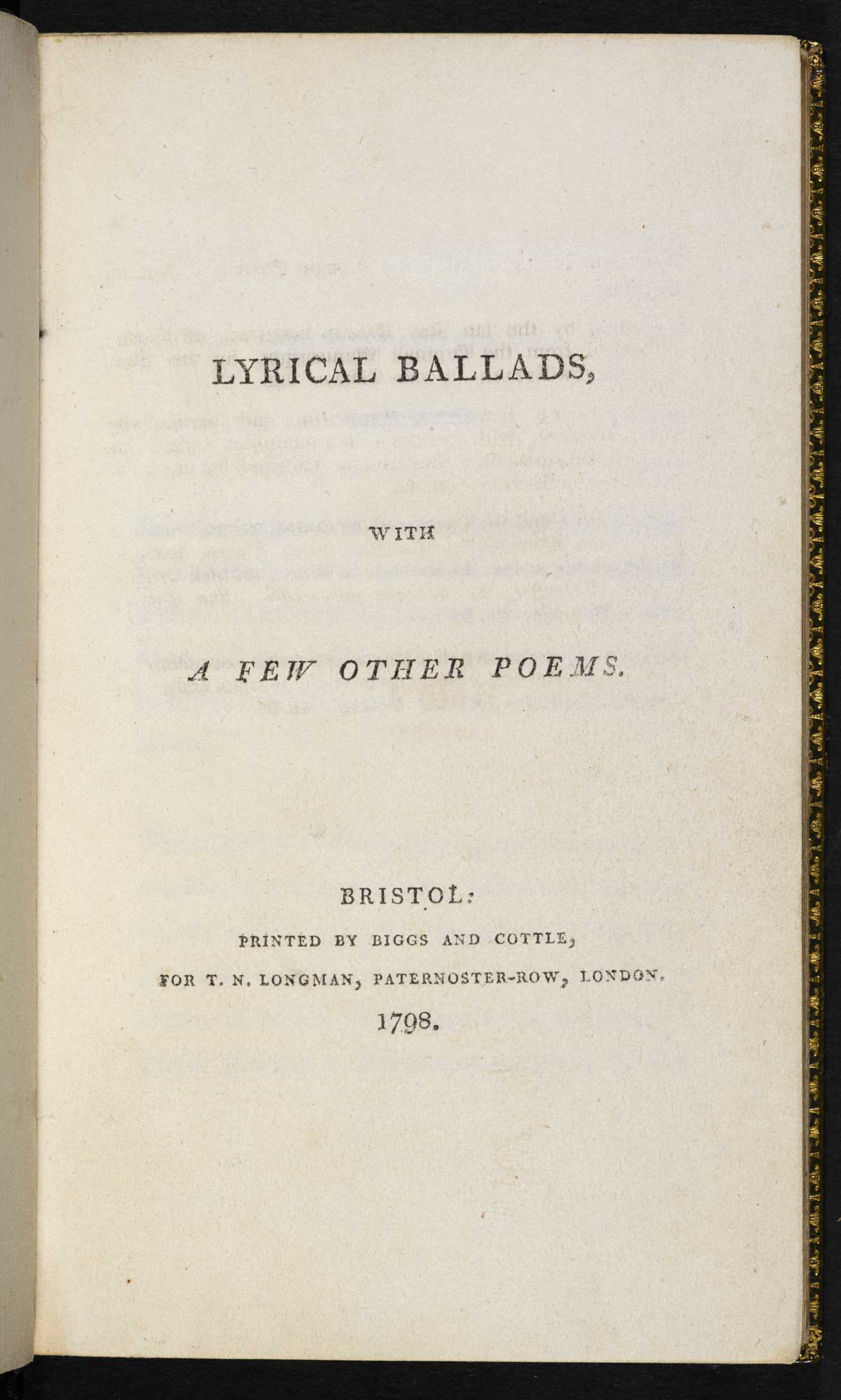
E’ evidente che il testo di Wordsworth affronti il tema fondamentale del romanticismo e non solo quell’inglese: nel momento in cui egli afferma di voler “rendere interessanti gli avvenimenti di tutti i giorni“, afferma l’idea di una poesia anticlassica che pertanto abbia come punto di riferimento la realtà quotidiana. Ma compito del poeta non è quella di raffigurarla, ma di “leggerla” con parole dettate dall’emozione, dall’interiorità, per questo esse cercheranno di dare una visione “simbolica” della realtà stessa perché saranno frutto dell’esplosione dell’interiorità trasfigurata in parola; da qui la ricerca di una naturalità e quindi di una semplicità del lessico poetico in cui debba trasparire “il sangue e la carne del poeta” che, in quanto poeta, dovrà essere in grado di toccare “il sangue e la carne del lettore”.
Samuel Taylor Coleridge nasce nel 1772 e come il suo amico Wordsworth, condivide, in gioventù, l’idea di libertà sbandierata dalla Rivoluzione francese. Sposatosi nel 1794, insieme alla moglie nel 1880 si trasferisce con la moglie e Wordsworth nel Keswick, nel distretto dei laghi”. Si ammala e diventa dipendente dall’oppio: sotto l’effetto della droga scrive il Kubla Khan, poema visionario, ma non è lontano da esso nemmeno il suo capolavoro The rime of ancient mariner (La ballata del vecchio marinaio), in cui si narra come un vecchio marinaio, che ha ucciso senza motivo un misterioso albatro che gli faceva da guida, sia condannato a viaggiare in eterno, come l’ebreo errante, raccontando la vicenda che ha causato il naufragio e la morte dell’equipaggio della sua nave e la propria condanna senza fine.
La produzione poetica di Coleridge possiamo definirla maggiormente elaborata, da un punto di vista contenutistico, rispetto a quella di Wordsworth; già nel sua opera più importante il poeta inglese aveva dato sfogo ad ardite simbologie che mettevano a dura prova la capacità del lettore; più diretta è invece la sua produzione lirico-meditativa, che troviamo presente nella pubblicazione delle Lyrical Ballads:
FROST AT MIDNIGHT
The Frost performs its secret ministry,
Unhelped by any wind. The owlet’s cry
Came loud—and hark, again! loud as before.
The inmates of my cottage, all at rest,
Have left me to that solitude, which suits
Abstruser musings: save that at my side
My cradled infant slumbers peacefully.
‘Tis calm indeed! so calm, that it disturbs
And vexes meditation with its strange
And extreme silentness. Sea, hill, and wood,
This populous village! Sea, and hill, and wood,
With all the numberless goings-on of life,
Inaudible as dreams! the thin blue flame
Lies on my low-burnt fire, and quivers not;
Only that film, which fluttered on the grate,
Still flutters there, the sole unquiet thing.
Methinks, its motion in this hush of nature
Gives it dim sympathies with me who live,
Making it a companionable form,
Whose puny flaps and freaks the idling Spirit
By its own moods interprets, every where
Echo or mirror seeking of itself,
And makes a toy of Thought.
But O! how oft,
How oft, at school, with most believing mind,
Presageful, have I gazed upon the bars,
To watch that fluttering stranger ! and as oft
With unclosed lids, already had I dreamt
Of my sweet birth-place, and the old church-tower,
Whose bells, the poor man’s only music, rang
From morn to evening, all the hot Fair-day,
So sweetly, that they stirred and haunted me
With a wild pleasure, falling on mine ear
Most like articulate sounds of things to come!
So gazed I, till the soothing things, I dreamt,
Lulled me to sleep, and sleep prolonged my dreams!
And so I brooded all the following morn,
Awed by the stern preceptor’s face, mine eye
Fixed with mock study on my swimming book:
Save if the door half opened, and I snatched
A hasty glance, and still my heart leaped up,
For still I hoped to see the stranger’s face,
Townsman, or aunt, or sister more beloved,
My play-mate when we both were clothed alike!
Dear Babe, that sleepest cradled by my side,
Whose gentle breathings, heard in this deep calm,
Fill up the intersperséd vacancies
And momentary pauses of the thought!
My babe so beautiful! it thrills my heart
With tender gladness, thus to look at thee,
And think that thou shalt learn far other lore,
And in far other scenes! For I was reared
In the great city, pent ‘mid cloisters dim,
And saw nought lovely but the sky and stars.
But thou, my babe! shalt wander like a breeze
By lakes and sandy shores, beneath the crags
Of ancient mountain, and beneath the clouds,
Which image in their bulk both lakes and shores
And mountain crags: so shalt thou see and hear
The lovely shapes and sounds intelligible
Of that eternal language, which thy God
Utters, who from eternity doth teach
Himself in all, and all things in himself.
Great universal Teacher! he shall mould
Thy spirit, and by giving make it ask.
Therefore all seasons shall be sweet to thee,
Whether the summer clothe the general earth
With greenness, or the redbreast sit and sing
Betwixt the tufts of snow on the bare branch
Of mossy apple-tree, while the night-thatch
Smokes in the sun-thaw; whether the eave-drops fall
Heard only in the trances of the blast,
Or if the secret ministry of frost
Shall hang them up in silent icicles,
Quietly shining to the quiet Moon.

Samuel Taylor Coleridge
Il gelo officia il suo ministero segreto / non aiutato da alcun vento. Il grido della giovane civetta / s’è fatto più alto, ascolta, ancora! alto come prima. / I degenti nella mia casa , tutti riposano, / mi hanno lasciato in questa solitudine / che si addice / alle meditazioni più astruse: tranne che al mio fianco / il mio bambino cullato dorme pacifico. / C’è calma davvero! una calma che disturba / ed irrita la riflessione col suo strano / ed estremo silenzio. Mare, e collina, e bosco, / con tutte le innumerevoli cose che continuano a vivere, / muti come sogni! La sottile fiamma blu / giace nel mio fuoco spento, e non guizza; / solo questa pellicola, che svolazza sulla griglia, / ancora svolazza lì, la sola cosa inquieta. / Credo che il suo movimento in questo silenzio della natura / le dia oscure corrispondenze con me che vivo, / facendone una forma amica / i cui minuscoli battiti e i capricci lo Spirito ozioso / interpreta secondo i suoi umori, ovunque / cercando eco o specchio di se stesso, e fa del pensiero giocattolo. // Ma, oh! / quante volte, quante volte, a scuola, con la più fiduciosa mente, piena di presagi, ho fissato le sbarre, / per vedere questo fluttuante straniero! E quante volte / con le labbra socchiuse/ avevo già sognato / il mio dolce luogo natale, e il vecchio campanile, / le cui campane, sola musica del povero, suonavano / da mattino a sera, in tutto il caldo giorno di mercato, / così dolcemente che mi agitavano e possedevano / con un selvaggio piacere, giungendo al mio orecchio / ancor più come articolati suoni delle cose a venire! / Così stavo a occhi aperti, Finché le placide cose, sognavo, mi cullavano nel sonno, / e il sonno prolungava i miei sogni! / E così rimuginavo tutto il mattino seguente, / spaventato dal viso severo del precettore, il mio occhio / fissato con finta attenzione sul mio libro che scivolava: / solo che se la porta si apriva a mezzo, / ed io gettavo / uno sguardo affrettato, e ancora il mio cuore sussultava, / perché ancora speravo di vedere il volto dello straniero / cittadino / o zia, o la sorella più amata/ la mia compagna di giochi / quando eravamo vestiti uguali! // Caro bambino che dormi cullato al mio fianco, / il cui respiro gentile, udito in questa profonda calma / riempie i vuoti sparpagliati, / e le momentanee pause del pensiero! / Il mio bellissimo bambino! Mi fa fremere il cuore / di tenera gioia il guardarti così, / e pensare che tu imparerai molte altre cose, / ed in molti altri scenari! Poiché io sono stato educato / nella grande città, chiuso in oscuri chiostri / e non vedevo nulla di bello tranne il cielo e le stelle. / Ma tu, bambino mio! / Vagherai come la brezza / per laghi e spiagge, sotto le rupi / di antichi monti, e sotto le nubi, / che riproducono nella loro massa laghi e spiagge / e rupi montane: così tu vedrai e sentirai / le belle forme e i suoni intellegibili / di questo eterno linguaggio che il tuo Dio / emette, che dall’eternità insegna / se stesso in tutto, e tutte le cose in se stesso. / Grande maestro dell’universo! Lui modellerà il tuo spirito / e dando forma esso chiede. // Perciò ogni stagione sarà dolce per te, / sia che l’estate rivesta tutta la terra, / di verde o che il pettirosso si posi e canti / tra i fiocchi di neve sul ramo spoglio / del melo molle di muschio, mentre il vicino tetto di paglia / per disgelo fumiga al sole, sia che sgrondino gocciole / udite soltanto nella tregua della bufera / o che il segreto ministero del gelo / le sospenda in silenti ghiaccioli / quieti scintillando alla quieta luna.
Possiamo dividere in quattro parti corrispondenti alle stanze di cui è composto:
- Il poeta è seduto a fianco di Hartley, suo secondo figlio, mentre dorme. Fuori il gelo, all’interno il fuoco morente di un camino e intorno solo silenzio. La mente comincia a vagare attraverso le bellezze del mondo naturale e nel camino una scheggia che guizza e quindi vive allo stesso modo del pensiero del poeta.
- Il dualismo si ricrea nell’immaginazione riandando a lui bambino, giovane scolaro, che, disattento, riandava al rumore del paese, alle campane, al mercato e temeva lo sguardo severo del maestro di fronte alla sua “svagatezza”; a aspettava con ansia l’arrivo di uno zio o di una sorella che, infine, lo portasse via
- Anche il suo bambino imparerà: ma non nel chiuso di una città, ma all’aperto dove potrà immergersi nelle spirito creativo di Dio attraverso il pensiero che non solo sarà modellato, ma modellerà lui stesso il creato;
- Per questo il mondo sarà a lui benigno in ogni stagione e in ogni aspetto di cui la natura lo rivestirà.

the redbreast sit and sing / Betwixt the tufts of snow on the bare branch
il pettirosso si posi e canti / tra i fiocchi di neve sul ramo spoglio
Il testo di Coleridge ci offre il suo contributo per una definizione dell’estetica romantica: si tratta cioè della sua concezione di imagination (immaginazione) come potere creativo della poesia, distinta dalla fancy (fantasia). Per lui esistono due tipi di immaginazione: l’immaginazione primaria, cioè la facoltà creativa alla base dell’atto della percezione, ripetizione dell’atto divino della creazione; l’immaginazione secondaria, o poetica, che può modificare o ricreare la creazione di Dio usando i dati della percezione in nuovi rapporti, forme e schemi. La mente non solo è attiva, come dimostra l’immaginazione primaria, ma anche creativa di una nuova realtà.
Ora essendo l’immaginazione secondaria individuale, non può imitare fedelmente il mondo ma utilizzerà proprie categorie di pensiero; per questo due individui non potranno mai avere la stessa visione del mondo, che sarà sempre unica e originale. Questa concezione e definizione dell’immaginazione era sicuramente debitrice a Kant e ai filosofi idealisti Fichte e Schelling.
Nella letteratura inglese si suole indicare come poeti della seconda generazione romantica coloro i quali sono accumunati soprattutto da uno atteggiamento titanico e ribelle che li coinvolge non solo letterariamente ma anche biograficamente.
George Gordon Byron nasce nel 1778 da un aristocratico piuttosto stravagante, facendo trascorrere al giovane figlio un’infanzia non proprio felice. Sin da giovane si dedica alla letteratura, ma le prime opere non riescono ad ottenere il successo sperato. Insofferente verso la ristretta società inglese comincia a viaggiare fermandosi per più di un anno in Spagna ed in Oriente. Al ritorno pubblica Childe Harold’s pilgrimage (Il pellegrinaggio del giovane Aroldo) opera che lo rende celebre. Costretto ad abbandonare l’Inghilterra (si parla di un rapporto incestuoso con la sorella, che determinò anche la fine del suo matrimonio, celebrato un anno prima) lo porta in Italia, dove aggiunse altre parti al suo capolavoro. Scrisse altre opere di minore importanza, ma fu viceversa importante il suo impegno per l’indipendenza greca; partito per combattere contro l’impero Ottomano, morì di febbri a Missoloungi (comune della Grecia meridionale).
Aroldo, dopo una lunga vita di piaceri, intraprende un viaggio che lo porta dal Portogallo al Giura, dopo aver visitato la Spagna, Albania e Belgio. Esule volontario e ribelle appassionato, di volta in volta egli medita sulle situazioni e le memorie che i vari luoghi gli suggeriscono: la triste condizione di schiavitù in cui versa la Grecia, Napoleone a Waterloo, Rousseau e Jolie. Nel quarto canto il poeta dimessa la funzione del pellegrino parla in prima persona dell’Italia e dei suoi grandi: da Petrarca a Boccaccio, da Tasso a Scipione e Rienzi, contrapponendo il passato storico e splendente al presente indegno.
L’EROE ROMANTICO
But soon he knew himself the most unfit
Of men to herd with Man; with whom he held
Little in common; untaught to submit
His thoughts to others, though his soul was quell’d
In youth by his own thoughts; still uncompell’d,
He would not yield dominion of his mind
To spirits against whom his own rebell’d;
Proud though in desolation; which could find
A life within itself, to breathe without mankind.
Where rose the mountains, there to him were friends;
Where roll’d the ocean, thereon was his home;
Where a blue sky, and glowing clime, extends,
He had the passion and the power to roam;
The desert, forest, cavern, breaker’s foam,
Were unto him companionship; they spake
A mutual language, clearer than the tome
Of his land’s tongue, which he would oft forsake
For Nature’s pages glass’d by sunbeams on the lake.
But in Man’s dwellings he became a thing
Restless and worn, and stern and wearisome,
Droop’d as a wild-born falcon with clipt wing,
To whom the boundless air alone were home:
Then came his fit again, which to o’ercome,
As eagerly the barr’d-up bird will beat
His breast and beak against his wiry dome
Till the blood tinge his plumage, so the heat
Of his impeded soul would through his bosom eat.
Self-exil’d Harold wanders forth again,
With nought of hope left, but with less of gloom;
The very knowledge that he lived in vain,
That all was over on this side the tomb,
Had made Despair a smilingness assume,
Which, though ’twere wild, – as on the plunder’d wreck
When mariners would madly meet their doom
With draughts intemperate on the sinking deck,
Did yet inspire a cheer, which he forbore to check.
 Lord Byron
Lord Byron
Ma si riconobbe presto come il meno adatto / tra gli uomini a entrare nel gregge dell’Uomo, col quale ebbe / poco in comune; incapace di sottoporre / i suoi pensieri ad altri, sebbene la sua anima fosse soffocata / in giovinezza dai suoi stessi pensieri; spontaneo ancora, / non voleva concedere il dominio della sua mente / a spiriti a cui il suo si ribellava; / orgoglioso nella sua solitudine, sapeva trovare / una vita in se stesso, per esistere fuori dall’umano. // Dove si elevano i monti, là aveva amici; / dove rombava l’oceano, là era la sua dimora; / dove un cielo s’offre azzurro, e un clima raggiante, / sentiva la passione e la forza di girovagare; / il deserto, la foresta, la caverna, la schiuma dei frangenti / gli facevano compagnia; parlavano / un linguaggio comune, più limpido del volume / della lingua della sua terra, a cui spesso rinunciava / per le pagine della Natura dai raggi del sole riflesse sul lago. // […] // Ma nella dimora dell’Uomo divenne una cosa / irrequieta e estenuata, e severo e tedioso, / disperato come un falcone nato libero che si spezzi le ali // al quale solo l’aria illimitata fosse dimora: // gli tornò allora quel parossismo e per superarlo, // come l’uccello in gabbia suole battere con ardore / il petto e il rostro contro la volta metallica / finché il sangue non gli lorda il piumaggio, così la collera / della sua anima reclusa gli devastava il petto. // Aroldo esule volontario vagabonda ancora, / di ogni speranza privo, ma con minore tristezza; / la stessa consapevolezza di vivere invano, / giacché tutto era compiuto al di qua della tomba, / aveva fatto assumere alla Disperazione un’aria sorridente, / sebbene fosse feroce – come sul relitto saccheggiato / quando i marinai resi folli vanno incontro al loro destino / con sorsi sfrenati sul ponte che affonda – / pure ispirava un’allegrezza, che lui si asteneva dal contenere.
Analizziamo il passo attraverso l’analisi di Barbari-Squarotti:
- Un Romanticismo aristocratico: nella prima strofa, Byron offre un ritratto di Aroldo che vive da solo, separato dal gregge dell’Uomo. Orgoglioso, Aroldo vive nella tipica condizione di isolamento dell’individuo romantico, già prefigurata da Alfieri in Italia, ma ne accentua un aspetto: il disprezzo verso i propri simili, espresso attraverso il termine gregge.
- La natura amica: nella seconda strofa, Byron rivela i veri amici e interlocutori dell’uomo romantico: la natura nei suoi paesaggi più solitari ed estremi (i monti, l’oceano, il deserto, la foresta, la caverna). Prevale qui il tipico tema romantico della solitudine nella natura, che rispecchia le passioni umane. Da notare la metafora del libro della natura, le cui pagine sono paesaggi riflessi nell’acqua del lago.
- Byron e Baudelaire: nella strofa successiva, Byron descrive la condizione di sofferenza dell’eroe romantico nella vita comune. Egli soffre nella quotidianità; la sua condizione è espressa dalla similitudine dell’uccello in gabbia che si scaraventa contro le sbarre fino a sanguinare (Charles Baudelaire, precursore del Decadentismo, dopo la seconda metà del secolo, nella raccolta I fiori del male, attribuirà una condizione simile all’albatro, simbolo del poeta). La soluzione è fuggire, vagabondare per il mondo, sempre oppresso e infelice, per evitare la disperazione, personificata con un sorriso feroce e con il paragone dei marinai che si ubriacano – per dimenticare l’angoscia – sulla nave che affonda, simbolo dell’esistenza umana.
 Joseph Mallord William Turner – Childe Harold’s Pilgrimage
Joseph Mallord William Turner – Childe Harold’s Pilgrimage
Percy Bysshe Shelley nasce nel 1792 da una ricca e importante famiglia inglese, con la quale ruppe a seguito di un matrimonio con la sedicenne Harriet Westbrook, senza mai più riallacciare i rapporti. Si lega a Godwin, di cui sposerà la figlia, dopo il suicidio di Harriet, accostandosi così a teorie piuttosto razionali ed ateisti. Si trasferisce dapprima in Svizzera, dove incontrerà Byron, quindi in Italia, pubblicando le sue opere più importanti, come I Cenci, o il dramma lirico Il Prometeo incatenato. Muore annegato nel golfo di La Spezia, di ritorno di una gita in barca, nel 1822.
 Alfred Clint: Percy Bysshe Shelley
Alfred Clint: Percy Bysshe Shelley
L’Ode al vento occidentale, una delle liriche più importanti dell’intero romanticismo europeo, viene pubblicata postuma.
ODE TO THE WEST WIND
I
O wild West Wind, thou breath of Autumn’s being,
Thou, from whose unseen presence the leaves dead
Are driven, like ghosts from an enchanter fleeing,
Yellow, and black, and pale, and hectic red,
Pestilence-stricken multitudes: O thou,
Who chariotest to their dark wintry bed
The winged seeds, where they lie cold and low,
Each like a corpse within its grave, until
Thine azure sister of the Spring shall blow
Her clarion o’er the dreaming earth, and fill
(Driving sweet buds like flocks to feed in air)
With living hues and odours plain and hill:
Wild Spirit, which art moving everywhere;
Destroyer and preserver; hear, oh hear!
II
Thou on whose stream, mid the steep sky’s commotion,
Loose clouds like earth’s decaying leaves are shed,
Shook from the tangled boughs of Heaven and Ocean,
Angels of rain and lightning: there are spread
On the blue surface of thine aëry surge,
Like the bright hair uplifted from the head
Of some fierce Maenad, even from the dim verge
Of the horizon to the zenith’s height,
The locks of the approaching storm. Thou dirge
Of the dying year, to which this closing night
Will be the dome of a vast sepulchre,
Vaulted with all thy congregated might
Of vapours, from whose solid atmosphere
Black rain, and fire, and hail will burst: oh hear!
III
Thou who didst waken from his summer dreams
The blue Mediterranean, where he lay,
Lull’d by the coil of his crystalline streams,
Beside a pumice isle in Baiae’s bay,
And saw in sleep old palaces and towers
Quivering within the wave’s intenser day,
All overgrown with azure moss and flowers
So sweet, the sense faints picturing them! Thou
For whose path the Atlantic’s level powers
Cleave themselves into chasms, while far below
The sea-blooms and the oozy woods which wear
The sapless foliage of the ocean, know
Thy voice, and suddenly grow gray with fear,
And tremble and despoil themselves: oh hear!
IV
If I were a dead leaf thou mightest bear;
If I were a swift cloud to fly with thee;
A wave to pant beneath thy power, and share
The impulse of thy strength, only less free
Than thou, O uncontrollable! If even
I were as in my boyhood, and could be
The comrade of thy wanderings over Heaven,
As then, when to outstrip thy skiey speed
Scarce seem’d a vision; I would ne’er have striven
As thus with thee in prayer in my sore need.
Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud!
I fall upon the thorns of life! I bleed!
A heavy weight of hours has chain’d and bow’d
One too like thee: tameless, and swift, and proud.
V
Make me thy lyre, even as the forest is:
What if my leaves are falling like its own!
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep, autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou, Spirit fierce,
My spirit! Be thou me, impetuous one!
Drive my dead thoughts over the universe
Like wither’d leaves to quicken a new birth!
And, by the incantation of this verse,
Scatter, as from an unextinguish’d hearth
Ashes and sparks, my words among mankind!
Be through my lips to unawaken’d earth
The trumpet of a prophecy! O Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind?
I. O tu vento selvaggio occidentale, alito / della vita d’Autunno, oh presenza invisibile da cui / le foglie morte sono trascinate, come spettri in fuga / da un mago incantatore, gialle e nere, / pallide e del rossore della febbre, moltitudini / che il contagio ha colpito: oh tu che guidi / i semi alati ai loro letti oscuri, / dell’inverno in cui giacciono freddi e profondi / come una spoglia sepolta nella tomba, / finché la tua azzurra sorella della Primavera / non farà udire la squilla sulla terra in sogno / e colmerà di profumi e di colori vividi / il colle e la pianura, nell’aria i lievi bocci conducendo / simili a greggi al pascolo; oh Spirito selvaggio, / tu che dovunque t’agiti, e distruggi e proteggi: ascolta, ascolta! // II. Tu nella tua corrente, nel tumulto / del cielo a precipizio, le nuvole disperse / sono spinte qua e là come foglie appassite / scosse dai rami intricati del Cielo e dell’Oceano, / angeli della pioggia e del fulmine, e si spargono / là sull’azzurra superficie delle tue onde d’aria / come la fulgida chioma che s’innalza / sopra la testa d’una fiera Monade, dal limite / fioco dell’orizzonte fino alle altezze estreme dello zenit, / capigliatura della tempesta imminente. Canto funebre / tu dell’anno che muore, al quale questa notte che si chiude / sarà la cupola del suo sepolcro immenso, sostenuta a volta, / da tutta la potenza riunita dei vapori / dalla cui densa atmosfera esploderà una pioggia / nera con fuoco e grandine: oh ascolta! // III. Tu che svegliasti dai loro sogni estivi / le acque azzurre del Mediterraneo, dove / si giaceva cullato dal moto dei flutti cristallini / accanto a un’isola tutta di pomice del golfo / di Baia e vide in sonno gli antichi palazzi e le torri / tremolanti nel giorno più intenso dell’onda, sommersi / da muschi azzurri e da fiori dolcissimi al punto / che nel descriverli il senso viene meno! / Tu per il cui sentiero la possente / superficie d’Atlantico si squarcia / e svela abissi profondi dove i fiori / del mare e i boschi fradici di fango, che indossano / le foglie senza linfa dell’Oceano, conoscono / la tua voce e si fanno all’improvviso grigi / per la paura e tremano e si spogliano: oh, ascolta! // IV. Fossi una foglia appassita che tu potessi portare; / fossi una rapida nuvola per inseguire il tuo volo; / un’onda palpitante alla tua forza, e potessi / condividere tutto l’impulso della tua potenza, / soltanto meno libero di te, oh tu che sei incontrollabile! / Potessi essere almeno com’ero nell’infanzia, compagno / dei tuoi vagabondaggi alti nei cieli, come quando / superare il tuo rapidi passo celeste / sembrava appena un sogno; non mi rivolgerei / a te con questa preghiera nella mia dolente / necessità. Ti prego, levami come un’onda, come / una foglia o una nuvola. Cado / sopra le spine della vita e sanguino! Un grave / peso di ore ha incatenato, incurvato / uno a te troppo simile: indomito, veloce ed orgoglioso. // V. Fa’ di me la tua cetra, com’è della foresta; che cosa importa se le mie foglie cadono / come le sue! Il tumulto / delle tue forti armonie leverà a entrambi un canto / profondo e autunnale, e dolcemente triste. / Che tu sia dunque il mio spirito, o Spirito fiero! / Spirito impetuoso, che tu sia me stesso! / Guida i miei morti pensieri per tutto l’universo / come foglie appassite per darmi una nascita nuova! / E con l’incanto di questi miei versi disperdi / come da un focolare non ancora spento, / le faville e le ceneri, le mie parole tra gli uomini! / E alla terra che dorme, attraverso il mio labbro / tu sia la tromba d’una profezia! Oh, Vento, / se viene l’Inverno, potrà la Primavera esser lontana?
Il brano di Shelley può essere strutturato in due parti distinte, corrispondenti la prima alle stanze I – III, l’altra alle due rimanenti. Ciò è chiaramente indicato dal finale del distico di ogni stanza, il cui verso si rivolge al vento usando la seconda persona invitandolo ad ascoltare la voce del poeta che canta la sua forza tumultuosa e distruttrice, l’energie vitale che lo contraddistingue e che dà vita al grandioso mutare del tempo. Nelle ultime due stanze il poeta desidera diventare esso stesso voce, come il vento, capace di emularne la forza per la preparazione di un’eterna primavera. Sembra quasi che Shelley voglia metaforizzare con il vento i moti rivoluzionari che in quel periodo attraversavano l’Europa per preparare un futuro di libertà indicato con la domanda retorica in cui seppur lontana verrà la Primavera, cioè la libertà per i popoli.
 Herny Raeburn : Sir Walter Scott
Herny Raeburn : Sir Walter Scott
Non si può terminare un discorso sul romanticismo inglese senza parlare della narrativa per la eco che esso ebbe sul futuro del romanzo in Europa: basti pensare che il nostro I promessi sposi, nasce dalla suggestione che Manzoni subì dalla lettura dell’Ivanhoe di Walter Scott.
Walter Scott (1771- 1832) è un scrittore scozzese, in principio dedito all’attività dell’avvocatura. Spinto da amore per la letteratura tedesca, dapprima si fece traduttore, conoscendone bene la lingua, e quindi scrivendo poemi narrativi ottenendo grande successo. Grazie a ciò divenne ricco, ma con abile capacità imprenditoriale seppe rinnovarsi quando il suo fare letterario venne oscurata dalla presenza di Byron; si dedicò pertanto alla narrativa, allontanandosi dal romanzo gotico e, inserendo l’idea di avventura già presente nell’opera di Defoe, in quello che verrà definito romanzo storico. La sua opera maggiormente rappresentativa è l’Ivanhoe (1820), che rappresenta appieno le istanze romantiche vigenti allora in Inghilterra e nella stessa Europa.
La vicenda si colloca nell’Inghilterra del XII secolo sullo sfondo dei contrasti tra sassoni e normanni. Wilfred di Ivanhoe, figlio di Cedric, ama lady Rowena, pupilla del padre, e ne riamato. Ma Cedric ha deciso di dare Rowena in moglie ad Athelstane di Coningsburgh per riportare una stirpe sassone sul trono, e perciò bandisce Ivanhoe, legato da amicizia con il re normanno Riccardo Cuor di Leone. Il giovane va crociato al seguito di Riccardo. Ma in assenza del re, Giovanni, suo fratello, usurpa il trono. Al ritorno dei crociati Ivanhoe, al gran torneo di Ashby-de-la-Zouche batte tutti i campioni dell’usurpatore. Ma i nobili normanni lo fanno prigioniero con Cedric e Rowena, Athelstane, la bella Rebecca e il padre di lei Isaac: vengono liberati da re Riccardo e Robin Hood, alla testa di sassoni e fuorilegge. Ivanhoe e Rowena si sposano: Rebecca, che ha sempre amato Ivanhoe, lascia l’Inghilterra col padre.
LA DESCRIZIONE DI GURTH E WAMBA
CAPITOLO I
Il sole stava tramontando su di una erbosa radura di quella foresta che abbiamo citato all’inizio del capitolo*. Centinaia di querce frondose, dal tronco corto e dai grandi rami, che forse avevano visto la marcia trionfale dei soldati romani, allungavano le braccia nodose su un folto tappeto di deliziosa erba verde. In alcuni punti le querce si alternavano ai faggi, agli agrifogli, a un sottobosco di piante diverse, così folto da intercettare i raggi obliqui del sole al tramonto; in altri, le querce si distaccavano le une dalle altre formando quei viali lunghi e spaziosi nel cui intrico l’occhio ama perdersi, mentre l’immaginazione li trasforma in sentieri verso luoghi ancor più selvaggi di silvestre solitudine. Qui i rossi raggi del sole inviavano una luce rotta e incolore che cadeva sui rami spezzati e sui tronchi muschiosi degli alberi, illuminando di macchie brillanti quelle parti di prato che riuscivano a raggiungere. Nel mezzo di questa radura c’era un ampio spazio aperto che sembrava esser stato destinato nei tempi antichi ai riti della superstizione druidica. Infatti, sulla cima di una collinetta, così regolare da sembrare artificiale, restava ancora parte di un cerchio di grosse dimensioni formato da massi rozzi e irregolari. Sette erano ancora eretti, gli altri erano stati spostati dalle loro sedi, probabilmente dallo zelo di qualche convertito al cristianesimo, e giacevano lì vicino o sul fianco della collina. Un solo grosso masso era rotolato fino in fondo e, bloccando il corso di un ruscelletto che scorreva placidamente ai piedi dell’altura, dava origine a un debole mormorio in quel placido e altrimenti silenzioso rivolo d’acqua. Completavano il paesaggio due figure umane che con le loro vesti e il loro aspetto ben si accordavano al carattere rustico e selvaggio tipico a quei tempi delle zone boscose del West-Riding, nello Yorkshire. Il più anziano dei due aveva un aspetto duro, primitivo e selvaggio. Il suo vestito era estremamente semplice: una giacca chiusa, con maniche, di pelle conciata, sulla quale originariamente doveva esserci stato il pelo, ma così consunta che sarebbe stato difficile distinguere dai ciuffi rimasti a quale animale fosse appartenuto. Questo abito primitivo lo copriva dalla gola alle ginocchia e svolgeva contemporaneamente tutte le funzioni di ogni altro capo di vestiario. L’apertura al collo era grande quanto bastava a far passare la testa; se ne poteva dedurre che lo si indossava facendolo scivolare dalla testa e sulle spalle, come una camicia moderna o un’antica cotta di maglia. Dei sandali, legati da lacci di pelle di cinghiale, gli proteggevano i piedi, e una fascia di cuoio sottile era avvolta intorno alle gambe fino al polpaccio, lasciando scoperte le ginocchia all’uso dei montanari scozzesi. Affinché aderisse il più possibile al corpo, la giacca era stretta in vita da una larga cintura di cuoio chiusa da una fibbia di bronzo; a un lato di questa era appesa una sorta di bisaccia e all’altro un corno di montone fornito di un’imboccatura per poterlo suonare. Nella stessa cintura era infilato uno di quei coltelli lunghi, larghi appuntiti e a due tagli, dal manico di corno, che erano fabbricati nella zona e venivano fin da allora chiamati coltelli di Sheffield. L’uomo non portava nulla sulla testa, che era riparata esclusivamente dai folti capelli arruffati, bruciati dal sole a tal punto da apparire di color rosso ruggine in contrasto con la barba piuttosto giallastra che gli cresceva sulle guance. Un’ultima parte del suo abbigliamento resta da descrivere ed è troppo importante per essere tralasciata: un anello di bronzo, simile al collare di un cane, ma senza apertura, ben saldato intorno al collo, abbastanza largo da non impedirgli la respirazione ma sufficientemente stretto da non poter essere tolto salvo che per mezzo di una lima. Su questo strano collare era incisa, in caratteri sassoni, la seguente iscrizione: «Gurth, figlio di Beowulph, è nato schiavo di Cedric di Rotherwood». Accanto a questo guardiano di porci, poiché tale era l’occupazione di Gurth, era seduto su uno dei massi druidici caduti a terra un uomo apparentemente più giovane d’una decina d’anni, il cui abito, sebbene simile nella forma a quello del compagno, era di materiale migliore e di fattura più bizzarra. La giacca era di un brillante color porpora e su di essa si era cercato di dipingere grottesche decorazioni in diverse tinte. Oltre alla giacca portava un corto mantello che gli arrivava appena a metà coscia, di stoffa rossa, pieno di macchie, bordato in giallo brillante; e poiché poteva passarlo da una spalla all’altra o, volendo, avvolgerselo intorno l’ampiezza a confronto della scarsa altezza ne faceva un indumento alquanto stravagante. Sulle braccia portava dei sottili braccialetti d’argento e al collo un collare dello stesso metallo con la scritta: «Wamba, figlio di Witless, è schiavo di Cedric di Rotherwood».
* Il romanzo viene introdotto da una premessa nella quale l’autore informa il lettore del luogo in cui si svolge la vicenda (la foresta presso Sheffield, nello Yorkshire)
Il testo presentato offre la tecnica con cui Scott opera per la stesura del suo romanzo, la fusione tra romance (“narrazione fittizia in prosa o in versi, il cui interesse s’impernia su fatti inconsueti e meravigliosi”) e novel (“narrazione fittizia che differisce dal romance perché i fatti vengono adattati al corso ordinario delle vicende umane e alla moderna situazione della società”). Tale fusione erano state presentate in un saggio dello stesso scrittore scozzese nel Saggio sul romance del 1824 e da cui abbiamo tratto le citazioni. Tale tecnica richiede uno scrittore onnisciente in grado di guidare il lettore non solo nei meandri della storia in sé, ma anche nella descrizione del modo di vestire e di pensare dei personaggi. In questo passo colpisce la capacità analitica in cui il modo con cui l’autore ci presenta il modo di vestire dei due, voglia offrirci anche il loro quadro sociale e “storico”.
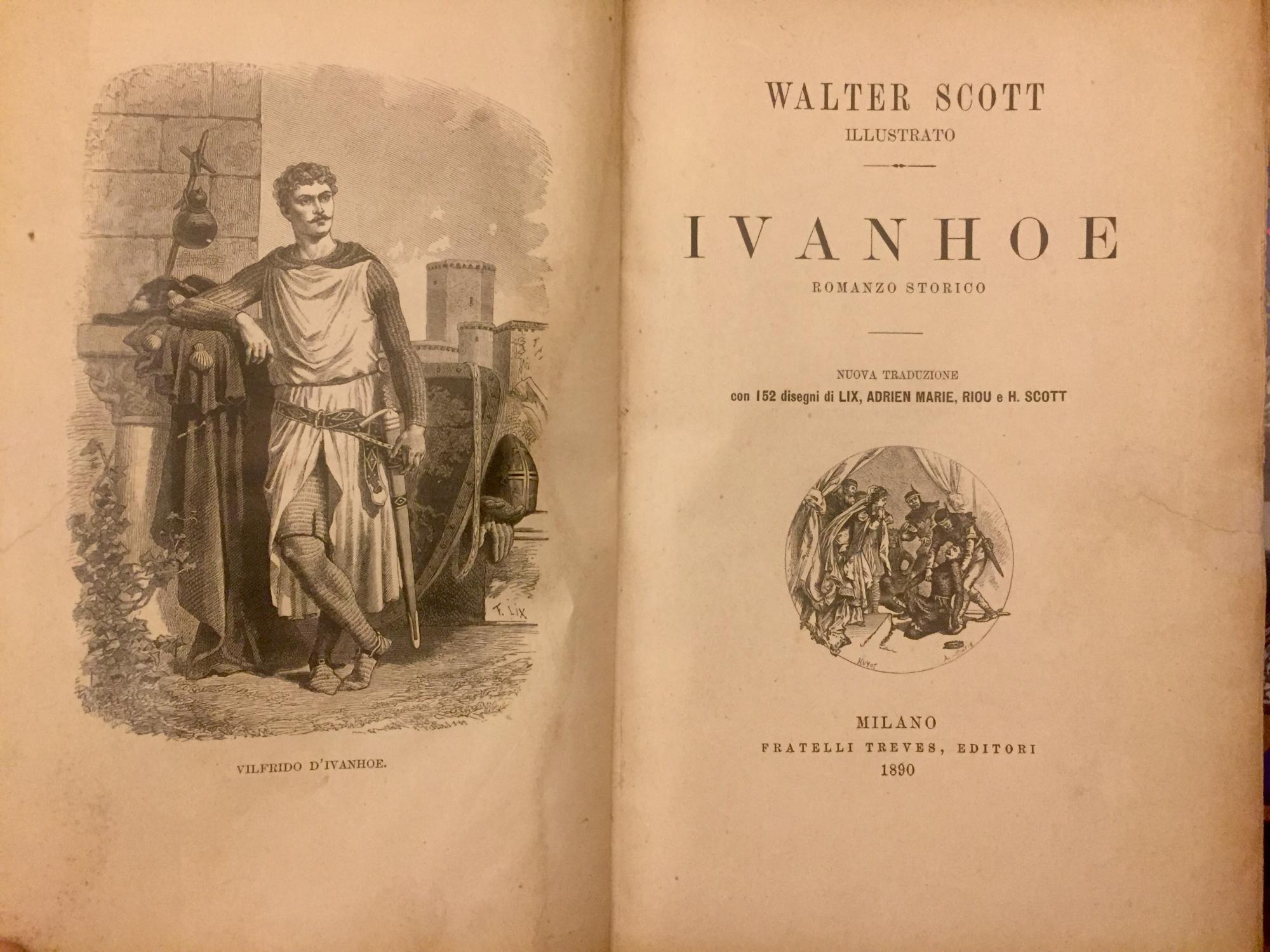 Edizione italiana dell’Ivanhoe
Edizione italiana dell’Ivanhoe
IL TORNEO
CAPITOLO XII
Non appena Rowena fu seduta, uno squillo di trombe parzialmente soffocato dalle grida della folla, salutò la sua nuova dignità. Intanto il sole caldo e luminoso splendeva sulle lucenti armature dei cavalieri delle due fazioni che si affollavano ai lati opposti del recinto e discutevano vivacemente sul miglior modo di condurre il combattimento e di sostenere lo scontro.
Poi gli araldi ordinarono il silenzio per ripetere le regole del torneo. Queste erano state calcolate in modo da ridurre in parte i pericoli del combattimento, precauzione tanto più necessaria in quanto lo scontro si sarebbe svolto con spade affilate e lance appuntite.
Ai campioni era proibito di usare la spada di punta e si dovevano limitare a menare colpi. Fu annunciato che potevano usare la mazza o l’ascia di guerra a piacere, ma il pugnale era un’arma proibita. Un cavaliere disarcionato poteva riprendere il combattimento a piedi con qualsiasi altro della fazione avversaria che si trovasse nelle stesse condizioni, ma i cavalieri a cavallo, in questo caso, non dovevano attaccarlo. Quando un cavaliere riusciva a spingere l’avversario ai confini del campo fino a fargli toccare la palizzata col corpo o con le armi, questi era obbligato a dichiararsi vinto e la sua armatura e il suo cavallo passavano a disposizione del vincitore. A un cavaliere che fosse stato così sopraffatto non era più concesso di prendere parte alla lotta. Se un combattente veniva buttato a terra e non era in grado di rialzarsi, il suo scudiero o paggio poteva entrare nel campo e portar fuori dalla mischia il padrone, ma in tal caso il cavaliere era considerato vinto e le sue armi e il suo cavallo erano dichiarati confiscati. Il combattimento doveva aver termine non appena il principe Giovanni avesse abbassato il bastone di comando, questa precauzione veniva di solito presa per evitare l’inutile spargimento di sangue causato dal protrarsi di uno sport tanto violento. Il cavaliere che avesse infranto le regole del torneo o comunque trasgredito quelle dell’onore cavalleresco poteva essere privato delle armi ed essere messo, con lo scudo rovesciato, a cavalcioni della palizzata ed esposto al pubblico disprezzo come punizione per un comportamento indegno di un cavaliere. Gli araldi conclusero queste avvertenze esortando ogni buon cavaliere a fare il suo dovere e a meritare il favore della regina della bellezza e dell’amore.
Fatto questo annuncio, gli araldi ritornarono ai loro posti. I cavalieri, entrando in un lungo corteo dai due lati del campo si disposero in doppia fila, gli uni esattamente di fronte agli altri, con il capo di ciascuna fazione al centro della prima fila; questi tuttavia andarono a occupare i loro posti solo dopo aver sistemato con cura le file del proprio gruppo e aver controllato la posizione di ciascuno.
Era una scena stupenda e al tempo stesso inquietante vedere tanti valorosi cavalieri a cavallo di ottimi destrieri e splendidamente armati, pronti ad affrontare uno scontro così formidabile, seduti sulle loro selle come tanti pilastri di ferro, in attesa del segnale d’inizio con lo stesso ardore dei loro generosi cavalli che, nitrendo e scalpitando, davano segni d’impazienza.
I cavalieri tenevano ancora alzate le loro lunghe lance, e le punte lucenti di queste scintillavano al sole mentre le banderuole di cui erano ornate sventolavano sopra le piume degli elmi. Rimasero in questa posizione mentre i marescialli di campo ispezionavano le file con la massima attenzione per controllare che ciascuna fazione avesse né più né meno del numero di uomini prestabilito. Il conteggio risultò esatto. Allora i marescialli si ritirarono dal campo e William de Wyvil con voce tonante pronunciò le parole del segnale: Laissez aller! Mentre parlava le trombe squillarono, le lance dei campioni furono immediatamente abbassate e messe in resta, gli sproni furono conficcati nei fianchi dei cavalli, e le due prime file di ciascun gruppo si slanciarono l’una contro l’altra a gran galoppo scontrandosi a metà campo con un urto il cui frastuono fu sentito a un miglio di distanza. La fila successiva delle due fazioni avanzò a passo più lento per aiutare i cavalieri che erano stati sopraffatti e per approfittare del successo dei vincitori. Non fu possibile vedere immediatamente i risultati dello scontro poiché la polvere sollevata dal calpestio di tanti cavalli aveva offuscato l’aria, ci volle un minuto perché gli ansiosi spettatori potessero vederne l’esito. Quando il campo divenne visibile, metà dei cavalieri di ciascun gruppo erano a terra disarcionati: alcuni dall’abilità della lancia del loro avversario, altri dalla mole e dalla potenza dell’antagonista che aveva gettato a terra cavallo e cavaliere alcuni giacevano sul terreno come se non dovessero rialzarsi mai più, altri si erano rimessi in piedi e affrontavano avversari nelle stesse condizioni, altri ancora, da entrambe le parti, erano feriti in modo tale da non poter proseguire il combattimento e cercavano di fermare il sangue con le sciarpe e di uscire dalla mischia. I cavalieri ancora a cavallo le cui lance si erano quasi tutte spezzate nella violenza dello scontro, si battevano Walter Scott – Ivanhoe 123 www.writingshome.com da presso con le spade, lanciando grida di guerra e scambiandosi colpi, come se l’onore e la vita dipendessero dall’esito del combattimento. La mischia aumentò ulteriormente con l’arrivo della seconda fila di ciascun gruppo che, agendo da riserva, si era precipitata in aiuto dei compagni. I seguaci di Brian de Bois-Guilbert gridavano: «Ah, Beau-séant! Beauséant! Per il Tempio! Per il Tempio!». La fazione avversa gridava in risposta: «Desdichado! Desdichado!», grido di guerra che avevano preso dal motto sullo scudo del loro condottiero.
I campioni si andavano così scontrando con estrema violenza e con alterne fortune, e la marea della battaglia sembrava spostarsi ora verso il lato meridionale ora verso quello settentrionale del campo, a seconda che prevalesse l’una o l’altra fazione. Frattanto il fragore dei colpi e le grida dei combattenti si confondevano paurosamente con gli squilli delle trombe e soffocavano i lamenti di coloro che erano caduti andando a rotolare senza protezione alcuna sotto le zampe dei cavalli. Le splendide armature dei combattenti erano ormai sporche di polvere e di sangue e cedevano sotto i colpi di spada e di ascia. I vivaci piumaggi, strappati dai cimieri, volavano nell’aria come fiocchi di neve. Tutto ciò che era bello ed elegante nell’abbigliamento marziale era scomparso, e quello che ora si vedeva non ispirava altro che terrore o compassione.
Eppure tanta è la forza dell’abitudine che non solo gli spettatori più grossolani che sono naturalmente attratti dagli spettacoli orripilanti, ma anche le dame di rango che affollavano le tribune seguivano il combattimento con eccitato interesse e senza desiderio alcuno di distogliere lo sguardo da uno scenario così terribile. Qua e là, in effetti, capitava di vedere una bella guancia impallidire, di udire un grido soffocato, quando un amante, un fratello o un marito venivano buttati giù da cavallo. Ma in generale le dame incoraggiavano i combattenti non solo battendo le mani e agitando veli e fazzoletti, ma anche esclamando: «Ottima lancia! Buona spada!», allorché qualche buon colpo veniva portato a segno sotto i loro occhi.
Se tale era l’interesse del gentil sesso per questo gioco sanguinario, ancora più comprensibile è quello degli uomini. Si manifestava con forti acclamazioni a ogni mutamento della sorte, e gli occhi di tutti erano così polarizzati sul campo che gli spettatori sembravano essi stessi dare e ricevere i colpi che con tanta abbondanza venivano inferti. E durante ogni pausa si sentiva la voce degli araldi che esclamavano: «Combattete, valorosi cavalieri! L’uomo muore, ma la gloria vive! Combattete! Meglio la morte che la sconfitta! Combattete, valorosi cavalieri! Occhi luminosi osservano le vostre gesta!».
In mezzo alle alterne vicende del combattimento, gli occhi di tutti cercavano di rintracciare i capi delle due fazioni, i quali, nel folto della mischia, incoraggiavano i compagni con la voce e con l’esempio. Entrambi davano grandi prove di coraggio, e né Bois-Guilbert né il cavaliere Diseredato avevano trovato nelle file avversarie un campione che potesse essere loro pari.
Ripetutamente avevano cercato di affrontarsi, spinti da reciproco astio e consapevoli che la caduta dell’altro poteva essere decisiva per la vittoria. Ma la folla e la confusione erano tali che durante la prima parte del combattimento i loro sforzi per incontrarsi erano stati vani, e ripetutamente erano stati separati dalla furia dei seguaci ansiosi di farsi onore misurando la propria forza con il capo della fazione avversaria. Ma quando il campo cominciò a spopolarsi di coloro che, in ciascuna fazione, si erano dichiarati vinti o erano stati spinti ai margini del recinto o erano comunque impossibilitati a continuare la lotta, il Templare e il cavaliere Diseredato si trovarono alla fine di fronte con tutta la furia che un astio mortale unito a una rivalità d’onore può suscitare. Tale era l’abilità di ciascuno nel parare e nel colpire che gli spettatori proruppero in un grido involontario e unanime che esprimeva la loro gioia e la loro ammirazione.
Ma in quel momento la fazione del cavaliere Diseredato stava avendo la peggio; il braccio gigantesco di Front-de-Boeuf da un lato e la forza poderosa di Athelstane dall’altro abbattevano e disperdevano coloro che li affrontavano direttamente. Quasi nello stesso momento parve che entrambi, trovandosi liberi da avversari, decidessero che la cosa migliore per dare un vantaggio decisivo al loro gruppo fosse aiutare il Templare nello scontro con il rivale. Perciò, voltati i cavalli nello stesso istante, il normanno spronò da una parte contro il cavaliere Diseredato e il sassone dall’altra. Sarebbe stato assolutamente impossibile per il cavaliere Diseredato sostenere un attacco così impari e inaspettato se non fosse stato messo in guardia dal grido unanime degli spettatori che non potevano non prendere a cuore un campione esposto a tale svantaggio.
«Attento! Attento! Cavaliere Diseredato!», gridavano tutti, tanto che questi si accorse del pericolo e, dopo aver rifilato un duro colpo al Templare, fece indietreggiare il cavallo in modo da evitare la carica di Athelstane e di Front-de-Boeuf. I due cavalieri, visto il loro tentativo così vanificato, irruppero da opposte direzioni tra l’oggetto del loro attacco e il Templare, rischiando quasi di far scontrare i cavalli prima di poterne frenare la corsa. Quando ne ebbero ripreso il controllo, li fecero voltare, e tutti e tre si unirono nello scopo di abbattere il cavaliere Diseredato.
Nulla avrebbe potuto salvarlo, salvo la forza straordinaria e la mobilità del nobile destriero che aveva vinto il giorno precedente.
Ciò gli fu di grande vantaggio poiché il cavallo di Bois-Guilbert era ferito e quelli di Front-de-Boeuf e di Athelstane erano entrambi sfiniti dal peso dei loro giganteschi padroni, ricoperti da capo a piedi delle armature, e dalle fatiche del giorno precedente. La sua bravura di cavaliere e la destrezza del nobile animale che montava consentirono al cavaliere Diseredato di tenere a bada i tre avversari per alcuni minuti, girandosi e roteando con l’agilità di un falcone in volo tenendo il più possibile separati i nemici, attaccando ora l’uno ora l’altro e menando fendenti con la spada senza rimanere ad attendere quelli a lui diretti. Ma benché il campo risuonasse degli applausi alla sua bravura era evidente che alla fine sarebbe stato sopraffatto, e i nobili che attorniavano il principe Giovanni lo implorarono tutti di abbassare il bastone e di salvare un cavaliere così coraggioso dalla sventura di essere sconfitto dal numero.
«No, per la luce del cielo!», rispose il principe; «questo giovanotto, che nasconde il suo nome e disprezza le nostre offerte d’ospitalità, ha già guadagnato un premio e può ben lasciare il turno agli altri». Ma mentre così parlava, un avvenimento inatteso cambiò le sorti della giornata.
C’era nelle file del cavaliere Diseredato un guerriero in armatura nera, in sella a un cavallo nero di grossa corporatura, alto, forte e potente nell’aspetto quanto il cavaliere che lo montava. Questi, che non aveva alcuna insegna sullo scudo aveva fino a quel momento mostrato scarso interesse per l’esito del combattimento e aveva respinto con apparente facilità gli avversari che l’avevano attaccato, senza tuttavia sfruttare il suo vantaggio e senza assalire nessuno. In poche parole, aveva fino allora recitato la parte dello spettatore piuttosto che quella di partecipante al torneo, fatto che gli aveva procurato da parte del pubblico il nome di Le Noir Fainéant, Il Nero Fannullone.
Improvvisamente, allorché vide il capo della sua fazione tanto duramente attaccato, questo cavaliere sembrò liberarsi dell’apatia e, dando di sprone al cavallo che era ancora fresco, si precipitò in suo aiuto come un fulmine, gridando con voce che sembrava uno squillo di tromba: «Desdichado, alla riscossa!». Appena in tempo, poiché, mentre il cavaliere Diseredato incalzava il Templare, Front-de-Boeuf gli si era avvicinato con la spada alzata. Ma prima che questa scendesse, il Cavaliere Nero gli assestò un colpo in testa che scivolando sul lucido elmo, si abbatté con violenza sul frontale del cavallo, e Front-deBoeuf rotolò a terra insieme al destriero, entrambi tramortiti dalla violenza dell’urto. Poi Le Noir Fainéant girò il cavallo verso Athelstane di Coningsburgh, e, siccome gli si era spezzata la spada nell’incontro con Front-de-Boeuf, strappò di mano al massiccio sassone l’ascia di guerra e, da combattente esperto nell’uso di quest’arma, gli diede un tal colpo sul cimiero che anche Athelstane rimase a terra privo di sensi. Compiuta questa duplice impresa, per la quale fu molto applaudito proprio perché del tutto inaspettata da parte sua, il cavaliere sembrò riprendere lo stato d’indolenza precedente e se ne ritornò lentamente verso il lato settentrionale della lizza lasciando il suo capo ad affrontare come meglio poteva Brian de Bois-Guilbert. Ma la cosa non era più così difficile come prima. Il cavallo del Templare aveva perso molto sangue e cedette alla carica del cavaliere Diseredato. Brian de Bois-Guilbert ostacolato dalle staffe da cui non riusciva a liberare il piede, rotolò sul campo. Il suo avversario saltò a terra, levò la spada fatale sopra la sua testa e gli ordinò di arrendersi. Allora il principe Giovanni, impietosito dalla situazione critica del Templare più di quanto lo fosse stato di fronte a quella del suo rivale, lo salvò dall’umiliazione di dichiararsi vinto abbassando il bastone e mettendo fine allo scontro.
Era ora compito del principe Giovanni nominare il miglior cavaliere della giornata, ed egli decise che l’onore toccava al cavaliere che la voce popolare aveva soprannominato Le Noir Fainéant. Fu fatto notare al principe, criticando la sua decisione, che la vittoria era stata conseguita in realtà dal cavaliere Diseredato che nel corso della giornata aveva abbattuto da solo sei campioni e che aveva poi disarcionato e fatto cadere a terra il capo della fazione avversaria. Ma il principe Giovanni rimase del suo parere, sostenendo che il cavaliere Diseredato e il suo gruppo avrebbero perso il torneo se non fosse stato per il potente aiuto del cavaliere dalla nera armatura, al quale perciò insisté di aggiudicare il premio.
Tuttavia, con sorpresa di tutti i presenti, non si riuscì a trovare il cavaliere prescelto da nessuna parte. Aveva lasciato il campo immediatamente dopo la fine del torneo ed era stato visto da alcuni spettatori scendere lungo una radura della foresta con lo stesso passo lento e gli stessi modi svogliati e indifferenti che gli avevano procurato l’epiteto di Fannullone Nero. Dopo che l’ebbero chiamato due volte con squilli di tromba e proclami degli araldi, fu necessario nominare un altro per ricevere gli onori che a lui erano stati destinati. Il principe Giovanni non aveva ormai altri pretesti per opporsi alla nomina del cavaliere Diseredato che fu quindi eletto campione della giornata. Attraverso il campo reso scivoloso dal sangue e ingombro di armature rotte e dei corpi di cavalli uccisi o feriti, i marescialli condussero di nuovo il vincitore ai piedi del trono del principe Giovanni.
«Cavaliere Diseredato», disse questi, «poiché solo con questo nome volete essere conosciuto, vi conferiamo per la seconda volta gli onori di questo torneo e vi annunciamo il diritto di richiedere e di ricevere dalle mani della regina dell’amore e della bellezza la corona che il vostro valore vi ha giustamente meritato». Il cavaliere si inchinò profondamente e con eleganza, ma non rispose nulla.
Mentre le trombe squillavano, mentre gli araldi si sfiatavano a tributare onore ai valorosi e gloria al vincitore, mentre le dame agitavano i fazzoletti di seta e i veli ricamati, e mentre tutti i presenti si univano in rumorose grida di esultanza, i marescialli condussero il cavaliere Diseredato attraverso il campo fino ai piedi del trono d’onore occupato da Lady Rowena. Il campione fu fatto inginocchiare sul gradino più basso. In effetti, dalla fine del combattimento il suo comportamento sembrava determinato più dall’intervento di coloro che gli erano intorno che dalla sua volontà, e fu visto barcollare mentre per la seconda volta veniva condotto attraverso la lizza. Rowena, scendendo dal trono con passo aggraziato e fiero, stava per mettere la corona che aveva in mano sull’elmo del campione quando i marescialli esclamarono: «Così non va… dev’essere a capo scoperto». Il cavaliere mormorò debolmente qualche parola che andò perduta nella cavità dell’elmo, ma che sembrava esprimere il desiderio che non gli fosse tolto.
I marescialli, non si sa se per amore del cerimoniale o per curiosità, non fecero caso alla sua riluttanza e gli tolsero l’elmo tagliando i lacci del casco e aprendo le fibbie della gorgiera. Quando l’elmo fu tolto, si videro i bei lineamenti, abbronzati dal sole, di un giovane uomo di circa venticinque anni in mezzo a una profusione di corti capelli biondi. Il volto era pallido come quello di un morto e segnato da una o due macchie di sangue.
Rowena, non appena lo vide, gettò un debole grido, ma immediatamente, facendo appello alla sua forza di carattere e imponendosi di continuare mentre tremava tutta per la violenza dell’improvvisa emozione, pose sulla testa china del vincitore la splendida corona premio della giornata, e con voce chiara e distinta pronunciò queste parole: «Io vi conferisco questa corona, signor cavaliere, come ricompensa al valore destinata al vincitore della giornata». A questo punto si fermò e poi con tono fermo aggiunse: «E mai corona cavalleresca potrebbe essere messa su fronte più degna!».
Il cavaliere abbassò il capo e baciò la mano della bella sovrana che aveva premiato il suo valore e poi, piegandosi ancora più in avanti, crollò ai suoi piedi.
La costernazione fu generale. Cedric, ammutolito dall’improvvisa apparizione del figlio che aveva bandito, si lanciò verso di lui come se volesse separarlo da Rowena. Ma ciò era già stato fatto dai marescialli di campo, i quali, intuendo la causa dello svenimento, si erano affrettati a togliergli l’armatura e avevano scoperto che la punta di una lancia era penetrata nel pettorale della corazza e aveva ferito a un fianco Ivanhoe.
 Immagine tratta da un’edizione illustrata dell’Ivanhoe
Immagine tratta da un’edizione illustrata dell’Ivanhoe
Il brano proposto ci mostra ancora un aspetto aperto da Scott che prevede la fedeltà storica, a tale scopo egli pone particolare attenzione all’elemento informativo/didattico sulle regole di un torneo medievale; scritto su ciò la sua prosa vira su elementi emozionali determinati sia nella crudezza descrittiva degli scontri sia sulla tecnica della suspence ottenuta scrivendo l’episodio da un punto di vista dello spettatore. Ma forse la parte più interessante è certamente il centrare l’attenzione verso due personaggi anonimi: essi sono anonimi sia per gli spettatori del torneo che per i lettori, facendo aumentare in loro la curiosità e quindi la voglia di continuare a leggere. Nello svelamento di uno dei due, cioè Ivanhoe, l’autore non può non far notare come l’eroe sia gravemente ferito, eccitando il lettore nel voler conoscere il prosieguo della sua vicenda; quindi gioca con la figura del personaggio del Fannullone, la cui anonimità è giustificata “narrativamente” in quanto nasconde la figura del legittimo re Riccardo.
Altro romanzo inglese d’enorme importanza sia per la tematica che per la eco che ancora oggi riceve è di Mary Shelley: Frankenstein o il moderno Prometeo del 1818:
 Mary Shelley
Mary Shelley
Mary Shelley (1797) nasce da William Godwin, filosofo dalle idee radicali, e Mary Wollstonecraft, autrice di A Vindication of the Rights of Woman, che morì nel darla alla luce. Aveva appena sedici anni quando incontrò Shelley che sposò in seguito, condividendo con lui una vita fatta di avventure e pericoli. Quando Shelley morì in mare, rimase vedova ad appena venticinque anni e, tornata in Inghilterra, dopo il successo straordinario del suo romanzo giovanile, appunto Frankenstein, riprese l’attività letteraria, di cui ci piace ricordare un altro notevole romanzo L’ultimo uomo del 1826.
Frankenstein, giovane svizzero studioso di filosofia naturale, servendosi di parte anatomiche sottratte a vari cadaveri, costruisce una creatura mostruosa, cui riesce, con procedimenti di cui lui solo ha il segreto, ad infondere la scintilla della vita. Atterrito per la creatura che ha creato, Frankenstein non riesce ad accudirlo e quindi il mostro fugge, non prima di avergli ucciso il fratellino. Lo scienziato lo ritrova sul Monte Bianco e, nonostante l’aspetto terrificante, la creatura si rivela la quintessenza della bontà di cuore e della mitezza. Ma quando si accorge del disgusto e della paura che suscita negli altri, la sua natura, incline alla bontà, subisce una totale trasformazione ed egli diviene un’autentica forza distruttiva: per questo chiede al suo creature di dar vita ad una compagna capace di amarlo e di placare la sete di vendetta verso gli uomini. Frankenstein promette ma non mantiene, inorridito dall’idea di una progenie di mostri. La creatura si vendica uccidendogli due amici, e viene infine raggiunto dal suo creatore nei ghiacci dell’Artico. Qui Frankenstein muore, dopo aver raccontato la storia ad un vecchio marinaio. Sulla sua tomba il mostro mostrerà la rabbia ma anche l’infinito amore per “suo padre” e quindi fuggirà alla ricerca dell’annientamento di sé.
L’APPARIZIONE DEL MOSTRO
(Capitolo V)
Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con un’ansia simile all’angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la scintilla della vita alla cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già l’una del mattino; la pioggia batteva lugubre contro i vetri, la candela era quasi consumata, quando, tra i bagliori della luce morente, la mia creatura aprì gli occhi, opachi e giallastri; trasse un respiro faticoso e un moto convulso ne agitò le membra.
Come posso descrivere la mia emozione a quella catastrofe, descrivere l’essere miserevole a cui avevo dato forma con tanta cura e tanta pena? Il corpo era proporzionato e avevo modellato le sue fattezze pensando al sublime. Sublime? Gran Dio! La pelle gialla a stento copriva l’intreccio dei muscoli e delle vene; i capelli fluenti erano di un nero lucente e i denti di un candore perlaceo; ma queste bellezze rendeva ancor più orrido il contrasto con gli occhi acquosi, grigiognoli come le orbite in cui affondavano, il colorito terreo, le labbra nere e tirate.
La vita non offre avvenimenti tanto mutevoli quanto lo sono i sentimenti dell’uomo. Avevo lavorato duramente per quasi due anni al solo scopo di infondere la vita a un corpo inanimato. Per questo avevo rinunciato al riposo e alla salute. L’avevo desiderato con intensità smodata, ma ora che avevo raggiunto la meta il fascino del sogno svaniva, orrore e disgusto infiniti mi riempivano il cuore. Incapace di sostenere la vista dell’essere che avevo creato, fuggii dal laboratorio e a lungo camminai avanti e indietro nella mia camera da letto, senza riuscire a dormire. Alla fine lo spossamento subentrò al tumulto iniziale e mi gettai vestito sul letto, cercando qualche momento di oblio. Invano! Dormii, è vero, ma agitato da sogni più strani. Mi sembrava di vedere Elisabeth, nel fiore della salute, per le strade di Ingolstadt. Sorpreso e gioioso, l’abbracciavo; ma come imprimevo il primo bacio sulle sue labbra, queste si facevano livide, color di morte; i suoi tratti si trasformavano e avevo l’impressione di stringere tra le braccia il cadavere di mia madre, avvolto nel sudario. I vermi brulicavano tra le pieghe del tessuto. Mi risvegliai trasalendo d’orrore; un sudore freddo mi imperlava la fronte, battevo i denti e le membra erano in preda a una tremito convulso quando – al chiarore velato della luna che si insinuava attraverso le persiane chiuse – scorsi la miserabile creatura, il mostro da me creato. Teneva sollevate le cortine del letto e i suoi occhi, se di occhi si può parlare, erano fissi su di me. Aprì le mascelle emettendo dei suoni inarticolati mentre un sogghigno gli raggrinzava le guance. Forse aveva parlato, ma non udii; aveva allungato una mano, come per trattenermi, ma gli sfugii precipitandomi giù per le scale. Mi rifugiai nel cortile della casa e vi passai il resto della notte, continuando a percorrerlo, agitatissimo, e tendendo l’orecchio a ogni rumore che annunciasse l’arrivo del diabolico cadavere al quale avevo sciaguratamente dato vita.
Oh! Nessun mortale avrebbe potuto sostenere l’orrore del suo aspetto! Una mummia riportata in vita non sarebbe risultata raccapricciante come quell’essere repulsivo. Lo avevo osservato quando non era ancora ultimato; anche allora era sgradevole, ma quando i muscoli e le giunture avevano assunto capacità di moto era diventato qualcosa che neppure Dante avrebbe saputo concepire.
Trascorsi una nottata infernale. A volte il mio polso batteva così rapido e violento che potevo sentire il palpitare di ogni arteria; altre volte l’estrema debolezza e il languore quasi mi facevano crollare a terra. Insieme all’orrore provavo l’amarezza della disillusione; sogni che a lungo erano stati stati il mio cibo e il mio ristoro si erano trasformati in incubi; e il rovesciamento era stato così rapido, così completa la disfatta!
Sorse il mattino, triste e piovoso, e mostrò ai miei occhi insonni e dolenti la chiesa di Ingolstadt, il suo bianco campanile e l’orologio che segnava le sei. Il guardiano aprì i cancelli del cortile, che era stato il mio asilo quella notte e uscii nelle strade percorrendole a passo svelto come per sfuggire al mostro che temevo mi si parasse dinanzi a ogni angolo. Non avevo il coraggio di tornare al mio alloggio, mi sentivo sospinto a camminare nonostante la pioggia che cadeva da un cielo nero e sconfortante mi bagnasse fino alle midolla.
Continuai così, sperando che l’esercizio fisico alleggerisse il peso che mi opprimeva la mente. Traversavo le strade senza avere idea di dove fossi, di cosa facessi. Sentivo il cuore stretto nella morsa dell’angoscia, e mi affettavo con passo irregolare, senza osare guardarmi attorno:
Come uno che, per strada deserta,
cammina tra paura e terrore,
e guardatosi intorno una volta, va avanti
e non volta mai più la testa
perché egli sa, un orrendo demonio
a breve distanza lo segue.*
*Versi tratti dalla Ballata del vecchio marinaio di Coleridge
L’opera di Mary Shelley presenta una serie di tematiche fondamentali del pensiero contemporaneo, che travalicano il tempo in cui l’opera fu scritta, ma continua ad illuminarci grazie alle trasposizioni cinematografiche e teatrali che si effettuano ancora oggi. Certamente essa non può che inserirsi all’interno del Romanticismo, laddove la figura titanica di Frankenstein, novello Dio, creatore di vita, non può che pagare la sua ybris, tracotanza e orgoglio, finendo per essere vittima di sé, come fosse il protagonista di una tragedia greca che abbia subito una nemesis da parte degli dei. Ma l’opera che la Shelley scrisse appena diciannovenne (frutto di una scommessa tra amici, i quali dovevano portare a termine un racconto gotico) non può essere compresa se non la si inserisce all’interno del processo dell’industrializzazione inglese; essa infatti, attraverso la trasformazione della natura e la produzione di qualcosa di nuovo, attraverso la sua continua modernizzazione, attraverso la “trasformazione” dell’uomo in un tutt’uno con la macchina produttrice sembra essere simboleggiato dalla figura della Creatura, ponendo l’interrogativo sul limite che la scienza deve porsi nella sua volontà di scoperta. A questo va aggiunto certamente il problema etico della diversità, dell’esclusione: se la Creatura è violenta è perché non è stato accettato e amato e tale non accettazione avviene dal punto di vista esteriore, non interiore. La sua anima pura contrasta con la deformità e questo tema illuminerà un altro grande romanzo della cultura europea Notre-Dame de Paris (1831) del francese Victor Hugo.
Francia
Il Romanticismo in Francia viene inaugurato dall’intellettuale ginevrina Madame de Staël con il testo De l’Allemagne (La Germania). In esso la scrittrice non fa altro che far conoscere ai francesi l’opera di Lessing, Goethe, Shiller, Novalis, nonché i teorici della nuova filosofia (si pensi a Fichte). Più che una teorica, la sua funzione vuole essere quella di “operatore culturale”, capace com’era di conoscere i più alti rappresentanti liberali e democratici, tessere rapporti, e costituire il fulcro di un dibattito culturale europeo. Ma non bisogna dimenticare che la Francia, pur essendo la capitale delle teorie razionaliste ed illuminate, aveva a cavallo tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, una personalità come Jean-Jacques Rousseau che con Julie ou la Nouvelle Héloïse aveva aperto la strada, come d’altra parte aveva fatto Goethe con I dolori del giovane Werther ed in Italia Foscolo con lo Jacopo Ortis.
L’aria culturale nuova in Francia l’aveva raccolta François-René de Chateabriand che già nel 1802 aveva scritto Le génie du Christianisme (Il genio del Cristianesimo) opera capitale per il risveglio cattolico d’Europa, apprezzato soprattutto in seguito, dopo il Congresso di Vienna, e due brevi romanzi Atala e René.
Nasce nel 1768 da nobile famiglia. Viene avviato alla carriera militare e nel 1791, si reca negli Stati Uniti. Al ritorno in Francia si unisce allo schieramento controrivoluzionario e si rifugia in Inghilterra dove rimane fino al 1800. La morte della madre e della sorella lo spingono verso una profonda conversione spirituale, scriverà infatti opere che avranno al centro la riflessione religiosa. Accostatosi alla vita politica alla fine dell’Esperienza napoleonica, vi resterà fino al 1830, quando salirà al potere Luigi Filippo. Si ritira quindi a vita privata, scrivendo opere di carattere autobiografico e storico. Si spegnerà a Parigi nel 1848.
 François-René de Chateabriand
François-René de Chateabriand
René, rifugiatosi nella colonia dei Natchez, in Louisiana, per vivere in solitudine, rivela all’amico Chactas e al missionario Souël le ragioni della sua malinconia e della sua scelta. Rievoca così i giorni della sua adolescenza, le lunghe passeggiate in compagnia della sorella Amélie. Già preda di una inestinguibile sete d’infinito. René cercava invano una ragione per pacificare la propria anima. Era arrivato perfino a intravvedere una soluzione nel suicidio, dal quale però era stato dissuaso dalla sorella. Ma Amélie, colpita da una strana crisi, aveva improvvisamente deciso di rinchiudersi in convento. Qui, ascoltando una sommessa invocazione della sorella a Dio, René aveva colto il segreto della sua “criminale passione” per lui. Sconvolto, si era imbarcato per l’America, dove un giorno l’ha raggiunto la notizia della morte prematura di Amélie. Chactas consola il giovane amico, mentre padre Souël gli ricorda severamente che “chiunque abbia ricevuto delle forze le deve consacrare al servizio dei suoi simili”.
L’EROE IN FUGA DA SE STESSO
Ben invano dunque avevo sperato di trovar nel mio paese di che calmare quest’inquietudine, quest’ardore che mi segue dovunque. Lo studio del mondo non mi aveva insegnato nulla, eppure non avevo più la dolcezza dell’ignoranza.
Mia sorella, con un modo di comportarsi inesplicabile, sembrava che si compiacesse d’aumentare il mio affanno: ella aveva lasciato Parigi qualche giorno prima del mio arrivo. Le scrissi che contavo di andare a raggiungerla; s’affrettò a rispondermi per distogliermi da questo proposito, col pretesto che non sapeva dove la chiamerebbero i suoi affari. Che tristi riflessioni feci allora sull’amicizia, che la presenza intiepidisce, che la lontananza cancella, che non resiste alla sventura, e ancor meno alla prosperità!
Mi trovai ben presto più solo nella mia patria di quel che fossi stato in una terra straniera. Per qualche tempo volli gettarmi in un mondo che non mi diceva niente e da cui non ero compreso. L’anima mia, che nessuna passione non aveva ancora logorata, cercava un oggetto a cui attaccarsi; ma mi accorsi che davo più di quel che ricevevo. Non mi si chiedeva un linguaggio elevato, né un sentimento profondo. Non facevo altro che rimpicciolire la mia vita per metterla alla pari con la società. Trattato da per tutto come uno spirito romantico, vergognoso della parte che recitavo, sempre più disgustato delle cose e degli uomini, presi il partito di ritirarmi in un sobborgo, per vivervi totalmente ignorato.
Trovai da principio abbastanza piacere in quella vita oscura e indipendente. Sconosciuto, mi confondevo tra la folla, vasto deserto di uomini!
Sovente, seduto in una chiesa poco frequentata, passavo intiere ore in meditazione. Vedevo povere donne venir a prostrarsi davanti l’Altissimo, o peccatori inginocchiarsi al Tribunale della penitenza. Nessuno usciva da quei luoghi senza un viso più sereno, e i sordi clamori che giungevano da fuori sembravano i flutti delle passioni e le tempeste del mondo che venivano a morire ai piedi del tempio del Signore. Gran Dio, che vedesti in segreto colar le mie lagrime in quei sacri ritiri, tu sai quante volte mi gettai a’ tuoi piedi per supplicarti di scaricarmi del peso dell’esistenza, o di cambiare in me il vecchio uomo!
Ah! chi non ha sentito qualche volta il bisogno di rigenerarsi, di ringiovanire alle acque del torrente, di ritemprare la sua anima alla fontana della vita! Chi non si sente qualche volta spossato dal peso della sua propria corruzione, e incapace di fare alcunché di grande, di nobile, di giusto!
Quando la sera era venuta, riprendendo la strada del mio ritiro, mi fermavo sui ponti per veder tramontare il sole. L’astro infiammando i vapori della città, sembrava oscillare lentamente in un fluido d’oro, come il pendolo dell’orologio dei secoli. Poscia mi ritiravo con la notte, a traverso un labirinto di strade solitarie. Guardando i lumi accesi nelle case degli uomini, mi trasportavo col pensiero in mezzo alle scene di dolore e di gioia che essi rischiaravano, e pensavo che, sotto tanti tetti abitati, io non avevo un amico. In mezzo alle mie riflessioni, l’ora batteva a colpi misurati sulla Torre della cattedrale gotica, e andava ripetendosi su tutti i toni, sempre più lontano, di chiesa in chiesa. Ahimè! ogni ora, nel mondo, apre una tomba e fa versare lacrime!
Quella vita, che m’aveva sulle prime sedotto, non tardò a diventarmi insopportabile. Quel ripetersi delle medesime idee mi stancava. Mi misi a scandagliare il mio cuore, a domandarmi che cosa desideravo. Non lo sapevo; ma a un tratto credetti che i boschi sarebbero la mia delizia. Eccomi in un subito risoluto di terminare in un esilio campestre un corso di vita appena cominciato e nel quale avevo già divorato dei secoli.
Abbracciai questo progetto con l’ardore che metto in tutti i miei disegni; partii precipitosamente per seppellirmi in una capanna, come altra volta ero partito per fare il giro del mondo. Mi si accusa d’aver gusti incostanti, di non poter godere a lungo della medesima chimera, d’essere preda di una immaginazione che si affretta a giungere al fondo dei miei piaceri, come se si stancasse della loro durata; mi si accusa di sorpassar sempre la mèta che posso toccare: ahimè! io cerco soltanto un bene sconosciuto il cui istinto m’insegue. È colpa mia se dappertutto trovo limiti, se ciò che è finito non ha alcun valore per me? Pure io sento che amo la monotonia dei sentimenti della vita, e se avessi ancora la follia di credere nella felicità, la cercherei nell’abitudine.
La solitudine assoluta, lo spettacolo della natura presto m’immersero in uno stato che quasi non è possibile descrivere. Senza parenti, senza amici, solo, per così dire, sulla terra, senz’aver ancora amato, ero oppresso da una sovrabbondanza di vita. Certe volte arrossivo subitamente e sentivo scorrere nel mio cuore come rivi di lava ardente: certe altre gettavo gridi involontari e le mie notti, sia che sognassi, sia che vegliassi, erano ugualmente agitate. Mi mancava qualche cosa, per riempire l’abisso della mia esistenza: discendevo nella valle, mi spingevo su per la montagna, invocando con tutta la forza dei miei desideri l’ideale oggetto d’una fiamma futura; l’abbracciavo nei venti, credevo udirlo nei gemiti del fiume: tutto era quell’immaginario fantasma, e gli astri nei cieli, e lo stesso principio della vita nell’universo. Pure quello stato di calma e d’inquietudine, d’indigenza e di ricchezza, non era senza attrattive: un giorno m’ero divertito a sfogliare una rama di salcio su d’un ruscello, e ad unire una idea a ogni foglia che la corrente portava via. Un re che tema di perdere la corona per un’improvvisa rivoluzione non prova angosce più vive delle mie a ogni accidente che minacciava i frammenti del mio ramoscello. O debolezza dei mortali! o infanzia del cuore umano che non invecchia mai! Ecco dunque a qual grado di puerilità può discendere la nostra superba ragione! E tuttavia molti uomini legano il loro destino a cose tanto da nulla quanto le mie foglie di salcio.
Ma come esprimere quella folla di sensazioni fuggitive che provavo nelle mie passeggiate? I suoni che rendono le passioni nel vuoto d’un cuore solitario somigliano al mormorio dei venti e delle acque nel silenzio d’un deserto: lo si gode, ma non lo si può ritrarre.
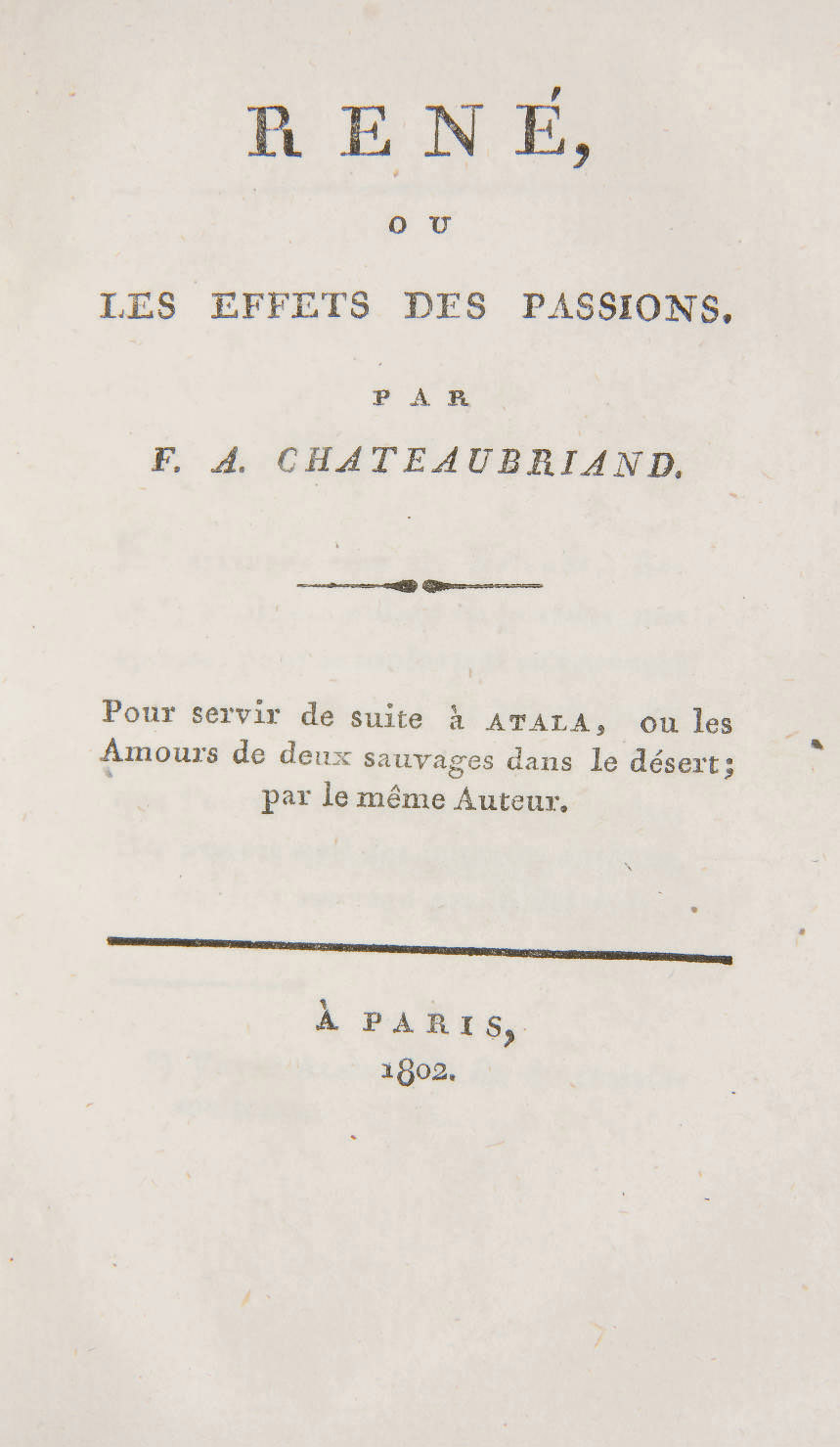
Ci troviamo di fronte ad un tipico rappresentante della letteratura che trova per gli antecedenti che conosciamo il suo più fulgido esempio nell’opera alfieriana; come il nostro astigiano, René, che certo non può che rappresentare l’autore stesso, si sente superiore agli altri, capace più degli altri di una sensibilità eccezionale. Ma essa è frustrata dalla realtà che lo circonda che è soprattutto legata da interessi economici. Per questo cerca di allontanarsi dalla città, fulcro di una borghesia gretta ed avida, per rifugiarsi in campagna, per cancellare la propria identità e confondersi con la gente semplice. La voglia di annullarsi e trovare se stesso la prova tuttavia all’interno della chiesa, dove l’Altissimo si configura per lui come l’Assoluto, non tuttavia capace di placarlo, ma di provocare in lui una continua tensione per trovare una motivazione per vivere. Se infatti la tensione verso l’assoluto alfieriana è legata all’idea laica, potremo dire, di libertà, se quella wertheriana ed ortisiana sancisce il suo fallimento con il suicidio, in Chateabriand diventa rincorsa verso il sublime divino.
Anche nella poesia la lirica francese s’inserisce nel rinnovamento europeo romantico, non dimenticando che, sul piano della cultura nazionale, tale aspetto letterario era stato messo un po’ da parte nella temperie illuminista. Fra i poeti più importanti ricordiamo Gerard De Nerval, di cui riportiamo una delle più belle, ma al tempo stesso più arcane poesie:
EL DESDICHADO
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,
Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :
Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.
Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène…
Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.
Io sono il Tenebroso, – il Vedovo, – lo Sconsolato, / Il Principe d’Aquitania dalla torre abolita: / La mia unica Stella è morta, – e il mio liuto costellato / Porta il Sole nero della Malinconia // Nella notte del Sepolcro, Tu che mi hai consolato, / Restituiscimi Posillipo e il mare d’Italia, / Il fiore che piaceva tanto al mio cuore desolato, / E la spalliera dove la vite si intreccia alla rosa. // Sono Amore o Febo?… Lusignano o Biron? / La mia fronte è ancora rossa per il bacio della Regina; / Ho sognato nella Grotta dove nuota la Sirena… // E per due volte vincitore ho attraversato l’Acheronte: / Modulando di volta in volta sulla lira di Orfeo / I sospiri della Santa e le grida della Fata.
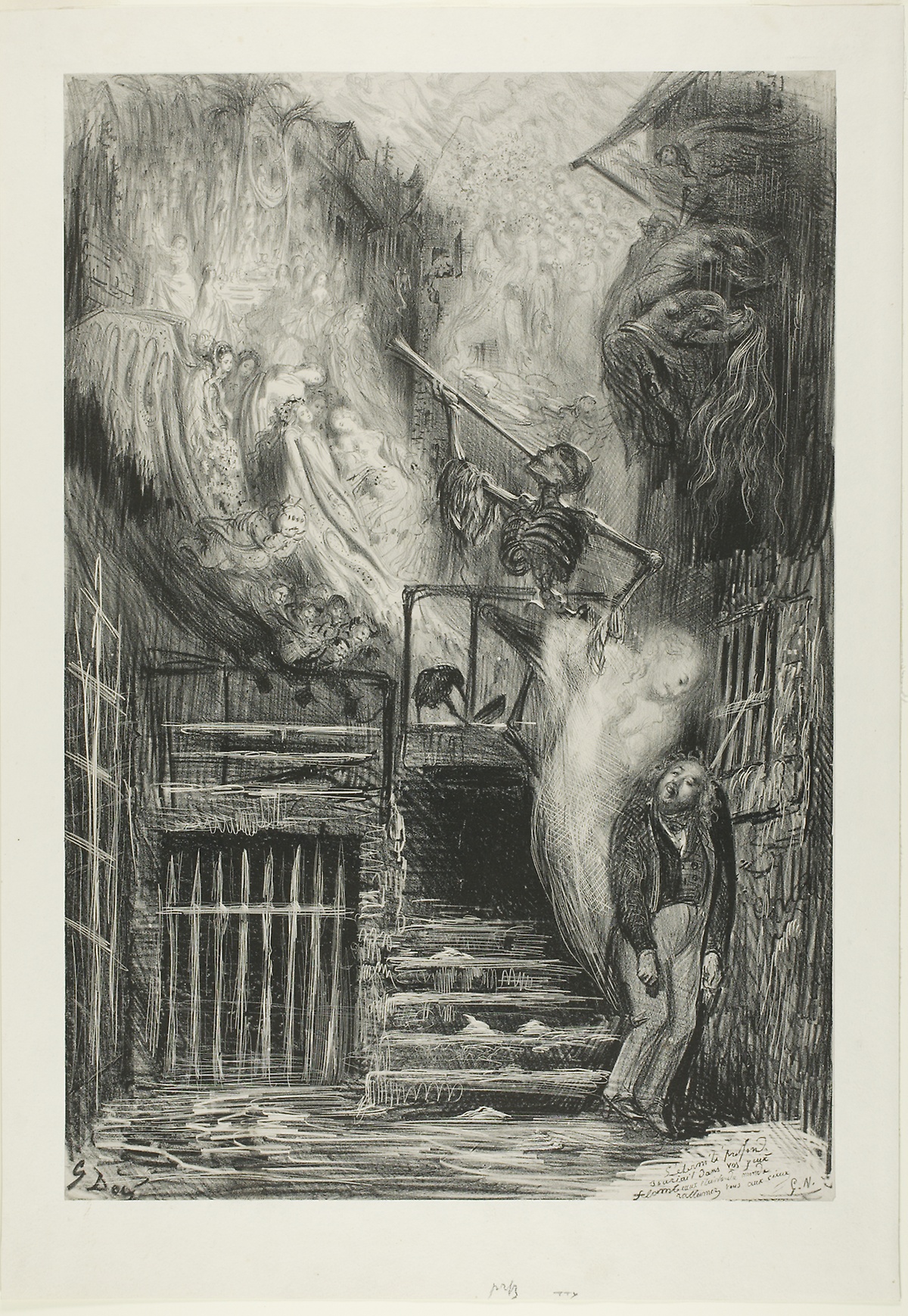 Gustave Doré: La morte di Gerard De Nerval
Gustave Doré: La morte di Gerard De Nerval
Poesia di difficilissima interpretazione: qualcuno ha voluto vedere in essa riferimenti all’alchimia, all’astrologia, ai tarocchi (i primi tre versi potrebbero essere riferiti agli arcani XV-XII: Diavolo, Torre e Stella), altri ancora riferimenti al mito della famiglia e degli antenati dello stesso Nerval; nessuna interpretazione è riuscita a cogliere appieno il significato ultimo del dettato poetico, ma forse era proprio questo quello a cui tendeva Nerval (poeta minato psicologicamente a causa della morte della madre avvenuta quando lui aveva solo due anni, lutto mai superato, morto suicida a soli 47 anni). Importante sul piano dell’inserimento del poeta e del brano proposto nel Romanticismo è la sua propensione al mito, al concetto di magia della parola poetica. D’altra parte qui ci troviamo di fronte ad un Nerval che di fronte al fallimento della vita risponde con la forza salvifica della poesia, nella quale troviamo mitizzate figure femminili capaci di risolvere tutte le sue contraddizioni.
Altro importante poeta del romanticismo francese è certamente Alfred de Vigny. figura emblematica di come i più sensibili intellettuali francesi percepiscono il periodo che va dalla fine dell’avventura napoleonica attraversando quasi tutta la prima metà dell’Ottocento francese. Nato nel 1797, per tradizione familiare si accosta alla vita militare, senza rinunciare tuttavia a frequentare ambienti intellettuali che giravano attorno alla figura di Victor Hugo. Sposatosi con una ragazza inglese, dopo esser passato dalla Loira a Parigi, assistette dapprima alla Rivoluzione del 1830, diviso tra politica umanitaria e fedeltà al regnante, sino al 1848, dove presentatosi alle elezioni e battuto, si ritirò a vita privata. Muore nel 1863.

La poesia proposta viene tratta dal libro in versi I Destini, iniziati nel 1838, ma pubblicati postumi nel 1863.
LA MORT DU LOUP
I
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon.
Nous marchions, sans parler, dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. — Ni le bois ni la plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs; seulement
La girouette en deuil criait au firmament;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y couchant; bientôt,
Lui que jamais ici l’on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions, pas à pas, en écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils voyaient,
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse,
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs l’homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa Louve reposait comme celle de marbre
Qu’adoraient les Romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées,
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante,
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang;
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
II
J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses fils, qui, tous trois,
Avaient voulu l’attendre; et, comme je le crois,
Sans ses deux Louveteaux, la belle et sombre veuve
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
A ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l’homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
III
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C’est vous qui le savez, sublimes animaux !
A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,
Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse.
– Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur !
Il disait : « Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler,
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »
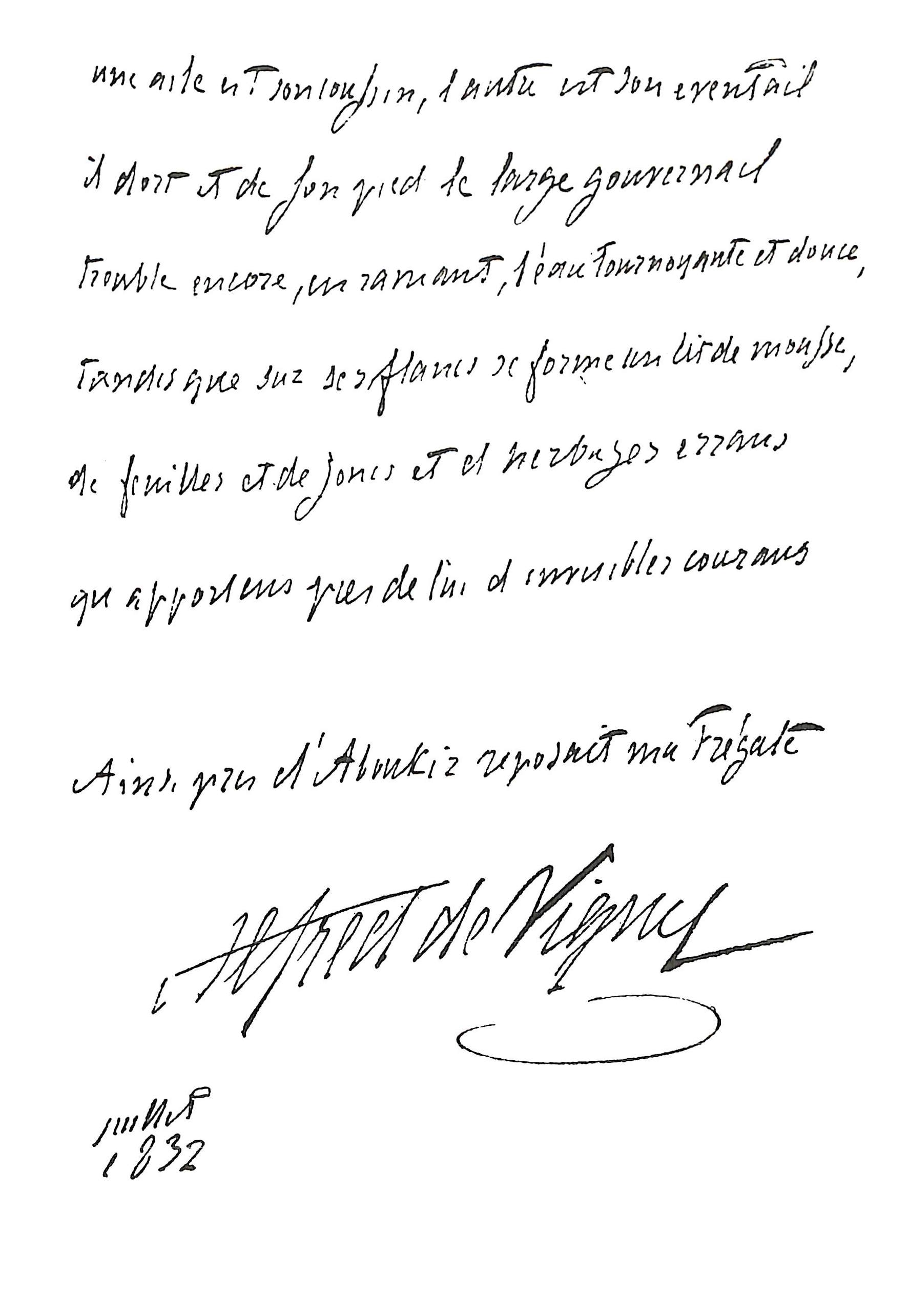 Autografo di Alfred De Vigny
Autografo di Alfred De Vigny
LA MORTE DEL LUPO
I. Le nubi sulla luna infiammata correvano / Come sull’incendio si vede salire il fumo, / E i boschi erano neri fino all’orizzonte. / Marciavamo, sul prato umido, silenziosamente, / Tra le edere intricate e tra le alte fronde, / Finché, sotto pini simili a quelli delle Lande, / Abbiamo scorto i segni delle unghie lasciati / Dai lupi errabondi che avevamo braccati. / Ci siam messi in ascolto, trattenendo il fiato / E col passo leggero. — Né il bosco né il prato / Emettevano un sospiro nell’aria; sola / Gridava luttuosa al ciel la banderuola; / Poiché il vento, che ben alto sulla terra soffiava, / Solo le torri solitarie coi suoi piedi sfiorava, / E le querce dabbasso, contro le rocce scoscese, / Sui gomiti parevano addormentate e distese. / Nulla si muoveva, dunque, finché, chinando la testa, / Il più vecchio dei cacciatori che seguivano la pista / Ha osservato la terra inginocchiato; ben presto, / Lui che sbagliarsi qui mai è stato visto, / Ha dichiarato sussurrando che le tracce recenti / Annunciavano il passaggio e gli artigli possenti / Di due lupi adulti e di due ancora cuccioli. / Noi tutti abbiamo allora sguainato i pugnali, / E, celando i fucili dai traditori barlumi, / Avanzavamo pian piano, scostando i rami. / In tre si fermano, ed io, cercando cosa vedano, / Scorgo d’un tratto due occhi che fiammeggiano, / E poi vedo al di là quattro forme leggere / Che danzavano alla luna in mezzo alle brughiere, / Come fanno ogni dì, davanti a noi in gran confusione, / I levrieri festanti, quando torna il padrone. / Simile la loro forma e simili i movimenti, / Ma i piccoli del Lupo danzavano silenti, / Ben sapendo che a due passi, con sonno leggero, / Dorme tra le sue mura l’uomo, nemico loro. / Il padre era sdraiato, e più in là, a un tronco appoggiata, / La sua Lupa riposava, come quella scolpita / Che adoravano i Romani, il cui i fianco lanoso / I semidei Remo e Romolo copriva amoroso. / Il Lupo avanza e si ferma, le due gambe dritte, / Piantate nella sabbia con le unghie ritorte. / S’è visto perduto, poiché è stato sorpreso, / La sua fuga stroncata e ogni passaggio chiuso; / Allora ha azzannato, nella sua gola ardente, / Del cane più ardito la gola ansimante, / E le mascelle d’acciaio non ha disserrato, / Malgrado i nostri spari l’avessero colpito, / E, come tenaglie, i nostri aguzzi coltelli / S’incrociassero piombandogli nei muscoli, / Fino all’ultimo istante, quando il cane strangolato, / Morto assai prima di lui, ai suoi piedi è stramazzato. / Allora il Lupo lo lascia e poi ci fissa. I coltelli gli restavano nel fianco, fino all’elsa, / Lo inchiodavano al prato del suo sangue cosparso; / I nostri fucili lo accerchiavano in un crescendo avverso. / Lui ci guarda ancora, quindi si ristende, / Leccandosi il sangue d’intorno alle sue zanne, / E, senza degnarsi di sapere per cosa sia perito, / Chiudendo i grandi occhi, muore senza un grido.
II. Ho chinato il capo sul fucile scarico di polvere, / Preso a riflettere, e non mi son potuto risolvere / Ad inseguire la Lupa e i cuccioli, che, tutti e tre, / Avevano voluto aspettarlo; e, penso tra me, / Se non fosse stato per i Cuccioli, la bella e triste vedova / Non l’avrebbe lasciato solo al momento della prova; / Ma il suo dovere era di salvarli, al fine / Di potergli insegnare a sopportare la fame, / A non vincolarsi mai con i patti civili / Stipulati dall’uomo con le bestie servili / Che cacciano avanti a lui, in cambio di cucce, / Loro, una volta signore di boschi e di rocce.
III. Ahimè! ho pensato, malgrado il gran nome di Uomini, / Che vergogna ho di noi, per quanto siamo infimi! / Come si debban lasciare la vita e tutti i suoi mali, / Siete voi a saperlo, o sublimi animali! / Se a ciò che in terra fu e si lascia si pensa, / Solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza. / – Ah! Ti ho ben inteso, selvaggio viaggiatore, / E il tuo ultimo sguardo m’è penetrato fino al cuore! / Diceva: «Se puoi, fa sì che l’anima tua pervenga, / A forza di ristarsene pensierosa e attenta, / Di stoica fierezza a quel siffatto punto / Cui io, nato nei boschi, subito son giunto. / Gemere, piangere, pregare è ugualmente indegno. / Compi il tuo lungo e arduo compito con impegno / Sulla via in cui la sorte ti ha voluto chiamare, / Poi, dopo, come me, soffri e muori senza fiatare.»
E’ il racconto in versi baciati, diviso in tre strofe di lunghezza ineguale, in cui Vigny descrive una caccia notturna contro i lupi. Risulta abbastanza evidente come il poeta francese utilizzi la storia sotto un punto di vista simbolico: l’uomo con i cani rappresenta il “mondo civile” dimentico della natura e delle sue eterne leggi; anche l’animale che l’accompagna ha perso dignità, si è fatto servo in cambio di una cuccia; ad emergere, viceversa, sono gli occhi fieri del lupo, occhi di sfida di chi sa che deve morire, ma muore per salvare i suoi lupacchiotti e la madre. Mentre azzanna un levriero, l’uomo lo colpisce: non c’è dolore, neanche rassegnazione, ma naturale accettazione del destino di chi, nato libero, sa di dover morire. Questo insegnamento ha tratto il cacciatore, affrontare stoicamente il destino dell’uomo.
America
L’America diventa nazione culturale quando riesce a mescolare i principi dei padri fondatori con il romanticismo già sviluppato in Europa. Potremo meglio dire che alla base della cultura di ogni buon cittadino americano ci sia stata da una parte la Bibbia (recepita nella versione pietistica) e il Robinson Crusoe di Defoe, massimo esempio, per loro del self made men espressione con la quale ancora oggi indicano il mito dell’uomo che partendo dal basso raggiunge da solo per meriti propri il successo, la ricchezza e la celebrità, come hanno in effetti fatto i padri pellegrini.
A riuscire in questa forma di proficua fusione possiamo indicare un gruppo di intellettuali che diedero vita a ciò che il critico letterario statunitense Francis Otto Matthiessen definirà “Rinascimento americano” e sono il poeta Walt Whitman ed i romanzieri Nathaniel Hawthorne, James Fenimore Cooper e Herman Melville. Non si inserisce in questo novero l’opera tuttavia contemporanea di Edgar Allan Poe.

Walt Withman
Walt Whitman nasce nel 1819, da padre carpentiere. Lasciati gli studi in tenera età, diventa prima tipografo (attività che gli permette di leggere molti autori) e in seguito maestro elementare. Passa quindi al giornalismo, attraverso il quale diffonde le proprie idee democratiche e libertarie. Nello stesso anno (1848) viaggia per gli Stati Uniti, raggiungendo il lontano Ovest. La vista di luoghi naturali e incontaminati saranno alla base del suo lavoro Foglie d’erba del 1850, che conobbe un’enorme eco. Muore nel 1892.
SONG OF OPEN ROAD
Afoot and light-hearted I take to the open road,
Healthy, free, the world before me,
The long brown path before me leading wherever I choose.
Henceforth I ask not good-fortune, I myself am good-fortune,
Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing,
Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms,
Strong and content I travel the open road.
The earth, that is sufficient,
I do not want the constellations any nearer,
I know they are very well where they are,
I know they suffice for those who belong to them.
(Still here I carry my old delicious burdens,
I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go,
I swear it is impossible for me to get rid of them,
I am fill’d with them, and I will fill them in return.)
A piedi e con cuore leggero m’avvio per la libera strada / in piena salute e fiducia, il mondo offertomi innanzi, / il lungo sentiero marrone pronto a condurmi ove voglia. // D’ora in avanti non chiederò più buona fortuna, sono io la buona fortuna, / d’ora in avanti non voglio più gemere, non più rimandare, non ho più bisogno di nulla, / finiti i lamenti celati, le biblioteche, le querule critiche, / forte e contento m’avvio per libera strada. // La terra, e tanto mi basta, / le stelle non scendan più accosto, / so che stanno assai bene dove sono, / so che bastano a quelli che appartengono ad esse. // (Eppure io porto anche qui i miei antichi, soavi fardelli, / li porto, uomini e donne, li porto con me dove vado, / dichiaro che mi è impossibile riuscire a disfarmene, / io sono colmo di essi e li colmerò a mia volta).
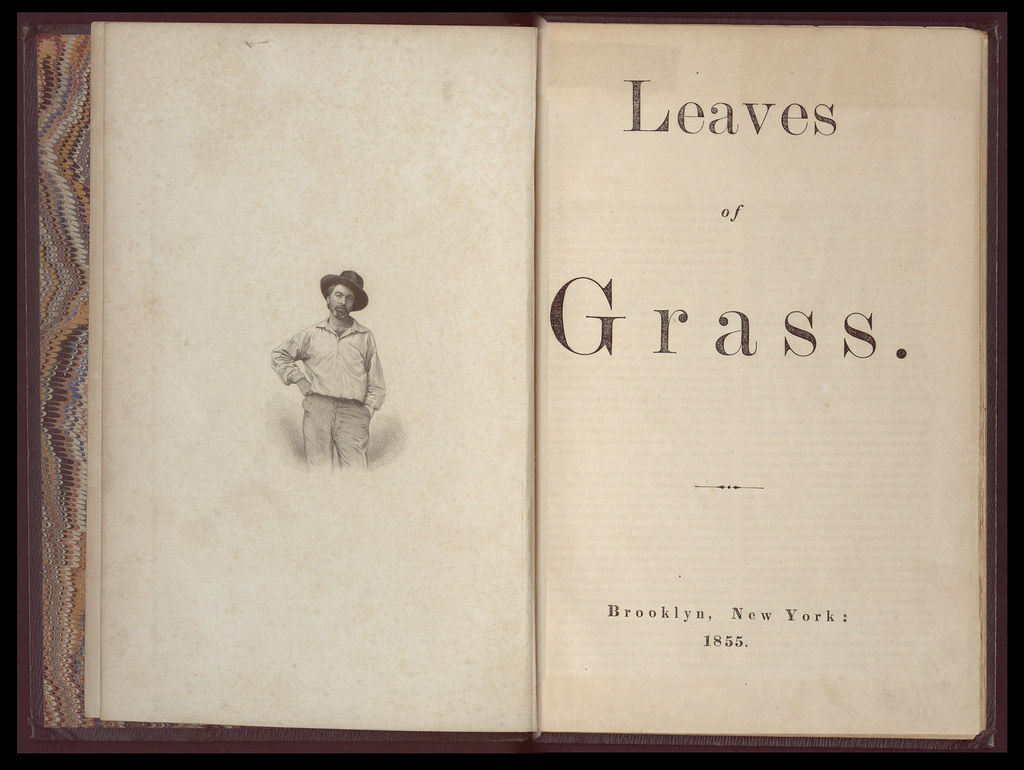
Il passo costituisce una parte di un piccolo poemetto dal titolo Il canto della strada all’interno dell’opera Foglie d’erba. E’ un canto assolutamente nuovo, anche rispetto alla poesia romantica europea: Whitman utilizza il verso libero e ad espressioni sublimi, alterna espressioni appena sussurrate, così come appare nell’inciso. In esso vi è tutta la poetica del poeta americano e dello spirito americano: è un canto on the road, l’uomo in cammino sul The long brown path è un uomo felice ed assapora la piena libertà accompagnata da una soddisfazione di sé; ma tale libertà non può essere scissa dal suo passato: per Withman la conquista della frontiera non può avvenire senza il portato della lezione della memoria e della tradizione culturale.
Ancora più famosa. soprattutto per l’incipit è quest’altra lirica di Withman:
O CAPTAIN! MY CAPTAIN
O Captain! My Captain! our fearful trip is done;
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won;
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring:
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
O Captain! My Captain! rise up and hear the bells;
Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills;
For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores a-crowding;
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;
Here captain! dear father!
This arm beneath your head;
It is some dream that on the deck,
You’ve fallen cold and dead.
My Captain does not answer, his lips are pale and still;
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will;
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done;
From fearful trip, the victor ship, comes in with object won;
Exult, O shores, and ring, O bells!
But I, with mournful tread,
Walk the deck my captain lies,
Fallen cold and dead.
O Capitano! mio Capitano! il nostro viaggio tremendo è finito, / La nave ha superato ogni tempesta, l’ambito premio è vinto, / Il porto è vicino, odo le campane, il popolo è esultante, / Gli occhi seguono la solida chiglia, l’audace e altero vascello; / Ma o cuore! cuore! cuore! / O rosse gocce sanguinanti sul ponte / Dove è disteso il mio Capitano / Caduto morto, freddato. // O Capitano! mio Capitano! alzati e ascolta le campane; alzati, / Svetta per te la bandiera, trilla per te la tromba, per te / I mazzi di fiori, le ghirlande coi nastri, le rive nere di folla, / Chiamano te, le masse ondeggianti, i volti fissi impazienti, / Qua Capitano! padre amato! / Questo braccio sotto il tuo capo! / E’ un puro sogno che sul ponte / Cadesti morto, freddato. // Ma non risponde il mio Capitano, immobili e bianche le sue labbra, / Mio padre non sente il mio braccio, non ha più polso e volere; / La nave è ancorata sana e salva, il viaggio è finito, / Torna dal viaggio tremendo col premio vinto la nave; / Rive esultate, e voi squillate, campane! / Io con passo angosciato cammino sul ponte / Dove è disteso il mio Capitano / Caduto morto, freddato.

La poesia nasce dall’emozione che su Withman ha avuto la notizia della morte di Lincoln, che, nel 1860, grazie l’approvazione della legge abolì lo schiavismo ma per questo, provocò l’immediata secessione degli stati del Sud e, dopo la loro sconfitta, la morte per mano degli assassini. Qui Withman, contrariamente al suo solito, reintroduce uno schema classico, strofe di otto versi con i primi quattro a rima baciata a due a due e gli altri quattro che formano come un ritornello. La poesia è costruita a livello metaforico (anch’esso classico): la nave come la nazione, il suo capitano il presidente, le tempeste le guerre civili; anche l’amore del popolo è reso con l’immagine della folle trionfante al ritorno della nave in porto. E’ che qui Withman si vuole porre come cantore della giovane patria, ma attraversata da tensioni e lutti. Eppure nessuna forza contraria è riuscita a limitare il suo anelito di libertà.
Ci piace concludere le poche parole spese su Withman con una riflessione tratta dall’Enciclopedia Garzanti della letteratura. “La poesia di Withman si radica profondamente in quel pianeta americano da cui ogni singola “foglia d’erba” trae energia vitale. Nella loro straordinaria intensità i versi di Withman riescono, grazie a una precisione elencatoria che non si fa mai pura cronaca né compiaciuta descrittività, a raggiungere un profondo misticismo. sia quando cantano un amore paganamente puro, sia quando si soffermano attoniti di fronte allo spettacolo della morte, sia quando tracciano figure di operai e di cocchieri in una notte d’inverno, o celebrano il progresso nella vigorosa immagine della ferrovia, essi trascendono il proprio oggetto per immergerlo in un campo di energia ritmica e psichica ben più vasto. Ed è questa la lezione che Withman trametterà ai suoi eredi più recenti, i poeti della «beat generation» e in particolare ad Allen Ginsburg”
 Oh capitano! Mio capitano! da L’attimo fuggente di Peter Weir (1989)
Oh capitano! Mio capitano! da L’attimo fuggente di Peter Weir (1989)
Anche la narrativa presenta delle opere la cui eco varcherà i confini nazionali; tuttavia il romanzo americano presenta all’interno di sé una componente culturale e religiosa che prende il nome di “trascendentalismo”. Carlo Izzo, anglista, lo definisce “un generico idealismo che si rifaceva a grandi linee a Platone e a Kant; l’affermazione della profonda rispondenza del microcosmo al macrocosmo, o dall’anima individuale con l’anima dell’universo…; un individualismo spinto in alcuni dei maggiori rappresentanti all’estremo; un’imprecisa aspirazione, in alcuni, a creare un’organizzazione sociale basata su principi di assoluta uguaglianza di diritti e di doveri”.
Tali aspetti si possono trovare nella figura di Nathaniel Hawthorne, nato nel 1804, da genitori discendenti dai primi colonizzatori puritani. Rimasto orfano del padre, fu costretto dalla madre ad una vita reclusa che lo iniziò con severità alla conoscenza e al culto delle tradizioni puritane. Pochi i fatti notevoli: sicuramente sei mesi nella Brook Farm dei trascendentalisti, la sua profonda amicizia con Melville, l’incarico come console in Inghilterra dal 1853 al 1857, due anni in Italia. Muore nel 1864. La sua opera maggiore è La lettera scarlatta del 1850:
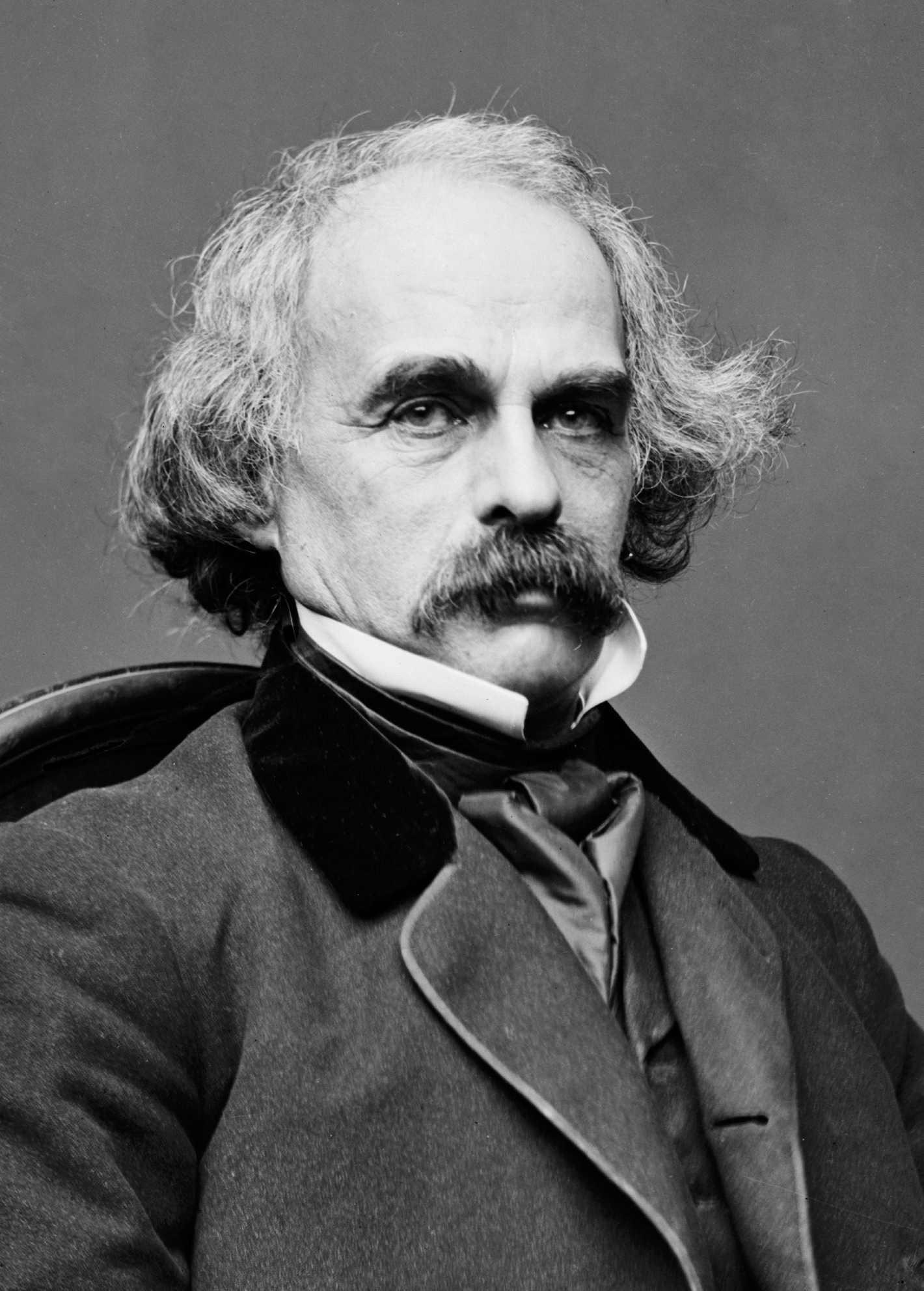 Nathaniel Hawthorne
Nathaniel Hawthorne
La vicenda – che l’autore, nell’introduzione dichiara di aver tratto da un documento scoperto negli archivi della dogana di Salem – si svolge nella Boston puritana del sec. XVII. Hester Prynne, che ha preceduto nel Massachusetts il marito, un anziano scienziato inglese, ha avuto una figlia, la piccola Pearl, da un amore “illegittimo” e viene crudelmente punita secondo le leggi del tempo: esposta sul palco della gogna, è condannata a portare per tutta la vita sul petto la simbolica lettera A (Adultera), da lei stessa ritagliata in un “bel panno scarlatto” e bordata da ricami bizzarri e arabeschi dorati. Interrogata, Hester continua ostinatamente a tacere il nome del suo amante. Il marito, dato per morto in un naufragio, è riuscito invece a scampare al mare e agli indiani; e arriva a Boston in tempo per assistere alla punizione di Hester. Le impone di non rivelare la sua presenza e, sotto il falso nome di Chillingworth, si mette alla ricerca del complice dell’adulterio della moglie. Riesce a scoprirlo: si tratta del giovane reverendo Dimmesdale, che soffre profondamente del suo peccato ma è troppo orgoglioso per accusarsi. Alla fine, tormentato dalla persecuzione di Chillingworth, che lo segue dappertutto implacabile, Dimmesdale cede: confessa pubblicamente la propria colpa e muore, stroncato dall’emozione.
NEGLI OCCHI DELLA FIGLIA
La verità è che questi piccoli puritani, figli della razza più intransigente che sia mai vissuta, indovinavano in quella madre e in quella figlia qualcosa di strano, di singolare, di dissimile da loro, le disprezzavano e non si peritavano di esprimere spesso ad alta voce il loro disprezzo. Pearl intuiva questo sentimento e lo ricambiava con un odio così profondo quale sembrava non poter allignare in un cuore di bimba. Questi scoppi d’ira erano, in un certo senso, di conforto per Hester, perché presupponevano una persona di carattere, più di quanto le ambigue manifestazioni di Pearl potessero far supporre. Ma in ciò essa vedeva pure il riflesso di quell’angoscia che una volta l’aveva perseguitata, perché la piccola aveva ereditato tutto quell’odio e quella collera che in altri tempi avevano straziato il suo cuore. Madre e figlia vivevano al bando della comunità sociale, e nella natura della piccina sembrava perpetuarsi quello stato d’animo che aveva caratterizzato Hester prima della nascita di Pearl e di cui la maternità cominciava ora a smorzare la violenza.
Quando giocava attorno alla capanna, Pearl non sentiva affatto della mancanza di una compagnia infantile. Da lei si sprigionava come un incantesimo di vita che si comunicava agli oggetti circostanti, come una torcia che propaga il fuoco a tutto ciò che sfiora. Al tocco fatato della sua mano, le cose più disperate – uno bastone, uno straccio, un fiore – senza mutare nella del loro aspetto esterno, divenivano com per incanto spiritualmente adatte commedia che in quel momento si rappresentava. La sua voce infantile era la voce di una moltitudine di personaggi, vecchi e giovani. I pini, annosi, cupi e solenni, che stormivano o sussurravano al vento, si trasformavano nei maggiorenti dei puritani, mentre le erbacce erano i loro ragazzi, e contro di essi specialmente si accaniva l’ira di Pearl. Ma in questi giochi meravigliosi cui si abbandonava la mente, non esisteva un linea di continuità: ora, infatti, essa si dava a correre e a danzare, quasi in preda ad uno stato di sovreccitazione, ora si accasciava in terra, quasi esausta da quella rapida e febbrile attività, per abbandonarsi subito dopo seguite a un altro scoppio d’energia. Tutto ciò richiamava in un certo modo alla mente i fantasmagorici giuochi dell’aurora boreale. Non che Pearl, per fantasia ed umore si differenziasse molto dagli altri ragazzi: sotto un certo punto di vista, era logico che essa in mancanza di compagni di gioco, si abbandonasse ai fantasmi della propria immaginazione: la stranezza consisteva nell’ostilità con cui essa considerava tutte queste creature del suo cuore e della sua mente. Mai uno di questi esseri le fosse amico! Sembrava godesse a seminare il terreno di denti del drago e che da ciascuno di essi nascesse un nemico contro il quale ella si scagliava con disperata energia. Nulla di più triste per il cuore di una madre che ne conosce la causa, di vedere questa visione di un mondo perennemente ostile in una creatura tanto giovane, di queste energie tese continuamente a difendere i propri diritti in immaginarie contese!
Osservando Pearl, spesso Hester Prynne posava il lavoro sulle ginocchia e gemeva, con una angoscia che tentava invano di nascondere: «O Padre Celeste – se ancora posso chiamarti mio Padre – chi è questo essere che ho messo al mondo?». E Pearl che udiva questa preghiera, o che, per qualche misterioso intuito, si rendeva conto di quell’angoscia, volgeva il viso alla madre, le sorrideva in modo misterioso e tornava di nuovo ai suoi giuochi.
Ma non abbiamo ancora parlato di una singolarità della bimba. La prima che parve interessarla e preoccuparla non fu, no, il sorriso della madre, a cui gli altri bimbi con quella smorfia della piccola bocca, intorno alla quale nascono tante discussioni per stabilire se sia stato o no un sorriso. La prima cosa di cui Pearl sembrò rendersi conto fu – indovinate? – la lettera scarlatta sul petto della madre. Un giorno, mentre Hester si chinava sulla sua culla, gli occhi della piccola si fissarono sul ricamo d’oro che circondava quel simbolo d’infamia; e le sue piccole mani si stesero per afferrarlo, mentre il suo volto s’illuminava di un sorriso, ma di un sorriso singolare che la faceva apparire stranamente più vecchia. Trattenendo il respiro, Hester aveva nascosto con un movimento istintivo quel segno fatale tentando di strapparlo, tanto quel gesto della piccina la straziava, ma Pearl, come se la madre scherzasse, l’aveva fissata negli occhi sorridendo. Da quel momento era cominciato per Hester un supplizio continuo, che aveva tregua solo quando la bambina dormiva. A volte, è vero, passavano intere settimane senza che lo sguardo di Pearl si posasse sulla lettera scarlatta; poi un giorno, all’improvviso, i suoi occhi la fissavano e il suo volto s’illuminava di quello strano sorriso che tanto male faceva a Hester.
Una volta, mentre, come le madri amano spesso fare, Hester cercava la sua immagine negli occhi della figlia, in questi balenò ad un tratto quello sguardo misterioso e crudele, ed essa – le donne sole e turbate si abbandonano spesso a sili fantasie – credette di scorgere in quel piccolo specchio nero non la sua immagine rimpicciolita, ma un altro volto, ostile, pieno di sorridente malizia, un volto che essa ben conosceva, ma che raramente aveva visto sorridere e mai esprimere tale cattiveria. Era come se uno spirito maligno si fosse impossessato della bimba e si divertisse a dimostrare la propria esistenza. Questa illusione si ripeté altre volte, sebbene in modo molto più confuso.
Un pomeriggio d’estate, Pearl, che era già abbastanza grande per camminare da sola, si divertiva a raccogliere fiori di prato e a gettarli in grembo alla madre, abbandonandosi a movenze di gioia degne di un elfo ogni volta che le capitasse di colpire la lettera scarlatta. Il primo impulso di Hester era stato quello di coprirsi il petto con le mani, sia per orgoglio, sia per rassegnazione, sia perché credesse che questa nuova pena la rendesse più meritevole agli occhi di Dio, dominò il suo istinto e, fissando tristemente gli occhi folli di Pearl, rimase a sedere, dritta e pallida come una morta. La piccina continuò a gettare fiori, prendendo sempre come bersaglio il simbolo di infamia ed infliggendo al cuore di quella povera madre che nulla poteva rimarginare su questa terra e che persino nell’altra vita l’avrebbero ancora tormentata. Alla fine, esauriti i proiettili, Pearl si fermò, guardando Hester in silenzio, mentre nei suoi profondi occhi neri (così almeno sembrò alla donna) balenava quella nota, sorridente immagine di spirito maligno.
«Figlia mia, chi sei tu?» gridò la madre.
«Sono la tua piccola Pearl!» rispose la bimba, e nel pronunciare queste parole rideva e saltava come un diavoletto che stesse per involarsi dalla cappa del camino.
«Sei davvero mia figlia?» insistette Hester, né la sua era una vana domanda, perché dubitava di venire a capo di quella specie di incantesimo che circondava l’esistenza della sua creatura.
«Sì, sono la tua piccola Pearl!» ripeté la bimba, continuando nei suoi giochi.
«Tu non sei mia figlia! Tu non sei la mia Pearl!» proruppe la madre, quasi in tono scherzoso, poiché spesso una specie di strana ilarità si mescolava al suo dolore. «Dimmi dunque chi sei e chi ti ha mandato qui».
«Dimmelo tu, mamma!» – rispose la bimba, seria, avvicinandosi a Hester e abbracciandole le ginocchia. «Dimmelo tu!»
«Ti ha mandato il tuo Padre Celeste».
Ma la brava esitazione che aveva preceduto queste parole, non sfuggì a Pearl che, spinta dalla sua bizzarria ed ispirata da qualche cattivo demone, sollevò la piccola mano e indicò la lettera scarlatta.
«E’ questo che mi ha mandato! – gridò pronta. «Io non ho un Padre Celeste!»
«Zitta, Pearl, zitta! Non parlare così!» – ribatté Hester, trattenendo a stento le lacrime. «Solo Lui ci ha messi tutti a questo mondo. Solo Lui ha messo al mondo me, che sono tua madre, e poi, molto tempo dopo, anche a te. E se non fosse così, da dove saresti venuta tu, piccolo e strano folletto?»
«Dimmelo! dimmelo!» ripeté Pearl, che non era più seria come prima, ma già rideva e ricominciava a cogliere fiori. «Proprio tu devi dirmelo! »
Ma Hester non poteva rispondere perché il suo animo era pieno di dubbi. Ricordava tra un sorriso e un brivido, le ciarle della gente che, notando lo strano carattere della bimba ed ignara della sua origine, la diceva figlia del demonio, uno di quegli esseri che, sin dai primi tempi del cattolicesimo, si favoleggiava fossero sparsi sulla terra, nati da un peccato di donna e destinati a mal operare. Lutero, secondo l’accusa dei monaci suoi nemici, apparteneva a questa razza infernale; né, fra quei puritani della Nuova Inghilterra, Pearl era la sola sospettata di così infausti natali.
 Immagine tratta da una scena del film tratta dal romanzo (1995)
Immagine tratta da una scena del film tratta dal romanzo (1995)
Questo passo si può definire emblematico all’interno del percorso non solo narrativo, ma morale di Hawthorne: la figura di Pearl non è “reale”, ma proiezione del senso di colpa di Hester: potremo addirittura affermare che se il narratore è esterno, la focalizzazione è interna. Per questo troviamo il brano proposto è piuttosto inquietante, ma è la stessa inquietudine della protagonista che vede nella piccola Pearl (il cui significato è Perla, così come appare in molte traduzioni) una trasfigurazione diabolica che, oltre alla “A”, le rinfaccia il suo peccato. Ma ci piace notare che l’animo di Hester, il suo senso di colpa, la fermezza ed il “necessario” dolore con la quale lo affronta (al contrario di Dimmesdale, padre della bambina, non in grado di sostenerlo e quindi lo pagherà in modo maggiore, con la morte) rappresenta lo stessa meditazione religiosa dell’autore che, sulla base del suo avvicinamento al trascendentalismo, vorrebbe liberare Esther dal peccato in quanto “la natura è la sola amica dell’uomo… affannarsi sui problemi del peccato, della predestinazione, della dannazione è inutile” (Cunliffe), ma la sua formazione pietista lo porta a considerare che l’espiazione del peccato è necessaria per ottenere la vera libertà.
Amico carissimo di Nathaniel Hawthorne è Herman Melville, autore di racconti marinareschi, tra i quali spicca il Moby Dick.
 Herman Melville
Herman Melville
Herman Melville nasce a New York nel 1819: lui stesso ci afferma che la sua università è stata il mare; s’imbarca infatti giovanissimo a 17 anni e per otto anni attraversa gli oceani, riportando varie avventure e l’esperienza di paesi visitati. Tutto ciò farà parte della sua produzione letteraria che all’inizio comprenderà opere come Taipi e Omoo di largo successo. Del 1851 scrisse il suo capolavoro, il Moby Dick, ma l’opera non ebbe un buon riscontro, portando lo scrittore a vivere con difficoltà per far fronte ai suoi problemi familiari. Cerca una più stabile condizione economica e diventa per questo doganiere, attività che condurrà fino alla fine dei suoi giorni. Muore nel 1891.
Il giovane Ishmael, narratore e testomone, salpa sulla baleniera “Pequod”, capèitanata da Achab. Questi ha giurato vendetta a Moby Dick, una possente e maligna balena bianca che in un viaggio precedente gli ha troncato una gamba. L’equipaggio teme il diabolico mostro, ma è ipnotizzato dalla sete di vendetta del capitano e lo segue. Inizia così un inseguimento che si protrae sui mari di tre quarti del globo. Il clima snervante di attesa offre lo spunto per lunghe riflessioni di carattere filosofico, in cui la bianchezza dell’ineffabile balena diventa metafora di realtà trascendenti la comprensione umana. L’indiano Queequeg, l’unico vero amico di Ishmael, morirà prima della fine della vicenda, dopo essersi costruito una bara su cui intarsia strani geroglifici. La caccia vera e propria è descritta soltanto negli ultimi tre capitoli: Moby Dick, avvistata e poi arpionata, trascina in una folle corsa le lance della baleniera, annientando nave ed equipaggio, e trascinando nell’abisso lo stesso Achab, crocefisso sul suo dorsi dalle corde degli arpioni. L’unico sopravvissuto è Ishmael, che scampa alla morte utilizzando la bara di Queequeg come imbarcazione di fortuna.

L’ULTIMA GIORNATA DI CACCIA
«Fermi, marinai! Il primo che soltanto fa il gesto di saltar giù da questa mia lancia, io lo rampono». Voi non siete altri uomini, ma siete le mie braccia e le mie gambe: perciò obbeditemi… Dov’è la balena? Di nuovo sott’acqua?»
Ma guardava troppo vicino alla lancia, perché Moby Dick, come se intendesse fuggire con il cadavere che portava, e come se il particolare luogo dell’ultimo incontro non fosse stato che una tappa nel suo viaggio a sottovento, aveva ripreso a nuotare risolutamente, ed aveva quasi superato la nave; quest’ultima, sinora, aveva fatto vela nella direzione contraria alla sua, quantunque in quel preciso momento fosse ferma. La balena pareva nuotare alla massima velocità, intenta soltanto a seguitare dritta per la sua strada, sul mare.
«Oh! Achab!» gridò Starbuck «nemmeno ora, nemmeno il terzo giorno, è troppo tardi per desistere. Guarda! Moby Dick non ti cerca. Sei tu, tu, che insensato cerchi lei». Disponendo la vela al vento che si alzava, la lancia solitaria fu spinta rapidamente a sottovento, dai remi e dalle vele insieme. Ed infine, quando Achab fu così vicino alla nave da poter chiaramente distinguere la faccia di Starbuck mentre si sporgeva dalla ringhiera, lo chiamò dicendogli di virare la nave e seguirlo, non troppo in fretta, ad una giusta distanza. Guardando in alto, vide Tashtego, Queequeg e Daggoo che montavano la guardia, attenti, alle tre teste d’albero, mentre i rematori oscillavano nelle due lance sfondate che erano state allora issate di fianco, affaccendati a ripararle. Mentre filava via, Achab ebbe, uno dopo l’altro, una rapida visione di Stubb e Flask attraverso i portelli, anch’essi indaffarati in coperta in mezzo a fasci di ferri nuovi e lance. Mentre vedeva tutto questo, mentre udiva i colpi di martello nelle imbarcazioni schiantate, fu come se ben altri martelli gli conficcassero un chiodo nel cuore. Ma raccolse le forze. E allora, accortosi che la banderuola, o vessillo, era sparita dalla testa dell’albero maestro, urlò a Tashtego, che proprio allora era arrivato su quel posatoio, di scendere di nuovo per prendere un’altra bandiera, un martello e dei chiodi e così inchiodarla all’albero.
Sia che la balena fosse affaticata dalla caccia di tre giorni e dalla resistenza che opponevano al suo nuoto le pastoie annodate in cui si trovava, sia che vi fossero in lei perfidie e malizie nascoste, comunque fosse la verità, la velocità della Balena Bianca prese a diminuire, almeno così parve dal fatto che la lancia le si riavvicinava rapidamente; quantunque, in verità, l’ultima corsa dell’animale non fosse stata così lunga quanto la prima. E sempre, mentre Achab correva sulle onde, i pescecani spietati lo accompagnavano, e con tanta ostinazione si attaccavano alla lancia, e così di continuo mordevano i remi arrancanti, che le pale furono tutte intaccate e schiacciate, lasciando piccole schegge nel mare, quasi a ogni tuffo.
«Non badateci! Quei denti fanno soltanto da nuove scalmiere ai vostri remi. Vogate! È un sostegno migliore la mascella del pescecane che l’acqua cedevole».
«Ma ad ogni morso, signore, le pale diventano sempre più piccole!»
«Dureranno lunghe quanto basta! Vogate!… Ma chi può dire – mormorò – se questi pescecani nuotano per pascersi della balena o di Acab?… Ma vogate! Sì, tutti all’erta, adesso, le siamo vicini. Il timone! Prendi il timone, fammi passare» e così dicendo, due rematori lo aiutarono ad andare sulla prora, mentre la lancia continuava la sua corsa.
Finalmente, mentre l’imbarcazione, gettata da un lato, arrivò correndo ad allinearsi al fianco della Balena Bianca, questa parve stranamente indifferente al suo arrivo, come le balene talvolta fanno, ed Achab si trovò proprio dentro alla montagna nebbiosa di vapore che, gettata dallo sfiatatoio della balena, si ravvolgeva intorno alla sua grande gobba da Monadnock.
Così vicino le era giunto Acab quando, con il corpo inarcato all’indietro e tutt’e due le braccia alzate e distese, per equilibrarsi, scagliò il ferro feroce e la maledizione ancor più feroce verso l’odiata balena. Mentre acciaio e maledizione affondavano fino al manico, come succhiati in una palude, Moby Dick si contorse sul fianco, spasmodicameme sfregò il fianco che le era più vicino contro la prua e, senza produrvi la minima falla, rovesciò così all’improvviso la lancia che, se non fosse stato per la parte elevata del parabordo cui si era aggrappato, Achab sarebbe stato scaraventato in mare un’altra volta. Accadde invece che tre rematori, che non conoscevano l’istante preciso del lancio, ed erano perciò impreparati ai suoi effetti, vennero sbalzati fuori; ma caddero in tal modo che, in un attimo, due di essi afferrarono il parabordo e, sollevandosi al livello della lancia sulla cresta di un’onda, vi si buttarono nuovamente dentro di peso, mentre il terzo cadeva senza scampo a poppa, ma rimaneva sempre a galla, nuotando.
Quasi contemporaneamente, con una possente decisione di totale, istantanea velocità, la Balena Bianca si gettò nel mare ribollente. Ma quando Achab gridò al timoniere di dar nuovamente volta alla lenza e di tenerla così, e comandò all’equipaggio di voltarsi sui sedili e di tirare la lancia fino al segno, la lenza traditrice, nel momento in cui sentì il doppio sforzo e la tensione si ruppe nell’aria vuota!
«Che cosa si spezza in me? Qualche nervo si spacca!… Tutto a posto, di nuovo! I remi, i remi! Balzatele addosso!»
Udendo lo slancio terribile dell’imbarcazione che squassava il mare, la balena si rigirò per presentare la pallida fronte a difesa, ma in quell’evoluzione, scorgendo lo scafo nero della nave che si avvicinava, e apparentemente vedendo in esso la fonte di tutte le sue persecuzioni, considerandolo, forse, un nemico più grande e più nobile, improvvisamente discese sulla sua prua avanzante sbattendo le mascelle tra impetuosi rovesci di spuma.
Achab vacillò, si batté la fronte con la mano: «Divento cieco: oh, mie mani! Allungatevi davanti a me, che io possa ancora trovare a tastoni la strada. È vicina?
«La balena! La nave!» urlarono i rematori annientati.
«I remi, i remi! Mettiti a pendio verso i tuoi abissi, o mare, che, prima che sia troppo tardi, Achab possa scivolare quest’ultima volta al suo segno! Io vedo: la nave! La nave! Balzate innanzi marinai! Non salverete la mia nave?»
Ma mentre i rematori forzavano violentemente la lancia attraverso i marosi che erano come magli, le estremità di prua di due tavole, precedentemente colpite dalla balena, si schiantarono, e, in un attimo, la lancia, momentaneamente immobilizzata, giacque quasi al livello delle onde mentre l’equipaggio, mezzo in acqua e ammollato, cercava in ogni modo di chiudere la falla e riversare fuori l’acqua che irrompeva.
Frattanto, nell’attimo in cui la scorse, a Tashtego, sulla testa d’albero, il martello rimase sospeso in mano, e la bandiera rossa, che lo avvolgeva a mezzo come un mantello, scivolò via da lui, come se fosse il suo cuore a volar via, mentre Starbuck e Stubb, ritti sul bompresso sotto, s’avvidero insieme con lui del mostro che sopraggiungeva.
«La balena, la balena! Timone a sopravvento, timone a sopravvento! Oh, tutte voi, dolci potenze dell’aria, abbracciatemi stretto! Che Starbuck non muoia, se deve morire, in un deliquio da donna! Timone a sopravvento, dico… a voi, sciocchi, la mascella! La mascella! È questa la fine di tutte le mie ardenti preghiere? Di tutte le mie fedeltà, lunghe una vita? Oh, Achab, Achab, ecco cosa hai fatto! Fermo, timoniere, fermo! No, no! Timone a sopravvento, di nuovo! Si volta per venirci incontro! Oh, la sua fronte implacabile avanza alla volta di uno cui il dovere dice che non può andarsene. Mio Dio, stammi vicino, ora!»
«Non starmi accanto, ma sotto, chiunque tu sia che ora aiuterai Stubb: perché Stubb, anche lui, rimane qui. Io ghigno a te, a te ghignante balena! Chi mai ha aiutato Stubb, o ha tenuto sveglio Stubb, se non l’occhio vigile di Stubb? Ed ora, il povero Stubb se ne va a letto su un materasso che è fin troppo soffice: se fosse imbottito di rovi! Io ghigno a te, a te ghignante balena! Attenti, voi, sole, luna e stelle, io vi dichiaro assassini di uno dei più buoni compagni che mai abbia sfiatato la sua anima. Con tutto ciò io tuttavia brinderei con voi, se soltanto voi porgeste la coppa! Oh, oh, oh! Tu balena ghignante! Ma presto ci saranno gran gorgoglii! Perché non fuggì, Achab? Quanto a me, via le scarpe e la giacca: che Stubb muoia in mutande! La morte più muffita e un po’ troppo salata, però; ciliegie! Ciliegie! Ciliegie! Oh, Flask, se avessimo una ciliegia rossa, prima di morire!
«Ciliegie? Io desidererei soltanto che fossimo là dove crescono. Oh, Stubb, spero che la mia povera madre abbia già ritirato la mia parte di paga, altrimenti adesso le toccherebbero quattro soldi, perché il viaggio è finito».
Sulla prua della nave, quasi tutti i marinai ciondolavano ora inerti; martelli, pezzi di tavole, lance e ramponi, tenuti macchinalmente in mano, così come erano accorsi dalle loro varie occupazioni, tutti gli occhi incantati fissi sulla balena che, vibrando stranamente la testa predestinata da parte a parte, gettava avanti a sé, mentre correva, una larga fascia di schiuma che si spargeva a semicerchio. Castigo, rapida vendetta ed eterna malvagità apparivano in tutto il suo aspetto, e ad onta di tutto quanto l’uomo mortale potesse fare, il massiccio contrafforte bianco della sua fronte urtò sulla destra la prua della nave, tanto che uomini e travi vacillarono. Alcuni caddero a faccia in giù. Come pomi d’albero spostati, arriva, le teste dei ramponieri dondolarono sui loro colli taurini. Sentirono le acque scrosciare attraverso la falla, come torrenti di montagna in una gola.
«La nave! Il carro funebre, il secondo carro funebre!» gridò Achab dalla lancia.
«Il suo legno non poteva essere che americano!»
Tuffandosi sotto la nave che si abbassava, la balena passò per il lungo sotto la chiglia, che rabbrividì; poi, rivoltandosi sott’acqua, risalì veloce alla superficie, lontano, dall’altra parte della prua, ma a poche yarde dalla lancia di Acab, dove, per qualche tempo, giacque tranquilla.
«Io volto la schiena al sole. Oh, Tashtego, fammi udire il tuo martello. Oh, voi, mie tre guglie non arrese, tu, chiglia intatta e tu, scafo, minacciato soltanto da un dio; tu, sicura coperta, tu timone superbo, e tu prua, puntata sulla Stella Polare! Nave gloriosa fino alla morte! Devi dunque perire, e senza di me? Devo io essere privato dell’ultimo caro orgoglio che anche i più vili capitani naufraghi hanno? Oh, solitaria morte di una vita solitaria! Oh, io sento che ora la mia maggiore grandezza dimora nel mio più grande dolore. Oh, oh! Da tutti i vostri limiti più lontani, riversatevi ora qui, voi arditi flutti della mia vita trascorsa, e coronate questo grande maroso della mia morte! Io mi volgo verso di te, balena distruggitrice ma non vincitrice, fino all’ultimo io lotto con te: dal cuore dell’inferno io ti trafiggo; in nome dell’odio, io vomito il mio ultimo respiro su di te. Affondino tutte le bare e tutti i carri funebri in una pozza comune! E poiché né l’una né l’altra di queste due cose sono per me, che io allora ti rimorchi in pezzi, mentre continuo a darti la caccia, quantunque legato a te, a te dannata balena! Così, io scaglio il lancione!»
Il rampone venne lanciato, la balena colpita fuggì innanzi, con la velocità del fuoco, la lenza corse nella scanalatura, ma si imbrogliò. Achab fece per districarla: la sciolse, ma la volta volante lo afferrò intorno al collo e in silenzio, come i muti di Turchia strangolano la vittima, lo fece schizzare fuori dalla lancia, prima che l’equipaggio si rendesse conto che era sparito.
L’istante seguente, il pesante occhiello impiombato all’estremità del cavo volò via dal tino completamente vuoto, abbatté un rematore, e, colpendo il mare, disparve negli abissi.
Per un momento, l’equipaggio della lancia, impietrito, rimase immobile, poi tutti si voltarono. «La nave? Gran Dio, dov’è la nave?»
Presto, attraverso un’atmosfera vaga e nebbiosa, videro il suo fantasma obliquo che svaniva, come nei vapori della Fata Morgana; soltanto l’albero più alto era ancora fuori dall’acqua, mentre, inchiodati dall’infatuazione, o dalla fedeltà o dal Fato ai loro posatoi un tempo superbi, i ramponieri pagani mantenevano le vedette affondanti nel mare. Ed ora, cerchi concentrici si impadronirono anche della lancia solitaria, e di tutto il suo equipaggio, di ogni remo fluttuante, e di ogni palo di lancia, e facendo girare rapidamente in un vortice le cose animate e inanimate, trascinarono anche la più piccola scheggia del Pequod fuori vista.
Ma mentre gli ultimi flutti si rovesciavano a tratti sul capo sommerso dell’indiano all’albero maestro, lasciando ancora visibili pochi pollici dell’eretta alberatura, insieme con lunghe yarde sventolanti della bandiera che ondeggiava calma, assecondando i marosi distruggitori che quasi la toccavano, in quell’istante, un braccio rosso e un martello si levarono all’indietro nell’aria libera, nell’atto di inchiodare più saldamente la bandiera all’albero affondante. A uno sparviero marino che beffardamente aveva seguito il pomo di maestro nella sua discesa dalla sua naturale dimora fra le stelle, beccando la bandiera e disturbando Tashtego – a quest’uccello capitò di far passare la grande ala vibrante fra il legno e il macello: e contemporaneamente, sentendo quell’etereo sussulto, il selvaggio sommerso, di sotto, nel suo anelito di morte tenne fermo il martello, e così l’uccello dei cieli, con strida ultraterrene, il becco imperiale allungato in su e tutto il corpo prigioniero avvolto nella bandiera di Achab, andò a fondo con la nave, che, come Satana, non volle sprofondare nell’inferno finché non ebbe trascinato con sé una parte vivente del cielo, per farsene un elmo.
Ora piccoli uccelli volarono stridendo sul vortice ancora spalancato; una tetra spuma bianca sbatté contro i suoi orli precipiti, poi tutto si calmò, e il grande sudario del mare si distese come già si stendeva cinquemila anni fa.

Testo di difficile comprensione, come del resto l’intero romanzo. La difficoltà è nella quasi impossibilità di poter dare un significato simbolico definitivo ai due protagonisti del brano: Achab e Moby Dick. Achab potrebbe sia rappresentare l’uomo contemporaneo che tenta di prevaricare la natura, sia quella di un moderno Ulisse (di derivazione dantesca) che vuole conoscere l’inconoscibile, il segreto ultimo della natura e come Ulisse finirà per esserne inghiottito – la nave dell’eroe infernale fa l’identica fine della nave di Achab. La balena bianca, proprio per il suo biancore potrebbe rappresentare Dio, un Dio tuttavia vendicativo che, attraverso la citazione sempre dantesca di un contrappasso, si vendica dell’uomo che vuole vendicarsi, ma si vendica altresì di chi vuole sfidarlo, come un moderno Capaneo, oppure il suo contrario, rappresentante del demonio che mette sulla sua croce Achab che muore, come figura Christi, crocefisso dalle corde sulla sua schiena. Ma è la conclusione è di puro pessimismo: non solo l’uomo viene sconfitto nell’impari lotta, ma di quest’ultima non rimane traccia, lo stesso simbolo di Dio, l’uccello, rimane inchiodato sull’albero della nave, inabissandosi con essa: il mare ricopre ogni cosa e cancella le tracce.
Ma forse lo scrittore che ebbe maggiore influenza nella cultura europea fu Edgar Allan Poe: egli infatti, tramite la mediazione del padre della lirica moderna, Charles Baudelaire, insegnò al vecchio continente a superare le istanze romantiche, soprattutto laddove esse scadevano in un vago sentimentalismo, per entrare all’interno dell’inconscio, anticipando, un po’ alla stessa maniera di Hoffmann , Freud.
 Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Nasce a Boston nel 1809, da genitori attori girovaghi che lo abbandonano a due anni presso un ricco mercante, John Allen, che tuttavia non lo adottò. Il concetto di abbandono non lo abbandonerà mai e verrà in qualche modo amplificato dalla morte, in giovane età, della madre, inasprendo in tal modo, in modo inconscio, la paura dell’abbandono. Studia nella città dove gli Allen si spostano, frequentando in ultimo l’Università della Virginia. Accusato di debiti gioco torna a Boston, dove decide di arruolarsi, ma viene cacciato per palese indisciplina. Raggiunge la zia a Baltimora e comincia l’attività di giornalista, ma dove comincia a pubblicare le sue prime prove, senza mai ottenere una stabilità economica. Ha ventisei anni quando decide di sposarsi con la cugina quattordicenne, Maria Clemm, ma costei, come la madre, è una bellezza destinata a spegnersi con la morte, che avviene nel 1847, lasciando il poeta preda delle sue ossessioni; datosi all’alcool, venne trovato, privo di sensi in una strada di Baltimora, portato in ospedale, vi morirà pochi giorni per un attacco di delirium tremens: siamo nel 1849, Poe aveva appena 40 anni.
IL CROLLO DELLA CASA USHER
Durante un giorno triste, cupo, senza suono, verso il finire dell’anno, un giorno in cui le nubi pendevano opprimentemente basse nei cieli, io avevo attraversato solo, a cavallo, un tratto di regione singolarmente desolato, finche’ ero venuto a trovarmi, mentre già si addensavano le ombre della sera, in prossimità della malinconica Casa degli Usher. Non so come fu, ma al primo sguardo ch’io diedi all’edificio, un senso intollerabile di abbattimento invase il mio spirito. Dico intollerabile poiché questo mio stato d’animo non era alleviato per nulla da quel sentimento che per essere poetico è semipiacevole, grazie al quale la mente accoglie di solito anche le più tetre immagini naturali dello sconsolato o del terribile. Contemplai la scena che mi si stendeva dinanzi, la casa, l’aspetto della tenuta, i muri squallidi, le finestre simili a occhiaie vuote, i pochi giunchi maleolenti, alcuni bianchi tronchi d’albero ricoperti di muffa; contemplai ogni cosa con tale depressione d’animo ch’io non saprei paragonarla ad alcuna sensazione terrestre se non al risveglio del fumatore d’oppio, l’amaro ritorno alla vita quotidiana, il pauroso squarciarsi del velo. Sentivo attorno a me una freddezza, uno scoramento, una nausea, un’invincibile stanchezza di pensiero che nessun pungolo dell’immaginazione avrebbe saputo affinare ed esaltare in alcunché di sublime. Che cos’era, mi soffermai a riflettere, che cos’era che tanto mi immalinconiva nella contemplazione della Casa degli Usher? Era un mistero del tutto insolubile; né riuscivo ad afferrare le incorporee fantasticherie che si affollavano intorno a me mentre così meditavo. Fui costretto a fermarmi sulla insoddisfacente conclusione che mentre, senza dubbio, eistono combinazioni di oggetti naturali e semplicissimi che hanno il potere di così influenzarci, l’analisi tuttavia di questo potere sta in considerazioni che superano la nostra portata. Poteva darsi, riflettei, che una piccola diversità nella disposizione dei particolari della scena, o in quelli del quadro sarebbe bastata a modificare, o fors’anche ad annullare la sua capacità a impressionarmi penosamente; e agendo sotto l’influsso di questo pensiero frenai il mio cavallo sull’orlo scosceso di un oscuro e livido lago artificiale che si stendeva con la sua levigata e lucida superficie in prossimità dell’abitazione, e affissai lo sguardo, con un brivido però che mi scosse ancor più di prima, sulle immagini rimodellate e deformate dei grigi giunchi, degli spettrali tronchi d’albero, delle finestre aperte come vuote occhiaie.
Eppure in questa lugubre casa io ora mi proponevo di soggiornare per alcune settimane. Il suo proprietario, Roderick Usher, era stato uno dei miei lieti compagni di infanzia, ma molti anni erano trascorsi dal nostro ultimo incontro. Una sua lettera mi aveva tuttavia raggiunto in un luogo remoto del paese, una lettera che, dato il carattere insistentemente importuno del mittente, non ammetteva risposta che di persona. Questo scritto rivelava una viva agitazione nervosa. Usher parlava di una acuta malattia fisica, di un disordine mentale che l’opprimeva, e di un impaziente desiderio di vedermi, essendo io il suo migliore, anzi il suo unico amico intimo, nella speranza di ottenere un sollievo al proprio male grazie alla serenità della mia presenza. Era il modo con cui tutto ciò, e molt’altro ancora, era detto, era il cuore che apparentemente accompagnava una tale richiesta, che non mi permise di esitare; ecco perché avevo obbedito senza indugio a quella che seguitavo a considerare tuttora come una piuttosto strana ingiunzione.
Benché da ragazzi fossimo stati direi persino intimi, in realtà io sapevo assai poco del mio amico. La sua riservatezza abituale era sempre stata eccessiva. Sapevo però che la sua famiglia, di origine antichissima, era sempre stata conosciuta per una particolare sensibilità di temperamento che si era manifestata attraverso le età in molte opere di un’arte esaltata, e si era recentemente rivelata in ripetute e munifiche elargizioni benefiche, per quanto discrete, come pure in un fervore appassionato per le complicazioni, quasi più che per le bellezze ortodosse e facilmente riconoscibili, della scienza musicale. Ero pure al corrente di un particolare assai notevole, che cioè la stirpe degli Usher, pur vetusta qual era, non aveva mai fatto germogliare alcun ramo duraturo; in altre parole, la discendenza dell’intera famiglia si era tramandata sempre in linea diretta, e questo sin dai tempi più remoti, a eccezione di qualche variante trascurabile e del tutto temporanea. Era forse questa mancanza, rimuginavo mentre riandavo col pensiero all’accordo perfetto tra il carattere del luogo e il carattere universalmente noto delle persone che vi abitavano (e frattanto riflettevo sul possibile influsso che il primo, in cosi’ lungo trascorrere di secoli, poteva avere esercitato sul secondo), era forse questa mancanza di rami collaterali e la conseguente invariata trasmissione diretta da padre in figlio del patrimonio col nome, ad avere in fine talmente identificate le due cose, il luogo e la famiglia, da confondere il titolo originario della proprietà nello strano ed equivoco appellativo di “Casa degli Usher”, un appellativo che sembrava racchiudere, nella mente del contadiname che lo usava, tanto la casata quanto il maniero familiare.
Già ho detto che il solo risultato del mio esperimento alquanto puerile di affissare cioè lo sguardo nelle cupe acque dello stagno, era stato quello di approfondire la mia prima curiosa impressione. Non può esservi dubbio che la consapevolezza del rapido aumentare della mia superstizione, – infatti, per quale motivo dovrei definirla altrimenti? – era servita principalmente ad accelerare quest’aumento. Tale, lo sapevo da tempo, è l’assurda legge di tutti i sentimenti aventi come base il terrore. E poteva essere stato per questo motivo soltanto che, allorché tornai ad alzare gli occhi verso la casa, distogliendoli dall’immagine di essa riflessa nello stagno, subentrò nella mia mente un pensiero bizzarro, talmente bizzarro e paradossale, che lo riferisco unicamente per dimostrare quanto fosse intensa la forza delle sensazioni che mi opprimevano. Avevo talmente esaltata la mia fantasia al punto di credere realmente che su tutta la dimora e sulla tenuta pendesse un’atmosfera caratteristica ad esse e alle immediate vicinanze, atmosfera che non aveva alcuna affinità con l’aria del cielo, ma che si esaltava dagli alberi ammuffiti, dal grigio muro, dal silenzioso stagno, come un vapore pestilenziale e mistico a un tempo, opaco, tardo, appena percettibile, soffuso di una sfumatura plumbea.
Scuotendomi dall’animo quel che doveva essere stato un sogno, ripresi a osservare più da vicino l’aspetto reale dell’edificio. Il suo tratto più caratteristico sembrava consistere in una estrema vecchiezza. Lo scolorimento del tempo era stato enorme. Tutta la facciata esterna era ricoperta di una fungosità minutissima che pendeva dalle gronde come una intricata finissima ragnatela. Tutto ciò era nondimeno in dipendente da un decadimento vero e proprio. La muratura era rimasta intatta, e sembrava esservi una strana incongruenza tra le parti ancora perfettamente unite della costruzione, e lo stato di rovina delle singole pietre. In questo elemento caratteristico vi era molto che mi rammentava l’aspetto totale tipico di una vecchia opera in legno che sia rimasta per lunghi anni a marcire in un sotterraneo abbandonato, senza essere in alcun modo intaccata dall’aria esterna. Ma all’infuori di questo indice di decadenza dell’insieme, la costruzione non rivelava gravi tracce di instabilità. Forse l’occhio di un osservatore attento avrebbe saputo discernere una fessura appena percettibile che partendo dal tetto, sulla facciata dell’edificio, attraversava il muro in direzione obliqua sino a perdersi nelle imbronciate acque dello stagno.
Dopo aver notato tutte queste cose mi diressi verso la casa, lungo un breve viale selciato. Un domestico mi prese il cavallo, e io entrai sotto l’arcata gotica dell’ingresso. Un valletto dal passo felpato mi condusse da lì, silenziosamente, attraverso molti anditi bui, labirintici, sino allo studio del suo padrone. Molto di quel che incontrai sul mio cammino contribuì, non so perché, ad avvalorare quel senso di vaga paura cui già ho alluso. Mentre gli oggetti che mi circondavano, le decorazioni del soffitto, le fosche tappezzerie delle pareti, la nerezza d’ebano dei pavimenti, i trofei allucinanti e le armature che vibravano al mio passaggio con secco rumore metallico, erano cose alle quali, anche in altro ambiente, io ero stato abituato sin dall’infanzia, mentre non esitavo a riconoscere l’aspetto familiare di tutti questi oggetti, seguitavo tuttavia ad avvertire quanto straniate dal mio spirito fossero invece le fantasticherie che queste immagini, pur note, evocavano in me. Su una delle scale d’accesso incontrai il medico di famiglia. Ebbi l’impressione che il suo aspetto riflettesse un’espressione mista di bassa astuzia e di perplessità. Mi passò accanto trepidante e proseguì innanzi. Subito dopo il domestico spalancò un uscio e m’introdusse alla presenza del suo padrone.
La camera in cui venivo così a trovarmi era molto ampia e altissima. Le finestre lunghe, strette, a sesto acuto, erano talmente sopraelevate sul pavimento di quercia nera da risultare del tutto inaccessibili dall’interno. I deboli bagliori di una luce soffusa di vermiglio s’infiltravano attraverso i pannelli intrecciati e servivano a rendere sufficientemente distinti gli oggetti più in vista sparsi per la stanza; l’occhio si sforzava tuttavia invano di raggiungere gli angoli più riposti del locale, o i recessi del soffitto a volta tutto adorno di fregi. Dalle pareti pendevano scuri drappeggi. Il mobilio era sovraccarico, scomodo, antico, in cattivo stato. Sparsi tutt’attorno giacevano molti libri e strumenti musicali, i quali non riuscivano però a dare alcuna vitalità alla scena. Ebbi l’impressione di respirare un’atmosfera di dolore. Un senso di tetraggine greve, profonda, irriducibile, pendeva su tutto e tutto permeava.
Al mio entrare, Usher si alzò da un divano sul quale si trovava completamente sdraiato, e mi accolse con una vivacità e un calore in cui mi parve a tutta prima di intuire una cordialità eccessiva, un poco troppo rassomigliante allo sforzo obbligato dell’annoiato uomo di mondo. Mi bastò tuttavia uno sguardo al suo viso per convincermi della sua perfetta sincerità. Ci mettemmo a sedere e rimanemmo silenziosi per alcuni istanti, mentre io l’osservavo con un sentimento misto a pietà e quasi di paura. Certo non avevo mai veduto nessuno che in così breve periodo di tempo avesse subita una così spaventosa trasformazione quanto quella che vedevo nella persona di Roderick Usher! Stentavo ad ammettere a me stesso che quell’essere svanito che mi stava dinanzi era il compagno della mia prima giovinezza. Eppure il suo viso era sempre stato assai caratteristico. Una carnagione cadaverica; occhi grandi, liquidi, oltremodo luminosi; labbra alquanto sottili e pallidissime, ma delineate con insuperabile perfezione; un naso delicato, di profilo ebraico, ma con un’ampiezza di narici insolita in modelli analoghi; un mento finemente cesellato che rivelava nella sua eccessiva rotondità una mancanza di energia morale; capelli di una tenuità e di una sofficità addirittura vaporose; tutti questi tratti, insieme con un’espansione insolita delle regioni temporali, contribuivano a formare nel loro complesso una fisionomia non facilmente dimenticabile. Ed ecco che proprio nell’esagerazione del carattere prevalente di questi tratti, e dell’espressione che essi erano soliti rendere, consisteva l’enorme mutamento che mi faceva dubitare della identità di colui col quale stavo parlando. Ma soprattutto il pallore spettrale della pelle e la luminosità irreale dell’occhio mi colpì e persino mi impaurì più di ogni altra cosa. Anche i serici capelli erano stati lasciati crescere senza cura, e così scarmigliati e rabbuffati come se fossero intessuti di lievissimi fili di ragno, più che ricadere intorno al viso vi fluttuavano intorno, tanto da non permettermi, sia pure con uno sforzo, di connettere quella loro impressione di arabesco a un’idea purchessia di umanità vera e propria.
In quanto ai modi del mio amico fui subito colpito da una specie di incoerenza, di inconsistenza in essi, e ben presto mi accorsi che ciò derivava da tutta una successione di deboli e vani tentativi per padroneggiare uno stato di trepidazione abituale, un’agitazione nervosa eccessiva. In realtà ero stato preparato a questo lato del suo carattere non tanto dalla sua lettera, quanto dalle reminiscenze di certe sue caratteristiche infantili e dalle conclusioni che avevo tratte dalla sua costituzione fisica e dal suo temperamento specialissimi. I suoi gesti erano a volte vivaci, a volte pigri e scontrosi. La sua voce passava rapidamente da un tono di tremula indecisione (allorché gli spiriti animali sembravano completamente soggiogati) a quella specie di concisione energica, quell’eloquio brusco, pesante, tardo, cavo, quella pronunzia plumbea, perfettamente equilibrata e modulata, gutturale, che si riscontra nel bevitore incorreggibile o nell’incallito fumatore d’oppio, nei momenti in cui l’eccitazione della droga è particolarmente intensa.
Fu con questi accenti che egli mi parlò dello scopo della mia visita, del suo ardente desiderio di vedermi, e del conforto che si riprometteva da me. Si dilungò quindi a descrivermi quello che secondo lui era il carattere della sua malattia. Si trattava, mi spiegò, di un male costituzionale ed ereditario, e al quale disperava di trovare un rimedio; una semplice affezione nervosa, si affrettò a soggiungere, che senza dubbio si sarebbe ben presto dileguata. Questo disturbo si manifestava con una sequela di sensazioni innaturali: e alcune tra queste, a mano a mano che egli me le elencava, mi interessavano e mi stupivano, benché forse la loro efficacia risiedesse solo nelle parole e nel tenore generale della narrazione. Usher soffriva assai di una ipersensibilità morbosa; poteva sopportare soltanto il cibo più insipido; poteva indossare soltanto indumenti di un certo tessuto; il profumo di un qualsiasi fiore gli era intollerabile; anche la luce più debole era una tortura per i suoi occhi, e non vi erano che pochi suoni speciali, e soltanto quelli di alcuni strumenti a corda, che non lo riempissero di orrore.
Mi avvidi che era schiavo, legato mani e piedi, di una forma anomala di terrore. «Io morirò,» mi disse, «dovrò morire in questa disperata follia. Così, così, non altrimenti, mi perderò. Temo gli avvenimenti del futuro non di per se stessi, ma per i loro risultati. Rabbrividisco al pensiero di un fatto qualsiasi, anche il più comune che possa operare su questa agitazione intollerabile del mio spirito. In realtà non rifuggo dal pericolo, se non nel suo effetto assoluto, cioè il terrore. In questo stato di smarrimento dei nervi, in questa pietosa condizione, sento che sopraggiungerà presto o tardi il momento in cui mi vedrò costretto ad abbandonare la vita e la ragione insieme in qualche conflitto con il sinistro fantasma della paura.
Appresi inoltre per tratti e attraverso accenti rotti e ambigui, un altro curioso aspetto delle sue condizioni mentali. Usher si sentiva incatenato da certe superstiziose impressioni alla casa in cui dimorava e dalla quale più non usciva da molti anni, per un influsso la cui forza superstiziosa era resa in termini troppo incerti per essere qui ridescritti; un influsso ispiratogli nell’animo, mi disse, semplicemente da alcune caratteristiche nella forma e nella sostanza della sua dimora familiare; era un effetto, insomma, che l’elemento fisico delle grigie mura e delle torri e del cupo stagno in cui tutte queste cose si riflettevano aveva infine prodotto sull’elemento morale della sua esistenza.
Ammetteva tuttavia, se pure con esitazione, che gran parte della caratteristica tristezza che così lo affliggeva poteva essere fatta risalire a un’origine più naturale e assai più tangibile, cioè alla grave e prolungata malattia, o , per meglio dire, alle condizioni sempre più prossime alla morte, di una sorella teneramente amata che da molti anni era la sua unica compagna e la sua sola ed ultima parente sulla terra. «La sua morte», – mi diceva con un’amarezza che non potrò mai dimenticare, «lascerebbe me inutile e debole, ultimo superstite dell’antica razza degli Usher». Mentre parlava, lady Madeline (così si chiamava la sorella di Roderik) attraversò lentamente un tratto lontano della stanza, e senza aver notato la mia presenza scomparve. Io la guardai con indicibile stupore, cui si mescolava un guizzo di paura, senza che tuttavia mi fosse possibile spiegarmi questo mio stato d’animo. Mentre i miei occhi seguivano i suoi passi allontanantisi, mi sentii invadere da una sensazione di stupore. Quando finalmente un uscio si chiuse alle sue spalle, il mio sguardo cercò istintivamente e ansiosamente il volto del fratello, ma questi aveva nascosto la faccia tra le mani e io potei soltanto notare che le sue dita emaciate si erano fatte ancora più esangui e che erano irrorate da molte lagrime appassionate.
Il male di lady Madeline da molto tempo metteva a dura prova la perizia dei suoi medici. Una composta apatia, un consumarsi graduale della persona, attacchi frequenti sebbene transitori di natura parzialmente catalettica ne costituivano l’insolita diagnosi. Fino a quel momento ella aveva resistito contro l’incalzare del male, e non si era mai messa a letto definitivamente, ma sul finire di quella sera in cui ero giunto alla casa, fu costretta a cedere (come suo fratello mi riferì durante la notte in preda a un’agitazione indescrivibile) al potere distruttore del male; e seppi che l’occhiata fuggevole con cui avevo colto la sua persona sarebbe stata probabilmente l’ultima poiché la giovane donna, almeno finché fosse vissuta, non sarebbe più stata visibile.
Durante alcuni giorni consecutivi il suo nome non venne più pronunciato né da Usher né da me, e in questo periodo di tempo io feci del mio meglio per alleviare la malinconia del mio amico. Dipingevamo e leggevamo insieme, oppure io restavo ad ascoltare, come perduto in un sogno, le sconnesse improvvisazioni della sua chitarra parlante. E così, mentre una sempre più stretta intimità mi permetteva di entrare ancora più addentro ai recessi del suo spirito, con sempre maggiore amarezza io ero costretto a constatare la vanità di ogni tentativo di rallegrare una mente da cui le tenebre si riversavano come una qualità positiva e insita su tutti gli oggetti dell’universo morale e fisico, in un’unica incessante irradiazione di mestizia.
Porterò sempre con me la memoria delle lunghe ore solenni da me trascorse così in solitudine insieme al signore della Casa degli Usher. Fallirei tuttavia se tentassi di rendere comunque l’idea esatta del carattere, degli studi o delle occupazioni di cui egli mi metteva a parte o nei quali mi faceva da guida. Su tutto una idealità sovraeccitata e profondamente turbata gettava un chiarore sulfureo. Le sue lunghe estemporanee lamentazioni funebri echeggeranno in eterno entro le mie orecchie. Fra tante altre cose rammento soprattutto in modo particolarmente doloroso una certa strana perversione e amplificazione dello sfrenato motivo dell’ultimo valzer di Weber. Riguardo ai dipinti, su cui la sua complessa fantasia si lambiccava, e che svanivano a ogni tocco in una indefinitezza di cui io rabbrividivo tanto più profondamente quanto meno capivo il motivo del mio rabbrividire, riguardo a questi dipinti (per nitide che siano ora dinanzi a me le loro rappresentazioni) tenterei invano di descrivere più di quel poco che può essere racchiuso entro il cerchio delle semplici parole scritte. La scarna semplicità, la nudità dei suoi disegni fermavano e colpivano l’attenzione. Se mai essere mortale riuscì a dipingere un’idea, questo mortale è stato Roderick Usher. Per me almeno, nelle circostanze che allora mi attorniavano, si levava dalle pure astrazioni che il misantropo riusciva a fissare sulla propria tela, una tale intensità di terrore arcano e intollerabile, quale mai avevo sofferto, sia pur lontanamente, nemmeno nella contemplazione delle indubbiamente scintillanti e tuttavia troppo concrete bizzarrie fantastiche di Füssli.
Una però di queste concezioni fantasmagoriche del mio amico che meno rigidamente delle altre partecipava dello spirito dell’astrazione può essere adombrata con parole, sia pure inadeguatamente. Si trattava di un piccolo quadro rappresentante l’interno di una volta o galleria rettangolare, immensamente lunga, dai muri bassi, bianchi, lisci, senza alcuna interruzione o fregio. Alcuni punti accessori del disegno servivano efficacemente a suggerire l’impressione che questo scavo s’ingolfasse a profondità prodigiosa sotto la superficie della terra. In tutta la sua vasta estensione non era possibile notare alcuna via di uscita, ne’ era discernibile torcia alcuna, o altra fonte artificiale di luce; e tuttavia si diffondeva ovunque un fiotto di raggi intensissimi che immergevano il tutto in uno splendore abbagliante e spettrale.
Già ho accennato a quello stato morboso del nervo auricolare che rendeva intollerabile al paziente ogni specie di musica, a eccezione di alcuni effetti di strumenti a corda. Erano forse questi confini ristrettissimi entro i quali egli si rinchiudeva, limitandosi al solo uso della chitarra, a dare origine in gran parte al carattere fantastico delle sue esecuzioni. Non era pero’ possibile spiegare in tal modo la fervida facilità dei suoi improvvisi. Questi devono essere stati, ed erano in realtà, nelle note, come pure nelle parole delle sue vagabonde fantasie (poiché non di rado egli si accompagnava con improvvisazioni verbali rimate), il risultato di quella padronanza intensa di sé e di quella concentrazione mentale cui già ho alluso e che è osservabile soltanto in alcuni particolari momenti, allorché l’eccitamento artificiale raggiunge il suo colmo. Sono riuscito a ricordare facilmente le parole di una di queste rapsodie. Forse ne fui tanto più fortemente impressionato perché mentre egli me le recitava, nella corrente sotterranea o mistica del suo significato, mi parve di notare, e per la prima volta, una piena consapevolezza da parte di Usher del vacillare della sua ragione. Questi versi, che egli aveva intitolati “Il palazzo incantato”, correvano pressapoco così:
Nella più verde delle nostre valli,
da buoni angeli visitata,
un tempo un bello e solenne palazzo,
radioso palazzo, ergeva la sua fronte.
Nel regno del monarca Pensiero
esso si ergeva!
Mai serafino levò le ali
su struttura più bella.
Stendardi gialli, di gloria e d’oro,
sul suo tetto sventolavano
e garrivano (ciò’, tutto ciò, accadeva negli antichi,
antichissimi tempi lontani),
e ogni dolce brezza che indugiava,
in quel dolce giorno,
lungo i contrafforti piumati e pallidi,
un odore alato disperdeva.
Visitatori di quella valle felice
attraverso due luminose finestre
videro spiriti muoversi musicalmente,
all’intonato ritmo di un liuto,
intorno a un trono, dove seduto
(Porfirogene!)
in pompa addicentesi alla sua gloria,
appariva il governante del regno.
E tutta di perle e di rubini scintillante
era la stupenda porta del palazzo,
attraverso cui giungeva fluente, fluente,
fluente e in eterno sfavillante,
una coorte di Echi, il cui dolce compito
era soltanto di cantare,
con voci di ineguale bellezza,
l’ingegno e la saggezza del loro re.
Ma creature malvage, in vesti di lutto,
assalirono l’eccelsa dimora del monarca
(ah, piangiamo, poiché mai un domani
spunterà per lui, abbandonato!),
e, tutt’attorno alla sua dimora, la gloria
che sfavillava e lussureggiava
non é che una favola vagamente ricordata
dell’antico tempo sotterrato.
E ora i viaggiatori in quella valle,
attraverso le finestre soffuse di rosso lucore,
vedono vaste forme muoversi fantastiche
al suono di una melodia discorde;
mentre, simile a un fiume rapido e irreale,
attraverso la pallida porta,
una folla ripugnante si riversa precipite,
senza sosta, e ride; ma più non sorride.
 Scena di un film di Epstein del 1928 ispirato alla novella di Poe
Scena di un film di Epstein del 1928 ispirato alla novella di Poe
Ricordo perfettamente che le riflessioni provocate da questa ballata ci portarono lungo un corso di pensieri in cui si manifestò un’opinione di Usher che io cito non tanto per la sua originalità (poiché altri l’hanno manifestata parimenti), quanto per l’ostinatezza con cui egli l’affermava. Quest’opinione, così grosso modo, verteva sulla sensibilità di tutte le cose vegetali. Ma nella sua alterata fantasia questo concetto aveva assunto un carattere più audace, violando, entro determinate condizioni, il regno dell’inorganico. Mi mancano le parole per esprimere appieno tutto il sincero abbandono del suo convincimento. Questa sua certezza tuttavia era collegata (come già ho accennato) alle grigie pietre della dimora dei suoi padri. Le condizioni di sensibilità erano state qui adempiute, così egli immaginava, dal sistema di collocamento di queste pietre, dall’ordine della loro disposizione, nonché dal modo con cui le molte fungosità che le ricoprivano si erano predisposte, e dalla posizione degli alberi putrescenti che circondavano la dimora, ma soprattutto dalla lunga indisturbata durevolezza di questa sistemazione, e dal suo rifrangersi e sdoppiarsi nelle immote acque dello stagno. La prova di ciò, la prova della sensibilità, era rintracciabile, mi disse (e qui mentre egli parlava io trasalii), nella lenta e tuttavia certa condensazione di un’atmosfera propria emanante dalle acque e dalle mura. Tale risultato era scopribile, soggiunse, nella silente, e tuttavia conturbante e terrificante influenza che per secoli aveva plasmato i destini della sua famiglia, e che aveva fatto di lui quello che io ora vedevo, quello che egli era. Opinioni come queste non hanno bisogno di commento, ne’ io ne tenterò alcuno.
I nostri libri, libri che da anni costituivano non piccola parte dell’esistenza mentale dell’invalido, erano, come è facile supporre, in stretto rapporto con questo elemento fantastico. Insieme consultavamo opere quali la Vervet et Chartreuse di Gresset, Belfagor di Machiavelli; il Cielo e inferno di Swedenborg; il Viaggio sotterraneo di Nicholas Klimm di Holberg; la Chiromanzia di Robert Flud, Jean d’Indagine e De La Chambre; il Viaggio nella distanza azzurra di Tieck; e La città del sole di Campanella. Il nostro volume preferito era una piccola edizione in ottavo del Directorium Inquisitorium, del domenicano Eymeric de Gironne; e vi erano alcuni passi di Pomponio Mela, intorno agli antichi satiri ed egipani africani, sui quali Usher soleva riflettere, sognando, per lunghe ore. Il suo maggior diletto consisteva però nello studio assiduo di un volume in-quarto gotico straordinariamente raro e curioso, il manuale cioè di una chiesa dimenticata intitolato Vigiliae mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae.
Non potevo fare a meno di meditare ripetutamente sui misteriosi riti descritti in quest’opera e sui loro probabili influssi sull’ipocondriaco, allorché una sera, dopo avermi annunciato bruscamente che lady Madeline più non viveva, mi dichiarò la sua intenzione di conservarne il cadavere per un periodo di quindici giorni (prima dell’inumazione definitiva) in una delle numerose cripte che si aprivano sotto i muri maestri dell’edificio. La ragione naturale che egli mi diede di questo suo singolare modo di agire era tale ch’io non mi sentii in grado di discuterla. Egli era stato spinto a questa decisione (così mi spiegò) in considerazione del carattere insolito della malattia che aveva minato l’esistenza di sua sorella, nonché di alcune indiscrete e impazienti richieste da parte dei medici, e infine in considerazione della posizione lontana e scomoda in cui si trovava il luogo di sepoltura avito. Non negherò che rammentandomi l’aspetto sinistro del personaggio da me incontrato sulle scale il giorno del mio arrivo alla casa, non provai alcun desiderio di controbattere quella che consideravo una precauzione tutt’al più innocua, e per nulla affatto innaturale. Su richiesta di Usher lo aiutai personalmente a predisporre ogni cosa per quella tumulazione temporanea. Dopo aver posato il corpo nella bara lo trasportammo noi due soli sino al luogo del suo riposo. La cripta in cui lo riponemmo (e che era rimasta chiusa talmente a lungo che le nostre torce, semi soffocate in quell’atmosfera opprimente, ci concessero ben poca possibilità di fare indagini) era piccola, umida, totalmente sprovvista di aperture che permettessero ammissioni di luce, essendo scavata a grande profondità proprio sotto quella parte dell’edificio in cui si trovava la mia stanza da letto personale. Doveva essere probabilmente servita, negli antichi tempi feudali, agli oscuri e biechi scopi cui sono destinate le prigioni sotterranee, e in epoca più recente doveva essere stata usata come deposito di polveri, o di qualche altra sostanza ad alto potere combustibile, poiché un tratto del pavimento della cripta, e tutta la parte interna di un lungo passaggio coperto attraverso il quale si raggiungeva la cripta stessa, erano accuratamente ricoperti di lamine di rame. Anche la porta, in ferro massiccio, era stata parimenti protetta. Il suo peso immenso faceva sì che ogniqualvolta essa si muoveva sui cardini si udiva un suono raschiante, insolitamente aspro.
Dopo aver posato su alcuni trespoli il nostro funebre carico, affidandolo a quel luogo di orrore, scostammo parzialmente il coperchio non ancora avvitato della bara e ci fermammo a contemplare il volto della morta. In quel momento, per la prima volta, la mia attenzione fu attratta dalla somiglianza sorprendente che esisteva tra il fratello e la sorella, e Usher, indovinando forse il mio pensiero, borbottò alcune parole dalle quali compresi che lui e la morta erano stati gemelli, e che tra essi erano sempre esistiti legami di affinità di natura difficilmente comprensibile. I nostri sguardi pero’ non si soffermarono a lungo sulla defunta, che non potevamo fissare senza un arcano timore. La malattia che aveva condotto alla tomba la dama nel fiore della giovinezza aveva lasciato, come accade di solito in tutti i disturbi gravi di carattere tipicamente catalettico, la beffa di un debole rossore sul seno e sul volto, e quel sorriso misteriosamente indugiante sul labbro che è così terribile nella morte. Richiudemmo il coperchio e lo avvitammo, e dopo aver chiuso a chiave la porta di ferro risalimmo faticosamente verso gli appartamenti poco meno tetri della parte superiore della casa. E ora che erano trascorsi alcuni giorni di amaro dolore, subentrò nel disordine mentale del mio amico un mutamento sensibile. I suoi modi soliti erano scomparsi: le sue occupazioni ordinarie trascurate o dimenticate. Errava di stanza in stanza con passo affrettato, ineguale, senza una meta. Il pallore del suo volto aveva assunto se possibile una sfumatura ancora più spettrale, ma la luminosità del suo sguardo si era completamente spenta. Non avevo più inteso l’asprezza cava che di quando in quando assumeva la sua voce, ma adesso le sue parole erano abitualmente caratterizzate da un tremolio vibrante, come se egli vivesse di continuo in uno stato di terrore estremo. Vi erano momenti, in verità, in cui io pensavo che la sua mente senza posa agitata, fosse travagliata da qualche segreto divorante, e che egli lottasse con se stesso per trovare il coraggio necessario a rivelarlo. A volte invece ero costretto ad addossare ogni cosa alle inesplicabili divagazioni della pazzia, poiché lo sorprendevo a fissare nel vuoto per lunghe ore, in atteggiamento di attenzione profondissima, come se ascoltasse qualche suono immaginario. Non è da stupire se questo suo stato terrorizzasse e contagiasse anche me. Mi sentivo invadere per gradi lenti ma sicuri, dei forsennati influssi delle sue fantastiche e tuttavia ossessionanti superstizioni.
Fu soprattutto nel ritirarmi per la notte, la sera del settimo ed ottavo giorno dopo la deposizione nella cripta di lady Madeline, che io sperimentai tutta la violenza di tali sensazioni. Il sonno non giunse sino al mio letto, mentre le ore andavano dileguandosi, lente e inutili. Cercavo di combattere l’inquietudine nervosa che si era impadronita di me. Mi sforzavo di pensare che buona parte del mio stato d’animo era dovuto all’influsso deprimente del tetro mobilio che arredava la stanza, ai panneggi cupi e gualciti i quali ondeggiavano bizzarramente contro le pareti, torturati dal fiato impetuoso di un temporale prossimo, frusciando inquieti intorno alle decorazioni del letto. Ma i miei tentativi erano vani. A poco a poco tutto il mio essere fu pervaso da un tremito incontenibile e alla fine un vero e proprio incubo gravò sul mio cuore terrorizzandomi senza ragione. Riuscii a scuotermelo di dosso gemendo e dibattendomi strenuamente, mi rizzai a sedere sui cuscini, e appuntando ansiosamente lo sguardo nelle fitte tenebre che avvolgevano la stanza tesi l’orecchio (non so per quale ragione, se non forse perché ne fui suggerito da un impulso istintivo) a misteriosi rumori sommessi, indefiniti, che giungevano a lunghi intervalli, tra le pause dell’uragano, non sapevo da dove. Sopraffatto da un disperato senso di orrore, inspiegabile e tuttavia intollerabile, mi rivestii precipitosamente (poiché capivo che per quella notte non avrei più potuto dormire) e tentai con tutte le mie forze di strapparmi allo stato pietoso in cui ero caduto, mettendomi a passeggiare rapidamente innanzi e indietro per la stanza. Mi aggiravo così da pochi istanti, allorché un passo leggero sulla scala vicina attrasse la mia attenzione. Lo riconobbi quasi subito per il passo di Usher. Un istante dopo egli bussava con tocco discreto alla mia porta ed entrava reggendo una lampada. Il suo aspetto era come al solito cadavericamente esangue, ma adesso leggevo nei suoi occhi come una folle ilarità, e vi era evidentemente in tutto il suo comportamento come una contenuta isteria. I suoi modi mi atterrirono; ma tutto era preferibile alla solitudine che avevo sino a quel momento sopportata e anzi accolsi la sua presenza con un sospiro di sollievo.
«E tu non l’hai veduto?» mi chiese bruscamente dopo essersi guardato attorno per alcuni attimi in silenzio. «E tu non l’hai veduto dunque?… Ma, aspetta! Lo vedrai». Così dicendo e dopo avere accuratamente schermata la lampada si avvicinò a uno dei finestroni e lo spalancò completamente alla tempesta. La furia impetuosa dell’uragano irrompente per poco non ci sollevò da terra. Era in verità una notte tempestosa e pure paurosamente bella, e di una misteriosa stranezza nel suo affascinante terrore. Evidentemente doveva essersi raccolto in tutta la sua forza, nei dintorni, un turbine, poichè il vento subiva frequenti e violenti mutamenti di direzione, e l’estrema densità delle nubi (che pendevano tanto basse da premere addirittura contro le torri stesse della casa) non ci impediva di scorgere la velocità pazzesca con la quale accorrevano da ogni punto per cozzare le une contro le altre, senza mai disperdersi in lontananza. Ripeto che nemmeno la loro straordinaria densità ci impediva di notare questo, benché non ci fosse possibile scorgere né la luna né le stelle, né vi fosse alcun guizzo di folgore a illuminare la scena. Tuttavia le superfici inferiori di quella massa enorme di vapori in tumulto, come pure tutti gli oggetti terrestri che immediatamente ci circondavano, risplendevano di una luce innaturale per una esalazione gassosa, vagamente luminescente eppur distintamente visibile, che avvolgeva e avviluppava la dimora come un fosforescente sudario.
«Tu non devi… bisogna assolutamente che tu non veda questo!» dissi rabbrividendo a Usher mentre lo riconducevo con dolce violenza dalla finestra a un sedile. «Queste apparizioni che ti sconvolgono non sono che fenomeni elettrici tutt’altro che rari, a meno che non abbiano la loro paurosa origine nei miasmi fetidi dello stagno. Richiudiamo la finestra; l’aria è fredda e pericolosa per la tua salute. Ecco qui uno dei tuoi libri favoriti. Io leggerò, e tu rimarrai ad ascoltarmi; e così potremo superare insieme questa notte spaventosa.
L’antico volume che io avevo intanto preso in mano era il Mad Trist di sir Launcelot Canning, ma io lo avevo definito il preferito di Usher più in un attimo di scherzosa malinconia che con intenzione seria; poiché in realtà vi era ben poco nel suo andamento prolisso, anti immaginativo e grottesco che potesse produrre un vero e proprio interesse sull’animo altamente idealistico e spirituale del mio amico. D’altronde era il solo libro che avessi immediatamente a portata di mano, e mi cullavo nella vaga speranza che l’agitazione che attualmente torturava l’ipocondriaco potesse trovare sollievo persino in quel paradosso di follia che mi accingevo a leggere (poiché la cronaca dei disordini mentali è piena di anomalie siffatte). Se avessi potuto infatti giudicare dall’apparenza di eccessiva e ipertesa vivacità con la quale ascoltava, o pareva ascoltare, le parole del racconto, mi sarei ben potuto congratulare con me stesso della riuscita del mio tentativo. Ero giunto a quel noto brano della vicenda in cui Ethelred, l’eroe del Trist, dopo aver tentato invano di essere ammesso pacificamente nell’abitazione dell’eremita, si accinge a entrarvi a viva forza. Qui, si rammenterà, le parole del racconto sono queste:
Ed Ethelred, che era di natura di valoroso cuore, e si sentiva ora più che mai vigoroso, causa la potenza del vino che egli aveva bevuto, non attese di parlamentare oltre con l’eremita, il quale invero era di una natura maligna e ostinata, ma sentendo la pioggia cadergli sulle spalle e temendo lo scatenarsi della tempesta, sollevò alta la sua mazza e a suon di colpi si aprì rapidamente una breccia sulle assi dell’uscio per farvi passare la sua mano guantata di ferro; ed ecco che tirando con questa energicamente spezzò e lacerò e divelse ogni cosa sinché il rumore del legno secco e cavo rimbombò e si ripercosse per tutta la foresta”.
Al termine di questa frase sussultai e tacqui per un istante, poiché mi sembro’ (pur concludendo immediatamente che la mia fantasia eccitata mi aveva ingannato), mi sembrò, dico, che da un punto imprecisato e lontanissimo della dimora mi giungesse vagamente alle orecchie quella che sarebbe potuta essere, in modo esattamente affine, l’eco (pur soffocata e sorda) proprio del rumore cricchiante e lacerante tanto minuziosamente descritto da sir Launcelot. Fu senza dubbio questa semplice coincidenza ad attrarre la mia attenzione, poiché tra lo sbatacchiare delle intelaiature delle finestre e i soliti rumori confusi del temporale vieppiù aumentati, questo rumore di per se stesso non aveva certamente nulla che altrimenti potesse interessarmi o turbarmi. Proseguii nella lettura:
Ma il prode campione Ethelred nell’entrare di là dalla soglia si adirò e si stupì di non scorgere alcun segno del maligno eremita; ma invece di costui un drago di aspetto squamoso e prodigioso, dalla lingua di fiamma, che sedeva a guardia di un palazzo d’oro dal pavimento d’argento; e sul muro era appeso uno scudo di scintillante bronzo adorno del seguente motto:
Colui che quivi entra, conquistatore e’ stato;
chi il drago uccide lo scudo otterrà
Ed Ethelred sollevo’ la sua mazza e colpi’ al capo il drago che cadde ai suoi piedi esalando il suo fiato pestilenziale con un urlo cosi’ orrido e aspro e al tempo stesso cosi’ penetrante, che Ethelred fu costretto a turarsi le orecchie con le mani contro quello spaventoso rumore di cui mai aveva inteso prima l’uguale”
Qui mi fermai di nuovo bruscamente, e adesso con un senso di smarrito stupore, poiché non vi era dubbio (per quanto da che direzione provenisse mi era impossibile dire) che in quel preciso istante anch’io sentivo inequivocabilmente un rumore sommesso e apparentemente lontano, ma aspro, prolungato, raschiante e forse stranamente urlante: l’esatta riproduzione insomma di quello che già la mia fantasia aveva evocato come l’urlo innaturale del drago qual era descritto dal novellatore.
Per quanto sgomentato di questa seconda e veramente straordinaria coincidenza, nonché da mille sensazioni contrarie e contrastanti, in cui predominava una meraviglia e un terrore estremi, conservai tuttavia sufficiente presenza di spirito per evitare di acuire con una mia qualsiasi osservazione lo stato di ipersensibilita’ nervosa del mio compagno. Non ero affatto certo che egli avesse notato questi rumori, sebbene una strana alterazione fosse in quegli ultimi pochi minuti avvenuta in tutto il suo aspetto. Da una positura iniziale che lo aveva tenuto di fronte a me, egli aveva a poco a poco mosso la sua seggiola in modo da sedere con la faccia rivolta all’uscio della stanza, dimodo che’io non potevo scorgere i suoi lineamenti che in parte, benché vedessi che le sue labbra tremavano come se egli mormorasse qualcosa intelligibilmente. Aveva lasciato ricadere la testa sul petto; ma capivo che non dormiva dal suo occhio spalancato, in una fissità quasi rigida, di cui potevo cogliere una visione fuggevole di profilo. Anche il movimento del suo corpo era in contrasto con questa eventualità, poiché si dondolava innanzi e indietro con un’oscillazione lieve ma al tempo stesso costante e uniforme. Dopo aver notato rapidamente tutto cio’, ripresi la lettura del racconto di sir Launcelot, che così procedeva:
E ora il campione sfuggito alla terribile furia del drago e pensando allo scudo di bronzo e alla rottura dell’incantesimo che incombeva su di esso, scostò dal suo cammino la carogna del mostro e avanzò valorosamente sul pavimento argenteo del castello verso il punto in cui lo scudo pendeva dalla parete, ed esso in verità non attese il suo giungere, ma cadde ai suoi piedi sul pavimento d’argento, con un fragore possente, spaventosamente rimbombante.
Le mie labbra avevano appena proferito queste ultime sillabe, che (come se uno scudo di bronzo fosse veramente caduto in quel medesimo istante con improvviso fragore sul pavimento d’argento) io avvertii una vibrazione distinta, cava, metallica, squillante, benché apparentemente soffocata. Incapace di dominare più a lungo i miei nervi, balzai in piedi, ma il moto misurato oscillante di Usher proseguì imperturbato. Accorsi alla seggiola in cui sedeva. Aveva gli occhi fissi dinanzi a sé e da tutto il suo aspetto emanava una rigidità petrigna. Ma non appenagli ebbi posato una mano sulla spalla sentii l’intero suo corpo vibrare di un brivido intenso; un sorriso malsano gli aleggiò sulle labbra e io vidi che egli mormorava sommessamente, frettolosamente, parole sconnesse, quasi fosse totalmente ignaro della mia presenza. Mi chinai sudi lui e alla fine compresi il pauroso significato delle sue parole. – Non l’ho udito? Certo che l’ho udito. E lo odo ancora. Da tanto…tanto… tanto… da molti minuti, da molte ore, da molti giorni, io lo odo, e tuttavia non ho osato… oh, pietà di me, miserabile sciagurato che sono! Non osavo… non osavo parlare! L’abbiamo calata nella tomba viva! Non ti dicevo che i miei sensi sono acutissimi? Ebbene ti dico adesso che io ho inteso persino i suoi primi deboli movimenti nella cavità del sarcofago. Li ho avvertiti… molti, molti giorni fa… e tuttavia non osavo… non osavo parlare! Ed ecco che… stanotte…Ethelred… ah! ah! L’abbattersi dell’uscio dell’eremita, e l’urlo di morte del drago, e il clangore dello scudo!… Vuoi dire piuttosto l’infrangersi della sua bara, il suono stridente dei cardini di ferro della sua prigione, il suo dibattersi entro l’arcata foderata di rame della cripta! Oh, dove fuggirò? Non sarà ella qui tra poco? Non sta forse affrettandosi per rimproverarmi la mia precipitazione? Forse che non ho inteso il suo passo sulle scale? Non distinguo forse lo spaventoso pesante battito del suo cuore? Pazzo! – A questo punto balzò in piedi come una furia e urlò queste parole come se nello sforzo esalasse tutta la sua anima: – Pazzo! Ti dico che ella sta ora in piedi fuori dell’uscio!
Quasi che la sovrumana energia della sua voce contenesse la potenza evocatrice di un incantesimo, gli enormi antichi pannelli che egli additava, di schiusero lentamente, in quel medesimo istante, le loro poderose nere fauci. Fu senza dubbio l’opera dell’uragano infuriante; ma ecco che fuor di quell’uscio si ergeva veramente l’alta ammantata figura di lady Madeline di Usher. Il suo bianco sudario era macchiato di sangue, e su tutto il suo corpo emaciato apparivano evidenti i segni di una disperata lotta. Per un attimo ella rimase tremante, vacillante sulla soglia, poi con un gemito sommesso e prolungato cadde pesantemente sul corpo del proprio fratello e nei suoi violenti e ormai supremi spasimi agonici lo buttò al suolo cadavere, vittima dei giustificati terrori che lo avevano agitato.
Da quella camera e da quella casa io fuggii inorridito. L’uragano infuriava ancora in tutta la sua collera mentre io attraversavo l’antico sentiero selciato. A un tratto rifulse sul viottolo una luce abbagliante e io mi volsi a guardare donde poteva provenire un così insolito fulgore, poiché dietro di me avevo soltanto l’immensa casa e le sue ombre. Il chiarore proveniva dalla luna calante, al suo colmo, sanguigna, che ora splendeva vividamente attraverso l’unica fessura appena discernibile di cui ho già parlato e che si stendeva dal tetto dell’edificio in direzione irregolare, serpeggiante, sino alla sua base. Mentre guardavo, questa fessura rapidamente si allargò, il turbine di vento infuriò in un supremo anelito, tutta l’orbita del satellite si rivelo’ improvvisa alla mia vista, il mio cervello vacillò, mentre i miei occhi vedevano le possenti mura spalancarsi, s’intese un lungo tumultuante urlante rumore simile al frastuono di mille acque, e il profondo stagno ai miei piedi si chiuse cupo e silenzioso sui resti della “Casa degli Usher”.
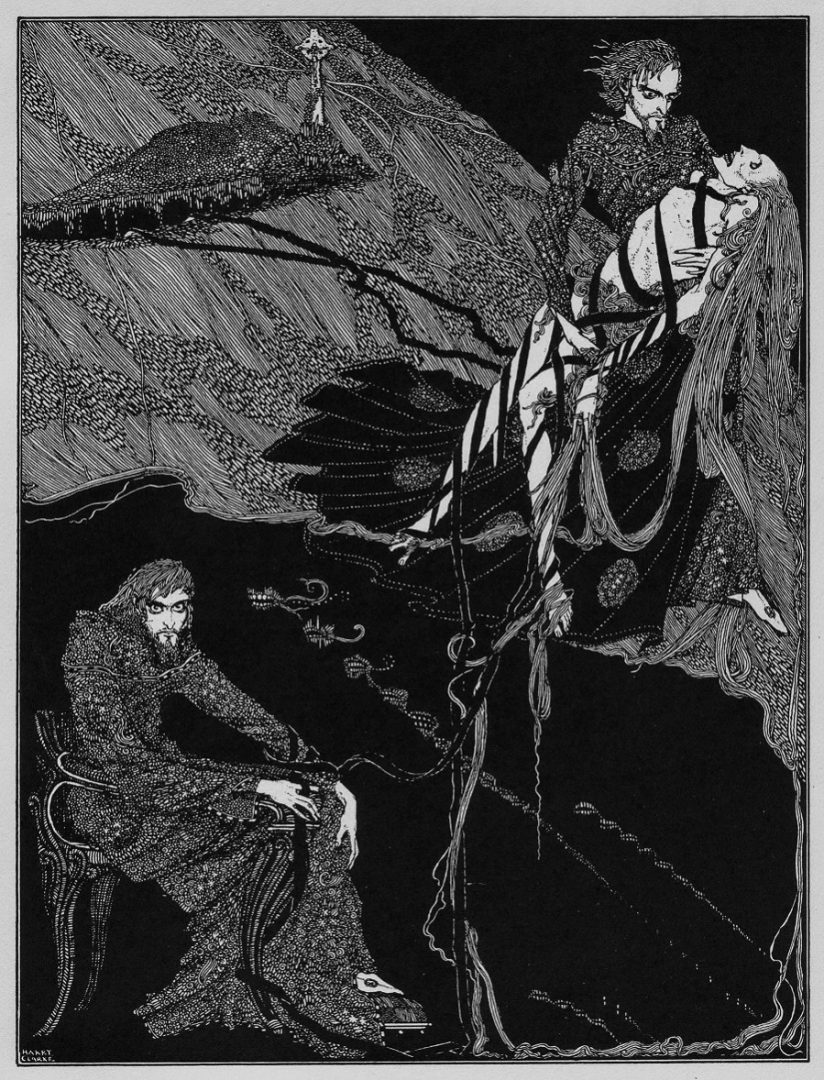 Harry Clarke: Illustrazione per il racconto Il crollo della casa degli Usher
Harry Clarke: Illustrazione per il racconto Il crollo della casa degli Usher
Il racconto si sviluppa attraverso un narratore interno alla storia, che ce la mostra nel modo in cui lui la percepisce. Attraverso questa tecnica, secondo cui il lettore ne sa quanto il narratore, Poe riesce a creare quel clima di tensione tipico di gran parte dei suoi racconti, attraverso i quali insegnerà sia la struttura della narrazione orrorifica, sia quella che in Italia prende il nome di gialla. Il protagonista è un intellettuale, nevroticamente malato che ha una sorella altrettanto malata, che ci appare in modo talmente ineffabile, da perdere qualsiasi consistenza. Essa più che una persona, sembra essere la personificazione dell’idea di morte, che si proietta all’interno della psiche ossessionata di Roderick. Si è che i due fratelli gemelli, la cui malattia funziona come se ci trovassimo di fronte alla teoria dei vasi comunicanti, non sono altro che la proiezione dell’idea di morte, verso il cui abisso precipitano, portando dietro sé la casa e tutto ciò che essa contiene. La critica psicoanalitica ha parlato di “rimosso” e di Madelaine (sorella di Roderick) come l’idea stessa di morte verso cui tende la pulsione dell’inconscio malato, e del suo io più profondo (saranno queste istanze che avvicineranno Poe più verso quella poetica maledetta dei poeti francesi e dei nostri scapigliati che all’interno della poetica romantica, non dimenticando, tuttavia che «l’arte di Poe, specie nei suoi racconti, è una delle espressioni più profonde di un’essenziale tendenza romantica: l’esplorazione della zona buia della psiche, dove si annidano i “mostri”, i terrori, le angosce, gli impulsi inconfessabili. E’ questa la caratteristica di quel filone della letteratura romantica che abbiamo definito “nero”. I racconti di Poe sono dominati da atmosfere allucinate, stravolte, dense di mistero, talvolta ottenute con grande economia di mezzi, talvolta invece puntando sul macabro e l’orroroso. Poe fu anche il creatore di un genere destinato ad immensa fortuna, il racconto poliziesco, fondato su un misterioso delitto e sulla ricerca dell’assassino da parte di un acuto investigatore (Gli omicidi della Rue Morgue)» (Guido Baldi)
Russia
Già all’inizio del Settecento la cultura russa si era aperta all’influenza europea, durante il cosiddetto “periodo pietroburghese” (nel 1713, Pietro il Grande trasportò la capitale a San Pietroburgo); in seguito grazie a Caterina II che permette entrino nel suo paese istanze illuminate e neoclassiche. Lo stesso si può dire per quanto riguarda la cultura romantica: ciò che tuttavia lo caratterizza è la vera e propria mitizzazione di Byron, preso ad esempio di una vita romantica. Ma non bisogna sminuire la cultura russa, come se fosse un semplice plagio di quella europea – in particolare francese o inglese; l’inserimento di elementi tipici della loro tradizione saranno preparatori per la grandissima stagione della letteratura russa durante la seconda metà dell’Ottocento.
Il romanticismo russo si esplicita sia sul piano lirico che su quello narrativo, generi sui quali si ispireranno sia Michail Jur’evič Lermontov che Aleksandr Sergeevič Puškin.
 Michail Jur’evič Lermontov
Michail Jur’evič Lermontov
Michail Jur’evič Lermontov nasce a Mosca nel 1814. A sedici anni si iscrive all’Università di Mosca, ma l’abbandona per abbracciare la carriera militare. Si getta con entusiasmo nella vita mondana di Pietroburgo, ostentando pose anticonformiste e di scherno veerso la società del tempo, cercando d’imitare il suo mito, Byron. Muore appena a 27 anni a seguito di un duello.
Tra le sue opere più importanti ci piace ricordare il poema Il demone (pubblicato dopo la morte) e Il novizio. Appaiono in ambedue figure come quella demoniaca, esiliata da un paradiso e alla ricerca di un assoluto, e che per questo si rifiuta di mescolarsi al mondo e alla grettezza della gente. Lo stesso argomento potremo trovarlo nel suo romanzo, Un eroe del nostro tempo (1840), inserito, tuttavia, in un ambiente più realista:
Un eroe del nostro tempo, ambientato nel Caucaso, è composto da cinque novelle che hanno in comune il protagonista, il giovane ufficiale Pečorin. Le prime due (Bela; Maksim Maksimyč, si fingono narrate all’autore da un amico di Pečorin, appunto Maksim Maksimyč. Le restanti (Taman; La principessa Mary; Il fatalista) appaiono tratte da un diario di Pečorin. Bela è una principessa tartara rapita con l’astuzia da Pečorin e uccisa per una vendetta dal tartaro Kasbič; Maksim Maksimyč è il fuggevole incontro di Pečorin con l’amico al quale affida il diario. Dopo una breve avvertenza in cui si informa il lettore della morte di Pečorin, si passa a Taman, storia di un agguato teso all’ufficiale da una bella contrabbandiera. Nella Principessina Mary, sullo sfondo della città termale di Piatigorks, Pečorin tesse una trama futile e perversa ai danni di due donne innamorate di lui, la sua antica amante Vera e la giovane Mary. Il tenente Grušnickij, innamorato di Mary, lo sfiderà e verrà da lui ucciso. Nel fatalista l’ufficiale Vulič, per dimostrare di credere al destino, sperimenta su di sé, di fronte a Pečorin, la “roulette russa”. La pistola fa cilecca, ma Pečorin gli ha letto in volto la morte e glielo dice. La sera stessa Vulič viene ucciso da un tartaro ubriaco incontrato per caso.
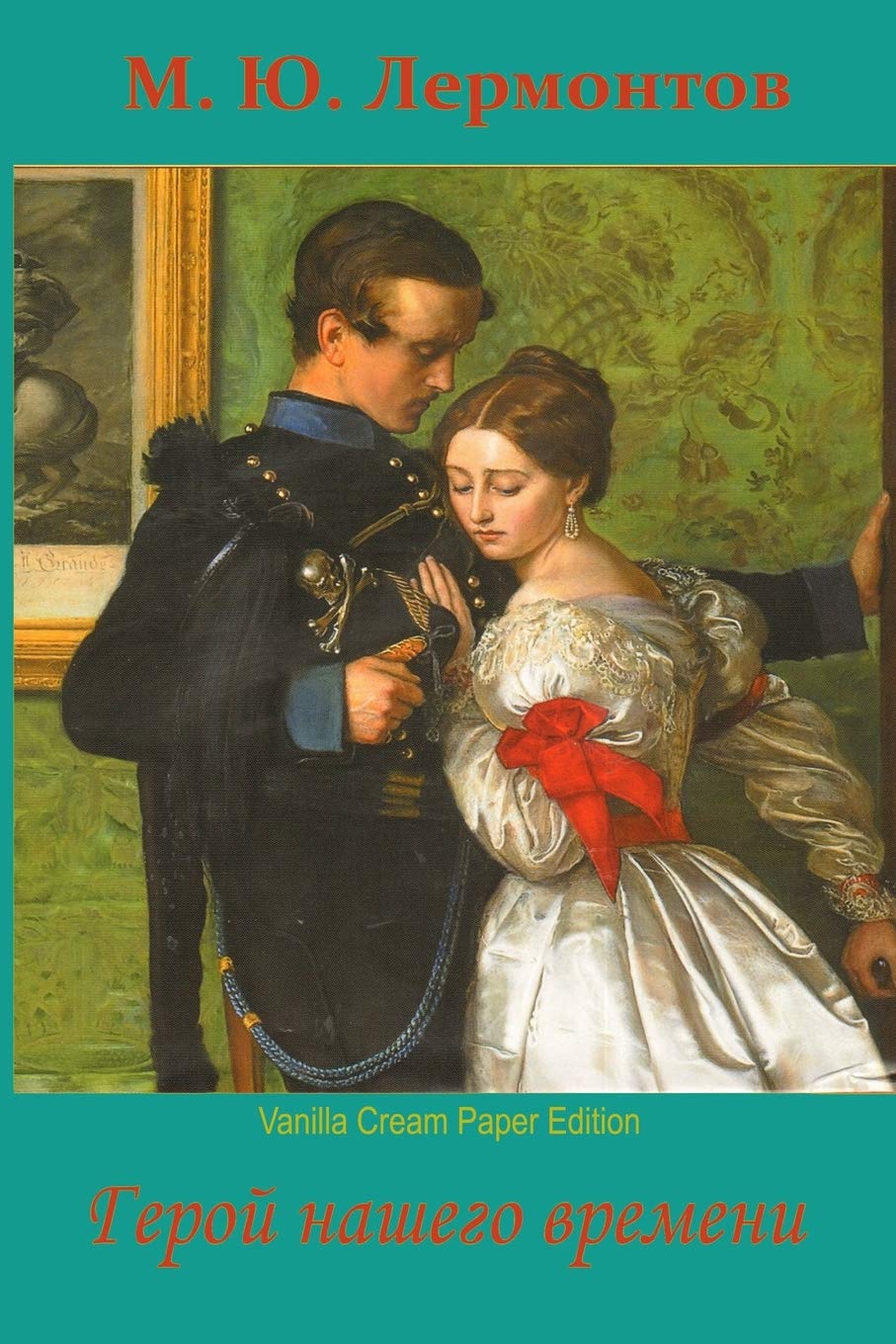
Edizione russa dell’opera di Lermontov
IN COMPAGNIA DELLA SIGNORINA MARY
La sera una numerosa compagnia si è avviata a piedi verso l’orrido. Secondo l’opinione degli scienziati locali quest’orrido non è altro che un cratere spento; esso si trova sulle pendici del Mašùk, a una versta dalla città. Vi si giunge per uno stretto sentiero tra rocce e arbusti; mentre salivamo la montagna ho porto il braccio alla principessina e lei non l’ha più lasciato per tutta la durata della passeggiata.
La nostra conversazione ha preso avvio dalle maldicenze: ho cominciato a passare in rassegna i nostri conoscenti, presenti e assenti, mettendone in evidenza dapprima i tratti ridicoli e poi i difetti. Mi si è eccitata la bile: avevo cominciato scherzando e ho terminato in preda a un autentico furore. Dapprima ciò l’ha divertita, ma poi l’ha spaventata.
«Siete un uomo pericoloso!» mi ha detto, «preferirei finire in un bosco sotto il coltello di un assassino piuttosto che sulla vostra lingua tagliente… Vi chiedo senza scherzi: il giorno che vi venisse in mente di parlare di me, prendete piuttosto un coltello e sgozzatemi: penso che non vi sarebbe così difficile.»
«Ho forse l’aspetto di un assassino?…»
«Siete peggio.»
Mi sono impensierito un momento e poi ho detto, assumendo un’aria profondamente commossa: «Sì, questa è stata la mia sorte fin dalla mia prima infanzia! Tutti leggevano sul mio viso i segni di brutte qualità che non avevo; ma le supponevano, e così sono nate. Ero riservato: mi rimproveravano di essere malizioso; così sono diventato chiuso. Sentivo profondamente il bene e il male; nessuno mi coccolava, tutti mi offendevano: così sono diventato permaloso; ero cupo mentre gli altri bambini erano allegri e chiacchieroni; io mi sentivo superiore a loro, e loro mi consideravano inferiore. Sono diventato invidioso. Ero pronto ad amare tutto il mondo, ma nessuno mi ha capito: allora ho imparato ad odiare. La mia giovinezza incolore è trascorsa nella lotta contro me stesso e il mondo; i miei sentimenti migliori, per timore di venire deriso, li ho sepolti nel profondo del cuore: e lì sono morti. Dicevo la verità, ma non mi credevano. Ho cominciato ad ingannare; dopo aver conosciuto bene il mondo e le molle della società mi sono fatto esperto dell’arte del vivere e ho visto che gli altri erano felici senz’arte, godevano gratis di quei vantaggi che io cercavo di ottenere così instancabilmente. Allora nel mio petto è nata la disperazione: non quella disperazione che si cura con un colpo di pistola, ma una disperazione fredda, impotente, nascosta dietro l’amabilità e un sorriso benevolo. Sono diventato un invalido morale: una metà della mia anima non esisteva, si era disseccata, era evaporata, era morta, io l’ho amputata e gettata via; invece l’altra reagiva e viveva al servizio di ognuno, ma questo nessuno l’ha notato, perché nessuno sapeva dell’esistenza dell’altra metà morta; ma adesso voi me ne avete suscitato il ricordo, e io vi ho recitato il suo epitaffio. Di solito gli epitaffi sembrano tutti ridicoli alla maggior parte della gente, ma non a me, in particolare quando mi ricordo di cosa cova sotto di essi. Del resto non vi chiedo di condividere la mia opinione: se la mia uscita vi pare ridicola, prego, ridete pure: vi avverto che non me ne addolererò affatto».
In quell’istante ho incontrato i suoi occhi: erano pieni di lacrime; la sua mano, appoggiata sopra la mia, tremava, le sue gote ardevano… le facevo pena! La compassione, sentimento a cui così facilmente soggiacciono le donne, aveva affondato i propri artigli nel suo cuore inesperto. Per tutta la durata della passeggiata è stata distratta, non ha civettato con nessuno e questo è un grande segno!
Siamo giunti all’orrido; le dame hanno lasciato il braccio dei loro cavalieri, ma lei non ha abbandonato il mio. Le arguzie dei dandies locali non la facevano ridere; lo strapiombo dell’abisso, sull’orlo del quale si trovava, non la spaventava, mentre le altre signore lanciavano gridolini e si coprivano gli occhi.
Sulla strada del ritorno non ho ripreso la nostra triste conversazione, ma alle mie domande e ai miei scherzi frivoli lei rispondeva brevemente e distrattamente.
«Avete amato?», le ho chiesto infine.
Lei mi ha guardato fissamente e ha scosso la testa… e di nuovo si è fatta pensierosa; era evidente che aveva voglia di dire qualcosa, ma che non sapeva da che parte cominciare; il suo petto era in agitazione Che fare? Una manica di mussolina è una debole difesa e una scintilla elettrica scoccò dal mio braccio al suo; quasi tutte le passioni cominciano così e sovente inganniamo noi stessi pensando che la donna ci ami per le nostre doti fisiche o morali; certamente esse preparano, predispongono il loro cuore ad accogliere il sacro fuoco, ma è tuttavia il primo contatto che decide la faccenda.
«Non è vero che oggi sono stata molto gentile?», mi ha domandato la principessina con un sorriso forzato al ritorno dalla passeggiata.
Ci siamo congedati…
E’ scontenta di sé: si accusa di freddezza! Oh, questo è il primo, importante trionfo! Domani ella vorrà ricompensarmi. Tutte queste cose le so già a memoria, ecco quel che è noioso!
 Pečorin in una fiction della tv russa
Pečorin in una fiction della tv russa
Nel brano sembra riecheggiare l’eco del grande romanzo del libertinismo francese Le relazioni pericolose: se tuttavia il racconto dell’atto di seduzione del visconte di Valmont verso l’austera Mme de Tourvel aveva per Laclos un significato di tipo moralista, nel caso di Lermontov ci troviamo, viceversa in un’azione in cui si vuole descrivere il vuoto entro cui si trova l’intellighenzia russa dopo il fallimento della rivoluzione decabrista del 1825. L’azione di Pečorin, non solo nel brano presentato, è condotta per noia “Tutte queste cose le so già a memoria, ecco quel che è noioso!“. Egli infatti è il rappresentante dell’uomo che non crede più a nulla; “medicina e veleno” lo definisce lo stesso Lermontov: medicina perché attraverso la mostra di sé può illustrare la vacuità e quindi la possibilità di riscatto; veleno perché denota quasi l’impossibilità dell’uomo a risorgere dallo stato in cui versa la Russia di allora. Romanticamente potremo definire Pečorin come un demonio, ma se tale demonio nelle opere precedenti cercava l’assoluto, nell’Eroe del nostro tempo denuncia la vacuità anche dell’uomo superiore.
Altro grande narratore è certamente Aleksandr Sergeevič Puškin, anch’egli autore di liriche, ma soprattutto del romanzo in versi Evgenij Oneghin e La figlia del capitano.
 Aleksandr Sergeevič Puškin
Aleksandr Sergeevič Puškin
Anche Puškin nasce a Mosca, nel 1799, da un famiglia di letterati: se pertanto la sua giovinezza si nutre della ricca biblioteca familiare, così non si può dire per quanto riguarda l’aspetto affettivo. Del suo primo periodo, oltre a precettori francesi e tedeschi, gli rimane in mente la “njanja” Arina Radionovna, che gli racconta antiche fiabe popolari. Entrato in liceo, si accosta ad idee riformatrici, che lo fanno allontanare dalla capitale. Andato in esilio, viaggia in Crimea, nel Caucaso, in Moldavia, per terminare ad Odessa. Richiamato dalla corte (affinché potesse essere controllato meglio) sposa la bellissima Natal’ja Gončarova, da cui ebbe quattro figli; ma il suo comportamento frivolo, gli porta più di un dispiacere, tanto da sfidare a duello un barone francese: ferito a morte, muore dopo due giorni, nel 1837.
“Ma perché è così importante, Puškin? Tutti conosciamo i grandi romanzieri russi dell’otto e del novecento, ma prima, nel settecento, chi erano i romanzieri russi? Non c’erano: quei pochi, come Karamzin, scrivevano imitazioni dei romanzi francesi, perché i romanzi russi non esistevano. Era una cosa esotica, per un russo, scrivere romanzi, nel settecento, ed era esotico anche, per la classe colta, parlare in russo, perché la lingua madre della maggior parte dei nobili russi dei tempi di Puškin non era il russo, era il francese, il russo lo parlavano i servi della gleba, che erano la maggioranza della popolazione ma non sapevano leggere e scrivere. A Puškin era molto simpatica la sua njanja, la sua bambinaia, Arìna Rodiònovna, che era una serva della gleba e che gli ha insegnato una lingua che era parlata e compresa dalla stragrande maggioranza dei russi, ma che non aveva una letteratura. Puškin ha usato questa lingua per fondare la letteratura russa moderna, le ha dato una dignità letteraria, ha usato, per primo, questo strumento così duttile, così tenero e così violento, dando il via a una stagione letteraria stupefacente.” (Paolo Nori)
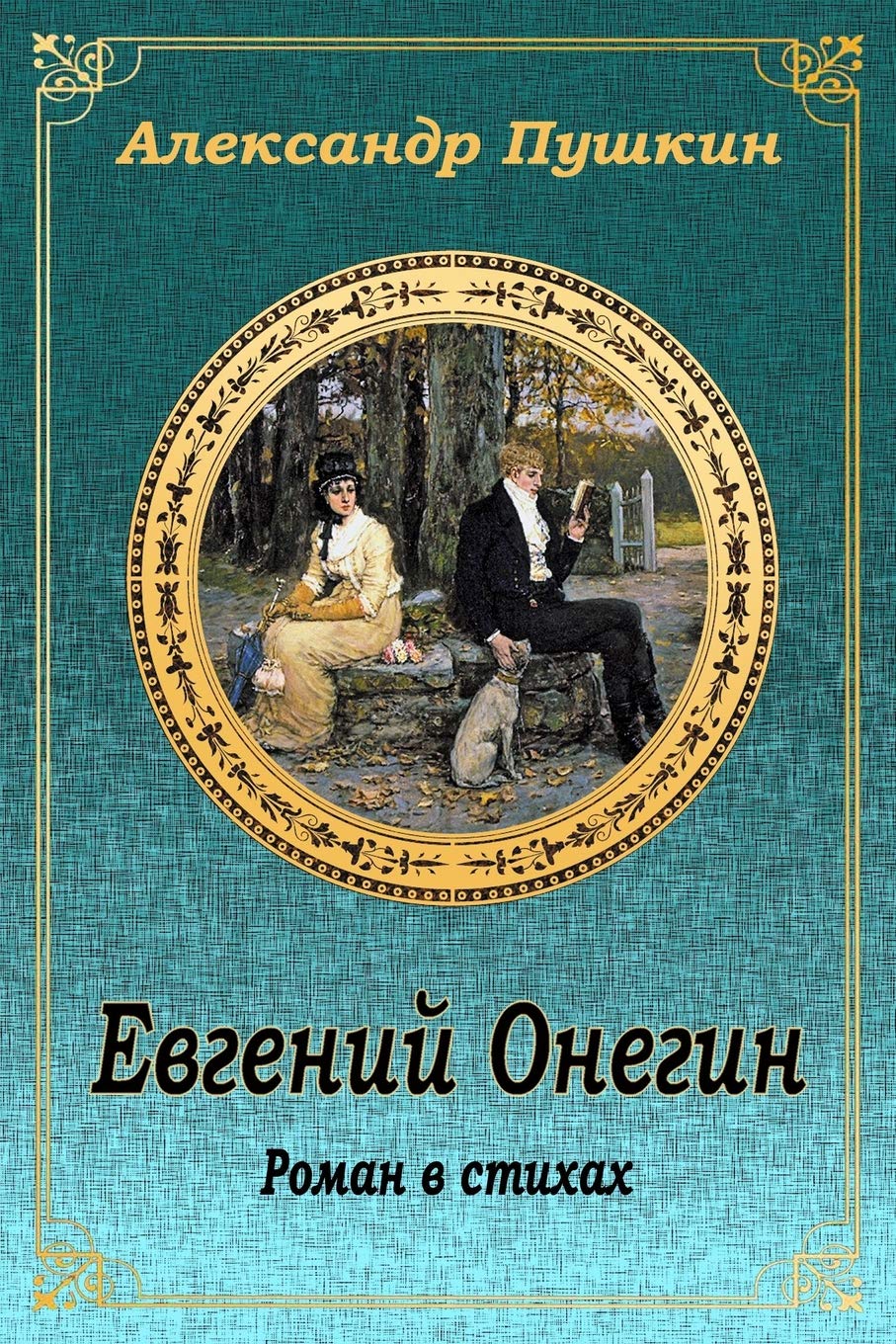 Edizione russa dell’Evgenij Oneghin
Edizione russa dell’Evgenij Oneghin
Nell’Evgenij Oneghin (1832), romanzo in versi, il protagonista è un dandy pietroburhese che rifiuta l’amore della bella e giovane Tatjana. Solo dopo molti anni la rincontra e stavolta s’innamora di lei, ma la donna nel frattempo si è sposata. Pur contraccambiando il suo amore, lo rifiuta per rispetto al marito. Più complessa la trama de La figlia del capitano (1834):
Romanzo storico. A raccontare la storia è l’ufficiale Grinjov, che ha assistito ai fatti e li descrive filtrandoli attraverso la sua sensibilità e cultura. Grinjov è di stanza nella fortezza di Belogòrsk, dove incontra e s’innamora di Mar’ja, la figlia del capitano Mirònov che è a capo dell’avamposto. La storia ha il suo culmine nell’attacco di Pugačëv al forte e nella sua conquista. Il capo dei ribelli fa giustiziare Mirònov, ma risparmia Grinjov per il coraggio dimostrato nel dichiararsi fedele all’imperatrice, e anzi lo libera. Grinjov viene per questo sospettato di tradimento e solo l’intervento di Mar’ja convincerà in seguito l’imperatrice a concedergli la grazia. Non vi sarà invece scampo per Pugačëv, di lì a poco orrendamente giustiziato.
IL FAZZOLETTO BIANCO
Quella notte non dormii e non mi spogliai. Avevo intenzione di recarmi all’alba verso la porta della fortezza da dove Mar’ja Ivànovna sarebbe dovuta uscire e là dirle addio per l’ultima volta. Sentivo in me un gran cambiamento: l’agitazione della mia anima mi era molto meno penosa della malinconia nella quale ancora poco tempo prima ero sprofondato. Alla tristezza della separazione si univano in me anche confuse ma dolci speranze e l’impaziente attesa dei pericoli e il sentimento di una nobile ambizione. La notte passò inavvertitamente. Volevo già uscire di casa quando la mia porta si aprì e si presentò da me un caporale con la notizia che i nostri cosacchi di notte avevano lasciato la fortezza prendendo con sé a forza Jùlaj e che attorno alla fortezza si aggiravano degli sconosciuti. Il pensiero che Mar’ja Ivànovna non avrebbe fatto in tempo a uscire mi terrorizzava; diedi velocemente al caporale alcune istruzioni e mi precipitai dal comandante.
Si faceva ormai giorno. Volavo per strada quando sentii che mi si chiamavano. Mi fermai. «Dove va?» disse Ivàn Ignat’ič, raggiungendomi. «Ivàn Kuzmič è sul bastione e mi ha mandato a cercarla. E’ arrivato Pugàč». «Se n’è andata Mar’ja Ivànovna?» chiesi con un tremito al cuore. «Non ha fatto in tempo» rispose Ivàn Ignat’ič, «la strada per Orenbùrg è interrotta; la fortezza è accerchiata. Andiamo male, Pëtr Andreič!»
Andammo sul bastione: un’altura naturale fortificata con delle travi di legno. Là si ammassavano già tutti gli abitanti della fortezza. La guarnigione era in armi. Il cannone l’avevano trasferito lì il giorno prima. Il comandante andava avanti e indietro di fronte al suo esiguo schieramento. La vicinanza del pericolo aveva animato il vecchio militare di uno straordinario vigore. Nella steppa, a poca distanza dalla fortezza si aggirava una ventina di uomini a cavallo. Sembravano dei cosacchi, ma tra loro si trovavano anche dei baschiri, che si potevano facilmente riconoscere dai cappelli di lince e dalle faretre. Il comandante faceva il giro del suo esercito dicendo ai soldati: «Be’, bambini, difendiamo oggi la mammina imperatrice e dimostriamo a tutto il mondo che siamo gente brava e onorata!». I soldati manifestarono ad alta voce il loro zelo. Švabrin stava accanto a me e guardava fisso i nemici. Gli uomini che si aggiravano per la steppa, notando dei movimenti nella fortezza si riunirono in gruppo e si misero a parlare tra loro. Il comandante ordinò a Ivàn Ignat’ič di dirigere il cannone sul loro gruppo e accostò egli stesso la miccia. La palla fischiò e volò sopra di loro senza fare alcun danno. I cavalieri, disperdendosi, sparirono al galoppo e la steppa si vuotò.
Allora comparve sul bastione Vasilisa Egòrovna e con lei Maša, che non aveva voluto separasi da lei. «Be’?» disse la moglie del comandante «come va la battaglia? Dove sarebbe il nemico?» «Il nemico è vicino» rispose Ivàn Ignat’ič: «Se Dio vuole, tutto andrà bene. Be’, Maša, hai paura?» «No, babbo» rispose Mar’ja Ivànovna «a casa da sola è peggio.» Allora gettò uno sguardo su di me e con uno sforzo sorrise . Involontariamente strinsi l’elsa della mia spada ricordando che il giorno prima l’avevo ricevuta dalle sue mani, come a difendere la mia amata. Il mio cuore ardeva. Mi immaginavo di essere il suo cavaliere. Bramavo di dimostrare che ero degno della sua fiducia, e con impazienza mi misi ad aspettare il momento decisivo.
Intanto, da un’altura che si trovava a mezza versta dalla fortezza erano sbucate nuove masse a cavallo e presto la steppa fu popolata da una folla di uomini armati di lance e di archi. Tra di loro su un cavallo bianco c’era un uomo in caffettano rosso e in mano la spada sguainata: era Pugačëv in persona. Si fermò; lo circondarono, e, era evidente, per ordine suo quattro uomini si allontanarono e a tutta velocità galopparono fino alla fortezza. Riconoscemmo in loro i nostri traditori. Uno di essi teneva sopra al cappello un foglio di carta; un altro teneva sulla lancia la testa di Julàj, che, con uno scrollone, ci gettò attraverso la palizzata. La testa del povero calmucco cadde ai piedi del comandante. I traditori gridavano: «Non sparate; uscite incontro al sovrano. Il sovrano è qui!»
«Adesso ve lo do io»! gridò Ivàn Kuzmič «ragazzi fuoco!» I nostri soldati spararono una salva. Il cosacco che aveva la lettera barcollò e cadde da cavallo; gli altri galopparono indietro. Gettai uno sguardo a Mar’ja Ivànovna. Colpita dalla vista della testa insanguinata di Julàj, stordita dalla salva, sembrava senza sensi. Il comandante chiamò un caporale e gli ordinò di prendere il foglio dalle mani del cosacco ucciso. Il caporale uscì dal campo e ritornò conducendo per le briglie il cavallo dell’ucciso. Consegnò la lettera al comandante. Ivàn Kuzmič la lesse tra sé e poi la fece in pezzi. Nel frattempo i rivoltosi si preparavano evidentemente all’azione. Presto le pallottole cominciarono a fischiare alle nostre orecchie e alcune frecce si conficcarono attorno a noi per terra e sulle travi di legno. «Vasilisa Egòrovna!» disse il comandante «questa non è faccenda da donne; porta via Maša; vedi: la ragazza è più morta che viva.»
Vasilisa Egòrovna, resa docile dalle pallottole, gettò uno sguardo alla steppa, nella quale c’era un gran movimento; poi si voltò verso il marito e gli disse: «Ivàn Kuzmič, la vita e la morte dipendono dalla volontà di Dio: benedici Maša. Maša avvicinti a tuo padre!»
Maša, pallida e tremante, si avvicinò a Ivàn Kuzmič, si mise in ginocchio e gli si inchinò fino a terra. Il vecchio comandante le fece tre volte il segno della croce; poi la fece alzare e, baciandola, le disse con voce mutata: «Be’, Maša sii felice. Prega Dio: non ti abbandonerà. Se troverai un uomo buono, che Dio vi dia amore e accordo. Vivete come abbiamo vissuto io e Vasilisa Egòrovna. Be’, addio Maša. Vasilisa Egòrovna, portala via, presto.» (Maša gli si gettò al collo e scoppiò in singhiozzi). «Baciamoci anche noi» disse, scoppiando a piangere la moglie del comandante «Addio, mio Ivàn Kuzmič. Perdonami se in qualche volta ti ho fatto arrabbiare!» «Addio, addio mammina!» disse il comandante abbracciando la sua vecchia. «Be’, basta! Andate, andate a casa; e se fai in tempo, metti a Maša il “sarafan”». La moglie del comandante si allontanò con la figlia. Seguii con lo sguardo Mar’ja Ivànovna. Lei si girò a guardare e mi fece un segno con la testa. A questo punto Ivàn Kuzmič si voltò verso di noi e tutta la sua attenzione si fissò sui nemici. I rivoltosi si strinsero intorno al loro capo e d’un tratto cominciarono a scendere da cavallo. «Adesso tenetevi forte,» disse il comandante «ci sarà l’assalto…» In quel momento si sentirono uno strillo e delle grida; i rivoltosi correvano a piedi verso la fortezza. Il nostro cannone era caricato a mitraglia. Il comandante li fece arrivare aala più breve distanza possibile e all’improvviso sparò ancora. La mitraglia colpì al centro della folla. I rivoltosi si spostarono da entrambi i lati e indietreggiarono. Il loro capo rimase solo in testa… Agitò la spada e sembrava che cercasse di persuaderli con calore. Le strilla e le grida, che per un momento avevano taciuto, subito ricominciarono. «Be’, ragazzi», disse il comandante, «adesso apri la porta e batti il tamburo! Ragazzi, avanti, alla sortita, con me!»
Il comandante, Ivàn Ignat’ič e io in un attimo eravamo oltre il bastione della fortezza; ma la guarnigione intimorita non si mosse. «Cosa state fermi, bambini?» gridò Ivàn Kuzmič, «se c’è da morire, moriamo: siamo soldati!» In quel momento i rivoltosi erano arrivati fino a noi e irruppero nella fortezza. Il tamburo tacque; la guarnigione gettò i fucili; mi spinsero a terra, ma mi rialzai ed entrai con i rivoltosi nella fortezza. Il comandante, ferito alla testa, era in piedi tra un mucchio di delinquenti che gli chiedevano le chiavi. I stavo per gettarmi in suo aiuto; alcuni cosacchi robusti mi presero e mi legarono con delle cinture, dicendo: «Adesso vi danno quel che vi meritate, disubbidienti al sovrano!» Ci trascinarono per le strade; gli abitanti uscivano dalle case con il pane e il sale. Echeggiò il suono delle campane. All’improvviso nella folla gridarono aspettava in piazza i prigionieri e riceveva il giuramento. La folla si riversò in piazza; spinsero là anche noi.
Pugačëv sedeva in poltrona sul terrazzino d’ingresso della casa del comandante. Aveva un rosso caffettano da cosacco con i galloni cuciti. Un alto cappello di zibellino con nappe dorate era calcato sui suoi occhi scintillanti. Il suo viso mi sembrò conosciuto. I capi cosacchi lo circondavano. Padre Gherasim, pallido e tremante, stava sul terrazzino con una croce in mano e sembrava che lo supplicasse in silenzio per le vittime imminenti. Sulla piazza alzarono in fretta una forca. Quando ci avvicinammo, i baschiri dispersero la folla ci presentarono a Pugačëv. Il suono delle campane tacque; si fece un profondo silenzio. «Qual è il comandante?» chiese l’impostore. Il nostro sottufficiale uscì dalla folla e indicò Ivàn Kuzmič. Pugačëv guardò minaccioso il vecchio e gli chiese: «Come hai osato opporti a me, il tuo sovrano?» Il comandante, sfinito dalla ferita, raccolse le ultime forze e rispose con voce ferma: «Tu a me non sei sovrano; tu sei un ladro e un impostore, hai capito?» Pugačëv si accigliò cupamente e sventolò un fazzoletto bianco. Alcuni cosacchi afferrarono il vecchio capitano e lo trasportarono fino alla forca. Sulla traversa stava a cavallo il baschiro che avevamo interrogato alla vigilia. Teneva in mano la corda e un istante dopo vidi il povero Ivàn Kuzmič appeso all’aria. Allora condussero da Pugačëv Ivàn Ignat’ič. «Presta giuramento» gli disse Pugačëv «al sovrano Pëtr Feòdorovič!» «Tu a noi non sei sovrano» rispose Ivàn Ignat’ič, ripetendo le parole del suo capitano, «tu, zietto, sei un ladro e un impostore!» Pugačëv scosse ancora il fazzoletto e il buon tenente si librò in aria accanto al suo vecchio capo.
La fila era arrivata a me. Guardai coraggiosamente Pugačëv preparandomi a ripetere la risposta dei miei generosi compagni. Allora, con mio indescrivibile stupore, vidi tra i capi dei rivoltosi Švabrin, coi capelli tagliati in tondo e un caffettano cosacco. Si avvicinò a Pugačëv e gli disse all’orecchio alcune parole. «Appenderlo!» disse Pugačëv senza guardarmi. Mi gettarono al collo un cappio. Cominciai a recitare tra me una preghiera recando a Dio un sincero pentimento di tutti i miei peccati e pregandolo per la salvezza di tutti coloro che erano vicini al mio cuore. Mi trascinarono sotto la forca. «Non aver paura, non aver paura» mi ripetevano i carnefici, desiderando forse davvero farmi coraggio. A un tratto sentii il grido: «Fermi, maledetti, aspettate!» I carnefici si arrestarono. Guardai: Savel’ič giaceva ai piedi di Pugačëv. «Padre mio!» diceva il povero servo «cosa ti viene dalla morte di un signorino? Lascialo libero; ti daranno un riscatto; e come esempio e per far paura ordina di appendere magari me che son vecchio!» Pugačëv fece un segno e mi slegarono e liberarono subito. «Il nostro babbino ti risparmia» mi dissero. In quel momento non posso dire che mi rallegrai della mia salvezza, non dirò tuttavia che me ne dispiacqui. I miei sentimenti erano troppo confusi. Mi portarono ancora dall’impostore e mi posero davanti a lui in ginocchio. Pugačëv mi tese la sua mano fitta di vene. «Bacia la mano, bacia la mano!» si diceva intorno a me. Ma io avrei preferito la pena più atroce a questa vile umiliazione. «Babbino Pëtr Andreič!» sussurava Savel’ič che stava dietro di me e mi spingeva: «non ostinarti! Cosa ti costa? Sputaci su e bacia al malf… (bah!) baciagli la mano.» Non mi muovevo. Pugačëv lasciò andare la mano dicendo con un sogghigno: – Sua signoria a quanto pare è ingrullito per la gioia. Alzatelo. Mi alzarono e mi lasciarono libero. Io misi a guardare il seguito dell’orribile commedia.
 L’esecuzione di Pugačëv
L’esecuzione di Pugačëv
Il passo rispecchia certamente l’intero romanzo: ciò che emerge è il contrapporsi tra due forme di violenza sia di chi difende, sia di chi attacca. Puškin non giudica, presenta e per far questo adotta la tecnica dello straniamento: a raccontare è Grinjov che fedele all’imperatrice ma al contempo legato da un rapporto di sincerità con Pugačëv (lo incontra come contadino che lo aiuta a ritrovare la strada perduta durante una tormenta) non può prendere posizione, come il suo autore. Per lui, molto presumibilmente, alla luce della violenza contro il capitano della fortezza di Pugačëv e la sua terribile morte per mano dell’imperatrice, è necessario un mondo più tollerante, fatto di una politica più umana, quale nella Russia di Alessandro I e Nicola I non garantivano.
Italia
In Italia la poetica romantica accoglie in modo propositivo le istanze che giungono dalla cultura europea, ma mette anche a frutto gli insegnamenti sia del Monti con i suoi squarci notturni che del Foscolo, il cui romanzo epistolare funge, se così si può dire, da tramite tra le istanze di un preromanticismo già patriottico e le più mature battaglie insurrezionali e politiche che costelleranno la nostra storia nazionale.
I punti del romanticismo italiano sono:
- la critica ma non l’abiura delle istanze illuministiche (critica al razionalismo più spinto, ma non alla verità);
- la riscoperta del Medioevo (sulla stregua anche della lettura del romano di Walter Scott, Ivanhoe),
- la rinascita religiosa (legata chiaramente anche al recupero dell’età di mezzo, in cui la credenza in Dio sovrintendeva ogni sapere ed ogni atto della vita)
- l’idea di Patria che s’accosta a quelle precedenti: non è un caso che sia proprio il Medioevo a porre fine all’Universalismo romano, e che le nuove realtà nazionali nascano proprio intorno all’anno 1000.
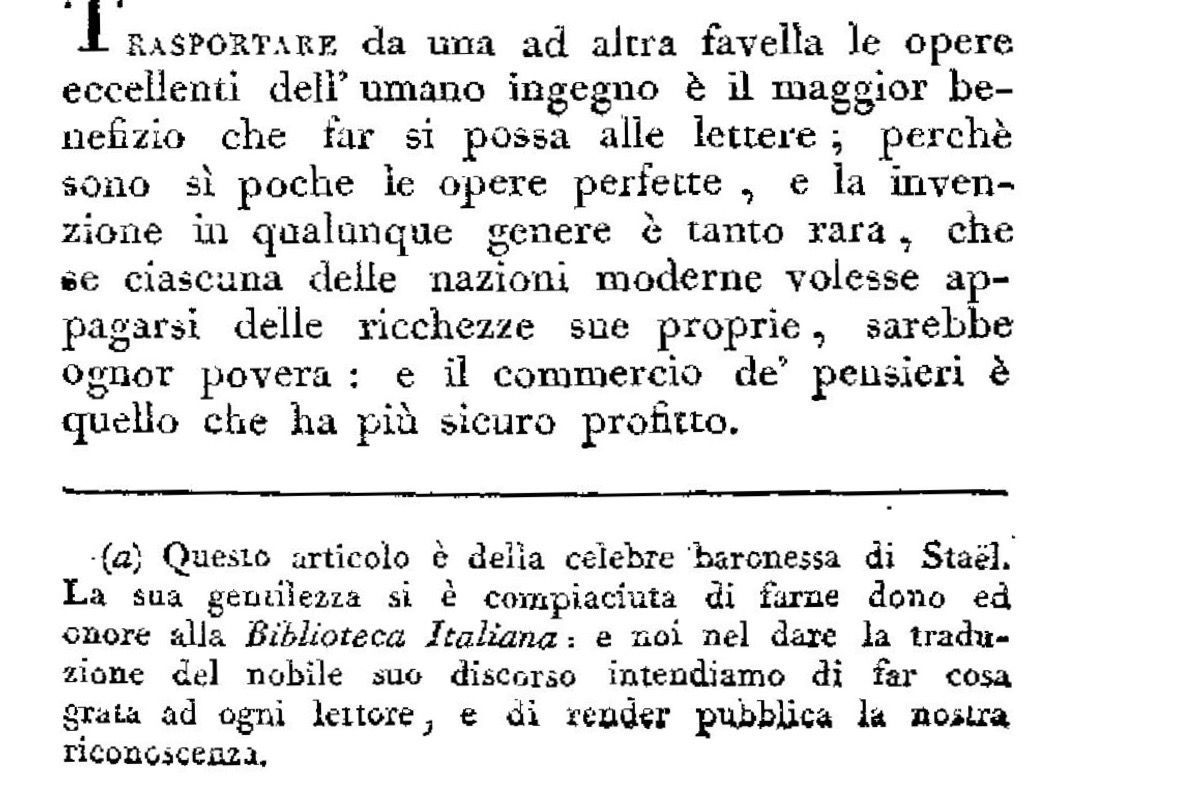
Articolo della De Staël
Alla fine dell’esperienza napoleonica, i nuovi governanti austriaci, attraverso il ministro Bellegarde, cercarono di convogliare su di sé l’approvazione della classe intellettuale di Milano, allora capitale culturale della penisola, attraverso la nascita di una rivista letteraria la Biblioteca Italiana, le cui pubblicazioni iniziarono nel 1814 e terminarono nel 1840. Nella città meneghina si trovavano Monti, Foscolo ed il giovane Manzoni; quest’ultimi rifiutarono, non così Monti che ne divenne direttore. Il Romanticismo italiano nesce nel gennaio del 1816 quando su questa rivista la ginevrina M.me De Staël pubblicò un articolo dal titolo Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni:
GLI ITALIANI SI RINNOVINO TRADUCENDO
L’Europa certamente non ha una traduzione omerica, di bellezza e di efficacia tanto prossima all’originale, come quella del Monti: nella quale è pompa ed insieme semplicità; le usanze più ordinarie della vita, le vesti, i conviti acquistano dignità dal naturale decoro delle frasi: un dipinger vero, uno stile facile ci addomestica a tutto ciò che ne’ fatti e negli uomini d’Omero è grande ed eroico. Niuno vorrà in Italia per lo innanzi tradurre la Iliade; poiché Omero non si potrà spogliare dell’abbigliamento onde il Monti lo rivestì: e a me pare che anche negli altri paesi europei chiunque non può sollevarsi alla lettura d’Omero originale, debba nella traduzione italiana prenderne il meglio possibile di conoscenza e di piacere. Non si traduce un poeta come col compasso si misurano e si riportano le dimensioni d’un edificio; ma a quel modo che una bella musica si ripete sopra un diverso istrumento: né importa che tu ci dia nel ritratto gli stessi lineamenti ad uno ad uno, purché vi sia nel tutto una eguale bellezza.
Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche; onde mostrare qualche novità a’ loro cittadini, i quali per lo più stanno contenti all’antica mitologia: né pensano che quelle favole sono da un pezzo anticate, anzi il resto d’Europa le ha già abbandonate e dimentiche. Perciò gl’intelletti della bella Italia, se amano di non giacere oziosi, rivolgano spesso l’attenzione al di là dall’Alpi, non dico per vestire le fogge straniere, ma per conoscerle; non per diventare imitatori, ma per uscire di quelle usanze viete, le quali durano nella letteratura come nelle compagnie i complimenti, a pregiudizio della naturale schiettezza. Che se le lettere si arricchiscono colle traduzioni de’ poemi; traducendo i drammi si conseguirebbe una molto maggiore utilità; poiché il teatro è come il magistrato della letteratura. Shakspeare tradotto con vivissima rassomiglianza dallo Schlegel, fu rappresentato ne’ teatri di Germania, come se Shakspeare e Schiller fossero divenuti concittadini. E facilmente in Italia si avrebbe un eguale effetto: né parmi a dubitare che sul bel teatro milanese non fosse gradita l’Atalía*, se i cori fossero accompagnati dalla stupenda musica italiana. Mi si dirà che in Italia vanno le genti al teatro, non per ascoltare, ma per unirsi ne’ palchetti gli amici più famigliari e cianciare. E io ne conchiuderò che lo stare ogni dì cinque ore ascoltando quelle che si chiamano parole dell’opera italiana, dee necessariamente fare ottuso, per mancanza di esercizio, l’intelletto d’una nazione. (…) In questa continua ed universale frivolezza di tutte le pubbliche e private radunanze, dove ognuno cerca l’altrui compagnia per fuggire sè stesso e liberarsi da un grave peso di noia, se voi poteste per mezzo a’ piaceri mescere qualche util vero e qualche buon concetto, porreste nelle menti un poco di serio e di pensoso, che le disporrebbe a divenire buone per qualche cosa.
Havvi oggidì nella Letteratura italiana una classe di eruditi che vanno continuamente razzolando le antiche ceneri, per trovarvi forse qualche granello d’oro: ed un’altra di scrittori senz’altro capitale che molta fiducia nella lor lingua armoniosa, donde raccozzano suoni vôti d’ogni pensiero, esclamazioni, declamazioni, invocazioni, che stordiscono gli orecchi, e trovan sordi i cuori altrui, perché non esalarono dal cuore dello scrittore. Non sarà egli dunque possibile che una emulazione operosa, un vivo desiderio d’esser applaudito ne’ teatri, conduca gl’ingegni italiani a quella meditazione che fa essere inventori, e a quella verità di concetti e di frasi nello stile, senza cui non ci è buona letteratura, e neppure alcuno elemento di essa?
Piace comunemente il drama in Italia: e degno è che piaccia sempre più, divenendo più perfetto e utile alla pubblica educazione: e nondimeno si dee desiderare che non impedisca il ritorno di quella frizzante giocondità onde per l’addietro era sì lieto. Tutte le cose buone devono essere tra sè amiche.
Gl’Italiani hanno nelle belle arti un gusto semplice e nobile. Ora la parola è pur una delle arti belle, e dovrebbe avere le qualità medesime che le altre hanno: giacché l’arte della parola è più intrinseca all’essenza dell’uomo; il quale può rimanersi piuttosto privo di pitture e di sculture e di monumenti, che di quelle imagini e di quegli affetti ai quali e le pitture e i monumenti si consacrano. Gl’Italiani ammirano e amano straordinariamente la loro lingua, che fu nobilitata da scrittori sommi: oltreché la nazione italiana non ebbe per lo più altra gloria, o altri piaceri, o altre consolazioni se non quelle che dava l’ingegno. Affinché l’individuo disposto da natura all’esercizio dell’intelletto senta in sè stesso una cagione di mettere in atto la sua naturale facoltà bisogna che le nazioni abbiano un interesse che le muova. Alcune l’hanno nella guerra, altre nella politica: gl’Italiani deono acquistar pregio dalle lettere e dalle arti; senza che giacerebbero in sonno oscuro, d’onde neppur il sole potrebbe svegliarli.
*Tragedia di Racine rappresentata in Italia nel 1692
 M.me De Staël
M.me De Staël
L’analisi della De Staël sulla cultura italiana è piuttosto attenta:
- loda l’idioma, elogiando la musicalità della versificazione del Monti nella sua traduzione dell’Iliade omerica rispetto a tutte quelle europee;
- critica l’esagerata venerazione verso gli autori antichi;
- disapprova l’uso di tutta la tradizione mitologica, diventata vuota forma, capace di parlare all’intelletto ma non al cuore.
E’ evidente che l’appunto che fa l’intellettuale ginevrina va a colpire i fondamenti su cui si è basata sinora la nostra tradizione letteraria, la quale non ha voluto solamente “abbellire” con i riferimenti l’opera letteraria, ma dare ad essi la forza per il superamento dello spazio e del tempo che la cancellazione di essi e l’attenzione verso il presente porterebbero.
 Pietro Giordani
Pietro Giordani
A lei risponde, sempre nella Biblioteca Italiana Pietro Giordani, nell’aprile del 1816:
UN ITALIANO RISPONDE A M.ME DE STAËL
Fra gli studi veramente utili ed onorevoli all’Italia porremo noi le traduzioni de’ poemi e de’ romanzi oltramontani? Sarà veramente arricchita la nostra letteratura adottando ciò che le fantasie settentrionali crearono? Così dice la baronessa, così credono alcuni italiani; ma io sto con quelli che pensano il contrario. Consideriamo prima la loro fondamentale ragione: ci vuole novità. Ma io dico: oggetto delle scienze è il vero, delle arti il bello. Non sarà dunque pregiato nelle scienze il nuovo, se non in quanto sia vero, e nelle arti, se non in quanto sia bello. Le scienze hanno un progresso infinito, e possono ogni dì trovare verità prima non sapute. Finito è il progresso delle arti: quando abbiano e trovato il bello, e saputo esprimerlo, in quello riposano. Né si creda sì angusto spazio, benché sia circoscritto. Se vogliamo che ci sia bello tutto ciò che ci è nuovo, perderemo ben presto la facoltà di conoscere e di sentire il bello. Gli artisti del disegno delirarono nel secolo decimosettimo, cercando nelle pitture, nelle statue, negli edifizi le più stravaganti novità; e uscirono affatto dalla bellezza e dalla convenienza; dove l’età nostra molto saviamente è ritornata. Ma l’arte di scrivere, che nel Seicento fu da moltissimi difformata per la stessa follia di novità, ha veramente mutato nel secol nostro, ma forse in peggio; in quanto che si è allontanata non pur dall’antico, ma dal nazionale. Ché almeno i seicentisti avevano una pazzia originale e italiana: la follia nostra è di scimie, e quindi tanto più deforme. Già si potrebbe molto disputare se sia veramente bello tutto ciò che alcuni ammirano ne’ poeti inglesi e tedeschi; e se molte cose non siano false, o esagerate, e però brutte; ma diasi che tutto sia bello; non per questo può riuscir bello a noi se lo mescoliamo alle cose nostre. O bisogna cessare affatto d’essere italiani, dimenticare la nostra lingua, la nostra istoria, mutare il nostro clima e la nostra fantasia, o, ritenendo queste cose, conviene che la poesia e la letteratura si mantenga italiana: ma non può mantenersi tale, frammischiandovi quelle idee settentrionali, che per nulla si possono confare alle nostre. Questa mescolanza di cose insociabili produrrebbe (come già troppo produce) componimenti simili a’ centauri, che l’antichità favolò generati dalle nuvole. Non dico per questo che non possa ragionevolmente un italiano voler conoscere le poesie e le fantasie de’ settentrionali, come può benissimo recarsi personalmente a visitare i lor paesi; ma nego che quelle letterature (comunque verso di sé belle e lodevoli) possano arricchire e abbellire la nostra, perché sono essenzialmente insociabili. Altro è andar nel Giappone per curiosità di vedere quasi un altro mondo dal nostro: altro è, tornato di là, volere fra gl’italiani vivere alla giapponese. Io voglio concedere a’ cinesi che abbia eleganza il loro vestire, abbia decoro il loro fabbricare, abbia grazia il loro dipingere. Ma se uno ci consigliasse di edificare e dipingere e vestire come i cinesi; poiché già è invecchiato il modo che noi teniamo di queste cose, parrebbeci buono il consiglio? Quante ragioni addurremmo di non doverlo né poterlo seguire! E della letteratura settentrionale oltre le ragioni abbiamo pur anche avviso dalla ’sperienza, che, innestata contro natura alle nostre lettere, ne ha fatto scomparire quel pochissimo che vi rimaneva d’italiano. Ognuno ponga mente come si scriva in Italia, dappoiché vi regna Ossian; dietro cui è venuta numerosa turba di simili traduttori. E bello è che questi appassionati di Milton, o di Klopstok, non conoscono poi Dante, e non conosciuto lo disprezzano: cosa da far molto ridere e gl’inglesi e i tedeschi. Troppo è vero che agli stranieri debbano parere isterilite oggidì in Italia le lettere; ma questa povertà nasce da pigrizia di coltivare il fondo paterno; né per acquistar dovizia ci bisogna emigrare e gittarci sulle altrui possessioni, i cui frutti hanno sapore e sugo che a noi non si confà. Studino gl’Italiani ne’ propri classici, e ne’ latini e ne’ greci; de’ quali nella italiana più che in qualunque altra letteratura del mondo possono farsi begl’innesti; poiché ella è pure un ramo di quel tronco; laddove le altre hanno tutt’altra radice; e allora parrà a tutti fiorita e feconda. Se proseguiranno a cercare le cose oltramontane, accadrà che sempre più ci dispiacciano le nostre proprie (come tanto diverse) e cesseremo affatto dal poter fare quello di che i nostri maggiori furono tanto onorati; né però acquisteremo di saper fare bene e lodevolmente ciò che negli oltramontani piace; perché a loro il dà la natura, che a noi altramente comanda; e così in breve condurremo la nostra letteratura a somigliare quel mostro che Orazio descrisse nel principio della Poetica*.
*Orazio all’inizio dell’Ars Poetica immagina, come corrispettivo di un testo di troppo libera invenzione fantastica, un mostro con testa di donna, cervice equina e membra prese ad ogni sorta di animali e ricoperte di piume.
La lettera di Giordani viene posta all’interno della posizione critica di alcuni letterati italiani di fronte all’argomentazione della De Staël, posizione che, per facilità, inseriremo all’interno dei “classicisti”. Eppure, al di là della pacata argomentazione del Giordani, che riprende il concetto della atemporalità dell’arte (finito è il progresso delle arti: quando abbiano e trovato il bello, e saputo esprimerlo, in quello riposano), lo stesso sottolinea il concetto di “italianità” nell’utilizzo del classico per le nostre lettere; in effetti il Giordani, che approfondirà in seguito il suo liberalismo e patriottismo, teme lo snaturamento della tradizione culturale e quindi dell’italianità, in un momento storico in cui il tema dell’identità nazionale è centrale nell’ideologia risorgimentale.
A favore della De Staël è invece Giovanni Berchet, che sempre nel 1816 scrive la fondamentale, per la poetica romantica, Lettera semiseria di Grisostomo per il suo figliolo:
 Giovanni Berchet
Giovanni Berchet
Il “PUBBLICO” ROMANTICO
Tutti gli uomini, da Adamo in giù fino al calzolaio che ti fa i begli stivali, hanno nel fondo dell’anima una tendenza alla poesia. Questa tendenza, che in pochissimi è attiva, negli altri non è che passiva, non è che una corda che risponde con simpatiche oscillazioni al tocco della prima.
La natura, versando a piene mani i suoi doni nell’animo di que’ rari individui ai quali ella concede la tendenza poetica attiva, pare che si compiaccia di crearli differenti affatto dagli altri uomini in mezzo a cui li fa nascere. Di qui le antiche favole sulla quasi divina origine de’ poeti, e gli antichi pregiudizi sui miracoli loro, e l’«est deus in nobis». Di qui il più vero dettato di tutti i filosofi: che i poeti fanno classe a parte, e non sono cittadini di una sola società ma dell’intero universo. E per verità chi misurasse la sapienza delle nazioni dalla eccellenza de’ loro poeti, parmi che non iscandaglierebbe da savio. Né savio terrei chi nelle dispute letterarie introducesse i rancori e le rivalità nazionali. Omero, Shakespeare, il Calderon, il Camoens, il Racine, lo Schiller per me sono italiani di patria tanto quanto Dante, l’Ariosto e l’Alfieri. La repubblica delle lettere non è che una, e i poeti ne sono concittadini tutti indistintamente. La predilezione con cui ciascheduno di essi guarda quel tratto di terra ove nacque, quella lingua che da fanciullo imparò, non nuoce mai alla energia dell’amore che il vero poeta consacra per instituto dell’arte sua a tutta insieme la umana razza, né alla intensa volontà per la quale egli studia colle opere sue di provvedere al diletto ed alla educazione di tutta insieme l’umana razza. Però questo amore universale, che governa l’intenzione de’ poeti, mette universalmente nella coscienza degli uomini l’obbligo della gratitudine e del rispetto; e nessuna occasione politica può sciogliere noi da questo sacro dovere. Finanche l’ira della guerra rispetta la tomba d’Omero e la casa di Pindaro.
Il poeta dunque sbalza fuori delle mani della natura in ogni tempo, in ogni luogo. Ma per quanto esimio egli sia, non arriverà mai a scuotere fortemente l’animo de’ lettori suoi, né mai potrà ritrarre alto e sentito applauso, se questi non sono ricchi anch’essi della tendenza poetica passiva. Ora siffatta disposizione degli animi umani, quantunque universale, non è in tutti gli uomini ugualmente squisita.
Lo stupido ottentoto, sdraiato sulla soglia della sua capanna, guarda i campi di sabbia che la circondano, e s’addormenta. Esce de’ suoi sonni, guarda in alto, vede un cielo uniforme stendersegli sopra del capo, e s’addormenta. Avvolto perpetuamente tra ’l fumo del suo tugurio e il fetore delle sue capre, egli non ha altri oggetti dei quali domandare alla propria memoria l’immagine, pe’ quali il cuore gli batta di desiderio. Però alla inerzia della fantasia e del cuore in lui tiene dietro di necessità quella della tendenza poetica.
Per lo contrario un parigino agiato ed ingentilito da tutto il lusso di quella gran capitale, onde pervenire a tanta civilizzazione, è passato attraverso una folta immensa di oggetti, attraverso mille e mille combinazioni di accidenti. Quindi la fantasia di lui è stracca, il cuore allentato per troppo esercizio. Le apparenze esterne delle cose non lo lusingano (per così dire); gli effetti di esse non lo commovono più, perché ripetuti le tante volte. E per togliersi di dosso la noia, bisogna a lui investigare le cagioni, giovandosi della mente. Questa sua mente inquisitiva cresce di necessità in vigoria, da che l’anima a pro di lei spende anche gran parte di quelle forze che in altri destina alla fantasia ed al cuore; cresce in arguzia per gli sforzi frequenti a’ quali la meditazione la costringe. E il parigino di cui io parlo, anche senza avvedersene, viene assuefacendosi a perpetui raziocini o, per dirla a modo del Vico, diventa filosofo.
Se la stupidità dell’ottentoto è nimica alla poesia, non è certo favorevole molto a lei la somma civilizzazione del parigino. Nel primo la tendenza poetica è sopita; nel secondo è sciupata in gran parte. I canti del poeta non penetrano nell’anima del primo, perché non trovano la via d’entrarvi. Nell’anima del secondo appena appena discendono accompagnati da paragoni e da raziocini: la fantasia ed il cuore non rispondono loro che come a reminiscenze lontane. E siffatti canti, che sono l’espressione arditissima di tutto ciò che v’ha di più fervido nell’umano pensiero, potranno essi trovar fortuna fra tanto gelo? E che maraviglia se, presso del parigino ingentilito, quel poeta sarà più bene accolto che più penderà all’epigrammatico?
Ma la stupidità dell’ottentoto è separata dalla leziosaggine del parigino fin ora descritto per mezzo di gradi moltissimi di civilizzazione, che più o meno dispongono l’uomo alla poesia. E s’io dovessi indicare uomini che più si trovino oggidì in questa disposizione poetica, parmi che andrei a cercarli in una parte della Germania.
A consolazione non pertanto de’ poeti, in ogni terra, ovunque è coltura intellettuale, vi hanno uomini capaci di sentire poesia. Ve n’ha bensì in copia ora maggiore, ora minore; ma tuttavia sufficiente sempre. Ma fa d’uopo conoscerli e ravvisarli ben bene, e tenerne conto. Ma il poeta non si accorgerà mai della loro esistenza, se per rinvenirli visita le ultime casipole della plebe affamata, e di là salta a dirittura nelle botteghe da caffè, ne’ gabinetti delle Aspasie, nelle corti de’ principi, e nulla più. Ad ogni tratto egli rischierá di cogliere in iscambio la sua patria, ora credendola il capo di Buona speranza, ora il cortile del Palais-royal. E dell’indole dei suoi concittadini egli non saprà mai un ette.
Ché s’egli considera che la sua nazione non la compongono que’ dugento che gli stanno intorno nelle veglie e ne’ conviti; se egli ha mente a questo: che mille e mille famiglie pensano, leggono, scrivono, piangono, fremono e sentono le passioni tutte, senza pure avere un nome ne’ teatri; può essere che a lui si schiarisca innanzi un altro orizzonte, può essere che egli venga accostumandosi ad altri pensieri ed a più vaste intenzioni.
L’annoverare qui gli accidenti fisici propizi o avversi alla tendenza poetica; il dire minutamente come questa, del pari che la virtù morale, possa essere aumentata o ristretta in una nazione dalla natura delle instituzioni civili, delle leggi religiose e di altre circostanze politiche; non fa all’intendimento mio. Te ne discorreranno, o carissimo, a tempo opportuno, i libri ch’io ti presterò. Basti a te per ora il sapere che tutte le presenti nazioni d’Europa — l’italiana anch’essa né più né meno — sono formate da tre classi d’individui: l’una di ottentoti, l’una di parigini e l’una, per ultimo, che comprende tutti gli altri individui leggenti ed ascoltanti, non eccettuati quelli che, avendo anche studiato ed esperimentato quant’altri, pur tuttavia ritengono attitudine alle emozioni. A questi tutti io do nome di «popolo».
Cosa afferma Berchet in questa celeberrima lettera? Il letterato lombardo parte da Giovambattista Vico, il quale afferma che dapprima gli uomini sono poeti e poi filosofi, definendo tale passaggio come crescita; Berchet la rovescia, dando la palma alla capacità poetica umana che è universale. Tuttavia tale capacità può essere distribuita in tre tipologie umane differenti:
- passiva: gli ottentotti, originariamente popolazione dell’Africa meridionale, per Berchet coloro che non possono e non sanno sollevarsi al di sopra di semplici bisogni fisici;
- spenta: i parigini, figli dell’illuminismo raziocinante e classicisti, così abituati alle raffinatezze letterarie da non saper più parlare “al cuore e alla fantasia”
- attiva: quella parte della popolazione a cui l’attività poetica non è ancora stata spenta, ma non trova corrispondenza letteraria che possa ravvivarla: tale compito spetta alla letteratura romantica.
Berchet non ne parla, ma è evidente che il suo discorso non può prescindere dall’attenzione che la cultura romantica deve alla lingua da utilizzare: infatti la lingua poetica sinora utilizzata, per Berchet, non può essere che quella “dei parigini”; quella per il romanzo, genere di nessuna tradizione nelle nostre lettere, – lo Jacopo Ortis foscoliano è, linguisticamente parlando, lirico) non esiste ancora (ci penserà, appunto, Manzoni).
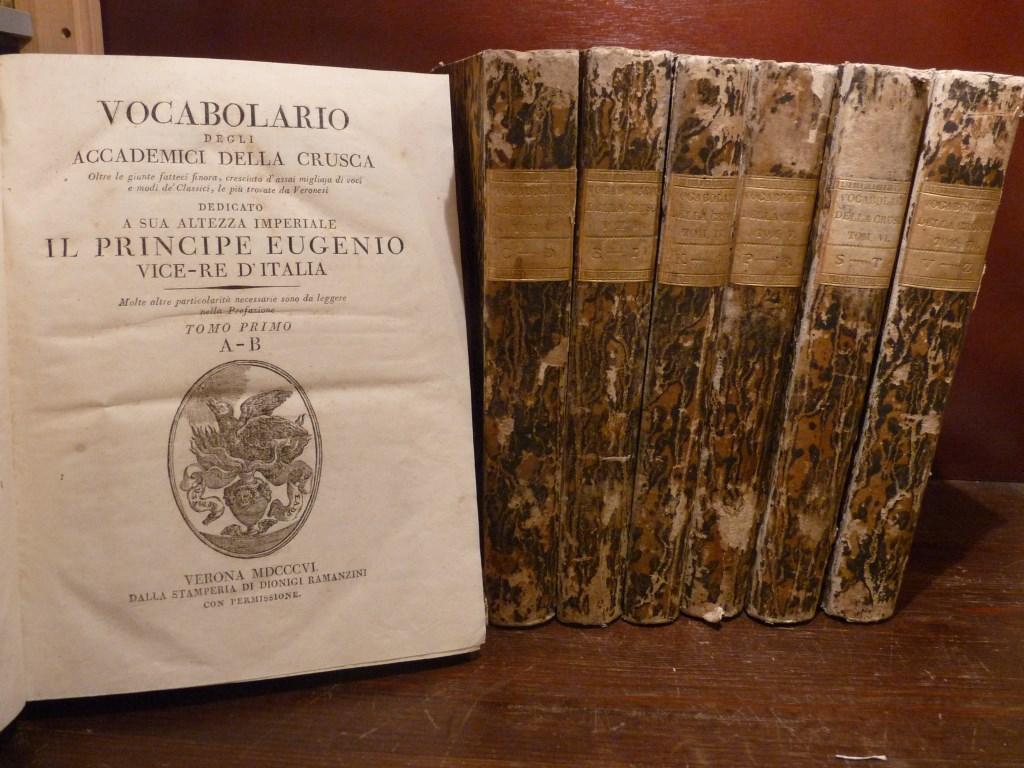 Il vocabolario della Crusca del 1806
Il vocabolario della Crusca del 1806
Ma perché nell’Ottocento diventa cruciale il discorso linguistico? Semplicemente perché l’Italia non è unita né politicamente né linguisticamente ed è sotto il controllo straniero; se il Romanticismo, ed il Risorgimento ad esso legato, mettono al centro della loro riflessione politica e culturale l’identità di nazione, risulta evidente che essa va cercata anche e soprattutto in una unificazione linguistica. Tre sono le teorie che qui velocemente riportiamo:
- Il purismo di Antonio Cesari e Basilio Puoti, secondo il quale la lingua letteraria deve riprendere i grandi trecentisti sino agli scrittori rinascimentali; aspra è la sua battaglia contro i francesismi (d’illuministica memoria), che assumono tuttavia anche valore politico;
- Moderatismo classicista i cui maggiori esponenti furono Vincenzo Monti e Pietro Giordani, secondo i quali non è corretto escludere tutta la tradizione letteraria; la lingua pertanto dovrà essere modellata sull’esempio dei grandi scrittori, ma non dovrà escludere le sollecitazioni che gli giungono dall’età presente (si pensi al linguaggio medico e tecnico)
- Moderno e nazionale, così come la vogliono i romantici, capace di sollecitare il pubblico offrendo loro un prodotto che parli al cuore e alla fantasia. Tale proposito l’affronterà in seguito il Manzoni che non interverrà in modo diretto sulla “questione della lingua”, quanto, piuttosto, in modo “pratico”; I promessi sposi sono infatti un esempio probante di una lingua nazionale e popolare, ottenuta utilizzando il toscano parlato dalle persone colte.
Il Romanticismo italiano, al pari e forse più dell’Illuminismo, coinvolto, come già detto, alla storia nazionale, non può prescindere dalla diffusione di idee, progetti, così come non può fare a meno di discussioni culturali e/o politiche. Per questo egli riprende e accentua l’importanza delle riviste: come per il ‘700 illuminato era stato fondamentale Il Caffè, per la cultura romantica saranno fondamentali Il Conciliatore, l’Antologia ed il Politecnico.
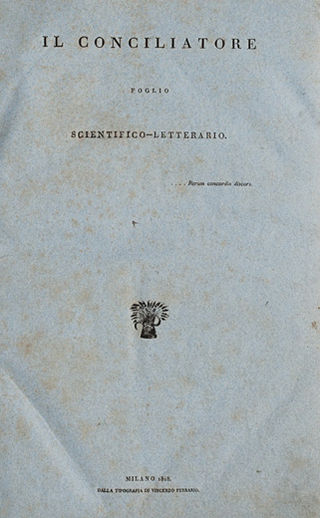
Il Conciliatore o Foglio azzurro per il colore delle sue pagine, durò soltanto un anno, dal 1818 al 1819, perché mal visto dall’autorità austriaca che vedeva in esso uno strumento politico più che letterario. Il suo programma si basa sul concetto di utilità generale, dice Borsieri, nel primo numero della rivista, a nome dell’intera redazione:
L’utilità generale deve essere senza dubbio il primo scopo di chiunque vuole in qualsiasi modo dedicare i suoi pensieri al servizio del Pubblico; e quindi i libri e gli scritti di ogni sorta, se dalla utilità vadano scompagnati, possono meritamente assomigliarsi a belle e frondose piante che non portano frutto, e che il buon padre di famiglia esclude dal suo campo. Partendo da questo principio parve agli Estensori del “Conciliatore” che due cose fossero da farsi nella scelta delle materie. Preferire in prima quelle, le quali sono immediatamente riconosciute utili dal maggior numero; ed unirle ad altre che, oltre l’essere dilettevoli di lor natura, avvezzano altresì gli uomini a rivolgere la propria attenzione sopra se stessi, e possono quando che sia recar loro una utilità egualmente reale, quantunque non egualmente sentita.
Il Conciliatore nasce con l’intenzione di riunire gli intellettuali italiani, fossero anche di estrazione diversa ad un progetto comune, per meglio dire conciliare differenti sensibilità per agire per il progresso del paese. Ma il nome della rivista, che chiaramente si opponeva alla filogovernativa Biblioteca Italiana, voleva anche “conciliare” la volontà di progresso tipica dell’Illuminismo con lo spirito romantico (aspetto che sarà tipico dei nostri maggiori romantici, Manzoni e Leopardi). Tuttavia l’idea di rinnovamento culturale e sociale non poteva non incontrare dapprima il contrasto, quindi l’opposizione del governo austriaco, che decise di convocare il direttore Silvio Pellico e di bandirlo da Milano se avesse continuato a pubblicare articoli “politici”. Pertanto la redazione decise di chiudere la rivista.
 Giampiero Viesseux
Giampiero Viesseux
L’Antologia può definirsi come l’erede della rivista milanese. Pubblicato nel tollerante Granducato di Toscana di Ferdinando III tra il 1821 ed il 1832, quando fu chiusa dopo i moti del ”31 in un nuovo clima di sospetto e repressioni. Più moderata del Conciliatore, la rivista tuttavia per chi vi collaborò mostrava chiaramente un ispirazione liberale e cattolica. Essa nacque dall’incontro tra Gino Capponi e Giampiero Viesseux e si riuniva appunto nel “Gabinetto scientifico-letterario Viesseux”, (gabinetto da cabinet francese piccolo luogo; ancora oggi si usa a livello politico: gabinetto di governo, cioè consiglio dei ministri) e venne frequentati da famosi letterari del tempo fra i quali ricordiamo Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni ed il francese Stendhal.
 Il Gabinetto Viesseux oggi (Sala Ferri)
Il Gabinetto Viesseux oggi (Sala Ferri)
La poesia romantica in Italia, al di là dell’esperienza leopardiana e manzoniana, per il resto è piuttosto caduca; potremo parlare tuttavia di diversi indirizzi: quello prettamente romantico, per citare i più rappresentativi, del Berchet e Grossi; il maggiormente politico, si pensi a Goffredo Mameli; l’importante (forse non nazionale) poesia dialettale di Carlo Porta (milanese) e Giuseppe Gioacchino Belli (romano); quella del secondo romanticismo, maggiormente sentimentale di Prati e Aleardi.
Cominciamo con Giovanni Berchet, di cui abbiamo già visto l’intervento teorico a sostegno della De Staël. Nato a Milano nel 1873, sin da giovane si accosta al romanticismo letterario per poi approdare alla carboneria durante i moti del ’21. Costretto a fuggire prima a Parigi e poi a Londra per una quindicina d’anni, fu lì, in esilio, che scrisse le sue principali opere. Tornato partecipò alla rivolta milanese del ’48. Al fallimento del moto rivoluzionario riparò in Piemonte, dove venne eletto deputato. Morì nel 1851.
IL TROVATORE
Va per la selva bruna
solingo il Trovator
domato dal rigor
della fortuna.
La faccia sua sì bella
la disfiorò il dolor;
la voce del cantor
non è più quella.
Ardea nel suo segreto;
e i voti, i lai, l’ardor
alla canzon d’amor
fidò indiscreto.
Dal talamo inacesso
udillo il suo Signor:
l’improvido cantor
tradì se stesso.
Pei dì del giovanetto
tremò alla donna il cor,
ignora fino allor
di tanto affetto.
E supplice al geloso,
ne contenea il furor:
bella del proprio onor
piacque allo sposo.
Rise l’ingenua. Blando
l’accarezzò il signor;
ma il giovan trovator
cacciato è in bando.
De’ cari occhi fatali
più non vedrà il fulgor,
non berrà più da lor
l’obblio de’ mali.
Varcò quegli atri muto
ch’ei rallegrava ognor
con gl’inni del valor,
col suo liuto.
Scese, varcò le porte;
stette, guardolle ancor;
e gli scoppiava il cor
come per morte.
Venne alla selva bruna:
qui erra il trovator,
fuggendo ogni chiaror
fuor che la luna.
La guancia sua sì bella
più non somiglia a un fior;
la voce del cantor
non è più quella.
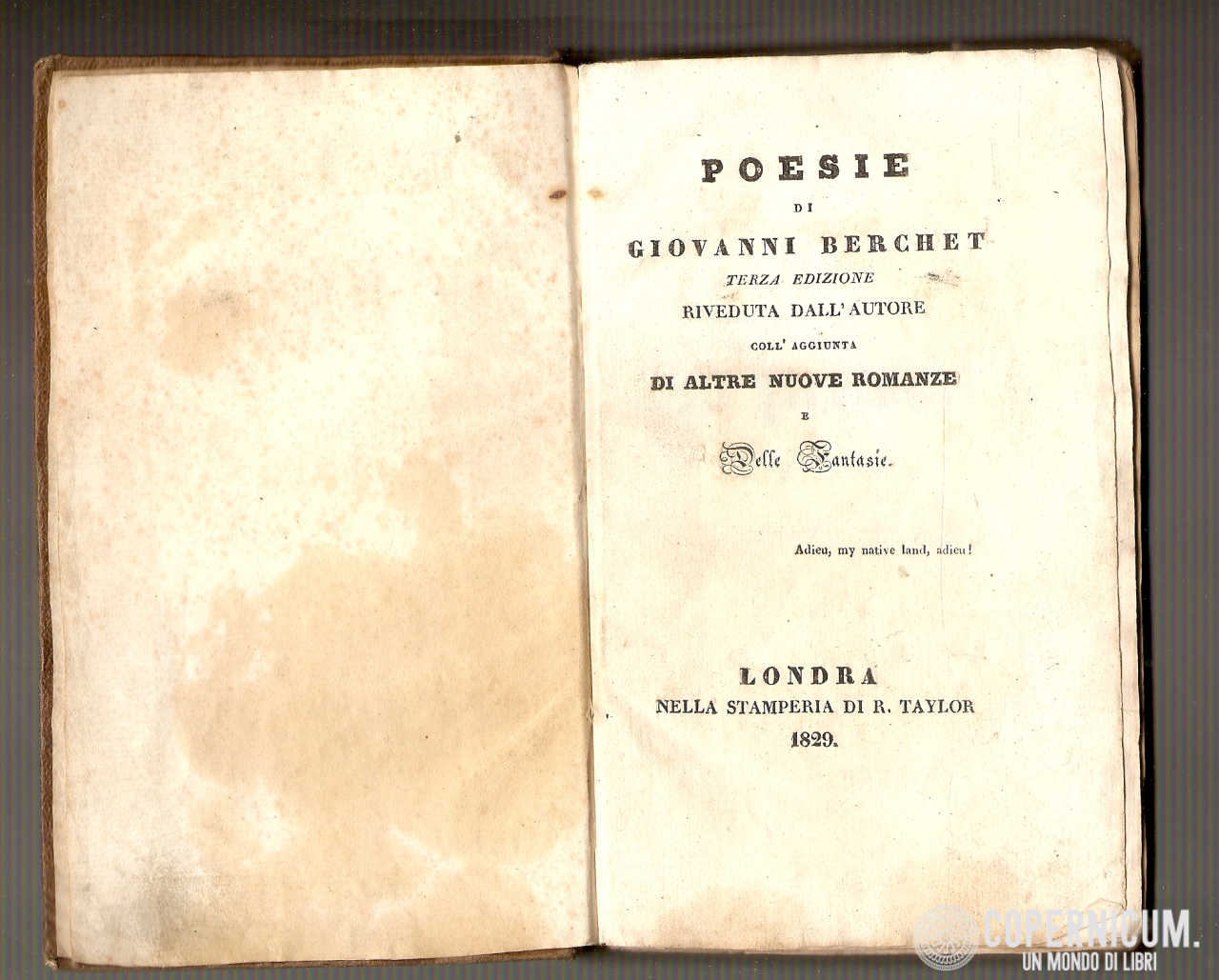 Edizione inglese delle “Romanze” di Berchet
Edizione inglese delle “Romanze” di Berchet
Il Trovatore, considerato da molti il capolavoro del Berchet, si presenta in modo paradigmatico riguardo la poetica romantica italiana; in esso infatti troviamo:
- tema sentimentale: un amore descritto in modo etereo, vago, in cui un giovane trovatore,
innamorato della della donna del Signore, viene scoperto e quindi bandito dalla patria;
- tema nazionale: il passo viene letto attraverso un’allegoria politica: il Signore rappresenta l’Austria, la castellana l’Italia ed il trovatore i patrioti costretti vagare lontano dalla patria. Ci piace ricordare che a fianco alla lettura (forse un po’ forzata) politica vi è anche quella autobiografica;
- tema storico: la riscoperta del Medioevo;
- La popolarità della lettura: Berchet ottiene la popolarità scegliendo come genere la romanza, dal carattere musicale ottenuto con l’utilizzo di stanze di quattro versi di cui i primi tre settenari e il quarto quinario con rime alternate di cui la terza e quarta in monorime. Continuo l’utilizzo delle parole tronche a dare velocità ed armonia al testo. Il lessico, pur ricercato, rifugge da ogni forma di mitologia e di intellettualismo spinto, riuscendo pertanto comprensibile ai lettori.
 Giuseppe Giusti
Giuseppe Giusti
Giuseppe Giusti è un poeta toscano, nato da agiata famiglia presso Pistoia nel 1809. Conobbe a Milano Alessandro Manzoni ed altri intellettuali lombardi. La loro amicizia lo avvicinò ad ideologie liberali. Partì per Firenze dove partecipò ai moti del ’48. Morì di tisi a casa di un suo amico nel 1840.
IL RE TRAVICELLO
Al Re Travicello
piovuto ai ranocchi,
mi levo il cappello
e piego i ginocchi;
lo predico anch’io
cascato da Dio:
oh comodo, oh bello
un Re Travicello!
Calò nel suo regno
con molto fracasso;
le teste di legno
fan sempre del chiasso:
ma subito tacque,
e al sommo dell’acque
rimase un corbello
il Re Travicello.
Da tutto il pantano
veduto quel coso,
«È questo il Sovrano
così rumoroso?
(s’udì gracidare).
Per farsi fischiare
fa tanto bordello
un Re Travicello?
Un tronco piallato
avrà la corona?
O Giove ha sbagliato,
oppur ci minchiona:
sia dato lo sfratto
al Re mentecatto,
si mandi in appello
il Re Travicello.»
Tacete, tacete;
lasciate il reame,
o bestie che siete,
a un Re di legname.
Non tira a pelare,
vi lascia cantare,
non apre macello
un Re Travicello.
Là là per la reggia
dal vento portato,
tentenna, galleggia,
e mai dello Stato
non pesca nel fondo:
Che scienza di mondo!
Che Re di cervello
è un Re Travicello!
Se a caso s’adopra
d’intingere il capo,
vedete? di sopra
lo porta daccapo
la sua leggerezza.
chiamatelo Altezza,
chè torna a capello
a un Re Travicello.
Volete il serpente
che il sonno vi scuota?
Dormite contente
costì nella mota,
o bestie impotenti:
per chi non ha denti,
è fatto a pennello
un Re Travicello!
Un popolo pieno
di tante fortune,
può farne di meno
del senso comune.
Che popolo ammodo
che Principe sodo
che santo modello
un Re Travicello!
La poesia del Grossi, formata da 9 strofe di otto versi senari con rima alternata per i primi quattro e baciata per gli altri quattro versi, unisce alla cosiddetta “popolarità” il sarcasmo tipico della cultura toscana. La prima è ottenuta riprendendo una celeberrima favola di Esopo, rielaborata in seguito anche in lingua latina da Fedro, nella quale si racconta appunto che alle rane di uno stagno che con insistenza chiedevano un re, Zeus gettò un pezzo di legno, un travicello, appunto, che venne accolto con tutti gli onori. Non passò tuttvia molto tempo che, stanche di vederlo galleggiare immobile e muto, le rane ripresero a protestare vivacemente; allora Zeus inviò loro un serpente che le divorò tutte. Giusti cambia il finale, adattandolo alla sua allegoria: sembra infatti che il poeta volesse alludere al granduca di Toscana Leopoldo II che con la sua politica attendista e fortemente tollerante cercava di “addormentare” i fermenti di ribellione presenti in Toscana.
Di carattere chiaramente politico è il testo di Goffredo Mameli, (morto giovanissimo a 22 anni nella difesa della Repubblica Romana) musicato in seguito da Michele Notaro:
 Goffredo Mameli
Goffredo Mameli
CANTO DEGLI ITALIANI
Fratelli d’Italia
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci,
l’Unione, e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Fratelli d’Italia / L’Italia si è svegliata, / si è messa in capo l’elmo di Scipione (che aveva conquistato l’Africa) / Dov’è la vittoria? / (La vittoria) porga il capo (all’Italia) / che Dio la creò schiava di Roma // Stringiamoci a coorte (suddivisione compatta di una legione romana) / siamo pronti a morire / l’Italia ci ha chiamato // Noi siamo da secoli / calpestati, derisi / perché non non siamo un popolo / perché siamo divisi / ci raccolga un’unica / bandiera, un’unica speranza / è arrivata già l’ora di unirci tutti insieme. // Stringiamoci a coorte (suddivisione compatta di una legione romana) / siamo pronti a morire / l’Italia ci ha chiamato // Uniamoci, amiamoci / l’unione politica e l’amore / mostrano al popolo / la via di Dio, / chi può allora vincerci? // Stringiamoci a coorte (suddivisione compatta di una legione romana) / siamo pronti a morire / l’Italia ci ha chiamato // Dalle Alpi sino alla Sicilia / dovunque è Legnano (dove si mostrò lo spirito che condusse la Lega Lombarda a sconfiggere l’imperatore Federgo Barbarossa nel 1176) / ogni uomo ha il coraggio di Ferruccio (militare che nel 1530 morì in difesa della Repubblica di Firenze contro le truppe imperiali) / i bambini d’Italia si chiamano Balilla (Giovanni Battista Perasso, soprannominato Balilla, nel 1746, lanciando una pietra contro un ufficiale, diede l’avvio a Genova alla rivoluzione che cacciò gli Austriaci dalla città) / i suoni di ogni tromba / ci richiama ad unirci (come in Sicilia, quando nel 1282, i palermitani si rivolsero contro gli Angioini, episodio storico che prende il nome di Vespri siciliani) // Le spade (dei mercenari) / sono giunchi che si piegano / ah, l’aquila imperiale / sta perdendo le penne / che ha bevuto / il sangue d’Italia / ed insieme alla Russia / il sangue di Polonia / ma quel sangue gli ha bruciato il cuore.
Quello che nel 1946 era ancora un Inno provvisorio, ma venne composto alla vigilia dell’insurrezione di Milano. In esso si notano le principali caratteristiche della poesia – in questo caso consapevolmente canzone – risorgimentale: aulicità del dettato con ripetute inversioni, l’uso della prosopopea, ancora il richiamo a diversi momenti storici, dalla storia romana fino al ‘700, anche con accenni certamente intuibili dai rivoluzionari. Il testo del Mameli è chiaramente d’ispirazione mazziniana, così come si comprende dal riferimento alla benedizione divina per l’azione rivoluzionaria.
(Vi riporto gli ultimi anni dell’iter incredibile che fece diventare questo testo il nostro Inno nazionale: Il 29 giugno 2016, sulla scia del provvedimento del 23 novembre 2012, è stata presentata alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati una proposta di legge per rendere il Canto degli Italiani inno ufficiale della Repubblica Italiana. Il 25 ottobre 2017, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato tale proposta di legge, coi relativi emendamenti e il 27 ottobre, il disegno di legge è passato all’omologa commissione del Senato della Repubblica. Il 15 novembre 2017 il disegno di legge che riconosce il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e di Michele Novaro quale inno nazionale della Repubblica Italiana è stato approvato in via definita dalla Commissione Affari costituzionali del Senato. Visto che le due citate commissioni parlamentari hanno approvato il provvedimento in “sede legislativa”, quest’ultimo è stato direttamente promulgato dal Presidente della Repubblica Italiana il 4 dicembre 2017 come “legge nº 181” senza la necessità dei consueti passaggi nelle aule parlamentari. Il 15 dicembre 2017 l’iter si è concluso definitivamente, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge nº 181 del 4 dicembre 2017, avente titolo “Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica”, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2017. I due commi che compongono la legge recitano:
«1. La Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono stabilite le modalità di esecuzione del «Canto degli italiani» quale inno nazionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.»
Data a Roma, addì 4 dicembre 2017
La seconda generazione romantica vide la luce dopo il fallimento dei moti rivoluzionari del ’48. In essa, soprattutto nella lirica, si nota un ripiegamento delle istanze precedentemente presenti sia sul piano del contenuto, dove, seppure si affrontava il discorso politico, spesso si cadeva nella retorica, oppure se il tema toccava i sentimenti si poteva scivolare nel lezioso.
I più rappresentativi poeti di questo periodo possiamo individuarli in Aleardo Aleardi (nato nel 1812) e Giovanni Prati (nato nel 1814), amici e collaboratori del periodico Il caffé Petrocchi. Impegnati politicamente ambedue vissero momenti di contrasto, conclusi con un temporaneo arresto da parte degli austriaci, ed ambedue conclusero la loro vita come senatori del Regno. Muoiono a Roma, il primo nel 1873, Prati nel 1884.
 Domenico Induno: Ritratto di Aleardo Aleardi
Domenico Induno: Ritratto di Aleardo Aleardi
ALEARDO ALEARDI: LE TRE SORELLE
Morían l’autunno e il giorno; ed io sedea
s’una eminente pietra
al passo de la tetra
via che mena a la selva. Una serena
primizia di crepuscolo scendea
su la valle profonda,
dove flotta del glauco Adige l’onda;
mentre ancora sul monte
scintillavano i vetri
d’un paesel lontano,
e il sol dall’orizzonte
saettava sul piano
purissimo del Garda
una striscia d’instabili splendori,
quasi magico ponte, onde le nostre
mutue speranze varchino e i dolori
da la veneta sponda a la lombarda.
Poscia di sotto a un padiglion di foco
tremolando la spera
calava a poco a poco;
calar pareva dietro a la pendice
d’un de’ tuoi monti fertili di spade,
Niobe guerriera de le mie contrade,
leonessa d’Italia,
Brescia grande e infelice.
Accese nuvolette di corallo
rideano ancor per gli ampi
spazi del cielo; ma col mesto riso
del moribondo pio
che accenna col sereno occhio un addio,
movendo al paradiso.
E dal sentïer che adduce
giù da la selva io vidi
a la quieta luce
venire una fanciulla
pur sotto il fascio de le legne altera;
bruna la faccia e il crine
e la pupilla nera,
come frutto di spine.
Ella piangea. «Dimmi l’affanno, o bella
fanciulla, che ài nel core.»
Io le richiesi; ed ella
Risposemi: «Signore,
ieri legato al par d’un omicida
m’ànno condotto a la prigione il padre,
perchè lo colser là, con la sua fida
canna che fulminava una pernice.
Io penso all’infelice,
io penso a la cadente avola mia».
E più non disse, e seguitò la via.
Qui sono riportate le prime due sezioni su cinque di cui è composto l’intero testo poetico. Vi si immagina che il poeta, seduto meditabondo sull’alta costa di un monte da cui si domina la valle dell’Adige e il lago di Garda (descrizione delle prime due stanze) e quindi incontri tre fanciulle (la prima è qui riportata nella terza stanza), tutte colpite da una pena inflitta loro dagli austriaci. Il testo ci offre la possibilità di analizzare come nell’Aleardi vengano compendiate tutte le reminiscenze poetiche tipiche dell’esperienza romantica, dagli idilli leopardiani alle ballate e canzoni popolareggianti.
 Giovanni Prati
Giovanni Prati
GIOVANNI PRATI: NOTTE
Chiusa è la stanza; il lumicino è spento;
tacita è l’ombra; e qui pensoso io giaccio.
L’andar dell’oriuolo, altro non sento;
e cadrò presto a’ vani sogni in braccio.
Saprà darmi letizia o turbamento
il fantastico mondo, a cui m’affaccio?
e il cardellino o la procella o il vento
mi solverà da l’incantato laccio?
Vedrò il domani e i miei ? vedrò la stanza
rivisitata da l’ambrosia luce?
Vegli su me la carità de’ numi.
Sebben, dolce sarebbe oltr’ogni usanza,
dentro un sogno d’amor che al ciel conduce,
chiudere al tempo e non aprir più i lumi.
“In Psiche, raccolta poetica in cui è inserito questo sonetto, i toni della poesia di Prati si fanno dolenti e malinconici. Vibra il senso del fallimento delle ambizioni personali e degli ideali storico-politici, e il poeta si rifugia nella dimensione privata del quotidiano (la presenza rassicurante delle cose di tutti i giorni, l’orologio, il cardellino, il vento…, che sembrano anticipare alla lontana Pascoli). L’aspirazione dell’animo, pervaso di vittimismo, è quella ad evadere nel sogno e in luoghi incantati, dove dimenticare le delusioni della vita. Nel finale, il sonetto si apre ad una prospettiva vagamente religiosa, in una recuperata sintonia con il tutto che si pone a mezzo tra il Romanticismo tedesco e certa estenuata religiosità decadente. Tuttavia è inutile cercare una qualche responsabilità ideologica: Prati mescola i numi di classica ascendenza con il sogno d’amor, così rivelando come la sua sia una fantasticheria innanzi tutto letteraria. (…) Il linguaggio permane troppo letterario, sospeso com’è tra la leziosità (il lumicino, l’oriuolo) e il sublime classicheggiante (l’ambrosia luce, i numi).” (Barbéri Squarotti).
Il Romanticismo lirico, oltre le naturali altissime esperienze di Manzoni e Leopardi, lo dobbiamo ricercare nella poesia dialettale. Infatti la scelta di inserirsi nel dibattito linguistico attraverso il dialetto raggiungeva due obiettivi fondamentali: quello della “reale” popolarità, dove il popolo non è il borghese di Berchet, ma quello reale che l’italiano non lo parla e si esprime solo nel linguaggio materno; l’altro la maggiore aderenza verso il reale, non come obiettivo da raggiungere, com’era per l’illuminismo, ma come rappresentazione dei reali sentimenti del popolo.

Carlo Porta
Carlo Porta raggiunge con la sua poesia vette elevatissime. Egli appartiene alla prima generazione romantica, essendo nato nel 1775. Di padre borghese, si allontana da Milano solo in due occasioni: una in Baviera, per imparare il tedesco, l’altra a Venezia, dove si diverte, spendendo gran parte del proprio denaro. Torna a Milano ma, con l’arrivo dei Francesi (1800), viene allontanato dagli incarichi pubblici cui si era appena avviato. Li riprende con Napoleone, che gli affida il compito di cassiere generale al Monte (che lo metterà a contatto con la parte più debole della popolazione). Manterrà tale funzione anche con il ritorno degli austriaci. Morirà deluso, perché gli viene attribuito un testo di violenta satira contro il potere che lo metterà in seri guai con l’amministrazione austriaca (in realtà lo scrisse Porta), e malato di gotta, nel 1821.
OFFERTA A DIO
Donna Fabia Fabron de Fabrian
l’eva settada al foeugh sabet passaa
col pader Sigismond ex franzescan,
che intrattant el ghe usava la bontaa
(intrattanta, s’intend, che el ris coseva)
de scoltagh sto discors che la faseva.
«Ora mai anche mì don Sigismond
convengo appien nella di lei paura
che sia prossima assai la fin del mond,
ché vedo cose di una tal natura,
d’una natura tal, che non ponn dars
che in un mondo assai prossim a disfas.
Congiur, stupri, rapinn, gent contro gent,
fellonii, uccision de Princip Regg,
Violenz, avanii, sovvertiment
de troni e de moral, beffe, motegg
contro il culto, e perfin contro i natal
del primm Cardin dell’ordine social.
Questi, Don Sigismond, se non son segni
del complemento della profezia,
non lascian certament d’esser li indegni
frutti dell’attual filosofia;
frutti di cui, pur tropp, ebbi a ingoiar
tutto l’amaro, come or vò a narrar.
Essendo ieri venerdì de marz
fui tratta dalla mia divozion
a Sant Cels, e vi andiedi con quell sfarz
che si adice alla nostra condizion;
il mio copè con l’armi, e i lavorin
tanto al domestich quanto al vetturin.
Tutte le porte e i corridoi davanti
al tempio eren pien cepp d’una faragin
de gent che va, che vien, de mendicanti,
de mercadanti de librett, de immagin,
in guisa che, con tanto furugozz,
agio non v’era a scender dai carrozz.
L’imbarazz era tal che in quella appunt
ch’ero già quasi con un piede abbass,
me urtoron contro un pret sì sporch, sì unt
ch’io, per schivarlo e ritirar el pass,
diedi nel legno un sculaccion sì grand
che mi stramazzò in terra di rimand.
Come me rimaness in un frangent
di questa fatta è facil da suppôr:
e donna e damma in mezz a tanta gent
nel decor compromessa e nel pudôr
è più che cert che se non persi i sens
fu don del ciel che mi guardò propens.
E tanto più che appena sòrta in piè
sentii da tutt i band quej mascalzoni
a ciuffolarmi dietro il va via vè!
risa sconc, improperi, atti buffoni,
quasi foss donna a lor egual in rango,
cittadina… merciaja… o simil fango.
Ma, come dissi, quell ciel stess che in cura
m’ebbe mai sempre fino dalla culla,
non lasciò pure in questa congiuntura
de protegerm ad onta del mio nulla,
e nel cuor m’inspirò tanta costanza
quant c’en voleva in simil circostanza.
Fatta maggior de mì, subit impongo
al mio Anselm ch’el tacess, e el me seguiss,
rompo la calca, passo in chiesa, giongo
a’ piedi dell’altar del Crocifiss,
me umilio, me raccolgh, poi a memoria
fò al mio Signor questa giaculatoria:
“Mio caro buon Gesù, che per decreto
dell’infallibil vostra volontà
m’avete fatta nascere nel ceto
distinto della prima nobiltà,
mentre poteva a un minim cenno vostro
nascer plebea, un verme vile, un mostro:
io vi ringrazio che d’un sì gran bene
abbiev ricolma l’umil mia persona,
tant più che essend le gerarchie terrene
simbol di quelle che vi fan corona
godo così di un tal grad ch’è riflession
del grad di Troni e di Dominazion.
Questo favor lunge dall’esaltarm,
come accadrebbe in un cervell leggier,
non serve in cambi che a ramemorarm
la gratitudin mia ed il dover
di seguirvi e imitarvi, specialment
nella clemenza con i delinquent.
Quindi in vantaggio di costor anch’io
v’offro quei preghi, che avii faa voi stess
per i vostri nimici al Padre Iddio:
ah sì abbiate pietà dei lor eccess,
imperciocché ritengh che mi offendesser
senza conoscer cosa si facesser.
Possa st’umile mia rassegnazion
congiuntament ai merit infinitt
della vostra accerbissima passion
espiar le lor colpe, i lor delitt,
condurli al ben, salvar l’anima mia,
glorificarmi in cielo, e così sia.”
Volendo poi accompagnar col fatt
le parole, onde avesser maggior pes,
e combinare con un po’ d’eclatt
la mortificazion di chi m’ha offes
e l’esempio alle damme da seguir
ne’ contingenti prossimi avvenir,
sorto a un tratt dalla chiesa, e a quej pezzent,
rivolgendem in ton de confidenza,
quanti siete, domando, buona gent?…
siamo ventun, rispondon, Eccellenza!
Caspita! molti, replico,… Ventun?…
Non serve: Anselm?… Degh on quattrin per un.»
Chi tas la Damma, e chì Don Sigismond
pien come on oeuv de zel de religion,
scoldaa dal son di forzellinn, di tond,
l’eva lì per sfodragh on’orazion,
che se Anselm no interromp con la suppera
vattel a catta che borlanda l’era!
Donna Fabia Fabroni di Fabriano sabato scorso era seduta al fuoco col padre Sigismondo ex francescano che nel frattempo (cioè mentre il riso cuoceva) le usava la bontà di ascoltare il discorso che lei veniva facendo. «Oramai anch’io, don Sigismondo, convengo pienamente nella sua paura che la fine del mondo sia assai vicina, perché vedo le cose di una natura tale che non possono aver luogo se non in un mondo in disfacimento. Congiure, stupri, rapine, popoli contro popoli, fellonie, uccisioni di Principi Regi, violenze, angherie, sovvertimenti di troni e di morale, beffe, motteggi contro il culto e perfino contro i natali del primo Cardine dell’ordine sociale. Questi, don Sigismondo, se non sono segni dell’adempimento della profezia, sono però degni frutti della filosofia attuale, frutti di cui, purtroppo, ebbi a ingoiare tutto l’amaro, come le racconterò. Ieri, essendo venerdì di marzo, dalla mia devozione fui tratta a San Celso, e vi andai con quello sfarzo che si addice alla nostra condizione: il mio coupé con lo stemma, e gli alamari tanto ai domestici quanto al cocchiere. Tutte le porte e i corridoi davanti al tempio erano pieni zeppi di una farragine di gente che va e viene, di mendicanti, di mercatanti di libretti e di immagini così che, con tanto trambusto, non v’era agio per scendere dalle carrozze. L’imbarazzo era tale che proprio mentre avevo già quasi in terra un piede mi spinsero contro un prete così sporco, così unto che io, per schivarlo e ritirare il passo, diedi nella carrozza una sederata tanto grande che di rimando mi fece stramazzare a terra. Come mi rimanessi in un simile frangente è facile da supporre: donna e dama, in mezzo a tanta gente, compromessa nel decoro e nel pudore, è più che certo che se non persi i sensi fu dono del cielo che mi guardò benevolmente. E ciò tanto più che appena sorta in piedi sentii da tutte le parti quei mascalzoni zufolarmi alle spalle il ‘va via vè!’ Risa sconce, improperi, atti di scherno, come se fossi una donna di rango uguale al loro, cittadina, merciaia o simile fango. Tuttavia, come Le ho detto, quel cielo stesso che mi ebbe sempre in cura fino dalla culla anche in questa congiuntura non tralasciò di proteggermi malgrado il mio nessun valore e mi spirò nel cuore tanta costanza quanta ce ne voleva in una simile situazione. Fatta maggiore di me, subito impongo al mio Anselmo che tacesse e mi seguisse: rompo la calca, passo in chiesa, giungo ai piedi dell’altare del Crocefisso, mi umilio, mi raccolgo, poi a memoria faccio al mio Signore questa giaculatoria ‘Mio caro buon Gesù, che per decreto dell’infallibile vostra volontà mi avete fatto nascere nel ceto distinto della prima nobiltà mentre a un minimo cenno vostro potevo nascere plebea, un vile verme, un mostro; io vi ringrazio che abbiate ricolma la mia umile persona di un così grande bene, tanto più che essendo le gerarchie terrene simbolo di quelle che vi fanno corona godo di un grado che è riflessione del grado dei Troni e delle Dominazioni. Tale favore, lungi dall’esaltarmi, come accadrebbe in un cervello leggero, serve invece soltanto a ricordarmi la mia gratitudine e il dovere di seguirvi e imitarvi, soprattutto nella clemenza verso i delinquenti. A pro di costoro quindi anch’io vi offro quelle preghiere, che voi stesso avete fatto a Dio Padre per i nemici vostri: ah sì, abbiate pietà dei loro eccessi, perché ritengo che mi abbiano offesa senza sapere cosa facessero. Che questa umile mia rassegnazione, congiuntamente ai meriti infiniti della vostra acerbissima passione, possa espiare le loro colpe, i loro delitti, condurli al bene, salvare la mia anima, glorificarmi in cielo, e così sia’. Volendo poi accompagnare con i fatti le parole, perché avessero maggior peso, e combinare con un po’ di éclat la mortificazione di chi mi ha offeso e l’esempio da seguire per le dame in futuro, esco rapidamente dalla chiesa e rivolgendomi a quei pezzenti in tono di confidenza: ‘Quanti siete, domando, buona gente? Siamo ventuno, rispondono, Eccellenza! Caspita, molti, replico… ventuno? Non serve: Anselmo? date loro un quattrino per ciascuno’. Qui tace la dama e qui don Sigismondo, pieno come un uovo di zelo di religione, scaldato dal suono delle forchette, dei piatti, era lì lì per sfoderarle un’orazione che, se Anselmo con la zuppiera non l’interrompe, vattelapesca che sproloquio era!
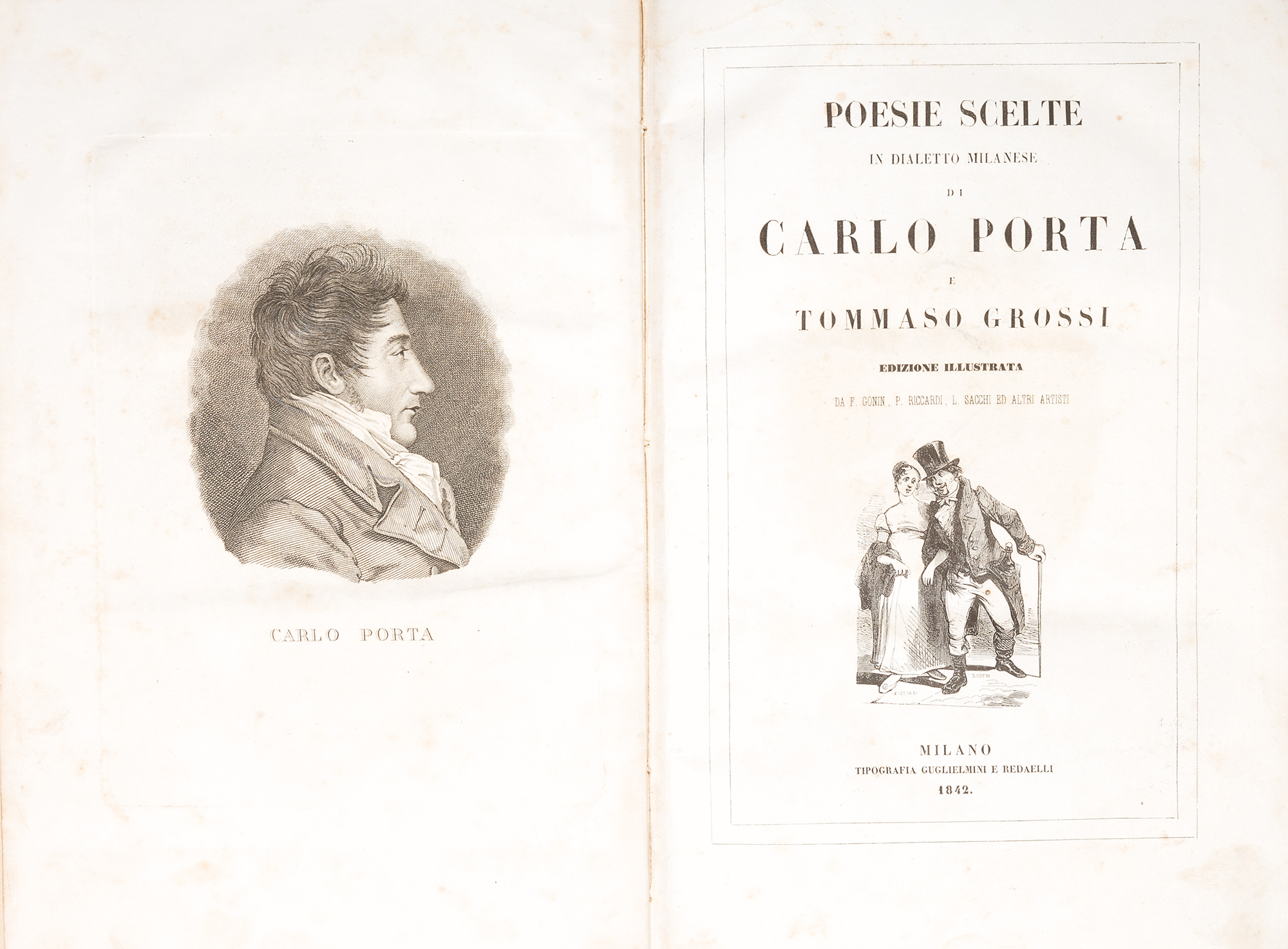
In questo testo, (schema metrico: sestine di endecasillabi, secondo lo schema ABABCC) uno dei più famosi del Porta, il poeta utilizza la struttura dell’antifrasi del Giorno, seguendo così quella linea lombarda di Parini che è un punto di riferimento importante. Infatti il testo viene illuminato proprio dal sarcasmo messo in luce dalle parole della donna che considera la nobiltà e i privilegi sociali di cui gode come fondati nella volontà stessa di Dio: per lei, le gerarchie terrene sono simbolo e riflesso di quelle celesti. E’ evidente pertanto che tutta la storia che anima i moti risorgimentali è un radicale sovvertimento dell’ordine voluto da Dio, tale da preannunciare la fine del mondo. La nobildonna quando deve parlare di popolo usa termini quali merciaja… o simil fango e descrivendo l’incidente, la culata contro la carrozza, per evitare di venire a contatto con un prete sudicio, cadendo così a terra, tra l’ilarità generale) utilizza riferimenti evangelici in modo assolutamente blasfemo (perdonali perché non sanno quello che fanno). Il linguaggio è estremamente composito e sperimentale, tanto che si può a buon diritto parlare di pastiche linguistico. La strofa del prologo e quella dell’epilogo, scritte in milanese popolare e schietto, esprimono il punto di vista del poeta, che idealmente associa al suo giudizio il popolo cittadino. In mezzo si colloca il monologo della protagonista, Donna Fabia, il cui modo di esprimersi è una caricatura della lingua dei ceti elevati milanesi, chiamata lingua corrente o parlar finito, forma linguistica intermedia fra dialetto e italiano, che tradisce sia la spontaneità e la sincerità dell’uno, sia la correttezza formale dell’altro. L’uso maldestro e insieme pretenzioso della lingua della nobildonna, che si innalza ulteriormente al momento della preghiera sacrilega, si confà perfettamente alla rappresentazione della sua ignoranza e arrogante superbia.
 Giuseppe Gioacchino Belli
Giuseppe Gioacchino Belli
La vita Giuseppe Gioachino Belli è più movimentata di quella del collega milanese: nasce a Roma nel 1791 da famiglia benestante, ma presto cade in miseria per la morte di peste del padre (1802) e quella della madre (1807). Ha appena sedici anni e si riduce a cercare qualche piccolo impiego ed ospitalità presso i prelati della città. Nel 1816 sposa una donna di dieci anni più grande, che lo aiuterà e lo proteggerà facendogli anche ottenere un lavoro più stabile presso la Curia papale. Rimessosi economicamente viaggia, raggiungendo Venezia, Milano (dove incontra Porta), Firenze che lo avvicina alle idee moderal liberali del Gabinetto Viesseux. La morte della moglie lo riporta a Roma, dove riprende il lavoro interrotto anni prima. A livello letterario la sua attività sembra scindersi in una ufficiale, con poesie disimpegnate e prone al potere costituito ed in una privata nelle poesie delle quali, dalla diffusione ristretta e circoscritta ad amici, attacca il governo e la religione. Alla proclamazione della Repubblica romana (1848), per la sua attività ufficiale cade in sospetto della nuova autorità, tale da portarlo ad assumere un atteggiamento sempre più reazionario, fino alla morte, avvenuta nel 1863.
Il suo itinerario poetico è stato ricostruito a posteriori dalla critica che ha sottolineato come il Belli abbia utilizzato per la sua produzione “il punto di vista” del popolo che appare a volte disincantato, privo di qualsiasi prospettiva futura, foss’anche consolatoria sul piano fideistico, sia arrabbiata, ma impotente contro il potere costituito della Chiesa.
LI PRELATI E LI CARDINALI
Pijete gusto: guarda a uno a uno
tutti li Cardinali e li Prelati;
e vederai che de romani nati
ce ne so ppochi, o nun ce n’è gnisuno.
Nun ze sente che Napoli, Belluno,
Fermo, Fiorenza, Genova, Frascati…
E qualunque città li ppiù affamati
li manna a Roma a cojonà er diggiuno.
Ma ssarìa poco male lo sfamalli:
er pegg’è che de tanti che ce trotteno
li somari sò ppiù de li cavalli.
E Roma, indove viengheno a dà ffonno,
e rinneghino Iddio, rubben’ e ffotteno,
è la stalla e la chiavica der monno.
Togliti la soddisfazione: osserva ad uno ad uno / tutti i cardinali ed i preti, / e vedrai che di quelli nati a Roma / ce ne sono proprio pochi, o addirittura non c’e nessuno. // Non si sente che gente di Napoli, Belluno (Veneti), / Fermo (Marchigiani), Firenze, Genova, Frascati (Laziali) / ed ogni città manda a Roma / i più affamati, a mangiare ad abbuffarsi // Ma sarebbe poco male sfamarli / il peggio è che di tanti che ci stanno / sono più i somari che i cavalli // e Roma, dove vengono a prendersi tutto / rinnegano Dio, rubano, fottono / è la stalla e la fogna del mondo.

Domenico Purificato: una litografia tratta dai sonetti del Belli
Il sonetto (ABBA, ABBA, CDC, EDE) appartiene a quella vis polemica contro il clero di Roma: qui viene sottolineata la non appartenenza alla città (d’altra parte l’internazionalismo era una caratteristica della Chiesa), ma tale sottolineatura indica proprio lo sguardo un po’ invidioso e rancoroso di chi ritiene che la rovina di Roma sia determinata dal disinteresse della città. Lo sguardo è sarcastico: la metafora equina tra asini e cavalli (non si capisce se il poeta voglia sottolineare la bassezza culturale o morale o, addirittura, ambedue), il climax degli ultimi due versi (bestemmiano, rubano, scopano / stalla, fogna). Il genere potrebbe essere associato all’invettiva di memoriale medievale contro il clero corrotto: ma lì vi era la ricerca di un rinnovamento; qui vi è solo l’esasperazione di un popolo sfruttato e offeso.
ER GIORNO DER GIUDIZZIO
Quattro angioloni co le tromme in bocca
Se metteranno uno pe cantone
A ssonà: poi co ttanto de vocione
Cominceranno a dì: «Fora a chi ttocca».
Allora vierà su una filastrocca
De schertri da la terra a ppecorone,
Pe ripijà ffigura de perzone
Come purcini attorno de la biocca.
E sta biocca sarà Dio benedetto,
Che ne farà du’ parte, bianca, e nera:
Una pe annà in cantina, una sur tetto.
All’urtimo uscirà ‘na sonajera
D’angioli, e, come si ss’annassi a letto,
Smorzeranno li lumi, e bona sera.
Quattro grandi angeli con le trombe in bocca / si metteranno uno per ogni angolo (del mondo) / a suonare: poi con gran vocione / cominceranno a dire: «Sotto a chi tocca». // Allora verrà su una fila / di scheletri dalla terra camminando a carponi / come pecore, per riprendere l’aspetto di persone, / come pulcini attorno alla chioccia. // E questa chioccia sarà Dio benedetto, / che ne farà due parti, bianca e nera: / una per andare in cantina (all’Inferno), una sul tetto (in Paradiso). // Alla fine uscirà un gran numero / di Angeli, e, come se si andasse a letto, / spegneranno le luci, e buona sera.
 Statua del Belli a Trastevere
Statua del Belli a Trastevere
Il tema de Il giudizio universale riguarda il post mortem e lo fa, come dice Vigolo, “attraverso la dismisura gigantesca e quasi sognata delle fantasie infantili” di un immaginario tipicamente secentesco, come il paesaggio della città belliana, piena di riferimenti del barocco ecclesiale. Tuttavia il poeta romano sposa l’immaginifico delle raffigurazioni con il degrado della cultura triviale e popolare: gli angeli stanno ai quattro cantoni (gioco infantile); gli scheletri vanno a pecoroni, le anime pulcini e Dio una gallina, l’inferno la cantina e il paradiso il tetto. Tutto questo senza alcun sentimento di trascendenza: la chiusa così prosaica di e bona sera, rimanda ad un nichilismo di fondo.
ER CAFFETTIERE FILOSOFO
L’ommini de sto monno sò ll’istesso
Che vvaghi de caffè nner mascinino:
C’uno prima, uno doppo, e un antro appresso,
Tutti cuanti però vvanno a un distino.
Spesso muteno sito, e ccaccia spesso
Er vago grosso er vago piccinino,
E ss’incarzeno, tutti in zu l’ingresso
Der ferro che li sfraggne in porverino.
E ll’ommini accusì vviveno ar monno
Misticati pe mmano de la sorte
Che sse li ggira tutti in tonno in tonno;
E mmovennose oggnuno, o ppiano, o fforte,
Senza capillo mai caleno a ffonno
Pe ccascà nne la gola de la morte.
Gli uomini di questo mondo sono come come / chicchi di caffé nel macinino: / uno prima, uno dopo, e un altro in seguito, / tutti quanti però vanno verso un medesimo destino. // Spesso cambiano posto, e spesso caccia / il chicco grosso quello piccolo, / e s’incalzano tutti nell’imboccatura / del ferro che li riduce in polvere. // E gli uomini in questo modo vivono nel mondo / mescolati per mano della sorte / che se li gira tutti in tondo in tondo; / e muovendosi ognuno, o piano, o forte, / senza mai capirne la ragione calano in fondo / per cadere nella gola della morte.
Anche in questo sonetto troviamo una meditazione sul finis vitae. Se quello precedente illustrava con fantasmagorica fantasia la corte divina, qui i colori si fanno scuri, il macinino ed i chicchi di caffè metafore entrambe dell’inutilità della vita. E’ che tale inutilità è condivisa dall’intera umanità che è qui vista in lotta l’un con l’altro per ottenere un non so che cosa che non servirà a nulla, se è destino finire come polvere (qui la metafora sembra quasi annullarsi). Torniamo al nichilismo puro, un nichilismo su cui stava riflettendo, con esiti letterari e filosofici diversi, Giacomo Leopardi.
Il romanzo in Italia avrà maggiori difficoltà ad imporsi, e questo è certamente causato da due fattori fondamentali:
- la mancanza di una tradizione;
- la frammentazione politica e quindi linguistica che non permette il possesso di una lingua media, adatta al genere romanzo;
- l’assenza di una diffusa classe borghese.
Possiamo dire che i primi tentativi che si fecero in Italia riguardarono il genere storico e derivarono tutti dalla lettura dapprima di Ivanhoe di Walter Scott, che, grazie anche all’apporto degli esuli, diede origine ad un vero e proprio scottismo, ed in seguito dal successo dei Promessi sposi.
D’altra parte, con meno complessità dell’opera manzoniana, il romanzo storico poteva essere piegato a fini patriottici/nazionalistici e quindi possedere quel fine educativo che permetteva loro di rafforzare l’idea risorgimentale. Non per niente i periodi storici sono per D’Azeglio il Rinascimento, per Grossi il Medioevo.
 Francesco Hayez: Massimo D’Azeglio
Francesco Hayez: Massimo D’Azeglio
Massimo D’Azeglio, nasce da nobile famiglia a Torino, nel 1798. Sin da giovane si lega ai circoli liberali italiani, diventando senatore del regno piemontese dal 1849 al 1852 e infine governatore di Milano nel 1860. Sposa Giulia, figlia di Manzoni, e, culturalmente non è solo autore di opere storiche e autobiografiche, ma anche un discreto pittore.
La sua opera più famosa è Ettore Fieramosca, pubblicato nel 1833, con grande successo.
La vicenda, ambientata durante la guerra tra Francesi e Spagnoli per il dominio su Napoli, ha come fulcro l’episodio della disfida di Barletta, causato dall’insulto di codardia rivolto da un cavaliere francese agli italiani, militanti nell’esercito spagnolo. Al motivo patriottico si affianca il tema amoroso: Ettore Fieramosca ama la bella Ginevra di Monreale, costretta a sposare Grajano d’Asti – combattente per denaro nelle truppe francesi – ed insidiata dal duca di Valentino. Dopo la sfida, che vede vincitori gli italiani e morto Grajano, Fieramosca scopre che Ginevra è stata rapita, violentata e uccisa dal duca, e sparisce misteriosamente, in preda al dolore.
LA DISFIDA
Gli uomini d’arme intanto accoppiatisi combattevano spada a spada, e così due a due dando e ribattendo quei grandissimi colpi, e volteggiandosi intorno scambievolmente per torre il lor vantaggio, venivan dilatando la zuffa serrata dal primo assalto; la polvere cacciata dal vento più non toglieva la vista dei combattenti; si conobbe che l’uomo d’armi scavalcato era Martellin de Lambris. Fanfulla, per disgrazia del Francese, gli si trovò contra, e con quella sua pazza furia, nella quale era pur molta virtù e somma perizia, gli appiccò alla visiera la lancia in modo che lo spinse quant’era lunga a fargli assaggiar s’era soda la terra, e nel fare il bel colpo alzò la voce in modo che s’udì fra tanto strepito, e gridò: «E uno!» poi vedendosi non lontano La Motta che al colpo di Fieramosca avea perduta una staffa, seguitava: «I danari non basteranno… sono pochi i danari…». Ed allargatasi poi la zuffa, disse al vinto: «Tu sei mio prigione…» ma l’altro rimessosi in piè gli rispose d’una stoccata che strisciò sulla corazza lucente del Lodigiano: non era scorso un secondo, e già la spada di Fanfulla era caduta a due mani sull’elmo del suo nemico, il quale sgangherato dalla prima percossa, a stento si resse in piedi; e Fanfulla gliene appoggiò un’altra, e un’altra, ed ogni volta gridava: «Son pochi i danari… son pochi… son pochi…» e lo sforzo del colpo gli faceva pronunziar la parola con quella specie d’appoggiatura che udiamo uscir dal petto degli spaccalegna quando calan l’accetta.
Colui non si potè riavere mai da questa tempesta malgrado i suoi sforzi: venne a terra mezzo stordito, ma non volea perciò sentir parlar di resa; onde Fanfulla, invelenito, gli diede l’ultima, cogliendo il tempo in cui provava a rizzarsi in ginocchio, e lo distese immobile sul sabbione dicendogli: «Sei contento ora?»
Bajardo, visto che colui si sarebbe fatto ammazzare inutilmente, mandò un re d’armi, il quale gettando il suo bastone fra i due guerrieri gridò ad alta voce: «Martellin de Lambris prisonnier.» Corsero alcuni uomini che l’ajutarono alzarsi, e sorreggendolo vennero a presentarlo al signor Prospero.
«Dio ti benedica le mani!» gridò questi al vincitore.
E diede ai suoi sergenti in guardia il barone francese che non volle lasciarsi toglier la barbuta, si gettò a giacere al piede d’una quercia, e vi rimase muto e immobile.
Fanfulla avea voltato il cavallo, e messolo di mezzo galoppo per tornar nella battaglia, guardava intorno ove potesse giovar l’opera sua, e veniva per giuoco facendo in aria colla spada mulinelli, nel quale esercizio avea la più destra e spedita mano dell’esercito.
Dando un’occhiata generale alla zuffa, vedeva che la fortuna non inclinava punto pei nemici, e che gli uomini d’arme italiani facevano molto bene il dovere: allora alzò più che mai il grido, chiamando a nome La Motta, e ricominciando la novella de’ danari son pochi; e queste tre parole le veniva cantando sull’aria d’una canzone che si udiva allora per le strade dai ciechi: onde l’atto del cavalcare in un certo suo modo sbadato e bizzarro, quel giocar di spada tanto mirabile, e pur fatto come scherzando, e ‘l tuono della voce, tutt’insieme dava a quella canzonatura un non so che di così curioso, che persino la seria fisonomia del signor Prospero dovette un momento lasciarsi aprire ad un sorriso.
Nel tempo impiegato a conseguir questa prima vittoria, Ettore Fieramosca aveva bensì colla lancia fatto staffeggiare La Motta, ma non gli era riuscito scavalcarlo. Era d’altra forza, e d’altro valore che il prigioniere di Fanfulla. Fieramosca geloso dell’onore riportato da questo, avea cominciato colla spada a lavorare in modo che lo sprezzatore degli Italiani con tutta la sua virtù a stento potea stargli contra. Le ingiurie profferite da lui la sera della cena, quando avea detto che un uomo d’arme francese non si sarebbe degnato aver un Italiano per ragazzo di stalla, tornarono in mente a Fieramosca; e mentre spesseggiava stoccate e fendenti, schiodando e rompendo l’arnese del suo nemico, e talvolta ferendolo, gli diceva con ischerno: «Almeno la striglia la sappiamo menare? Ajutati, ajutati, che ora son fatti, e non parole.»
Non potè colui sopportar lo scherno, e menò un colpo al capo con tal furia che, non giugnendo Ettore ad opporre lo scudo, tentò ribatterlo colla spada; ma non resse, volò in pezzi, e quella del Francese cadendo sul collarino della corazza lo tagliò netto, e ferì la spalla poco sopra la clavicola. Fieramosca non aspettò il secondo: spintosi sotto, l’abbracciò tentando batterlo in terra; l’altro lasciata la spada pendente, tentava di sferrarsi. Ciò appunto volea Fieramosca: sviluppatosi da lui prima che avesse potuto riprender la spada, dato di sprone al cavallo, lo fece lanciarsi da una parte; ed ebbe tempo di spiccar l’azza che pendea dall’arcione, colla quale tornò addosso all’avversario.
Il buon destriere di Fieramosca ammaestrato ad ogni qualità di battaglia, cominciò, avvertito da un leggier cenno di briglia e di sprone, a rizzarsi come un ariete che voglia cozzare, e far volate avanti, senza mai scostarsi tanto dall’avversario che il suo signore non lo potesse giungere. Vedendolo lavorare con tanta intelligenza, pensava Fieramosca: “Ho pur fatto bene a condurti meco!”. E si portò tanto virtuosamente coll’azza, che venne riacquistando sul Francese il vantaggio che aveva perduto.
La zuffa di questi antagonisti che potean dirsi i migliori delle due parti, se non decideva della somma della battaglia, quasi però avrebbe deciso dell’onore. Sarebbe stato doppio biasimo per La Motta esser vinto, avendo egli manifestato tanto disprezzo pe’ suoi nemici; doppia gloria a Fieramosca il riportarne vittoria. I suoi compagni, conoscendo che egli era atto a tal impresa, si guardarono dal prendervi parte; si guardavano anche i Francesi dal porgere ajuto al loro campione, onde non si dicesse che dopo tanti vanti non gli era bastata la vista di star contra un solo. Perciò, quasi senz’avvedersene, per alcuni minuti restaron tutti dal combattere fissando gli occhi ne’ due guerrieri. In questi pensieri che abbiam accennati produssero un incredibile impegno di vincere, e combattevano con un accanimento, un’attenzione a non commetter errori, un’alacrità a profittar dei vantaggi, che la loro zuffa poteva dirsi un modello dell’artecavalleresca.
Diego Garcia di Paredes, che avea passata la sua vita nei fatti d’arme, pur colpito da maraviglia alla vista di così maestrevole battaglia, non potendo più star alle mosse, si era alzato in piedi; poi, venuto sull’estremo ciglio del greppo che dominava il campo, gli stava guardando avidamente. Veduto da lontano, con quel suo busto gigantesco piantato su due gambe erculee, e colle braccia naturalmente pendenti, pareva immobile al pari d’una statua; ma, ai vicini, il contrarsi de’ muscoli sotto le strette vesti di pelle che portava, lo stringer delle pugna, e più di tutto lo sfavillar degli occhi, palesavano quanto bollisse internamente, e si rodesse di non poter essere ivi altro che spettatore.
I riguardi che impedivano agli altri di turbar questa battaglia, o non vennero in mente, o non furon curati da Fanfulla che, lasciato il signor Prospero, veniva scorrendo pel campo; punse il cavallo, e colla spada in alto si serrò contro La Motta. Se n’avvide Ettore e gli gridò: «Indietro!» ma ciò non bastando, spinse il cavallo in traverso a quello del Lodigiano, e col calcio dell’azza gli diede a man rovescia sul petto onde con poco buon garbo gli fece rattener le briglie: «Basto io per costui, e son di troppo,» gli disse istizzito.
Fu da tutti lodato l’atto cortese verso La Motta fuorché da Fanfulla, che prorompendo in una di quelle esclamazioni italiane che non si possono scrivere disse, mezzo in collera mezzo in riso: «Hai la lingua nelle mani!»
Voltò il cavallo, e messosi a guisa di pazzo fra i nimici, gli sconvolse senza assalirne nessuno in particolare; e finito così quel momento d’inazione, si rinnovò più calda che mai la battaglia. Fin dal principio, Brancaleone fisso nel suo proposito avea corso la lancia con Grajano d’Asti, e la fortuna si era mostrata uguale fra loro. Venuti alla spada, si mantennero ancora senza deciso vantaggio per nessun de’ due: Brancaleone era forse superiore al suo nemico per robustezza ed anche per maestria, ma il Piemontese era gran giocator di tempo; e chi conosce l’arte dello schermire, sa quanto sia utile questa qualità.
Fra i combattenti dell’altre coppie la vittoria era per tutto in forse, e quantunque la battaglia non durasse che da un’ora e mezzo circa, era stata però tanto ostinata e calda che si poteva facilmente conoscere gli uomini ed i cavalli aver bisogno d’un breve respiro, che venne loro conceduto di comune accordo dai giudici. La tromba ne diede il segno, ed i re d’armi entrando in mezzo spartirono i combattenti.
Quel bisbiglio che udiamo sorger istantaneo nei nostri teatri al calar del sipario dopo uno spettacolo che si sia cattivata l’attenzione degli spettatori, nacque egualmente fra le turbe che circondavano il campo. I cavalieri tornati alla prima ordinanza scavalcarono: chi si traea la barbuta per rinfrescarsi la fronte e tergerne il sudore; chi, trovando l’arnese o la bardatura de’ cavalli guasta in qualche parte, s’ingegnava di racconciarla. I cavalli, scotendo il capo e dimenando le mascelle, cercavan sollievo al dolore cagionato dalle scosse de’ freni. E non sentendo più l’uomo in sella, si piantavan sulle quattro zampe, ed a capo basso davano un crollo prolungato facendo risonare le loro armature. I venditori del contorno trovandosi a polmoni freschi, alzarono più alte le grida, e i due padrini, mossi i cavalli, vennero a trovare i loro guerrieri. Per la prigionia d’uno de’ Francesi, e per trovarsi gli altri malmenati e feriti quasi tutti, fu giudicato da ognuno, gli Italiani aver la meglio; e fra i molti che aveano scommesso per l’una o per l’altra parte, quelli che tenevan pe’ primi cominciavano ad accigliarsi ed a dubitare. Il buon Bajardo aveva troppa esperienza di simili fatti per non accorgersi che le cose voltavan male pe’ suoi. Studiando di non mostrar questo sospetto, gli incoraggiava, li poneva in ordinanza e veniva ricordando ad ognuno le regole dell’arte, i colpi da tentarsi ed il modo di difendersi.
Prospero Colonna che vedeva i suoi avere minor bisogno di riposo per esser meno maltrattati dei nemici, dopo una mezz’ora, domandò che si riprendesse la battaglia, ed i giudici ne fecero dare il cenno. I cavalli, ai quali un ansar frequente facea ancora battere i fianchi, stimolati dallo sprone rialzarono il capo; e si lanciaron di nuovo gli uni contra gli altri. Ormai la vittoria si dovea decidere in pochi momenti: crebbe il silenzio, l’immobilità negli spettatori, l’accanimento e la furia nei combattenti. Le gale del vestire, le penne, gli ornamenti eran volati in brani, o bruttati di polvere e di sangue. Dal fianco di Fieramosca pendeva tagliata da un fendente la sua tracolla azzurra, l’elmo era rimasto nudo e basso, ma egli, ferito soltanto leggermente nel collo, si sentiva gagliardo del resto, e stringeva La Motta col quale si era di nuovo accozzato. Fanfulla avea a fronte Jacques de Guignes. Brancaleone seguitava la sua battaglia con Grajano, avvisando al modo di coglierlo sull’elmo, e gli altri compagni qua e là per il campo si raggiravano accoppiati coi Francesi combattendo la maggior parte coll’azza, e stringendoli mirabilmente.
A un tratto s’alzò un grido fra gli spettatori: tutti, e persino i combattenti, volgendosi per conoscerne la causa, videro che la zuffa tra Brancaleone e Grajano era finita. Questi, curvo sul collo del destriere, coll’elmo ed il cranio aperti pel traverso, perdeva a catinelle il sangue che scorreva nei buchi della visiera sull’arme e giù per le gambe del cavallo, il quale stampava le pedate sanguigne. Rovinò in terra alla fine, e risonò sul suolo come un sacco pieno di ferraglia. Brancaleone alzò l’azza sanguinosa brandendola sul capo, e gridò con voce maschia e terribile: «Viva l’Italia: e così vadano i traditor rinnegati»: ed insuperbito, si cacciò menando a due mani sui nemici che ancora facevan difesa. Ma non durò a lungo il contrasto. La caduta di Grajano parve desse il crollo alla bilancia. Fieramosca accanito per la lunga ed ostinata difesa di La Motta, raddoppiò la forza de’ colpi con tanta rapidità, che lo sconcertò, lo sbalordì, e privato dello scudo, con mezza spada in mano e l’arnese schiodato e rotto, lo percosse sul collo coll’azza di tanta forza, che lo fe’ rannicchiarsi stordito sull’arcione dinnanzi, e quasi smarrita la luce degli occhi.
Prima che si riavesse, Fieramosca, il quale gli stava a destra, buttandosi lo scudo dietro le spalle, l’afferrò colla manca alle corregge che sulla spalla reggono il petto della corazza, e stringendo le cosce, diede di sproni al cavallo. Questi si lanciò avanti, e così il cavaliere francese fu violentemente tratto giù dalla sella. Quando si stese in terra, Fieramosca che avea colto il tempo e s’era buttato da cavallo, gli si trovò sopra colla daga sguainata, ed appuntandogliela alla vista in modo che un poco gli toccava la fronte, gli gridò: «Renditi o sei morto.» Il barone, ancor mezzo fuor di sé, non rispondeva; e questo silenzio potea costargli la vita: gliela salvò Bajardo, gridandolo prigione.
Condotto via La Motta da’ suoi famigli che lo consegnarono al signor Prospero, Fieramosca si voltò per risalire a cavallo: il cavallo era scomparso: girò lo sguardo per la battaglia e vide che Giraut de Forses, essendogli stato morto il suo, aveva tolto il destriere dell’Italiano e stava fra’ suoi facendo ancor testa agli uomini d’arme nemici. Il buon Ettore conobbe che solo e a piedi non avrebbe potuto riaver il cavallo. L’aveva nutrito ed allevato di sua mano, ed addestrato a seguirlo alla voce; onde non si confuse: fattosegli più presso che potè, cominciò a chiamarlo, battendo il piede come era usato di fare quando voleva dargli la biada. Il cavallo si mosse per venire a quel cenno, e volendo il cavaliere contrastargli, prima cominciò ad impennarsi, poi si mise a salti, e senza che colui potesse né opporglisi né governarlo, lo portò suo malgrado fra gli Italiani che, circondatolo, l’ebber prigione senza colpo di spada. Scendendo dal cavallo sul quale tosto saltò Fieramosca, malediceva la sua fortuna; ma questi, resagli per la punta la spada che gli era stata tolta, gli disse: «Fatti con Dio, fratello, piglia le tue armi e torna fra’ tuoi, che i prigioni gli abbiamo per forza d’arme, e non per arti da ciurmadori.»
Il Francese, che ogn’altra cosa s’aspettava, restò molto maravigliato. Pensò un momento, poi rispose: «S’io non m’arrendo alle vostre armi, m’arrendo alla vostra cortesia.» E, presa la sua spada alla metà della lama, andò a deporla a terra avanti al signor Prospero: e fu detto da tutti quelli che lodavano l’atto cortese di Fieramosca, anche il Francese aver operato e parlato saviamente. Per la qual cosa esso solo fu poi rimandato senza che pagasse il riscatto.
La parte francese era scemata di quattro delle sue migliori spade, mentre l’italiana contava ancora i suoi tredici uomini a cavallo: e si poteva facilmente conoscere in qual modo la cosa dovesse andar a finire. Nonostante, i Francesi scavalcati, che erano cinque, si serrarono insieme; ai loro lati si posero due per parte i quattro a cavallo, e così ordinati si disposero a far testa di nuovo agli Italiani, i quali rannodando per la terza volta la loro battaglia, fecero impeto tutt’insieme sugli avversarj.
Non venne in mente ad alcuno che questi vi potessero reggere, ma ammirando tuttavia la costanza e l’arte di quella brava gente, crebbe negli spettatori l’ansiosa curiosità di veder l’esito del loro ultimo disegno; e quasi ad alcuni sapeva male, che con tanto valore dovessero cimentarsi con grandissimo rischio della loro vita ad un giuoco tanto disuguale. Ma per questo non temevano i Francesi: pesti, feriti, coperti di polvere e di sangue, pur offrivan fiero ed onorato spettacolo, stando arditi ad aspettare la rovina che veniva loro addosso di tanti cavalli, e pareva dovesse ridurli in polvere. Si mossero alla fine gl’Italiani, non colla prima celerità, che la stanchezza lo vietava ai cavalli, molti dei quali per le violente scosse dei freni avean la bocca coperta di spuma sanguigna. Alzarono i cavalieri più forte il grido di “Viva Italia!” e malgrado l’instare degli sproni, vennero a ferire d’un galoppo grave e sonante. Nonostante le leggi promulgate al principio, fu tale la smania di curiosità che invase a quel punto gli spettatori, che il cerchio formato da loro all’intorno s’andò progressivamente stringendo. Gli uomini che avean la cura di mantener l’ordine, curiosi più degli altri, anch’essi seguiron quel moto concentrico, come vediamo succedere quando in piazza si caccia il toro, che al principio ognuno sta saldo al suo luogo, ma quando un cane comincia ad attaccarsegli all’orecchio, e poi se n’attacca un altro, e quasi hanno fermato il loro nemico, nessun può più star a segno, crescon le grida, gli schiamazzi, si scioglie l’ordine, ognuno si spinge avanti per veder meglio.
In mezzo alla fila di nuovo schierata degli Italiani s’era posto Fieramosca, il quale aveva il miglior cavallo; ed ai suoi lati, a mano a mano quelli che l’aveano meno stanco, o più corridore; cosicchè nell’andar addosso ai nemici il centro si spinse avanti, figurando un cuneo, del quale Ettore era alla punta. Quest’ordine fu tanto ben mantenuto che, giunto al ferire, sforzò la fila dei Francesi senza che potessero porvi riparo. Qui sorse una nuova zuffa più serrata, più terribile che mai: al numero, al valore, alla perizia degli Italiani s’opponevano sforzi più che umani, disperazione, rabbia del disonore imminente ed inevitabile: i prodi ed infelici Francesi, fra un turbine di polvere, cadevano insanguinati sotto le zampe de’ cavalli, si rialzavano afferrandosi alle staffe, alle briglie de’ vincitori; ricadevano, spinti, maltrattati, calpestati, rotolandosi sotto sopra, mezzo disarmati, cogli arnesi infranti, e pur sempre sforzandosi di riaversi, raccogliendo in terra pezzi di spade, tronchi di lancia, e perfino sassi onde ritardar la sconfitta.
Ettore, il primo, alzò il grido onde lasciasser l’impresa e si rendesser prigioni; ma appena era udito in quel fracasso; o se l’udivano, negavan coi fatti, soffrendo muti quelle orribili percosse; ed ebbri pel furore, seguitavano la mirabil difesa. De’ quattro che eran ancora in sella al principio di questo ultimo scontro, uno era caduto, e si difendeva a piedi; a due erano stati morti i cavalli: il quarto, preso in mezzo, era stato fatto prigione. Sarebbe impossibile il descrivere tutti gli strani accidenti, i colpi, gli atti disperati che accaddero in quegli ultimi momenti, dei quali fra gli spettatori rimase per molti anni una memoria di maraviglia e di orrore.
De Liaye, per dirne uno, fu veduto afferrare a due mani il freno di Capoccio romano, per istracciargli, se potesse, o togliergli la briglia; il cavallo se lo cacciò sotto colle zampate, ma non potè mai farsi lasciar dal Francese, che trascinato pel campo fu condotto in tal modo innanzi al signor Prospero, e ci vollero molti ajuti e molte braccia, tanto era fuor di se stesso, a fargli aprire le mani e porlo fra i prigionieri. Alla fine parve agli Italiani stessi troppo crudel cosa seguitare una simil battaglia; il gridar di Fieramosca fu imitato dagli altri, e tutti insieme sospeso il ferire, venivan dicendo a quei pochi superstiti: «prigioni… prigioni».
Fra il popolo cominciò un bisbiglio, crebbe, e senza che valesse l’opposizione degli araldi, cominciaron voci e poi schiamazzi ed urli onde finisse il combattere, ed i Francesi avesser la vita salva: rotti gli ordini, s’eran stretta la turba intorno ai combattenti, che si trovavano chiusi in un cerchio di trenta o quaranta passi di diametro: chi gridava, chi faceva svolazzar fazzoletti e cappelli, quasi sperando di partir così la battaglia; chi si volgeva ai giudici ed ai padrini. Il signor Prospero fattosi far luogo, e venuto più presso, alzava la voce e il bastone per indurre i Francesi alla resa; Bajardo, anch’esso, per quanto sentisse dolore dell’infelice riuscita de’ suoi, visto esser inutile un maggior contrasto, e pensando che era troppo peccato lo sprecar così il sangue e le vite di que’ valorosi, si spinse avanti, e gridava ai suoi che finissero, e si desser prigioni: ma né la sua, né l’altrui voce non era ascoltata dai vinti, che avendo appena ancora sembianza d’uomini parevan piuttosto demonj, furie scatenate. Scesero alla fine anche i giudici dal tribunale; vennero in mezzo al cerchio, fecero dar nelle trombe e gridar ad alta voce gl’Italiani vincitori: questi allora voller ritirarsi, ma tutto era niente: i loro nemici, che la rabbia, il dolore, le ferite avean inebriati al punto di non capire e non sentir più nulla, seguivano, come tigri che siano strette fra gli avvolgimenti d’un serpente, a ghermirsi come potevano co’ loro avversarj.
Diego Garcia, finalmente, visto che non v’era altro modo, prese partito, e gettandosi alle spalle di Sacet de Jacet, che attaccato con Brancaleone pretendeva strappargli l’azza dalle mani mentre questi era in forse d’appiccargliene un colpo sul capo, ed al certo l’avrebbe fatto cascar morto, l’avvinghiò con quella sua maravigliosa forza, e lo trasse suo malgrado fuor della zuffa. Quest’esempio fu imitato da molti spettatori, e in un momento furon tutti addosso ed attorno ai combattenti; e quantunque ne riportassero qualche percossa, pure, urtandosi, stracciandosi i panni, dopo molto stento e molto tirare, vennero a capo di levar di mezzo que’ cinque o sei uomini mezzo fracassati; e quantunque si dibattessero ancora, e schiumasser di rabbia, pure alla fine li trassero sotto le querce cogli altri prigioni.
La prima cura di Fieramosca, finito appena il combattere, fu gettarsi da cavallo e correre a Grajano d’Asti, che giaceva immobile nel luogo ov’era caduto.
Quando Brancaleone ebbe fatto il bel colpo, il cuor generoso di Ettore non aveva pur potuto difendersi da un primo moto di gioia. Ma nato appena, lo represse un sublime e virtuoso pensiero. Venne a lui, fece scansar la gente che gli stava affollata intorno, e gli s’inginocchiò accanto. Il sangue scorreva ancora dall’ampia ferita, ma lento ed aggrumato: gli sollevò il capo adagio adagio, e con tanta cura, che si sarebbe pensato avesse a salvare il suo più caro amico e giunse a liberarlo dalla barbuta.
Ma l’azza, spaccato il cranio, era entrata nel cervello tre dita: il cavaliere era morto. Ettore con un sospiro, che sorse dal profondo del cuore, depose di nuovo a terra il capo dell’ucciso, e rizzatosi, disse a’ suoi compagni che erano anch’essi venuti a vedere, e più direttamente a Brancaleone: «Codesta tua arme,» ed additava l’azza che quegli teneva in pugno stillante ancora di sangue, «ha compiuta oggi una gran giustizia. Ma come potremmo godere tal vittoria? Il sangue che inzuppa questa terra non è egli sangue italiano? e costui forte e prode in guerra, non avrebbe potuto spargerlo a sua ed a nostra gloria contra i comuni nemici? La tomba di Grajano allora sarebbe stata venerata e gloriosa; la sua memoria, un esempio d’onore. Invece egli giace infame, e sulle sue ceneri peserà la maledizione de’ traditori della patria…» Dopo queste parole tornarono tutti in silenzio e pensosi ai loro cavalli. Il cadavere fu la sera portato a Barletta, ma quando si volle seppellirlo nel sagrato, il popolo, levato a rumore, non lo permise. I becchini lo portarono al passo d’un torrente a due miglia dalla città, cavarono una fossa e ve lo chiusero. D’allora in poi quel luogo fu chiamato il Passo del traditore.
 Ettore Fieramosca in un’edizione del 1848
Ettore Fieramosca in un’edizione del 1848
Risulta evidente da questo passo, che corrisponde più o meno alla fine del romanzo, come l’antecedente letterario più immediato sia Walter Scott e non Manzoni; il duello di Ivanhoe e la disfida di Barletta hanno più punti in comune: l’attenzione per i costumi, il gusto dell’orrido, uno stile indugiante su particolari ottenuto dal punto di vista di chi guarda. Ciò che invece ci piace sottolineare è invece la peculiarità della pagina di D’Azeglio: infatti prima dell’orrido, l’uso del comico nella prima parte, tutto dedicato al personaggio di Fanfulla, con la continua cantilena riguardo i soldi (ricordiamo che, prima della disfida, i cavalieri delle due fazioni dovevano versare una certa somma con cui riscattare i prigionieri: gli italiani la versarono, i francesi per la sicumera di battere gli “imbelli italiani” no); quindi il patetico nell’episodio di Enrico contro l’ucciso rivale in amore Grajano. Ma ancora più importante è il fine: D’Azeglio vuole accendere il lettore d’amor patrio. L’esercito è spagnolo, ma i mercenari italiani combattono in terra d’Italia e l’ultima parte del passo è tutta votata alla propaganda patriottica: il discorso di Enrico sembra maggiormente rivolto, così carico di retorica, ad un traditore della causa risorgimentale più che ad un episodio cinquecentesco. Bisogna inoltre dire che laddove l’ideologia patriottica prevale sul tessuto del romanzo anche la verità storica viene a volte piegata al fine prefissato dall’autore che all’esattezza della fonte.
 Scena del film Ettore Fieramosca di Alessandro Blasetti del 1938
Scena del film Ettore Fieramosca di Alessandro Blasetti del 1938
Un altro importante romanzo storico è il Marco Visconti di Tommaso Grossi, dove invece è più penetrante l’influenza manzoniana:
La storia, ambientata in Lombardia, nel Trecento, narra l’amore contrastato fra Bice del Balzo e Ottorino Visconti, cugino di Marco, il condottiero, fratello di Galeazzo, che, invaghito della ragazza, ostacola il matrimonio fra i due e solo poco prima di essere ucciso a tradimento si pente delle proprie malefatte. La narrazione di numerosi avvenimenti storici – documentati sulle cronache del tempo, secondo l’esempio manzoniano – si intreccia al racconto delle vicende dei personaggi, inseriti nel paesaggio lombardo, descritto meticolosamente.
MORTE, PENTIMENTO E REDENZIONE
Durava da più ore quel faticoso lavoro, quando parve ad alcuno d’udire come una voce lontana che uscisse di sotterra. Marco fa cessare immediatamente ogni rumore: stanno tutti in orecchi… Da lì a qualche tempo la voce si fa intendere un’altra volta; una voce lunga, acuta, come di lamento, che viene da una carbonaia scavata sotto quel primo sotterraneo, tra le più basse fondamenta d’un torrazzo. Su, presto, all’opera tutti quanti; la novella speranza raddoppia la lena: in un momento si sganghera un cancello, si sconquassa, si abbatte un uscio. Marco con una fiaccola in mano entra egli per il primo in un camerotto, fa risaltare una ribalta a fior di terra, e giù per una scaletta a chiocciola fino al fondo della torre divisata. S’avanza palpitando per entro una vasta oscurissima prigione, ode una voce che gli domanda misericordia, vede in un angolo, a canto al muro di fronte, come un’ombra che gli tende le braccia; si precipita verso quella parte; il lume che reca fra le mani rischiara un’ignota figura… Non è Bice altrimenti… è un uomo… Era il Tremacoldo.
Il giullare diede tostamente notizia dell’esser suo, del come essendo capitato in castello per esplorare se ivi fosse nascosta la figlia del conte del Balzo, l’avesser preso, e gettato in quel fondo, donde non isperava omai più di poter uscire a veder lume. Di Bice, nessuna novella.
Rotti i ceppi, il prigioniero fu posto subito in libertà, e Marco, più scoraggiato che mai, comandò che si continuassero le intraprese indagini. Dopo qualche tempo venne giù uno scudiere ad annunziargli che il conte e la contessa del Balzo erano giunti al castello, e domandavano di lui premurosamente. A questa nuova egli impallidì: diede alcuni passi verso la porta come per uscire, per correre ad incontrare quei nuovi ospiti; ma poi tornò indietro, e colla fronte dimessa, colle braccia spenzolate, stette un bel pezzo appoggiato ad un pilastro senza muover parola, senza dar un segno.
Se non che, dal lato opposto a quello in cui Marco era in quei punto, si sentì gridare da più voci in una volta:
«E’ qui! è qui! è trovata! è trovata!» Tutti quanti, gittati gli arnesi, rispondono con un altro grido di gloia, e corrono a precipizio verso quella banda. Il lume di molte faci agitate rischiara mutabilmente le lunghe brune vôlte dell’intricato labirinto.
«E’ ella viva?» domanda Marco di mezzo alla folla degli accorrenti.
«E’ morta,» risponde una voce dal luogo a che tutti erano dirizzati.
Ed ecco venir innanzi un gruppo di gente, e nel mezzo due scudieri che portano pietosamente sulle braccia la figlia del Conte bianca in volto, e cogli occhi chiusi e il capo pendente su d’una spalla. Lauretta la seguiva tutta scapigliata, e sorreggendole con le mani la fronte non cessava dal baciarla, dall’innondarla di lagrime.
Marco, cui erano rimbombate nel cuore le prime voci di speranza e di morte, che vedeva or proceder lento lento quel corteo funebre, e al lume di tante faci raffigurava a poco a poco la bella persona, il bianco volto della giovane portata, non potea persuadersi che quello spettacolo fosse reale: sperava pure d’essere posseduto dall’illusione fantastica d’un sogno; per certificarsene, andava stendendo intorno attonitamente le mani; ed ora palpava le muraglie, ora stringeva per le spalle e per le braccia le persone che s’abbattevano a passargli dinanzi; finalmente, facendosi largo tra la folla che s’aperse tosto per lasciarlo passare, accostossi a Bice, e le pose una palma sulla fronte. Il freddo che gli venne da quel tocco lo riscosse dalla stordigione, dalla stupidità in che era caduto: un tremore crescente gli si diffuse per le membra, il sangue gli rifluì violentemente al volto rigonfiandogli le vene della fronte, dalla quale si vedevano scorrere grosse gocce di sudore.
Così, seguitando a lato a lato la fanciulla, pervenne fino in capo alla scala, per la quale dal sotterraneo s’usciva nel cortiletto. Ivi l’impressione dell’aria aperta, la vista del sole, parvero tornarlo affatto nel sentimento; si ricordò di Ermelinda, la quale stava aspettando; sentì com’ella sarebbe morta di spavento e di dolore, se avesse trovato d’improvviso la figlia a quel modo; e quel pensiero potè restituirgli ad un tratto l’usata forza. Fece segno alla gente che lo seguitava, e che gli era d’intorno, di fermarsi; e con voce sicura, e con un’aria posata, che fece maravigliare tutti quanti, comandò che, spenti i lumi, cessato ogni rumore, la folla si disperdesse tacitamente, e si guardassero bene dal far parola di quanto avean visto laggiù.
Egli, precedendo Lauretta e i due scudieri che portavano Bice, s’avviò in silenzio verso le camere della castellana.
Come la figlia del Conte fu posta su d’un letto a giacere, Marco domandò all’ancella di lei, quando la sua padrona fosse spirata.
«Ell’era ancor viva poco fa,» – rispose Lauretta con voce interrotta dai singhiozzi, «e mi è morta di spavento, fra le braccia, quando sentì rovinar l’uscio della prigione, e credevamo che venissero per assassinarci.»
In questa entra il medico del castello ch’era stato tosto chiamato: guarda, esamina la giacente, le accosta un lume alla bocca… la fiammella par che si pieghi alquanto mossa da un tenue fiato. Lauretta, la castellana, le si affaticano intorno, adoperando ogni argomento per riaverla: a poco a poco le si ridesta il battito del cuore, le rinvengono i polsi; il calore della vita torna a diffondersi per le membra… Ma le forze sono consunte di lunga mano dai patimenti, dalle angosce, dallo spavento durato: le entrò una febbre ardente… Potrà ella giugnere a veder il domani?
Marco, che all’improvvisa gioia del trovarla viva s’era sentito rapire fuor di sé stesso, a questo annunzio abbassò desolatamente il capo, e disse in cuor suo: “Ecco adempite le parole del profeta;” poscia col volto e coll’atto di un uomo che non ha più nulla da temere o da sperare a questo mondo, avvicinossi alla moglie del Pelagrua, ed interrogolla intorno ad Ottorino.
La donna, che da certe parole dette da Lodrisio in sua presenza sospettava che lo sposo di Bice fosse rinchiuso nel castello di Binasco, comunicò a Marco quel suo sospetto, e questi risolvette di mettersi subito sulle tracce del trafugato. Uscì dunque dalla camera dell’inferma, presso la quale volle che per allora non rimanesse che la sua ancella, affinché la poveretta che andava sempre più ricuperando gli spiriti, nel momento che sarebbe tornata in sé, non avesse a vedersi d’intorno altro volto che quel volto soave e fidato.
«Ora andate a chiamar la madre di Bice,» disse poscia alla castellana, «ditele che preghi… che preghi anche per me.»
Ciò detto, discese precipitosamente nella corte, lasciò alcuni ordini al giudice del luogo, ed uscì a cavallo dal ponte levatoio, che si rialzò subito dietro le sue spalle.
La camera entro cui Bice era stata portata dava su d’uno spiano che stendevasi innanzi al castello dalla parte d’oriente. Il sole già alto entrando per una finestra, in faccia alla quale era collocato il letto su ch’ella posava, diffondea sul suo volto un chiarore, che ne faceva risaltar la pallidezza e lo sfinimento mortale. Al primo rinvenire, la fanciulla apriva gli occhi, e li richiudeva tostamente, portandovi una mano per difenderli dalla luce, dolorosa in quel primo incontro, dopo le lunghe ore passate nella più fitta oscurità del carcere da cui era stata tolta.
L’ancella chiuse subito le imposte; poi tornata a sedersi a canto alla padrona, l’abbracciava piangendo, e chiamandola per nome. Ella sentì I’impressione di quelle lagrime, riconobbe quella voce, ed aprendo un’altra volta gli occhi, la stette guardando qualche tempo come smemorata, e poi disse:
«Sei tu, Lauretta?»
«Sì, son io, non abbiate sospetto di nulla; siamo liberate, state di buon animo.»
Ma ella, che non apprendeva ancor bene il senso delle parole, domandava paurosamente:
«Dove sono iti quei manigoldi?… Hanno pur fracassato l’uscio della prigione, ho pur intese le lor grida, e sentiti i colpi dei loro pugnali nella persona… Oh dimmi, non m’hanno dunque uccisa?… mi pareva d’esser morta, e che mi portassero a seppellire in mezzo a tanta gente, con tanti lumi d’intorno… Era notte; e come s’è fatto giorno chiaro in un tratto? e dove siamo noi adesso?»
«Siamo nelle camere della nostra buona castellana; siamo libere, vi dico; è stato lo stesso Marco che è venuto…»
Il suono di quel nome terribile fu come il tocco d’un ferro rovente, che fa risentire un tramortito. Bice balzò a sedere sul letto, e diceva: «Fuggiamo! fuggiamo! nascondimi, salvami, salvami per pietà!»
«Oh no, Dio! tranquillatevi: Marco non è qui; e poi, state sicura, non entrerà in queste camere persona che voi non vogliate… Siamo libere, torno a dirvi; e, sapete la buona nuova che v’ho a dare? Vostra madre è giunta.»
«Mia madre?»
«Sì, vostra madre, e tosto che siate riavuta tanto da poter sopportare la via, torneremo a casa insieme con lei.»
«Oh! non volermi ingannare ancora! non ti ricordi quante volte me l’hai detto che sarebbe venuta? e poi?…»
«Ma ora ella è qui, vi dico, è qui, e la vedrete quando che sia!»
«No, no, mia cara, la tua pietà è troppo crudele; no, che non la vedrò più; l’ho domandata tante volte al Signore questa grazia, con tante lagrime, con tanta fiducia!… Egli non m’ha voluta esaudire!… Ed ora… sarebbe troppo tardi.»
«Ah figlia mia!» gridò in quella Ermelinda con una voce mezzo spenta dall’angoscia. Trattenuta essa dal medico nella camera vicina, perché lo spavento della prima gioia non desse un troppo grande scrollo alle forze affralite dell’inferma, di là aveva sentito ogni sua parola; e non potendo più reggere all’impeto dell’affetto s’era precipitata fra le braccia di lei.
Bice chinò il capo sull’omero della madre, e stettero lungamente strette insieme in silenzio.
Fu la prima Ermelinda a sciogliersi da quel nodo soave, e pur doloroso; e ponendo una mano sul capo della figlia: «Ora statti riposata;» le diceva, «vedi, io son qui con te, per non abbandonarti mai più: staremo sempre insieme, sempre, sempre; sì, cara, cara la mia povera Bice! Tutti i guai sono finiti, non pensar più che a cose liete, pensa a tua madre che è qui con te, che non ti si staccherà mai più da canto.»
Bice obbedì, posò un istante il capo sui guanciali; ma non potendo frenarsi, lo rilevò subitamente, e alzando un’altra volta le braccia le intrecciò intorno al collo della madre; e siccome, questa resisteva pure mollemente, ed accennava sgomentita che cessasse:
«No.» diceva la figliuola, «no, lasciate ch’io sfoghi il desiderio di tanti giorni, di tante notti dolorose: lasciatemi godere questa consolazione, lasciate che m’innebrii d’una dolcezza che sarà l’ultima della mia vita.»
«Per carità, rimettiti in calma: tanto commovimento… così sfinita come sei!…»
«Ah! no,» replicava Bice, «credetemi, non me ne può venir altro che bene, provo un sollievo… lasciate, lasciatemi;» e stringendola, e baciandole il volto, e innondandola di calde lagrime, non faceva che ripetere con un gemito d’amore: «Oh madre mia! oh cara madre!»
Ermelinda, vinta alla fine da quel sentimento che tutto soverchia, si abbandonò fra le braccia della figlia, e piangendo anch’essa, le ricambiava i baci e le carezze che ne ricevea. Era uno spettacolo di pietà, ma d’una pietà consolante, d’una pietà tutta piena di letizia, di pace, e, dirò pure, di riverenza, il vedere le due infelici mescere insieme le lagrime, non saziarsi dallo stare negli amplessi, dal ripetersi il loro mutuo amore, i loro lunghi tormenti nel tempo che erano state divise.
«Sai che è qui anche tuo padre?» disse Ermelinda, tosto che si fu quietata tanto da poter profferire le parole.
«Perchè non viene?» rispose la fanciulla, serenandosi in volto di nuova gioia.
Fu chiamato il Conte, il quale entrò con un’aria tra il commosso e lo spaventato. Ma quando vide la figlia tanto smagrita, così svenuta, staccare un braccio dal collo della madre, e stenderlo amorosamente verso di lui, la codardia fu vinta dalla pietà, né gli rimase più altro affetto fuor quello di padre. Corse a lei, ed abbracciandole il capo, le disse tutto intenerito: «Tu stai male, figlia mia.»
«Oh! no, ora che sono co’ miei cari parenti sto bene, sto troppo bene… Ma, e Ottorino?…»
Il Conte strinse le labbra, come chi inghiotta una medicina amara, e per quanto si facesse forza non potè a meno di lasciarsi scappare queste parole:
«Oh! per l’amor di Dio! chi vai tu a nominare adesso! in questo luogo!»
«Non è egli il mio sposo?» rispose la fanciulla con un atto che sapeva pure d’un certo qual risentimento; quindi volgendosi con maggior tenerezza alla madre: «E’ egli vivo? posso io sperare di vederlo?»
«Oh! sì, il Signore ce l’avrà serbato,» disse Ermelinda. «A quel che mi disse la castellana, egli debb’essere a Binasco; e lo stesso Marco è partito di qui per cercar di lui, per condurtelo tosto che l’abbia trovato.»
«Marco!» esclamarono ad una voce il padre e la figliuola, colpiti ambedue da una diversa maraviglia, da un diverso terrore.
«Si, Marco Visconti,» ripeté la donna: e qui si fece a narrare il colloquio ch’ella avea avuto seco la notte antecedente; disgravò il Visconte d’ogni enormità non sua; disse del profondo dolore di lui per quella parte di colpa che avea avuta nel principio; certificò la sua risoluzione di riparare colla propria vita, ove fosse stato d’uopo, ogni sconcio che n’era venuto in seguito; fece parola della cresciuta sua benevolenza verso Ottorino, né peritossi pure di confessare l’amor di lui verso Bice, ora che quell’amore, purificato dai rimorsi e dal pentimento, erasi mutato in una carità ossequiosa ed espiatrice; infine parlò tanto a commendazione, non che a discolpa, di quell’uomo, che poté togliere ogni ombra di sospetto, ogni traccia di rancore dall’animo tanto del marito che della figlia.
Quest’ultima, che avea cominciato ad ascoltare con ansietà paurosa, alla fine del discorso levò gli occhi al cielo, e stringendo le palme esclamò: «Il Signore gli perdoni!» poi volgendosi un’altra volta alla madre: «M’avete detto ch’egli è uscito per cercar d’Ottorino, è vero?… Credete voi che possa giungere a tempo a vedermi?»
«Ah, non dir cosi, figlia mia!» sclamò Ermelinda con voce di dolce e accorato rimprovero: «senti, cara, la vita e la morte stanno nelle mani d’un Signore misericordioso… egli non vorrà… per pietà di noi…» e si tacque.
Bice prese una mano di sua madre e gliela baciò: né l’una osava dare, né l’altra chiedere, parole di speranza, d’una speranza che nessuna d’esse avea in cuore.
Per tutto quel giorno il male venne sempre più acquistando rovinosamente di forza su quel corpo troppo affievolito e rotto per potergli durar contro.
La fanciulla, obbedendo alle prescrizioni del medico avvalorate dalle più strette preghiere della madre, stavasi coricata quietamente e in silenzio, accontentandosi d’affissare di continuo quella sua cara a piè del letto, dove s’era posta a sedere, e di seguitarla cogli occhi ogni volta che per qualche necessità tramutavasi da luogo a luogo.
A piè del letto medesimo, in compagnia di Ermelinda, stava seduta anche l’ancella, l’amorosa Lauretta, la quale, per quanto fosse stata pregata da tutti, e da Bice principalmente, non avea mai voluto abbandonar quella camera, per andare a prender un po’ di riposo, di cui doveva aver tanta necessità, dopo le dure vigilie delle notti antecedenti. Ella narrava interrottamente e sotto voce alla madre la storia dei mali che avea patiti insieme colla sua giovane padrona, da che erano state condotte a Rosate, fino a quel giorno; le perfidie, gli spaventi, con che si era tentato di svolger Bice dalla fede data al suo sposo, di aggirarla per farla rinunziare a lui, perché avesse a piegarsi a veder di buon occhio quel terribile uomo, che esse credevano l’autore di tutta quella persecuzione; né tacque in fine la carità usata ad esse dalla castellana, che in quanto la sua strettezza, ed il sospetto, in cui il marito vivea continuamente di lei, glielo consentivano, non avea lasciato mai di sovvenirle di opportuni avvisi, di consigli, e d’ogni sorta di consolazione. Ermelinda, commossa da quel racconto, gettava a quando a quando uno sguardo compassionevole sulla figlia che avea patito tanto; ed ella che si accorgeva troppo bene di che fosse tutto quel lungo ragionare. le rispondeva con un sorriso pieno d’amore.
Quel riposo però, quella quiete, veniva talvolta turbata da qualche rumore che si sentiva in castello: Bice si faceva tosto intenta, una lieve fiamma le saliva sul volto, e domandava alla madre: «E’ giunto?…» L’interrogata usciva tosto dalla camera, e rientrava dopo qualche tempo, dicendo di no, ed aggiugnendo sempre qualche parola di consolazione e di speranza.
Verso sera, l’inferma, che si sentiva sempre più grave, chiese d’un confessore: stette a lungo con un vecchio Benedettino che fu chiamato ad assisterla, poscia volle tornar a vedere i suoi parenti.
«Senti, figlia mia,» le disse il padre, «Ottorino non è ancor giunto, ma l’aspettiamo prima che sia giorno.»
Ella si conturbò tutta, e rispose: «Ottorino! il mio sposo! il mio caro sposo!… Oh, se il Signore m’avesse fatto tanta grazia!… se avessi potuto vederlo prima di morire!»
«Via, offritelo a Lui,» disse il pio monaco, «offritelo a Lui che ve l’avea dato; e adorate l’eterno consiglio di giustizia e di pietà, che accetta questo sacrificio del cuore ad espiazione delle vostre colpe, a rimedio dell’anima vostra.»
La poveretta congiunse le palme, e levò gli occhi al cielo in atto di viva sì, ma dolorosa rassegnazione; ma Ermelinda, posandole una mano sul capo: «Oh figlia mia!» esclamava, oh cara la mia figlia! ch’io t’abbia dunque a perdere! che mi rimane a questo mondo senza di te, ch’eri il mio conforto, la mia sola consolazione!»
La fanciulla chinò il capo, e pianse: dopo un momento ripigliava singhiozzando:
«Consolazione! avete detto? e che consolazione avete mai avuta da questa miserabile, che colla sua protervia ha seminato tante spine sul sentiero della vostra vita?… Oh cara madre! io non ve ne chieggo perdono, perché so che mi avete già perdonato tutto; e voi pure, padre mio, e voi pure m’avete perdonato, è vero?»
Ermelinda e il Conte soffocati dal pianto non potevano formar parola: stettero tutti qualche tempo in silenzio. Intanto l’ancella, dopo aver porto all’inferma non so che bevanda ristoratrice, erasi adagiata sulla seggiola a canto al letto, e vinta dalla stanchezza e dal disagio a poco a poco chinava il capo sulle coltri e s’addormentava. Bice, che se ne accorse, senza rimuovere una mano che le tenea su d’una spalla, accennò con l’altra agli astanti che stessero zitti, che si guardassero da ogni strepito; ella medesima ricambiando di tanto in tanto qualche parola col confessore, abbassò la voce, quantunque per sé stessa già mezzo spenta, e il pio monaco intenerito da quella gentile sollecitudine fece altrettanto. Dapprima, ad ogni poco ella si faceva acconciar le coltri o i guanciali; ora voleva rilevarsi, ora mutar fianco, come sogliono gl’infermi che non sanno trovar requie in nessun lato; ma adesso sforzavasi di star quieta nella giacitura in cui si trovava, osando a mala pena di trarre il fiato per paura di non destare quella sua cara, nel cui volto abbassava gli occhi, e teneali intesi in atto d’amorosa compiacenza.
Quando Lauretta si destò, cominciava a spuntar l’alba, e vedevasi la fiammella d’una lucerna posta a canto al letto impallidire al primo chiarore ch’entrava dalla vetriera di fronte.
La svegliata volse intorno gli occhi attoniti, non sapendo in quel subito dove si fosse, se non che venne ad incontrarli in quelli di Bice, la quale schiudendole un riso pieno di dolcezza: «Sei qui con me,» le disse: «sei colla tua cara Bice.» L’altra abbassò il volto, dolente e vergognoso che la fralezza delle membra avesse potuto farle obliare per qualche tempo la sua diletta padrona in quello stremo. Ma questa, che indovinò l’animo dell’amorosa compagna, seppe consolarnela tosto coll’imporre a lei sola ogni minuto servigio di che le facesse mestieri, col ricevere graziosamente tutte quelle amorevolezze, ch’essa con sottile, raddoppiata sollecitudine, le veniva profondendo.
Verso un’ora di sole disse di sentirsi stanca e di voler riposare; si coricò, chiuse gli occhi, e da lì a qualche tempo prese sonno; un sonno lento ed affannato: ma tutto ad un tratto fu vista riscuotersi come in sussulto, levò il capo dai guanciali, e tosto vi ricadde; un sudor freddo le corse sul volto, cessò l’anelito, i polsi sparirono; e fu uno spavento generale, chè tutti la credettero spirata. Non era stata però che una strettezza passeggiera di cuore, un deliquio da cui si riebbe in breve, e vedendosi d’intorno i suoi cari che si disperavano:
«Di che piangete?» disse, «ecco, ch’io sono ancora con voi.»
Tutti le si strinsero d’intorno, ed essa, dopo aver ripreso un po’ di lena, rivolta alla madre: «Però,» continuava, «sento che la vita mi fugge, e l’ora è vicina; or via, siate forte, e accogliete l’ultime mie parole, l’ultimo voto dell’anima mia.»
Si trasse di dito un anello, e lo porgeva a lei dicendo: «Mi fu dato da Ottorino alla presenza vostra; simbolo di un nodo che dovea durar poco quaggiù, ma che verrà rinnovato in paradiso… Se vi è concesso di rivederlo, rimettetelo nelle sue mani, che me lo mostrerà un giorno… E ditegli insieme, che in questo solenne momento, tremando d’avermi fra poco a trovar sola nelle mani del Signore, l’ho pregato d’una cosa, pel bene che mi ha voluto, per la sua, per la mia salute eterna, l’ho pregato che non domandi ragione ad alcuno di quel tanto che ho patito quaggiù.»
Riposò un momento, quindi accennando con un lieve moto del capo l’ancella che stavasi a piè del letto: «Io non ve la raccomando: l’avete sempre avuta negli occhi e nel cuore; ma dopo tutto quello che ha patito per me, come mi sarebbe stata una sorella, così sia per voi una figlia… Ella vi sarà più sottomessa di questa… che avete amata troppo.» E volgendosi a Lauretta: «Mi prometti?…»
«Ah! sì,» rispose l’interrogata, «non l’abbandonerò mai finché avrò vita, starò sempre con lei; tutta, tutta per lei.»
Allora sentendosi mancar le forze si tacque. Stette lungo tempo come sopita, alla fine schiuse lentamente gli occhi, li volse alla finestra d’onde entrava il sole, e mormorò fra sé stessa: «Oh le mie care montagne!»
La madre le si fece più dappresso, ed ella movendo a fatica la voce sempre più fioca e vacillante, profferì interrottamente queste parole: «Là, nel camposanto di Limonta, in quella cappelletta… dove giace il mio povero fratello… vi abbiam pregato … e pianto insieme tante volte… Ch’io riposi presso di lui … vi tornerete sola a pregare, a piangere per ambedue… Mi verrà il suffragio di quella buona gente… Salutateli tutti per me… e la povera Marta, che ha un figlio anch’essa in quel santo luogo…»
La madre più coi cenni che colla voce, impedita dal pianto, l’assicurò che avrebbe fatto ogni suo desiderio. Allora il monaco, accorgendosi come non rimanessero all’inferma che pochi istanti di vita, si pose la stola, la benedisse, e cominciò a recitar sopra di lei le orazioni degli agonizzanti. Tutti s’inginocchiarono intorno al letto, e vi rispondevano singhiozzando. Bice anch’essa, quando con un fioco articolar di voci, quando col chinar lento e divoto del capo, mostrava di prender parte agli affetti espressi da quelle sante parole: il suo volto placido e sereno rendeva testimonianza della pace di quell’anima pia, che fra i dolori della morte pregustava il gaudio d’un’altra vita.
Ma tutto ad un tratto l’augusta quiete che regnava là dentro, vien rotta da un fragore di passi concitati che salgono la scala: tutti gli sguardi si rivolgono verso l’uscio; la castellana levandosi in piedi si fa incontro a due persone che vi si affacciano, e ricambia alcune parole; l’uno dei vegnenti si ferma sul limitare, ma l’altro avventandosi nella camera si precipita ginocchione a piè del letto, ne stringe e bacia le coltri, e le innonda di lagrime.
Ermelinda, il Conte, Lauretta, conobbero tosto Ottorino; gli altri l’indovinarono.
Il giovane arrivava allora allora dal castello di Binasco in compagnia di quell’uomo, in nome del quale v’era stato tenuto prigione, e che era corso in persona a liberarlo.
La morente, scossa da quel subito trambusto, aperse languidamente gli occhi, e senza essersi potuta accorgere del sopravvenuto, chè gli altri standole d’intorno gliene toglievan la vista, domandò che fosse.
«Rendete lode a Dio,» sclamò il confessore intenerito, «avete accettata dalle sue mani l’amarezza, l’avete accettata con pace, con riconoscenza; accettate collo stesso animo la gioia che ora vi vuol dare, e tanto quella che questa vi sarà attribuita a merito.»
«Che?… Ottorino?…» disse l’agonizzante facendo un ultimo sforzo per profferire quel nome.
«Sì, il vostro sposo,» ripetè il sacerdote, e accostatosi al giovane, lo fece levare in piedi e lo condusse presso di lei. Bice gli fissò in volto gli occhi lampeggianti d’un raggio che stava per ispegnersi, e gli stese una mano, sulla quale egli chinò la faccia tramutata, ma non più lagrimosa. Dopo un istante, la moribonda ritrasse dolcemente a sè quella mano; e mostrandola al suo sposo, accennava nello stesso tempo la madre, e s’affannava per dir qualcosa senza poter mai profferire distintamente le parole. Il monaco indovinò il suo desiderio, e vôlto al giovane: «Vuol dirvi dell’anello nuziale ch’essa ha dato alla madre, e che riceverete da lei.» Il volto di Bice si animò tutto d’un sorriso, accennando di sì. Allora Ermelinda si trasse tostamente di dito quell’anello, e lo porse ad Ottorino, il quale baciollo e disse: «Verrà meco nel sepolcro.»
«E una preghiera vi ha legato la vostra sposa,» seguitava a dirgli il sacerdote, «che deponghiate, se mai l’aveste nel cuore, ogni pensiero di vendicarla. La vendetta appartiene al Signore.»
Ella tenea fissi ansiosamente gli occhi nel volto del giovane, il quale stavasi a capo basso e non rispondea parola; ma il confessore, prendendo l’irresoluto per un braccio: «Or via,» gli domandò con voce grave e severa, «lo promettete? lo promettete a questa vostra sposa, che sull’ultimo passo tra la vita e la morte, fra il tempo e l’eternità, ve lo domanda come una grazia, ve lo impone come un debito, in nome di quel Dio innanzi al quale ella sta per comparire?»
«Sì, lo prometto,» rispose Ottorino, dando in uno scoppio di pianto. Bice lo ringraziò con uno sguardo pieno d’angelica dolcezza, che mostrava chiaramente come non le restasse più nulla da desiderare a questo mondo.
Allora il sacerdote fe’ cenno agli astanti; i quali tornarono a inginocchiarsi, ed ei riprese le preghiere interrotte. Solo in un momento di sospensione e di silenzio universale, l’agonizzante parve accorgersi d’un suono represso di singhiozzi, che veniva dalla camera vicina, e levò uno sguardo lento in volto alla madre, come domandandole che cosa fosse: questa abbassò il viso fra le mani, ché non le reggeva il cuore di profferire un nome; ma il sacerdote curvandosi sulla moribonda le disse sottovoce: «Pregate anche per lui, principalmente per lui: è Marco Visconti.» La pia chinò soavemente il capo ad accennare che già lo faceva, e non fu più vista rilevarlo: era spirata.
 Tommaso Grossi
Tommaso Grossi
Il romanzo di Tommaso Grossi è del 1834 e l’autore mostra di conoscere molto bene il romanzo manzoniano che viene pubblicato nella sua edizione nel 1827. Ispirandosi alla trama dei Promessi sposi e alla figura dell’Innominato – personaggio simile a Marco Visconti che si pente, alla fine della storia, delle proprie azioni – Grossi segue il modello del romanzo storico di impostazione manzoniana inserendo, però, anche elementi patetici, tragici e avventurosi tratti dalla scuola di Scott. Il brano proposto vede affiancati il tono misterioso e avventuroso che avvolge la descrizione del castello e dei suoi sotterranei e carceri in cui i due amanti sono rinchiusi e quello sentimentale e patetico della scena finale, quando Ottorino ritrova Bice in punto di morte e giura di rinunciare a vendicare la sorte subita, confidando nella giustizia divina. Ma l’accentuazione di quest’ultimo aspetto fa di questo romanzo un punto di riferimento piuttosto importante per il prosieguo del romanzo d’appendice che al di là degli esiti letterari diventa decisivo come termometro della alfabetizzazione del pubblico italiano. Tale tipologia romanzesca sarà operativa soprattutto all’indomani dell’Unità d’Italia.
 Film Mario Bonnard: Marco Visconti (1940)
Film Mario Bonnard: Marco Visconti (1940)
Se mai dovessimo scorgere un’evoluzione nel genere di romanzo storico, dovremmo leggerlo nell’opera di Ippolito Nievo la cui opera, come dice efficacemente il critico Vincenzo Mengaldo, potrebbe definirsi come un “romanzo storico del presente”.
Ippolito Nievo nasce a Padova nel 1831. Studia nella città veneta legge, ma rimane affascinato, sin dalla più giovane età dalle idee mazziniane. Svolge un’intensa attività politica che lo porta a partecipare all’avventura garibaldina. Dopo Calatafimi e Palermo, rimane in città, dove svolge l’attività di sovrintendente. Di ritorno dalla Sicilia con i documenti amministrativi della spedizione, muore in mare per un naufragio della nave “Ettore” su cui si era imbarcato. Era il 1861.
 Ippolito Nievo
Ippolito Nievo
L’opera di cui ci occupiamo è Confessioni di un italiano (conosciute anche come Confessioni di un ottuagenario) scritte, in modo anche piuttosto veloce, tra il 1578 e il 1579, ma pubblicate postume nel 1867.
La vicenda s’immagina narrata dal protagonista quando è ormai più che ottuagenario e copre le vicende che vanno dal 1775 al 1885. Carlo Altoviti, allevato da uno zio, il conte di Fratta, si innamora ancora adolescente della cugina, la Pisana. A padova, dove va a studiare, Carlo è infiammato da ardori patriottici e liberali: la Pisana, che ha sposato un nobile, vecchio e ricchissimo, un po’ perché malconsigliata, un po’ per far dispetto a Carlo, lo raggiunge. Bizzarra, volubile, appassionata, gli resta accanto a Napoli, dove il giovane partecipa ai moti della Repubblica Partenopea, a Genova assediata, a Bologna. Qui lo abbandona, ma per tornare da lui a Venezia, quando egli si ammala, curandolo con abnegazione. Caduto Napoleone, Carlo partecipa ai moti liberali e viene arrestato: è condannato ai lavori forzati e nel carcere perde la vista. Commutata la pena nell’esilio, si reca a Londra, accompagnato dalla Pisana che arriva a mendicare per aiutarlo. A Londra Carlo incontra un amico, valentissimo medico, che gli ridona la vista; ma la Pisana, ormai gravemente ammalata, muore.
LA PISANA
La Pisana era una bimba vispa, irrequieta, permalosetta, dai begli occhioni castani e dai lunghissimi capelli, che a tre anni conosceva già certe sue arti da donnetta per invaghire di sé, e avrebbe dato ragione a color che sostengono le donne non esser mai bambine, ma nascer donne belle e fatte, col germe in corpo di tutti i vezzi e di tutte le malizie possibili. Non era sera che prima di coricarmi io non mi curvassi sulla culla della fanciulletta per contemplarla lunga pezza; ed ella stava là coi suoi occhioni chiusi e con un braccino sporgente dalle coltri e l’altro arrotondato sopra la fronte come un bel angelino addormentato. Ma mentre io mi deliziava di vederla bella a quel modo, ecco ch’ella socchiudeva gli occhi e balzava a sedere sul letto dandomi dei grandi scappellotti e godendo avermi corbellato col far le viste di dormire. Queste cose avvenivano quando la Faustina voltava l’occhio, o si dimenticava del precetto avuto; poiché del resto la Contessa le aveva raccomandato di tenermi alla debita distanza dalla sua puttina, e di non lasciarmi prender con lei eccessiva confidenza. Per me c’erano i figliuoli di Fulgenzio, i quali mi erano abbominevoli più ancora del padre loro, e non tralasciava mai occasione di far loro dispetti; massime perché essi si affaccendavano di spifferare al fattore che mi aveano veduto dar un bacio alla contessina Pisana, o portarmela in braccio dalla greppia delle pecore fino alla riva della peschiera. Peraltro la fanciulletta non si curava al pari di me delle altrui osservazioni, e seguitava a volermi bene, e cercava farsi servire da me nelle sue piccole occorrenze piuttostoché dalla Faustina o dalla Rosa, che era l’altra cameriera, o la donna di chiave che or si direbbe guardarobbiera. Io era felice e superbo di trovar finalmente una creatura cui poteva credermi utile; e prendeva un certo piglio d’importanza quando diceva a Martino: «Dammi un bel pezzo di spago che debbo portarlo alla Pisana!» Cosí la chiamava con lui; perché con tutti gli altri non osava nominarla se non chiamandola la Contessina. Queste contentezze peraltro non erano senza tormento poiché pur troppo si verifica così nell’infanzia come nell’altre età il proverbio, che non fiorisce rosa senza spine. Quando capitavano al castello signori del vicinato coi loro ragazzini ben vestiti e azzimati, e con collaretti stoccati e berrettini colla piuma, la Pisana lasciava da un canto me per far con essi la vezzosa; e io prendeva un broncio da non dire a vederla far passettini e torcer il collo come la gru, e incantarli colla sua chiaccolina dolce e disinvolta. Correva allora allo specchio della Faustina a farmi bello anch’io; ma ahimè che pur troppo m’accorgeva di non potervi riescire. Aveva la pelle nera e affumicata come quella delle aringhe, le spalle mal composte, il naso pieno di graffiature e di macchie, i capelli scapigliati e irti intorno alle tempie come le spine d’un istrice e la coda scapigliata come quella d’un merlo strappato dalle vischiate. Indarno mi martorizzava il cranio col pettine sporgendo anche la lingua per lo sforzo e lo studio grandissimo che ci metteva; quei capelli petulanti si raddrizzavano tantosto più ruvidi che mai. Una volta mi saltò il ticchio di ungerli come vedeva fare alla Faustina; ma la fatalità volle che sbagliassi boccetta e invece di olio mi versai sul capo un vasetto d’ammoniaca ch’essa teneva per le convulsioni, e che mi lasciò intorno per tutta la settimana un profumo di letamaio da rivoltar lo stomaco. Insomma nelle mie prime vanità fui ben disgraziato e anziché rendermi aggradevole alla piccina, e stoglierla dal civettare coi nuovi ospiti, porgeva a lei e a costoro materia di riso, ed a me nuovo argomento di arrabbiare e anche quasi d’avvilirmi. Gli è vero che partiti i forestieri la Pisana tornava a compiacersi di farmi da padroncina, ma il malumore di cotali infedeltà tardava a dissiparsi, e senza sapermene liberare, trovava troppo varii i suoi capricci, e un po’ anche dura la sua tirannia. Ella non ci badava, la cattivella. Avea forse odorato la pasta di cui era fatto, e raddoppiava le angherie ed io la sommissione e l’affetto; poiché in alcuni esseri la devozione a chi li tormenta è anco maggiore della gratitudine per chi li rende felici. Io non so se sian buoni o cattivi, sapienti o minchioni cotali esseri; so che io ne sono un esemplare; e che la mia sorte tal quale è l’ho dovuta trascinare per tutti questi lunghi anni di vita. La mia coscienza non è malcontenta né del modo né degli effetti; e contenta lei contenti tutti; almeno a casa mia.
Devo peraltro confessare a onor del vero che per quanto volubile, civettuola e crudele si mostrasse la Pisana fin dai tenerissimi anni, ella non mancò mai d’una certa generosità; qual sarebbe d’una regina che dopo aver schiaffeggiato e avvilito per bene un troppo ardito vagheggino, intercedesse in suo favore presso il re suo marito. A volte mi baciuzzava come il suo cagnolino, ed entrava con me nelle maggiori confidenze; poco dopo mi metteva a far da cavallo percotendo con un vincastro senza riguardo giù per la nuca e traverso alle guancie; ma quando sopraggiungeva la Rosa od il fattore ad interrompere i nostri comuni trastulli che erano, come dissi, contro la volontà della Contessa, ella strepitava, pestava i piedi, gridava che voleva bene a me solo più che a tutti gli altri, che voleva stare con me e via via; finché dimenandosi e strillando fra le braccia di chi la portava, i suoi gridari si ammutivano dinanzi al tavolino della mamma. Quelle smanie, lo confesso, erano il solo premio della mia abnegazione, benché dappoi spesse volte ho pensato che l’era più orgoglio ed ostinazione che amore per me. Ma non mescoliamo i giudizi temerari dell’età provetta colle illusioni purissime dell’infanzia.
Il brano ci presenta uno dei ritratti femminili più giustamente celebrati, e tale capacità è tutta nell’adottare il punto di vista di Carlino il quale ci descrive La Pisana a partire dalla sua soggezione rispetto a lei; quindi, attraverso il suo filtro in questo caso da adolescente innamorato, esclude a priori ogni atteggiamento moralistico o pedagogico. L’autore infatti non esprime giudizi e se è lo stesso Carlino (alter ego, chiaramente di Ippolito) a non esprimerli è lo stesso lettore che se ne deve esentare. Iltutto è aiutato anche da una forma lessicale assolutamente nuova, i cui linguaggi vengono mescolati con elementi vernacolari veneti e lombardi, registri a volte aulici a volte colloquiali, termini presi dalla tradizione culturale toscana: insomma un anti purismo assai lontano dal progetto linguistico manzoniano.
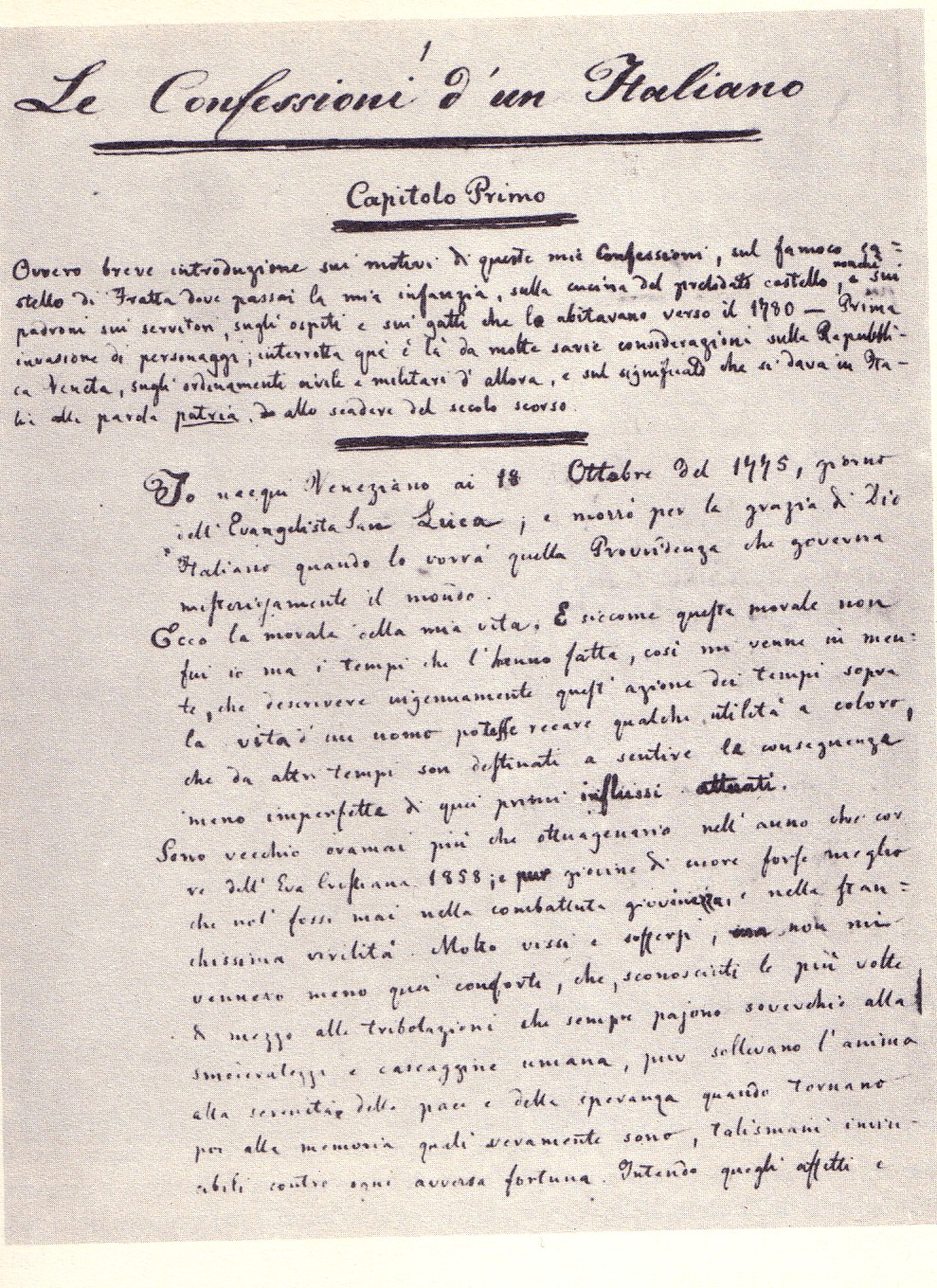 Manoscritto del romanzo
Manoscritto del romanzo
Tuttavia è l’intero progetto di Nievo ad essere interessante: egli è pienamente convinto che una storia individuale ha senso se si lascia catturare e quindi fluisce con i grandi avvenimenti; la vita di Carlino e de La Pisana è sì una grande storia d’amore ma tale storia si vivifica nel momento in cui partecipa alle azioni, alle scelte politiche, alle ideologie. Nievo va oltre il manzonismo di Renzo e Lucia (persone semplici è vero, che si stagliano nel palcoscenico secentesco) e fa dei suoi protagonisti delle figure vive, attori protagonisti nel palco sette/ottocentesco. E’ evidente che tale posizione trasformi il romanzo anche in un perfetto Bildungsrosman (romanzo di formazione) ottenuto attraverso un racconto che si muove continuamente tra presente e passato (Carlino che vive, Carlino che ricorda e giudica). Un ultimo aspetto che ci dice come NIevo abbia meditato sull’ideologia di Rousseau, facendo della vita campagnola e della giovinezza un eden perduto rispetto alla corruzione della città. E’ per tutto questo che l’opera di Nievo è di fondamentale importanza, come ponte di passaggio tra il Romanticismo ed il Verismo.
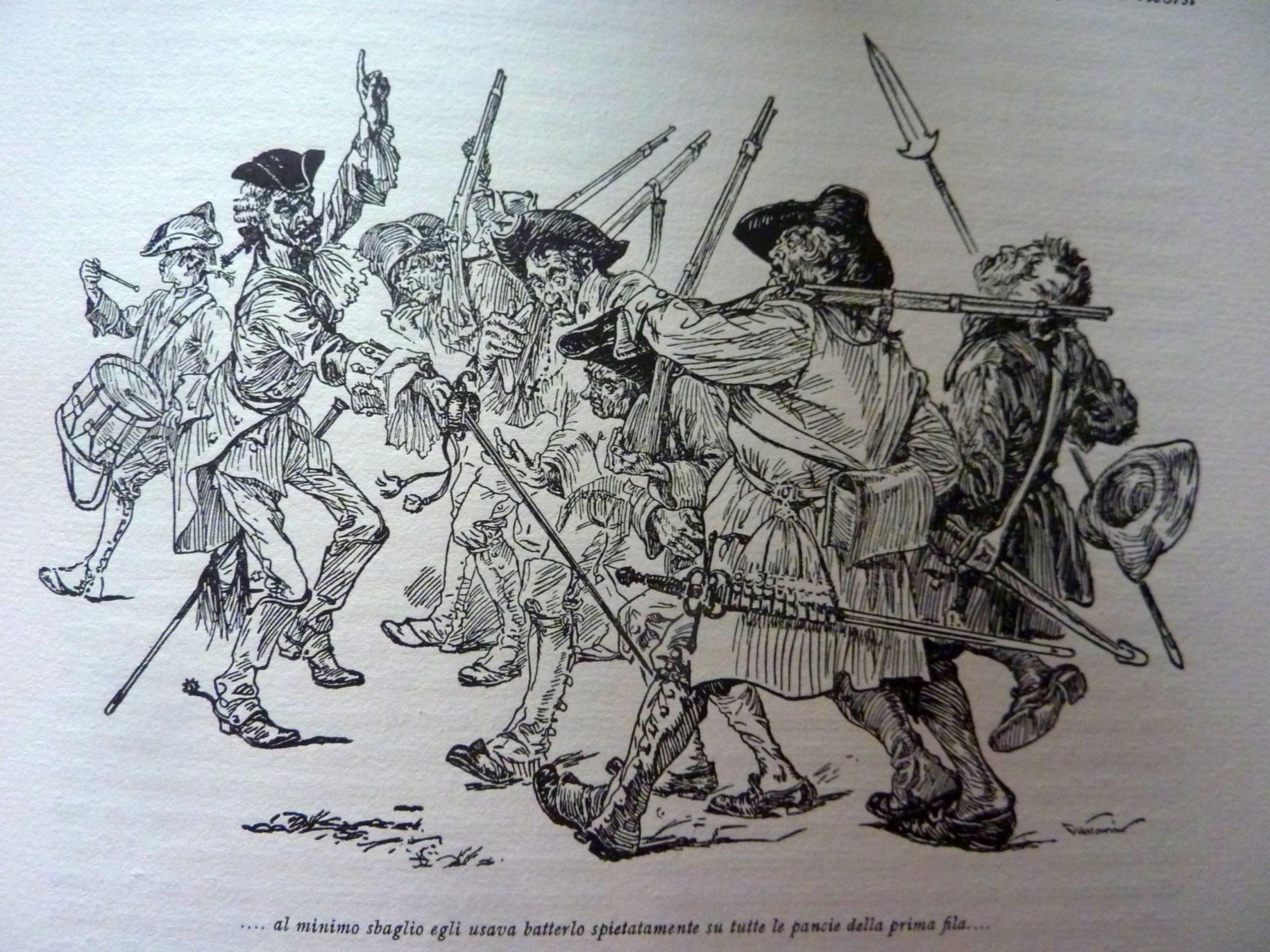 Illustrazione di un’edizione de Confessioni di un italiano (I capitolo)
Illustrazione di un’edizione de Confessioni di un italiano (I capitolo)
Altro genere che avrà un ruolo determinante nell’ispirare ideali risorgimentali è quello memorialistico. Anche qui il riferimento è nelle opere settecentesche (si pensi a Goldoni ed Alfieri), ma se in esse il punto di riferimento è individualistico, qui l’io diventa espressione di un movimento. Gli scrittori romantici che adottano tale genere sia prima dell’unità, come Pellico e Settembrini, sia dopo come Abba, sembra siano pienamente consapevoli del loro ruolo di testimonianza di uomini inseriti in un processo storico, quale appunto quello risorgimentale, capitale per gli avvenimenti politici cui aderiscono.
Tra le opere maggiormente lette e la cui lettura proseguirà, con intento edificante, fino agli anni Cinquanta, vi è Le mie prigioni di Silvio Pellico.
 Silvio Pellico, nasce a Saluzzo nel 1789. Completa gli studi a Lione, presso un ricco parente e acquisisce una buona cultura francese. Si stabilisce poi a Milano dove incontra Foscolo e Monti e fra gli stranieri la Staël, Stendhal e Byron. Ottiene un vero e proprio trionfo con la Francesca da Rimini, rappresentata nel 1815. Inseritosi nei circoli romantici, precettore in casa del conte Lambertenghi, è uno dei più assidui collaboratori del Conciliatore. Introdotto nella Carboneria, il 13 ottobre 1820 viene arrestato e poi processato e condannato a morte, ma la pena viene commutata a quindici anni di “carcere duro”, da scontare nella fortezza dello Spielberg, in Moravia. Nel 1830 è graziato e torna a Torino, dove vive come bibliotecario dei marchesi Barolo, adeguandosi alla mentalità reazionaria e bigotta di quell’ambiente. Muore nel 1854.
Silvio Pellico, nasce a Saluzzo nel 1789. Completa gli studi a Lione, presso un ricco parente e acquisisce una buona cultura francese. Si stabilisce poi a Milano dove incontra Foscolo e Monti e fra gli stranieri la Staël, Stendhal e Byron. Ottiene un vero e proprio trionfo con la Francesca da Rimini, rappresentata nel 1815. Inseritosi nei circoli romantici, precettore in casa del conte Lambertenghi, è uno dei più assidui collaboratori del Conciliatore. Introdotto nella Carboneria, il 13 ottobre 1820 viene arrestato e poi processato e condannato a morte, ma la pena viene commutata a quindici anni di “carcere duro”, da scontare nella fortezza dello Spielberg, in Moravia. Nel 1830 è graziato e torna a Torino, dove vive come bibliotecario dei marchesi Barolo, adeguandosi alla mentalità reazionaria e bigotta di quell’ambiente. Muore nel 1854.
IL CARCERIERE SCHILLER
Maroncelli ed io fummo condotti in un corridoio sotterraneo, dove ci s’apersero due tenebrose stanze non contigue. Ciascuno di noi fu chiuso nel suo covile.
Acerbissima cosa, dopo aver già detto addio a tanti oggetti, quando non si è più che in due amici, egualmente sventurati, ah sì! acerbissima cosa è il dividersi! Maroncelli nel lasciarmi, vedeami infermo, e compiangeva in me un uomo ch’ei probabilmente non vedrebbe mai più: io compiangea in lui un fiore splendido di salute, rapito forse per sempre alla luce vitale del sole. E quel fiore infatti oh come appassì! Rivide un giorno la luce, ma oh in quale stato!
Allorchè mi trovai solo in quell’orrido antro, e intesi serrarsi i catenacci, e distinsi al barlume che discendeva da alto finestruolo, il nudo pancone datomi per letto ed un enorme catena al muro, m’assisi fremente su quel letto, e presa quella catena, ne misurai la lunghezza, pensando fosse destinata per me. Mezz’ora dappoi, ecco stridere le chiavi; la porta s’apre: il capo-carceriere mi portava una brocca d’acqua.
«Questo è per bere,» disse con voce burbera; «e domattina porterò la pagnotta.»
«Grazie, buon uomo.»
«Non sono buono,» riprese.
«Peggio per voi,» gli dissi sdegnato. «E questa catena,» soggiunsi, «è forse per me?»
«Sì, signore, se mai ella non fosse quieta, se infuriasse, se dicesse insolenze. Ma se sarà ragionevole, non le porremo altro, che una catena a’ piedi. Il fabbro la sta apparecchiando.»
Ei passeggiava lentamente su e giù, agitando quel villano mazzo di grosse chiavi, ed io con occhio irato mirava la sua gigantesca, magra, vecchia persona; e, ad onta de’ lineamenti non volgari del suo volto, tutto in lui mi sembrava l’espressione odiosissima d’un brutale rigore!
Oh come gli uomini sono ingiusti, giudicando dall’apparenza, e secondo le loro superbe prevenzioni! Colui ch’io m’immaginava agitasse allegramente le chiavi, per farmi sentire la sua trista podestà, colui ch’io riputava impudente per lunga consuetudine d’incrudelire, volgea pensieri di compassione, e certamente non parlava a quel modo con accento burbero, se non per nascondere questo sentimento. Avrebbe voluto nasconderlo, a fine di non parer debole, e per timore ch’io ne fossi indegno; ma nello stesso tempo supponendo che forse io era più infelice che iniquo, avrebbe desiderato di palesarmelo.
Nojato della sua presenza, e più della sua aria da padrone, stimai opportuno d’umiliarlo, dicendogli imperiosamente, quasi a servitore:
«Datemi da bere.»
Ei mi guardò, e parea significare: “Arrogante! qui bisogna divezzarsi dal comandare.”
Ma tacque, chinò la sua lunga schiena, prese in terra la brocca, e me la porse. M’avvidi pigliandola, ch’ei tremava, e attribuendo quel tremito alla sua vecchiezza, un misto di pietà e di reverenza temperò il mio orgoglio.
«Quanti anni avete?» gli dissi con voce amorevole.
«Settantaquattro, signore: ho già veduto molte sventure e mie ed altrui.»
Questo cenno sulle sventure sue ed altrui fu accompagnato da nuovo tremito, nell’atto ch’ei ripigliava la brocca; e dubitai fosse effetto, non della sola età, ma d’un certo nobile perturbamento. Siffatto dubbio cancellò dall’anima mia l’odio che il suo primo aspetto m’aveva impresso.
«Come vi chiamate?» gli dissi.
«La fortuna, signore, si burlò di me, dandomi il nome d’un grand’uomo. Mi chiamo Schiller.»
Indi in poche parole mi narrò qual fosse il suo paese, quale l’origine, quali le guerre vedute, e le ferite riportate.
Era svizzero, di famiglia contadina: avea militato contro a’ Turchi sotto il general Laudon a’ tempi di Maria Teresa e di Giuseppe II, indi in tutte le guerre dell’Austria contro alla Francia, sino alla caduta di Napoleone.
Quando d’un uomo che giudicammo dapprima cattivo, concepiamo migliore opinione, allora, badando al suo viso, alla sua voce, a’ suoi modi, ci pare di scoprire evidenti segni d’onestà. È questa scoperta una realtà? Io la sospetto illusione. Questo stesso viso, quella stessa voce, quegli stessi modi ci pareano, poc’anzi, evidenti segni di bricconeria. S’è mutato il nostro giudizio sulle qualità morali, e tosto mutano le conclusioni della nostra scienza fisionomica. Quante facce veneriamo perchè sappiamo che appartennero a valentuomini, le quali non ci sembrerebbero punto atte ad ispirare venerazione se fossero appartenute ad altri mortali! E così viceversa. Ho riso una volta d’una signora che vedendo un’immagine di Catilina, e confondendolo con Collatino, sognava di scorgervi il sublime dolore di Collatino per la morte di Lucrezia. Eppure siffatte illusioni sono comuni.
Non già che non vi sieno facce di buoni, le quali portano benissimo impresso il carattere di bontà, e non vi sieno facce di ribaldi che portano benissimo impresso quello di ribalderia; ma sostengo che molte havvene di dubbia espressione.
Insomma, entratomi alquanto in grazia il vecchio Schiller, lo guardai più attentamente di prima, e non mi dispiacque più. A dir vero, nel suo favellare, in mezzo a certa rozzezza, eranvi anche tratti d’anima gentile.
«Caporale qual sono,» diceva egli, «m’è toccato per luogo di riposo il tristo ufficio di carceriere: e Dio sa, se non mi costa assai più rincrescimento che il rischiare la vita in battaglia!»
Mi pentii di avergli dimandato con alterigia da bere. «Mio caro Schiller,» gli dissi, stringendogli la mano, «voi lo negate indarno, io conosco che siete buono, e poichè sono caduto in quest’avversità, ringrazio il Cielo di avermi dato voi per guardiano.»
Egli ascoltò le mie parole, scosse il capo, indi rispose, fregandosi la fronte, come uomo che ha un pensiero molesto: «Io sono cattivo, o signore; mi fecero prestare un giuramento, a cui non mancherò mai. Sono obbligato a trattare tutti i prigionieri senza riguardo alla loro condizione, senza indulgenza, senza concessione d’abusi, e tanto più i prigionieri di stato. L’Imperatore sa quello che fa; io debbo obbedirgli.
«Voi siete un brav’uomo, ed io rispetterò ciò che riputate debito di coscienza. Chi opera per sincera coscienza può errare, ma è puro innanzi a Dio.»
«Povero signore! abbia pazienza, e mi compatisca. Sarò ferreo ne’ miei doveri, ma il cuore… il cuore è pieno di rammarico di non poter sollevare gl’infelici. Questa è la cosa ch’io volea dirle.»
Ambi eravamo commossi. Mi supplicò d’essere quieto, di non andare in furore, come fanno spesso i condannati, di non costringerlo a trattarmi duramente.
Prese poscia un accento ruvido, quasi per celarmi una parte della sua pietà, e disse: «Or bisogna ch’io me ne vada.»
Poi tornò indietro, chiedendomi da quanto tempo io tossissi così miseramente com’io faceva, e scagliò una grossa maledizione contro il medico, perchè non veniva in quella sera stessa a visitarmi.
«Ella ha una febbre da cavallo,» soggiunse; «io me ne intendo. Avrebbe d’uopo almeno d’un pagliericcio, ma finchè il medico non l’ha ordinato, non possiamo darglielo.»
Uscì, richiuse la porta, ed io mi sdrajai sulle dure tavole, febbricitante sì, e con forte dolore di petto, ma meno fremente, meno nemico degli uomini, meno lontano da Dio.
A sera venne il soprintendente, accompagnato da Schiller, da un altro caporale e da due soldati, per fare una perquisizione.
Tre perquisizioni quotidiane erano prescritte: una a mattina, una a sera, una a mezzanotte. Visitavano ogni angolo della prigione, ogni minuzia; indi gl’inferiori uscivano, ed il soprintendente (che mattina e sera non mancava mai) si fermava a conversare alquanto con me.
La prima volta che vidi quel drappello, uno strano pensiero mi venne. Ignaro ancora di quei molesti usi, e delirante dalla febbre, immaginai che mi movessero contro per trucidarmi, e afferrai la lunga catena che mi stava vicino, per rompere la faccia al primo che mi s’appressasse.
«Che fa ella?» disse il soprintendente. «Non veniamo per farle alcun male. Questa è una visita di formalità a tutte le carceri, a fine di assicurarci che nulla siavi d’irregolare.»
Io esitava; ma quando vidi Schiller avanzarsi verso me e tendermi amicamente la mano, il suo aspetto paterno m’ispirò fiducia: lasciai andare la catena, e presi quella mano fra le mie.
«Oh come arde!» diss’egli al soprintendente. «Si potesse almeno dargli un pagliericcio!»
Pronunciò queste parole con espressione di sì vero, affettuoso cordoglio, che ne fui intenerito.
Il soprintendente mi tastò il polso, mi compianse: era uomo di gentili maniere, ma non osava prendersi alcun arbitrio.
«Qui tutto è rigore anche per me,» diss’egli. «Se non eseguisco alla lettera ciò ch’è prescritto, rischio d’essere sbalzato dal mio impiego.»
Schiller allungava le labbra, ed avrei scommesso, ch’ei pensava tra sé: “S’io fossi soprintendente, non porterei la paura fino a quel grado; né il prendersi un arbitrio così giustificato dal bisogno, e così innocuo alla monarchia, potrebbe mai riputarsi gran fallo.”
Quando fui solo, il mio cuore, da qualche tempo incapace di profondo sentimento religioso, s’intenerì e pregò. Era una preghiera di benedizioni sul capo di Schiller; ed io soggiungeva a Dio: «Fa ch’io discerna pure negli altri qualche dote che loro m’affezioni; io accetto tutti i tormenti del carcere, ma deh, ch’io ami! deh, liberami dal tormento d’odiare i miei simili!.
A mezzanotte udii molti passi nel corridoio. Le chiavi stridono, la porta s’apre. È il caporale con due guardie, per la visita.
«Dov’è il mio vecchio Schiller?» diss’io con desiderio. Ei s’era fermato nel corridoio.
«Son qua, son qua,» rispose.
E venuto presso al tavolaccio, tornò a tastarmi il polso, chinandosi inquieto a guardarmi, come un padre sul letto del figliuolo infermo.
«Ed or che me ne ricordo, dimani è giovedì!» borbottava egli; «pur troppo giovedì!»
«E che volete dire con ciò?»
«Che il medico non suol venire, se non le mattina del lunedì, del mercoledì e del venerdì, e che dimani pur troppo non verrà.»
«Non v’inquietate per ciò.»
«Ch’io non m’inquieti, ch’io non m’inquieti! In tutta la città non si parla d’altro che dell’arrivo di lor signori: il medico non può ignorarlo. Perché diavolo non ha fatto lo sforzo straordinario di venire una volta di più?»
«Chi sa che non venga dimani, sebben sia giovedì?»
Il vecchio non disse altro; ma mi serrò la mano con forza bestiale, e quasi da storpiarmi. Benchè mi facesse male, n’ebbi piacere. Simile al piacere che prova un innamorato, se avviene che la sua diletta, ballando, gli pesti un piede: griderebbe quasi dal dolore, ma, invece, le sorride, e s’estima beato.
 “In uno stile misurato e dimesso, privo di enfasi e di toni patetici, l’autore offre in questo episodio, uno dei più celebri de Le mie prigioni, un esempio del processo di trasformazione da lui vissuto in carcere. I ruoli sociali separano Pellico dal suo carceriere e, soprattutto, lo sdegno e l’odio, impediscono all’autore di cogliere l’umanità di Shiller. Per questo motivo il centro ideologico dell’episodio, e che vale come chiave di lettura dell’intera opera, consiste nella preghiera con cui Pellico si rivolge a Dio affinché lo liberi dal tormento di odiare il suo prossimo e l’aiuti a scoprire l’altrui umanità.”
“In uno stile misurato e dimesso, privo di enfasi e di toni patetici, l’autore offre in questo episodio, uno dei più celebri de Le mie prigioni, un esempio del processo di trasformazione da lui vissuto in carcere. I ruoli sociali separano Pellico dal suo carceriere e, soprattutto, lo sdegno e l’odio, impediscono all’autore di cogliere l’umanità di Shiller. Per questo motivo il centro ideologico dell’episodio, e che vale come chiave di lettura dell’intera opera, consiste nella preghiera con cui Pellico si rivolge a Dio affinché lo liberi dal tormento di odiare il suo prossimo e l’aiuti a scoprire l’altrui umanità.”
(De Caprio / Giovanardi).
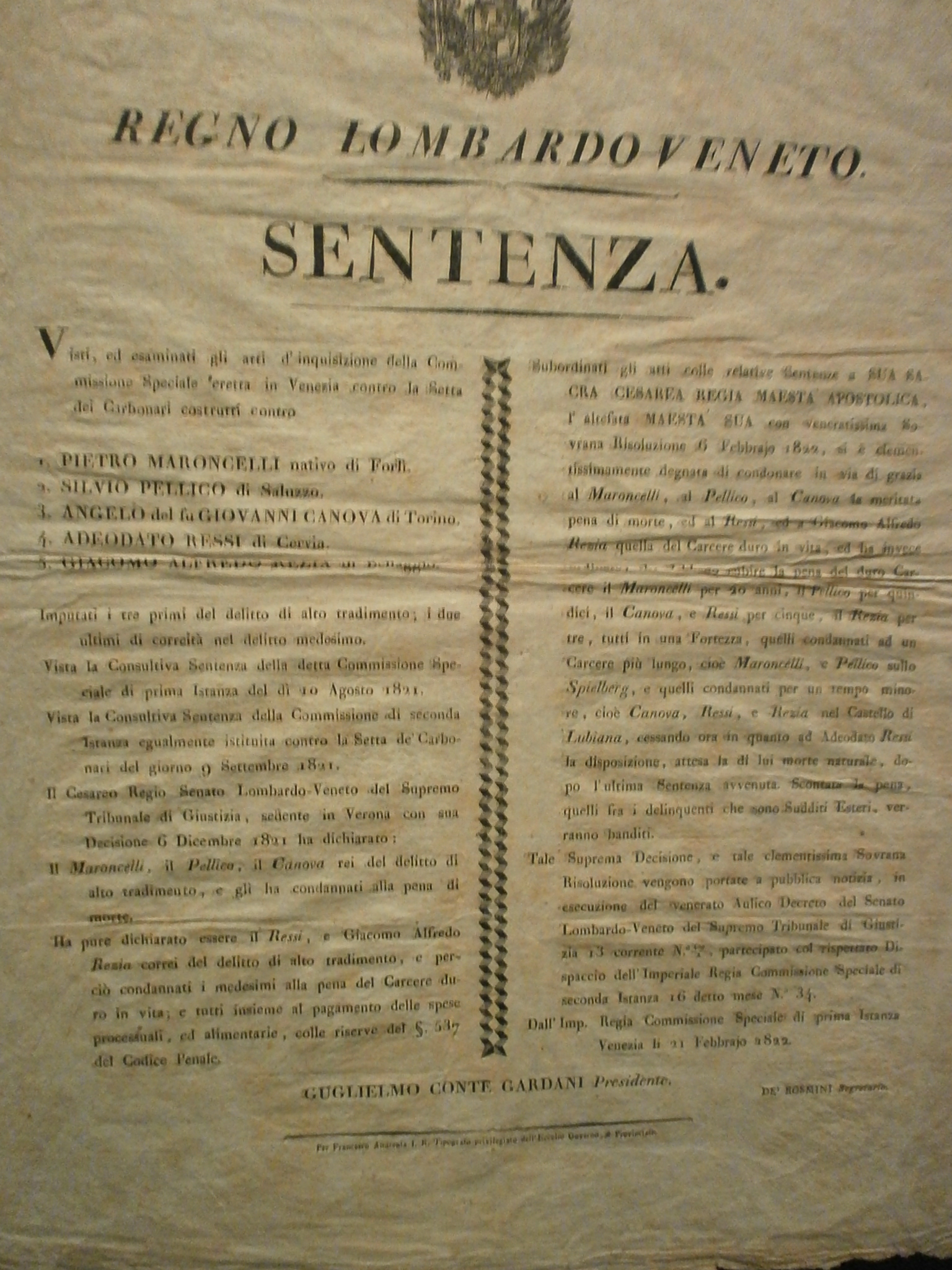 Sentenza di condono per Pietro Maroncelli e Silvio Pellico
Sentenza di condono per Pietro Maroncelli e Silvio Pellico
Sembra quasi che il 1848 segni una forte linea di demarcazione tra il romanzo scritto prima e quello successivo. La spinta propulsiva del romanzo storico o anche quella di tipo memorialistico pubblicata tra gli anni ’20 e ’40 aveva come funzione quella pedagogica che ben poteva essere riassunta nel detto manzoniano “l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo.” Il fallimento di tale moto, porta lo stesso romanzo a riflettere su stesso e ad indagare la realtà senza il filtro della storia o della memoria.
A tale scopo sembra interessante il tentativo di Niccolò Tommaseo, che nasce nel 1802 a Sebenico in Dalmazia da famiglia veneta. Giovane si trasferisce prima a Milano poi a Firenze. Qui nell’Antologia di Viesseux scrive un articolo antiaustriaco che lo costringe all’esilio. Si rifugia a Parigi dove entra in contatto con i fuoriusciti italiani. Qui scrive alcune sue opere tra le quali Fede e bellezza, che terminerà quando torna a Venezia. Nel 1847 viene arrestato dopo aver tenuto un discorso sulla libertà di stampa; liberato l’anno successivo (1848), partecipa al governo veneto, battendosi per la non unificazione con il Piemonte e per la guerra in Austria. Battuta la repubblica si rifugia a Corfù, poi nel ’54 raggiunge Torino e nel ’59 Firenze. Gli ultimi anni sono funestati dalla ciecità. Muore a Firenze nel 1874, repubblicano convinto che rifiuta la cittadinanza italiana.
Il romanzo si avvale di una tecnica mista di rievocazioni dell’uno e dell’altro protagonista, pagine di diario, narrazione in terza persona. La vicenda è povera di avvenimenti, mentre abbondano le confessioni e gli sfoghi sentimentali. Giovanni e Maria si sono conoscuiuti a Quimper; i due si confidano il loro passato, le esperienze amorose di cui furono ora vittime ora colpevoli; dopo aver superato contrasti e tentazioni, si sposano. Anche nel matrimonio continuano a confidarsi ogni più piccolo moto dell’animo. Poi Giovanni si batte in un duello con un francese che ha insultato l’Italia; ferito, guarisce, ma per vedersi morire tra le braccia, consunta dalla tisi, Maria.

LA MORTE DI MARIA
Una notte di dicembre fredda e piovosa (eran le undici sonate, e il fuoco del caminetto già spento), Maria pregata, non voleva smettere prima di finire il lavoro. Giovanni le si accosta quasi supplichevole: e stava per baciarla in fronte, quando s’accorge di non so che rosso sul volto suo più pallido e più soavemente mesto che mai. Mentre guarda spaventato, Maria ritira in fretta la pezzuola che aveva sul grembiule; egli trepidando gliela prende, la trova intrisa di sangue, e mette un grido. «Non è nulla.» «Da quando?» «Dall’altr’ieri. Oh per carità non vi spaventate.» Egli cadeva abbattuto sopra una seggiola; e Maria l’abbracciava sollecita come fa madre figliuolo pericolante. Solevano (tale fin dal primo era il patto) dormire divisi: che da questo reciproco rispetto, conducevole insieme a virtù e a libertà, a sanità e a pulizia, credevano giovarsi l’amore. Ma quella sera ell’era sì ghiaccia, ed egli sì intimorito, e sì diffidente del silenzio di lei, che pregò di posarlesi accanto. E nell’impeto del dolore innamorato congiunsero labbro a labbro; e con ardore più abbandonato ma con anima monda riprovarono nuove le gioie note: ed egli le disse parole d’amore quali ella non aveva sentite, misera, mai […]. Un’imagine or lontana or presente, velata dalla speranza, ma pur terribile, gli stava dinanzi; e avvelenava la dolcezza, e la faceva correre più veemente, penetrar più profonda. Parevagli d’abbracciare una donna condannata a morire, e la stringeva a sé come per rattenere l’angelo suo fuggente. Ma dell’affannarla col tremito dell’amore sentiva rimorso, e ristava a un tratto: ed essa con dolce voce lo chiamava confortando, e parlava degli anni avvenire. Così passarono tutta la notte: e mentr’ella s’addormentava, semi aperte le labbra rosseggianti, e con sul pallido viso la pace di persona consolata; Giovanni pensava: “Dio buono! difficil cosa anco i puri affetti esercitare con animo puro. Quante memorie vietate, fin ne’ concessi abbracciamenti! Perdono, o terribile Iddio dell’amore severo! Non mi punite: non togliete a me questa ch’è ormai conglutinata con l’anima mia!”. […] Il male ripigliava con furia: le febbri talvolta la levavan di sé; e nel delirio vedeva cose pietose, e quando liete, ch’erano più di tutte pietose a sentire. La notte del dì ventun di dicembre vaneggiò lungamente. “… Mi manca il respiro. E una volta mi pareva sì poca cosa quest’erta. Non è costì la chiesetta dell’Annunziata, e Bastia colaggiù? Inginocchiamoci. Questo ramoscello d’ulivo chi ce l’arà messo all’inferriata così? Una donna di quelle che si rammentano il Paoli. Vo’ serbarne una foglia. E gli allori della tomba d’Arquà? L’ho veduta io. Come bello il grande avvallar di que’ colli, che Dio destinava a consolazione d’un’anima pentita! Ma un fiume ci manca. La Brenta vorrei qui; e non tutte, ma qualche allegra palazzina delle allegre sue rive. La Brenta mi piace: le grandi correnti del Po mi spaventano. I’ amo il grande nel lieto, io mesta. Ferrara mi piace, città serena e solinga. Ve’ ve’, Giovanni, un ponte dell’Adige che accavalcia il Po; e la collina gaia di fronte: e un altro ponte, e un altro ancora. Ma non è questa, Verona? Come presto siam giunti! Son pur liete le città della povera Italia! Non posso più. Sediamo su questa gradinata: io sono inferma; m’è lecito a me. Nel duomo d’Imola un giorno pregai ginocchioni sopra una gradinata così. I’ ero bella allora, dicevano: e adesso! Ma dentro rea, e irrequieta. Quanto soffersi! E quella notte a Mantova nel sotterraneo di sant’Andrea, quanto piansi! Ma non è Pesaro, quella? Quelle statue che biancheggiano sotto gli alberi… Che? non son cerri codesti. Oh l’aveste veduta, quella ragazzina di Pescia, come parlava soavemente! con dinnanzi un fascio di legne di cerro, nuda i piè: pur bellina! – Ah il mio petto! Preghiamo Dio che mi dia pazienza. Non mi reggo ritta. Poserò la fronte da un lato di quest’altare. Che dice lassù? A Cristo… poi una parola scancellata. Povera me, non ci veggo più. Ma le sculture sono del Cividale: le riconosco. Oh Giovanni, compratemi un quadrettino di Frate Angelico: piccolo, purché di lui. Vi ricordate di quell’Annunziata che vidimo a Nantes? L’angelo come pudico, com’angelica in viso Maria, bruna, gracile, veneranda! L’angelo, le mani al petto, ella giunte e commesse, vestita di rosso pallido, d’azzurro pallido, e il fondo, un rosso più vivo: leggeva. E all’angelo era verde il manto e parte dell’ali, e sopra volante una colomba candida in raggi d’oro. Son pur gentili le creature dell’uomo che crede in Dio!” Qui la lingua impedita dava suoni confusi: e Maria nello sforzo si riscoteva ansimando.
Il dì ventidue peggiorò. Tornando frettoloso Giovanni da chiamare il medico, sulla piazza l’arresta una fila di bambini che, condotti da’ buoni fratelli delle scuole cristiane, uscivano da messa a due a due, con le braccia un sull’altro raccolte al petto, vispi, modesti, i be’ capelli giù per le spalle, e più gentili i più poveretti. S’impazientiva egli dell’intoppo, preparato da Dio per dargli luogo d’imbattersi col buon prete di Pontcroix, che in quel punto uscì di chiesa, e primo lo vide, e lo salutò con gioia, perché nulla sapeva del male di lei. Giovanni lo pregò di venire; e perché il prete dubitava: «venite. La consolerà rivedere chi le ha fatto del bene. E anch’a voi farà bene il vederla in tale stato. La lo conosce il suo stato. Parlatele senza tema di spaurirla: l’offendereste, se no».
Maria nel vederlo alzò il braccio e la voce come persona sana, e brillò ne’ begli occhi languidi. Egli tacito e conturbato le si pose di fronte appiè del letto, gli occhi abbassati levando or a lei ora al crocefisso, e cominciò: «Maria, un’altra volta io vi vidi languente, e vi consolai parlando del nostro buon Dio. Egli solo sa se voi siate destinata a più lungo patire: ma il patire v’ha già da gran tempo preparata alla morte. Terribile parola all’anima degli spensierati, non a coloro che l’hanno tante volte invocata nel pianto. Il più gran dolore di chi muore amato, è il dolore de’ cari che restano: ma con essi rimane Iddio. Duro mistero all’amore umano, ma certo come la morte: la vostra partita, o sorella, per quelli che v’amano sarà il meglio. Ringraziate Iddio delle consolazioni c’ha sparse sull’afflitta vostra vita; pensate agli errori commessi; e doletevene con amorosa fiducia nell’instancabile Amore. Offrite in espiazione le pene dell’ultimo sacrifizio: offritele per coloro che muoiono in quest’istante a migliaia su tutte le regioni della terra, più infelici e men disposti di voi; per que’ che rimangono a tribolare e a peccare, per que’ che nascono e nasceranno; per le nazioni intere ch’hanno terribilmente affannata vita e agonia lunga anch’esse. Noi di quaggiù pregheremo che, giunta presto in luogo di luce, ci assistiate di lassù, e c’insegniate la via. Se le consolazioni umane non fossero poca cosa ai pensieri di Dio, e se voi già nol sapeste, vi direi che, finch’io vivo, Giovanni il vostro marito, averà in Bretagna un fratello; che a me vederlo e meritare il su’ affetto, sarà consolazione desiderata: direi che morite benedetta, o Maria…».
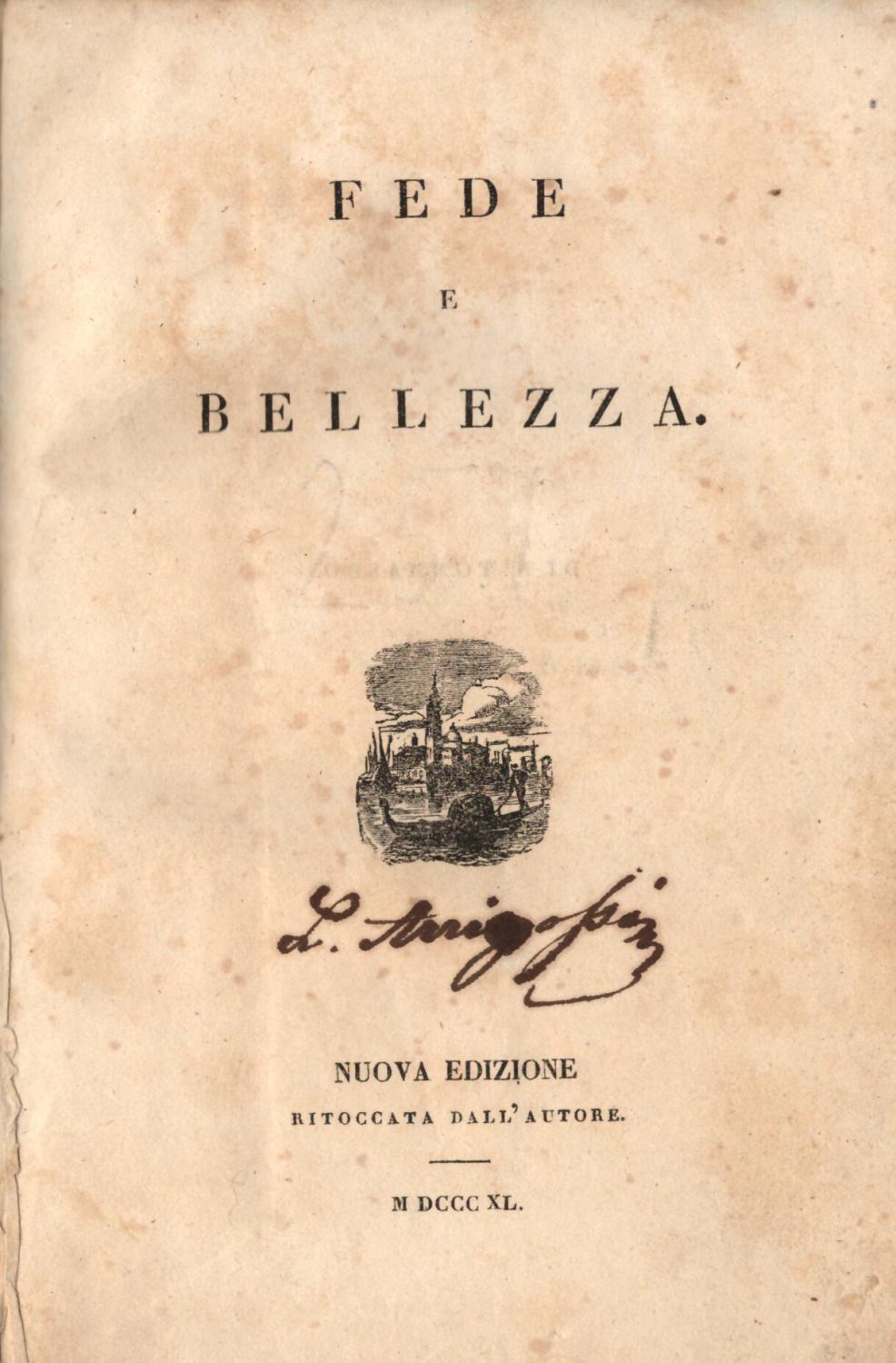 Fede e bellezza (1840)
Fede e bellezza (1840)
Ci troviamo di fronte ad una delle ultime pagine del tesrto di Tommaseo, dove ci viene descritto il lungo delirio di Maria. Tale episodio se da una parte richiama la figura dell’Ermengarda di manzoniana memoria, non lesino l’apporto della conoscenza del romanzo francese (nello specifico Volupté di Saint-Beuve), nonché di alcune eroine epiche o tragiche. Quello che interessa è qui l’ibridismo linguistico di Tommaseo: voci antiche, calchi dal latino, vocaboli in uso, ma soprattutto quasi un “anticipo” del flusso di coscienza.
Tuttavia quello che vogliamo sottolineare è che il tentativo di Tommaseo di riprendere il romanzo “realista” che in Francia vedeva i capolavori di Stendhal e Balzac, ma tale tentativo non riesce a partorire un’opera che possa pareggiare, per importanza, sul piano europeo, il capolavoro manzoniano.
 Auguste Jean-Baptiste Vinchon: Cinzia e Properzio
Auguste Jean-Baptiste Vinchon: Cinzia e Properzio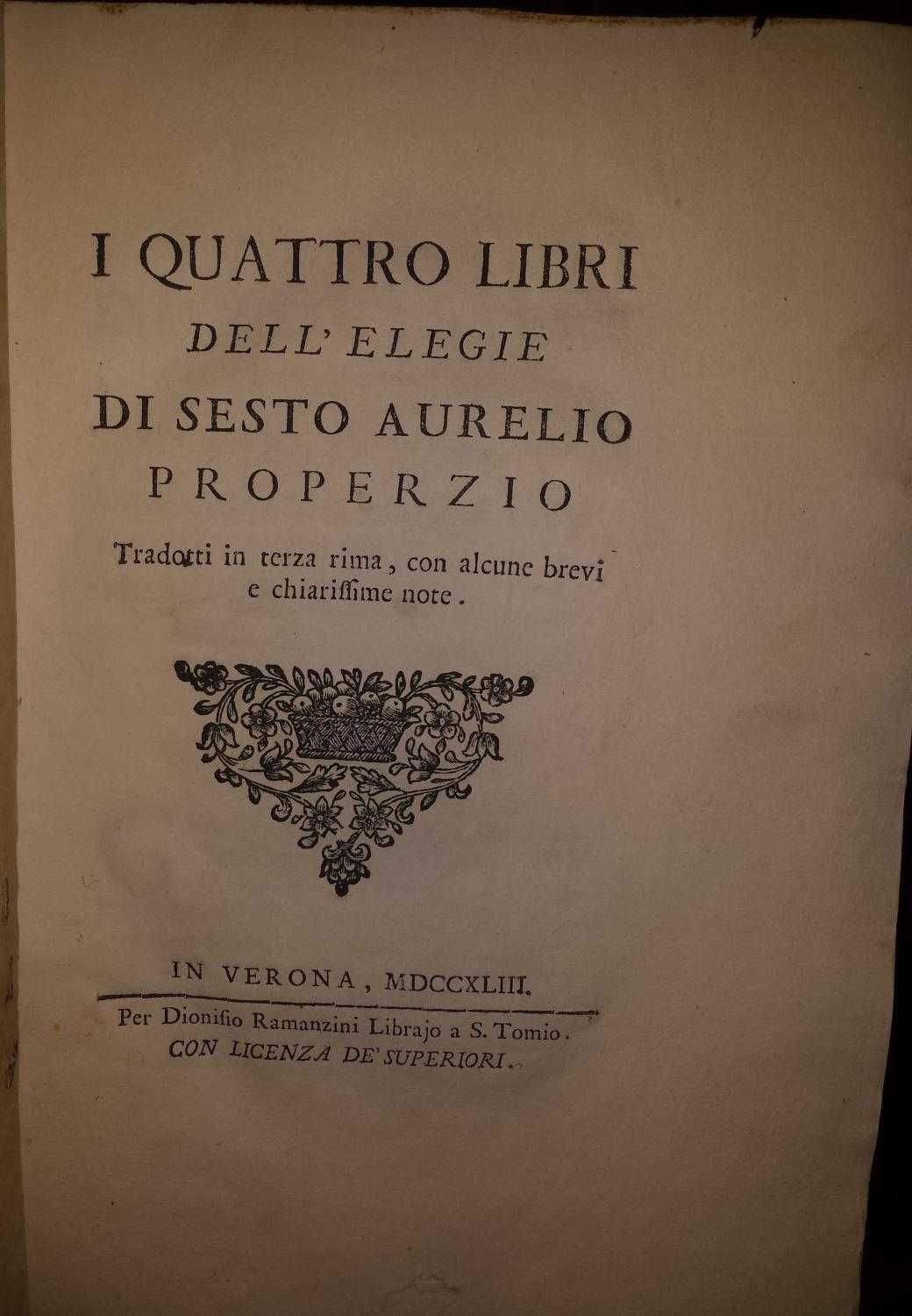









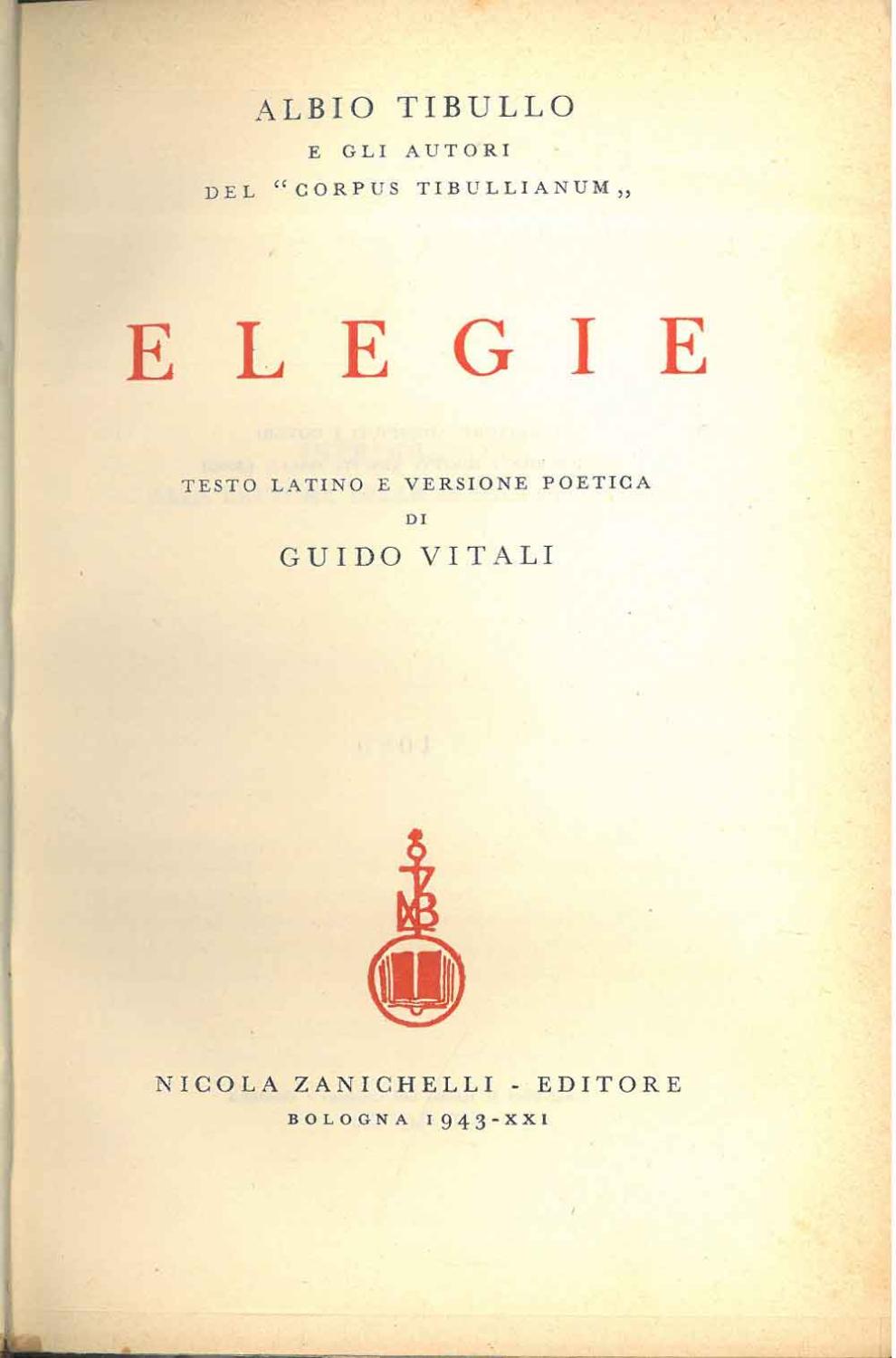


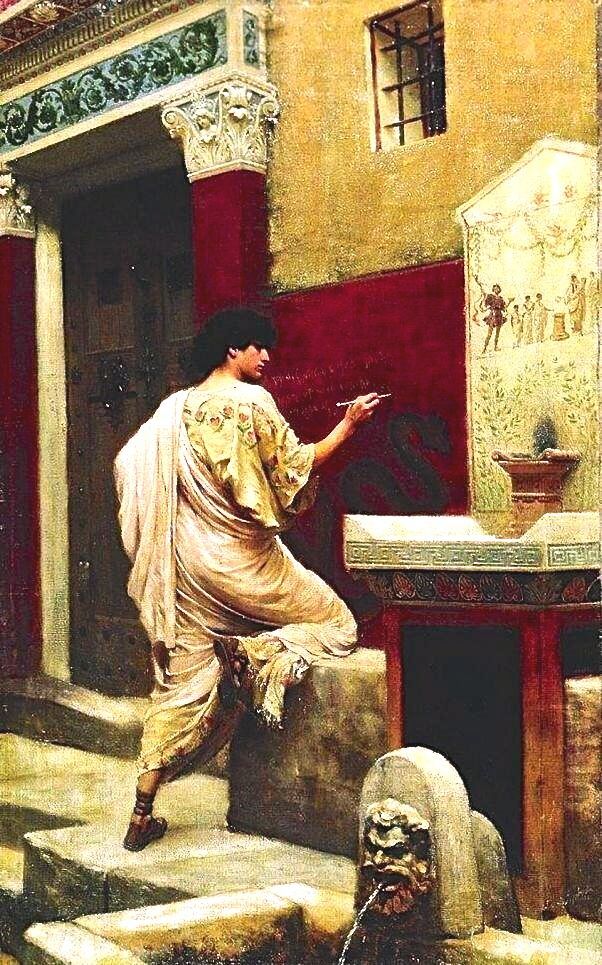 IL
IL 










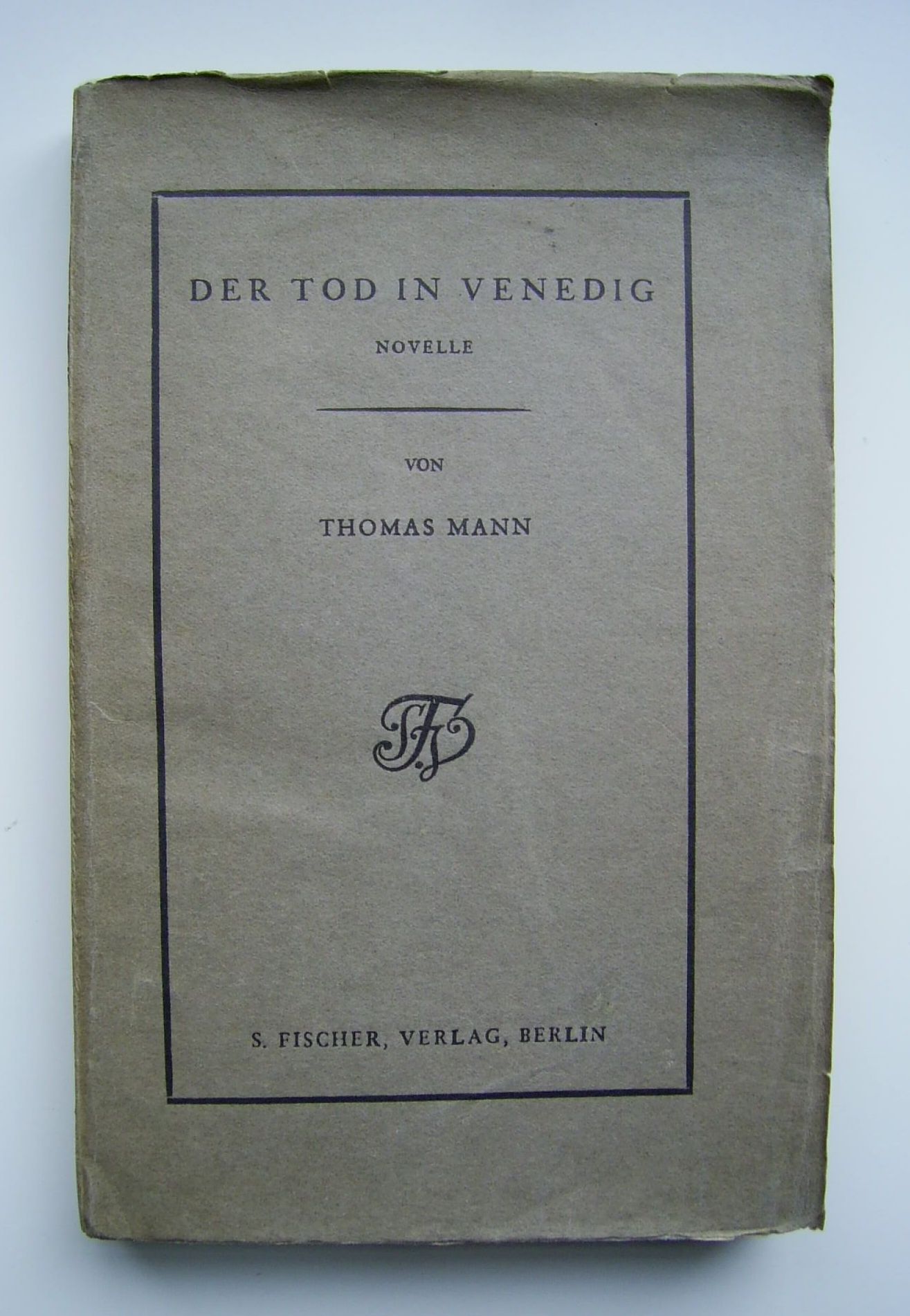
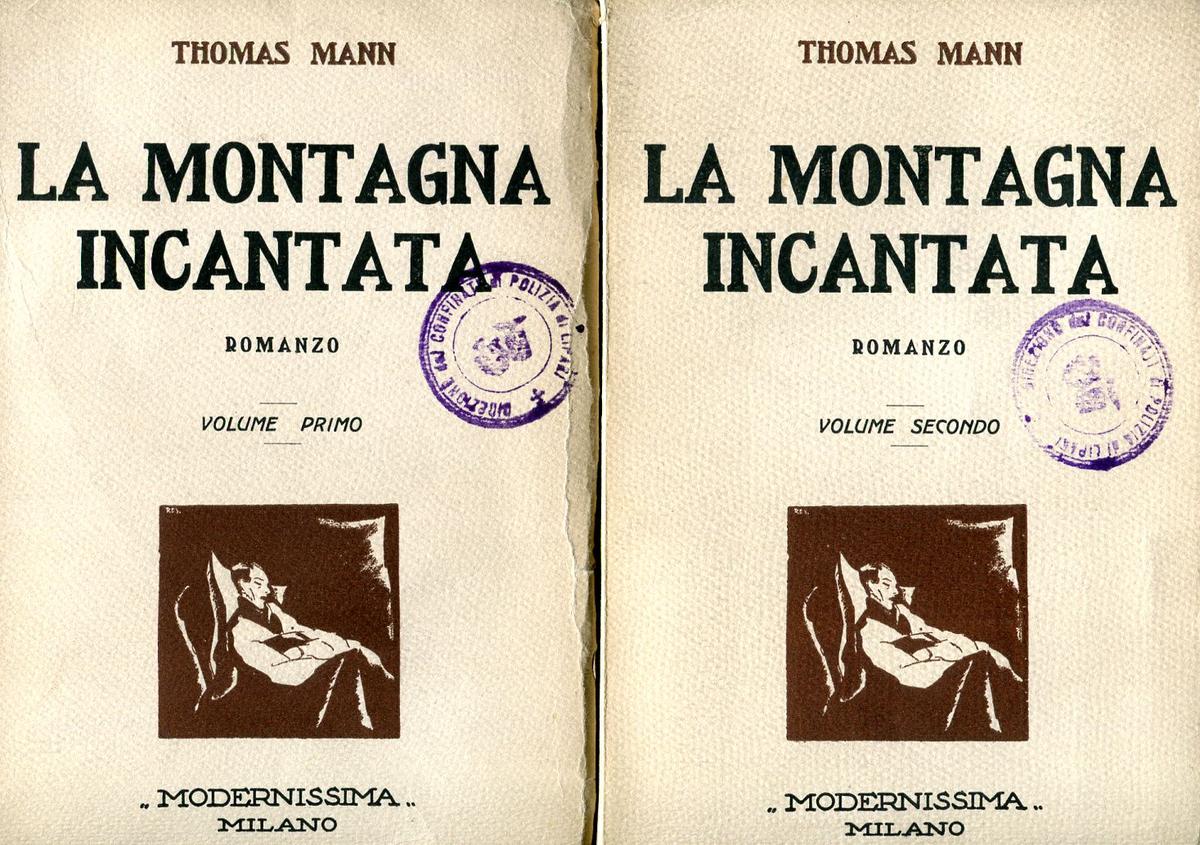
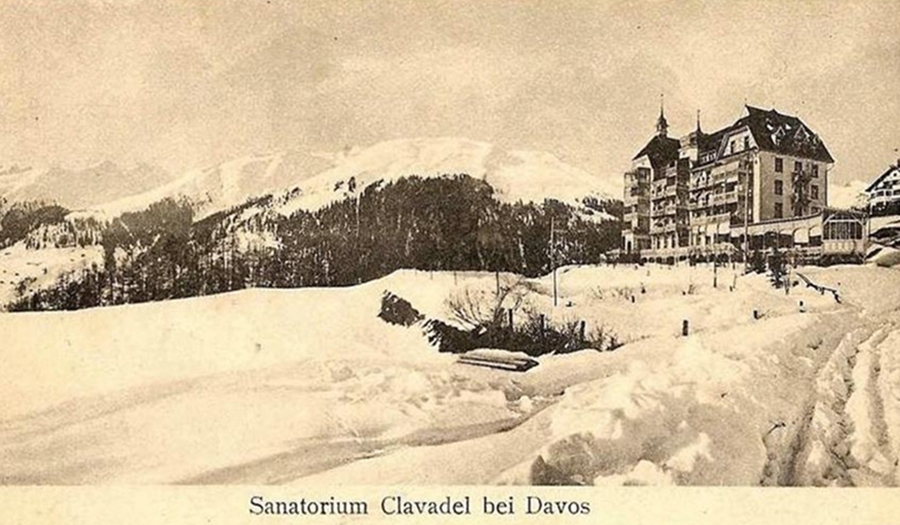
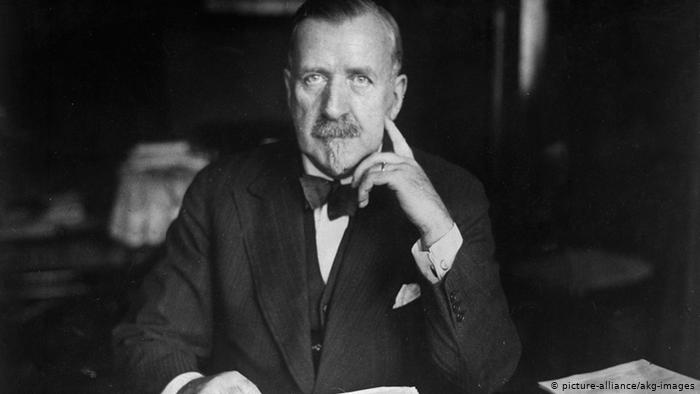
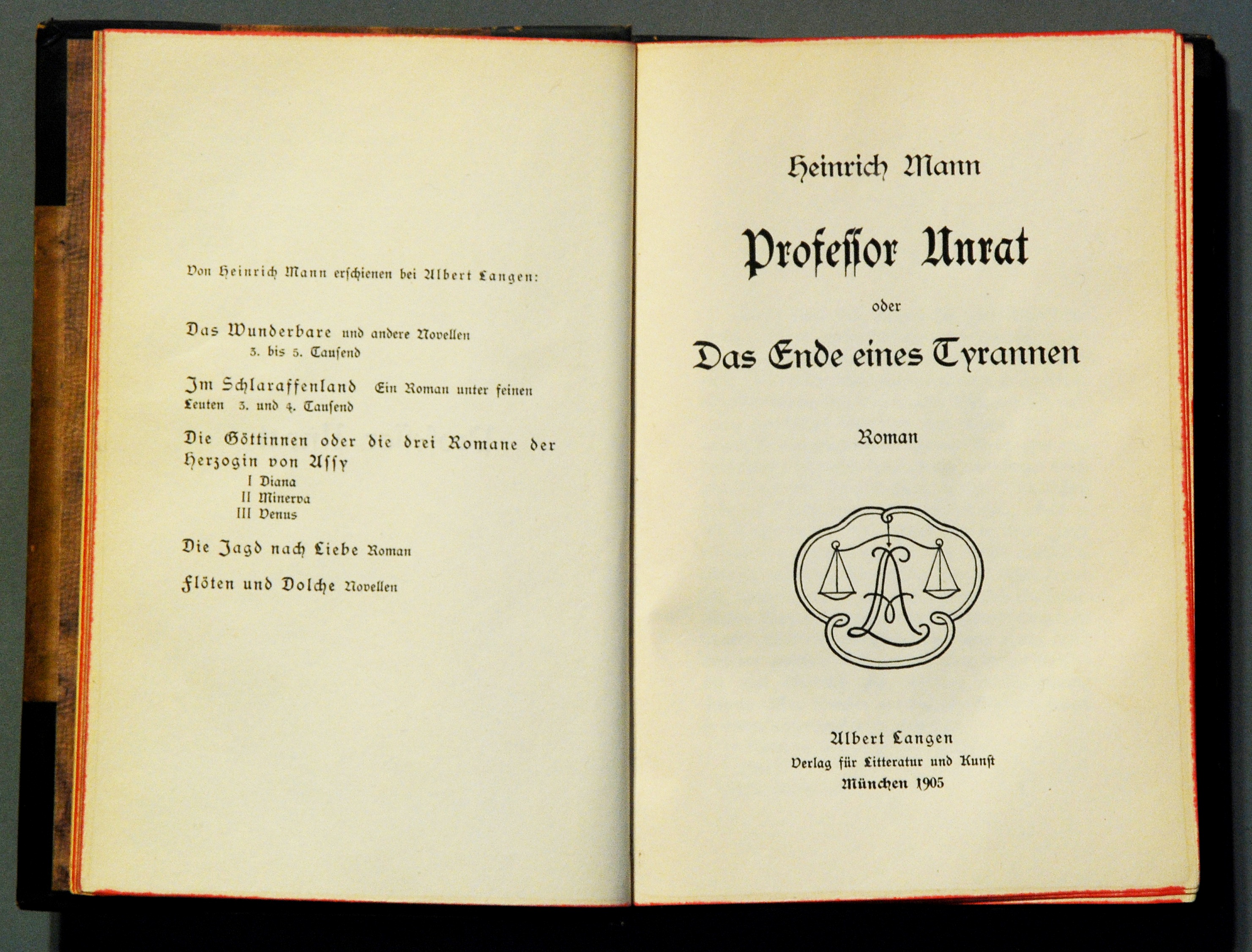


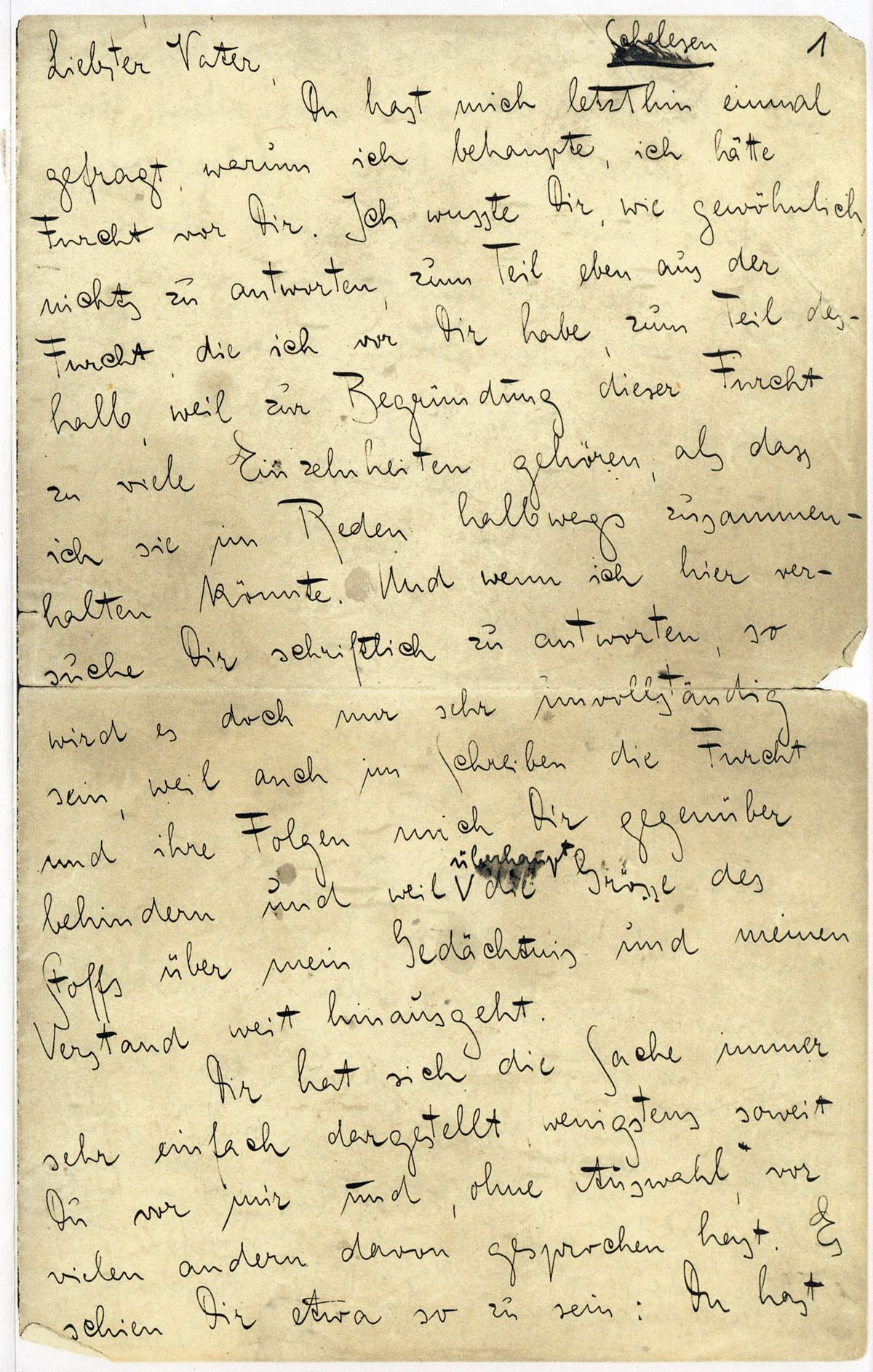


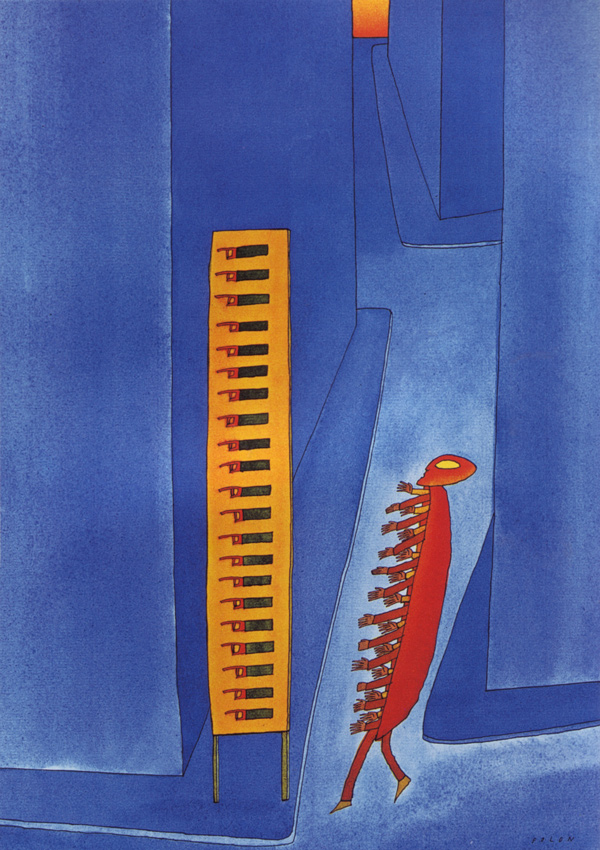


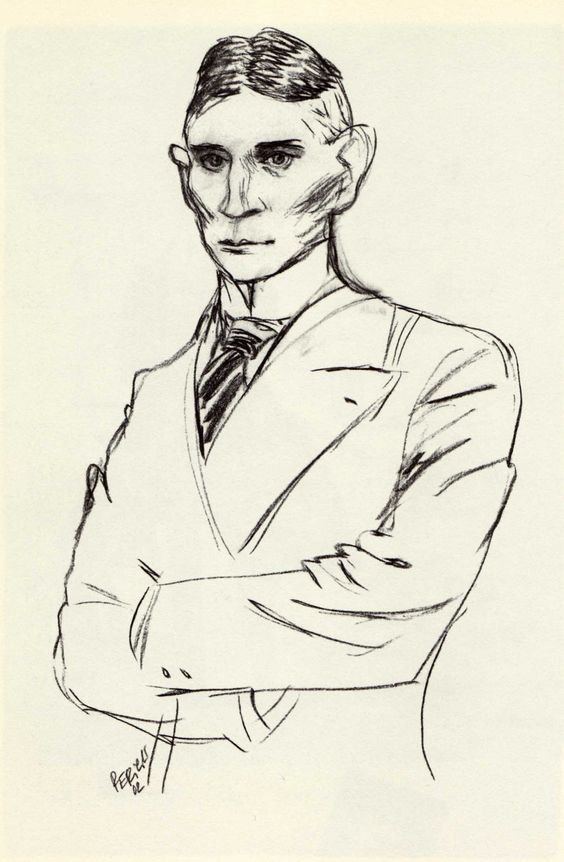








 La grandezza di questo racconto, considerato come una delle prove più alte dell’intera narrazione novecentesca, sta nell’incredibile capacità nel descrivere oserei dire in modo “realistico” un momento piccolo borghese quale una cena prenatalizia e di averlo disseminato di notazioni che invece lo facevano virare verso un’interpretazione di tipo simbolico. Una di esse è il concetto di “epifania” “come un’illuminazione improvvisa che rivela, a chi lo percepisce o la vive, un senso profondo e remoto di un evento, si tratta di situazioni, gesti, eventi per lo più minimi e insignificanti, nella considerazione abituale e agli occhi distratti degli uomini, che tuttavia, per un concorso particolare di circostante, vengono investiti da un fascio di luce, balzano in primo piano con tutta la loro carica di senso, doloroso e gioioso che sia, e determinano un movimento complesso della coscienza dei personaggi.” (Grosser). La vediamo dapprima investire Gretta: non è ancora l’atto finale, ma è come se una macchina da presa afferrata da Gabriel, riprendesse e “vedesse” la moglie per la prima volta: ascolta una musica e nell’ascoltarla diventa più leggera, radiosa, la melodia ne turba la coscienza. Tuttavia Gabriel, vedendola quasi illuminata, sembra non comprendere questa nuova luce che irradia nell’anima della moglie se non come oggetto di un forte desiderio sessuale che per il momento sembra invaderlo. Ma una volta soli, lui viene a sapere la motivazione per cui Gretta sia stata così sconvolta dalle note di una canzone: nel paese in cui precedentemente viveva quando aveva diciassette anni, un povero operaio del gas gliela cantava. Costui era morto giovane, era malato; ma il giorno prima che lei partisse per Dublino, durante la notte, sfidando il freddo era andato a salutarla. Tale gesto forse ne aveva affrettato la morte. Dopo averlo raccontato a Gabriel, Gretta si addormentò piangendo.
La grandezza di questo racconto, considerato come una delle prove più alte dell’intera narrazione novecentesca, sta nell’incredibile capacità nel descrivere oserei dire in modo “realistico” un momento piccolo borghese quale una cena prenatalizia e di averlo disseminato di notazioni che invece lo facevano virare verso un’interpretazione di tipo simbolico. Una di esse è il concetto di “epifania” “come un’illuminazione improvvisa che rivela, a chi lo percepisce o la vive, un senso profondo e remoto di un evento, si tratta di situazioni, gesti, eventi per lo più minimi e insignificanti, nella considerazione abituale e agli occhi distratti degli uomini, che tuttavia, per un concorso particolare di circostante, vengono investiti da un fascio di luce, balzano in primo piano con tutta la loro carica di senso, doloroso e gioioso che sia, e determinano un movimento complesso della coscienza dei personaggi.” (Grosser). La vediamo dapprima investire Gretta: non è ancora l’atto finale, ma è come se una macchina da presa afferrata da Gabriel, riprendesse e “vedesse” la moglie per la prima volta: ascolta una musica e nell’ascoltarla diventa più leggera, radiosa, la melodia ne turba la coscienza. Tuttavia Gabriel, vedendola quasi illuminata, sembra non comprendere questa nuova luce che irradia nell’anima della moglie se non come oggetto di un forte desiderio sessuale che per il momento sembra invaderlo. Ma una volta soli, lui viene a sapere la motivazione per cui Gretta sia stata così sconvolta dalle note di una canzone: nel paese in cui precedentemente viveva quando aveva diciassette anni, un povero operaio del gas gliela cantava. Costui era morto giovane, era malato; ma il giorno prima che lei partisse per Dublino, durante la notte, sfidando il freddo era andato a salutarla. Tale gesto forse ne aveva affrettato la morte. Dopo averlo raccontato a Gabriel, Gretta si addormentò piangendo. 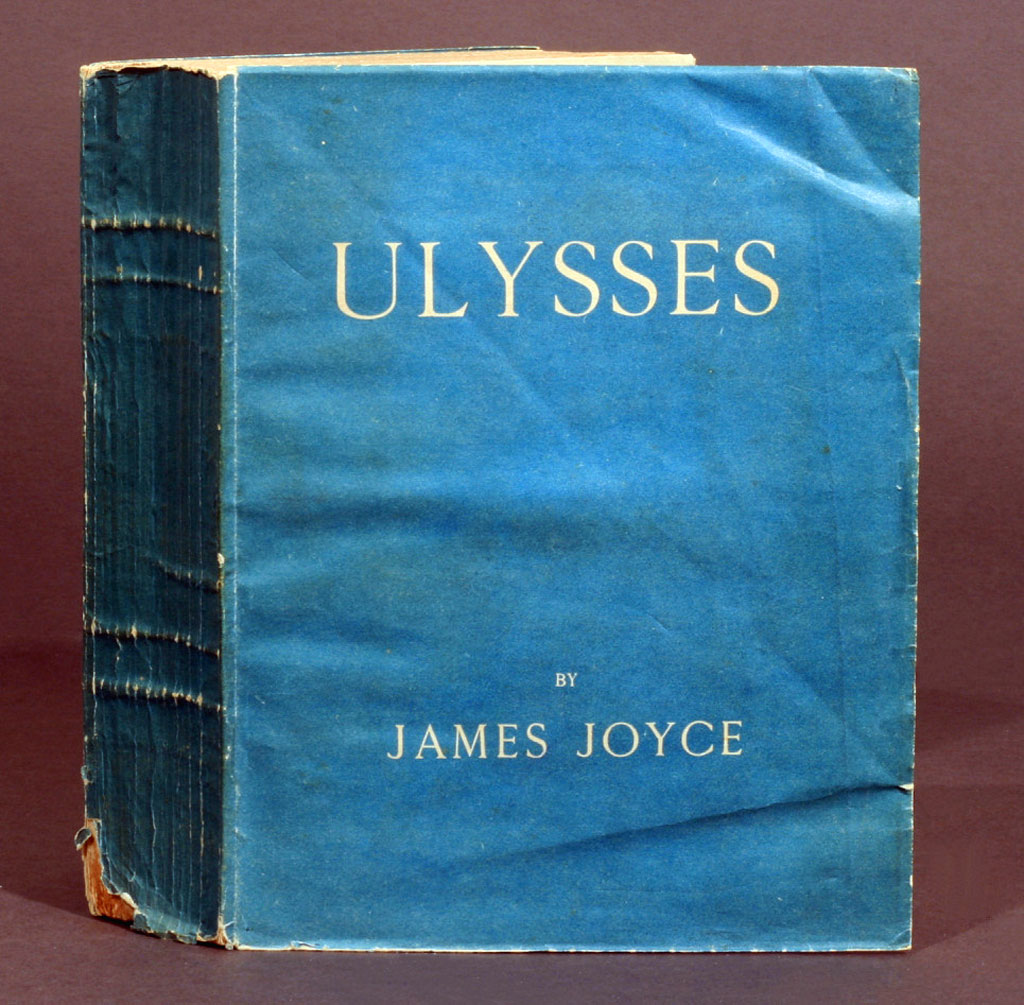 L’Ulisse rappresenta un salto qualitativo non tanto nei contenuti (viene ripresa la descrizione della vita di Dublino), quanto nella tecnica compositiva.
L’Ulisse rappresenta un salto qualitativo non tanto nei contenuti (viene ripresa la descrizione della vita di Dublino), quanto nella tecnica compositiva.




 Virginia Woolf, nata Stephen, nasce a Londra nel 1882 da un critico letterario. La sua adolescenza è ricca di conoscenze letterarie, formate soprattutto da coloro che daranno vita al Circolo di Bloomsbury (gruppo di giovani laureati a Cambridge soprattutto ostili all’Inghilterra vittoriana ed edoardiana). Nel 1912 sposa Leonard, con il quale darà vita ad una casa editrice che pubblicherà le sue maggiori opere, tra le quali ricordiamo La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927) e l’anno successivo Orlando; il suo impegno oltre che letterario, sarà anche civile, prendendo parte alle rivendicazioni femminili per i loro diritti. Ciò ci è testimoniato da Una stanza tutta per sé del 1929. Pubblicherà ancora il romanzo Le onde, ma verrà colpita da un forte esaurimento nervoso, accompagnato da momenti di depressione che la condurranno ad uccidersi annegando nel 1941.
Virginia Woolf, nata Stephen, nasce a Londra nel 1882 da un critico letterario. La sua adolescenza è ricca di conoscenze letterarie, formate soprattutto da coloro che daranno vita al Circolo di Bloomsbury (gruppo di giovani laureati a Cambridge soprattutto ostili all’Inghilterra vittoriana ed edoardiana). Nel 1912 sposa Leonard, con il quale darà vita ad una casa editrice che pubblicherà le sue maggiori opere, tra le quali ricordiamo La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927) e l’anno successivo Orlando; il suo impegno oltre che letterario, sarà anche civile, prendendo parte alle rivendicazioni femminili per i loro diritti. Ciò ci è testimoniato da Una stanza tutta per sé del 1929. Pubblicherà ancora il romanzo Le onde, ma verrà colpita da un forte esaurimento nervoso, accompagnato da momenti di depressione che la condurranno ad uccidersi annegando nel 1941. LA SIGNORA DALLOWAY
LA SIGNORA DALLOWAY Tutto ciò è bene espresso nel brano iniziale: si parte dal comprare dei fiori e dalla constatazione che bisogna togliere le porte dai cardini, per innescare l’afflusso dei ricordi quando nella casa di campagna cambiava l’aria e ancora ragazza veniva corteggiata da Peter. Mentre attraversa la strada Clarissa è investita dal rumore della città, ma proprio allora sente il bisogno di focalizzare la sua attenzione sul rintocco dell’orologio, quindi sul passar del tempo. Anche i più sciagurati si attaccano a questo tempo perché amano la vita e l’amore per essa la conduce all’idea di giovani uomini morti in guerra. Ma i giovani ora sono pronti all’amore, negli ippodromi della città e le signore si fanno belle con gli orpelli messi in vendita (ma deve fare attenzione a non spendere troppo per sua figlia). Ma anche lei quella sera sarà bella.
Tutto ciò è bene espresso nel brano iniziale: si parte dal comprare dei fiori e dalla constatazione che bisogna togliere le porte dai cardini, per innescare l’afflusso dei ricordi quando nella casa di campagna cambiava l’aria e ancora ragazza veniva corteggiata da Peter. Mentre attraversa la strada Clarissa è investita dal rumore della città, ma proprio allora sente il bisogno di focalizzare la sua attenzione sul rintocco dell’orologio, quindi sul passar del tempo. Anche i più sciagurati si attaccano a questo tempo perché amano la vita e l’amore per essa la conduce all’idea di giovani uomini morti in guerra. Ma i giovani ora sono pronti all’amore, negli ippodromi della città e le signore si fanno belle con gli orpelli messi in vendita (ma deve fare attenzione a non spendere troppo per sua figlia). Ma anche lei quella sera sarà bella.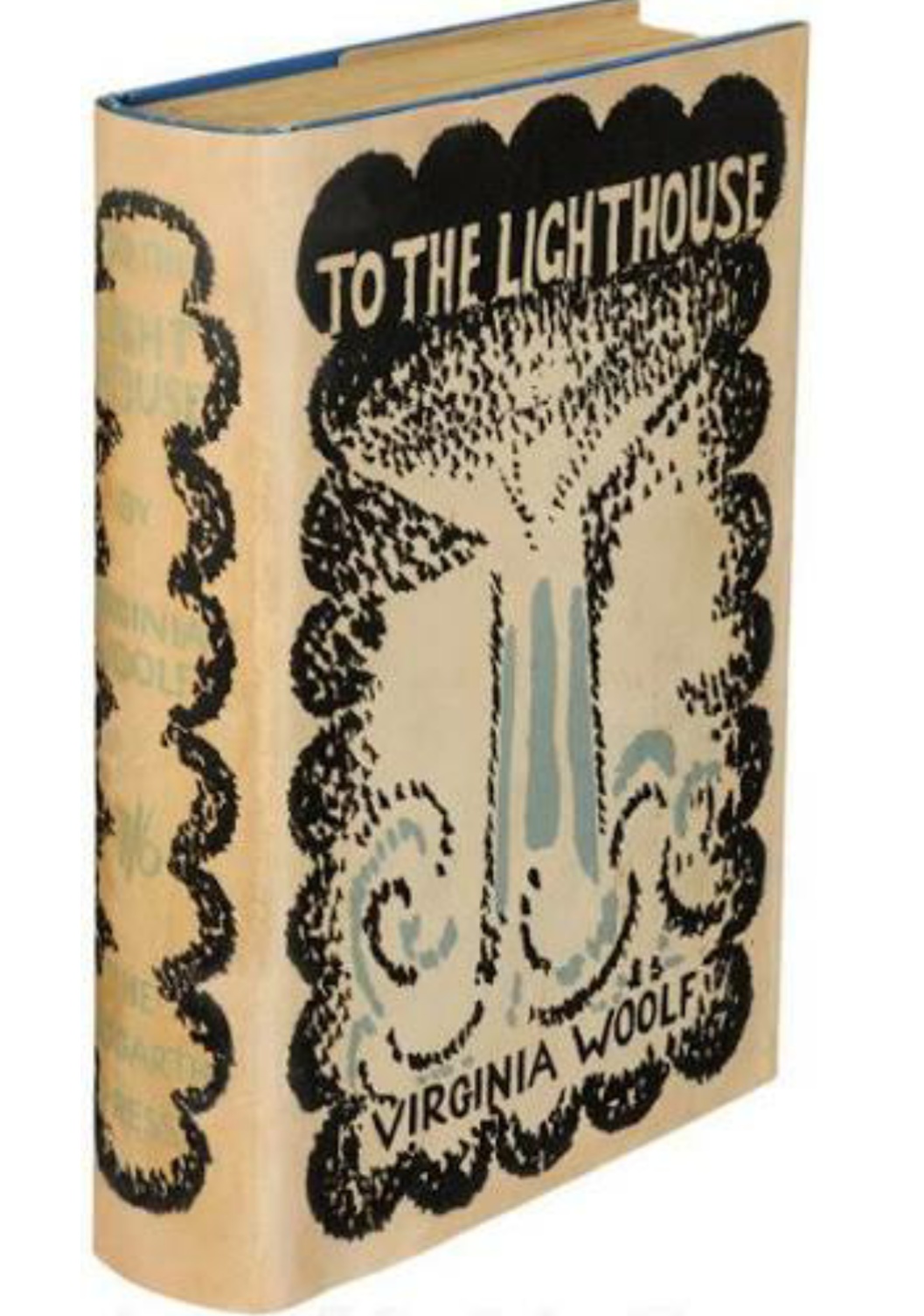



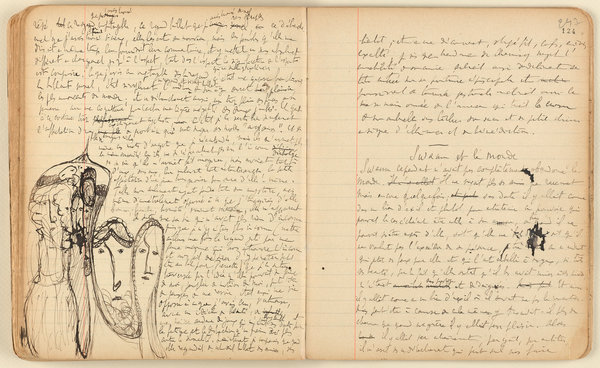




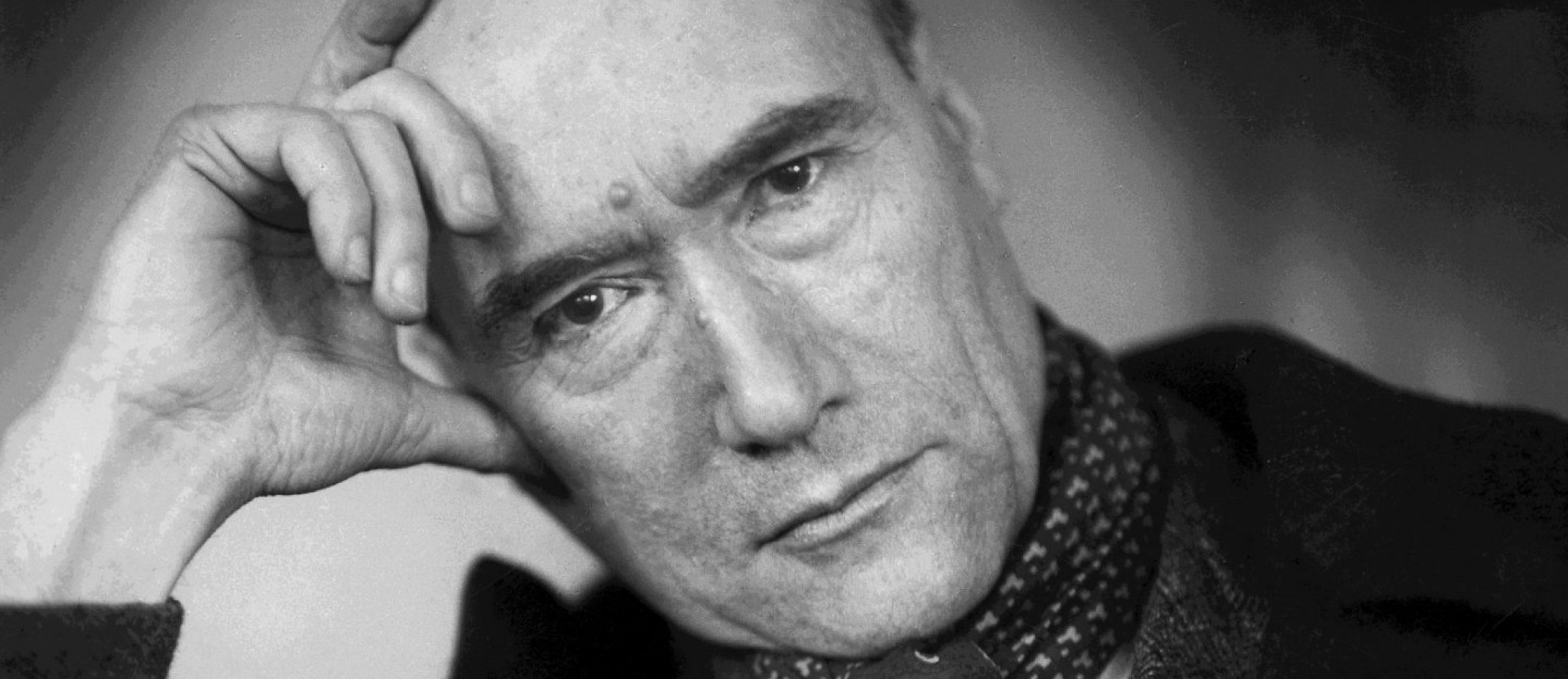
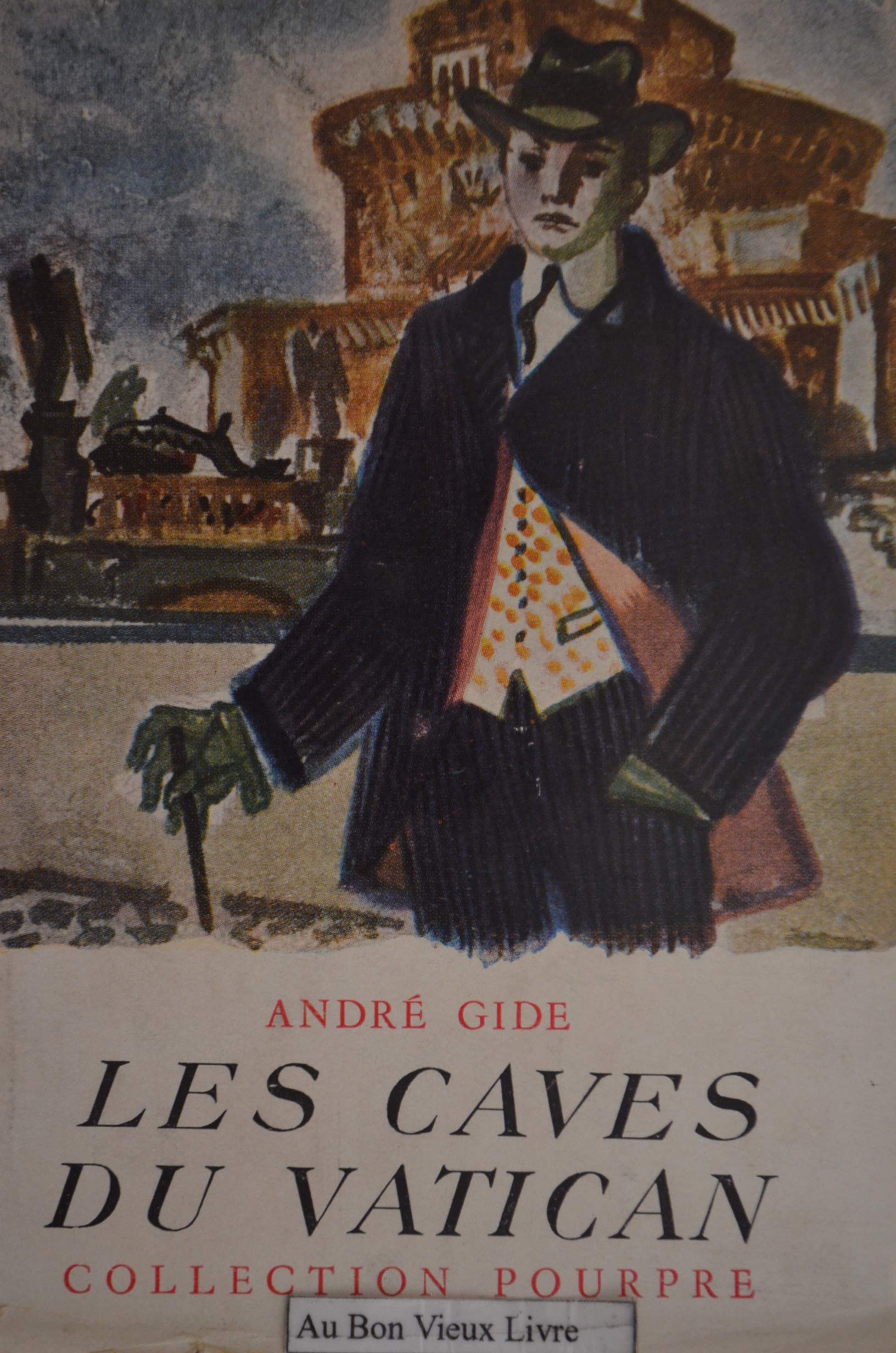
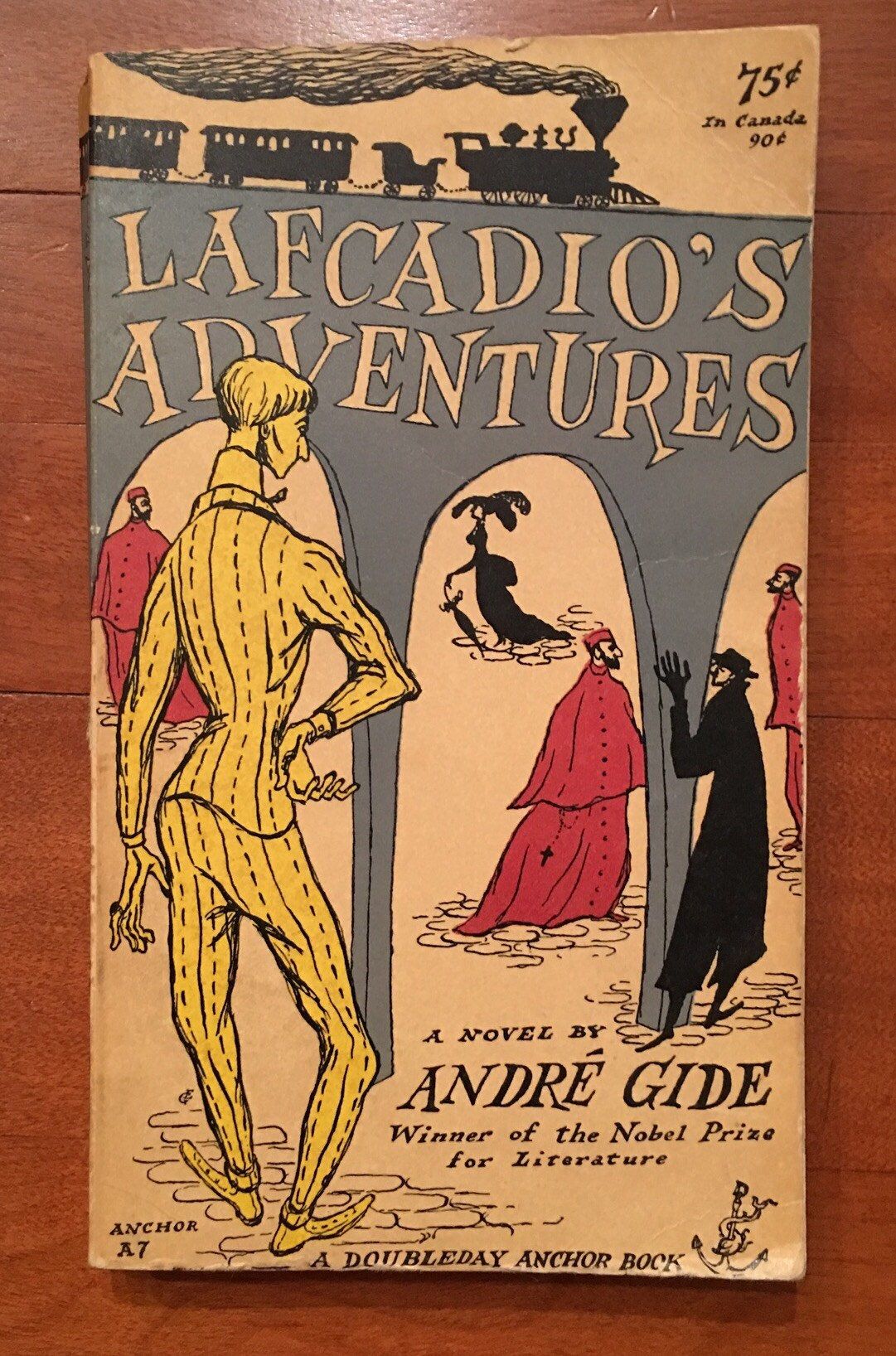
 Miguel de Unamuno è uno scrittore e filosofo spagnolo, più precisamente nativo della regione Basca. Nasce infatti a Bilbao nel 1880. Fu un uomo che da giovane viaggiò sia in Francia che in Italia e al suo ritorno ricoprì la cattedra di lingua e cultura greca nell’università di Salamanca. Divenne rettore nel 1901, ruolo che ricoprì fino al 1914 quando fu destituito per la sua attività contro la monarchia. Dopo dieci anni venne esiliato per la sua opposizione al regime di Primo de Rivera. Fuggì e su una nave francese raggiunse il suolo transalpino dove rimase sino al 1930. Allo scoppio delle guerra civile appoggiò il franchismo, pur criticando l’atteggiamento terroristico dei militari. Per averli attaccati viene un ennesima volta destituito e messo agli arresti domiciliari. Muore d’infarto nel 1936.
Miguel de Unamuno è uno scrittore e filosofo spagnolo, più precisamente nativo della regione Basca. Nasce infatti a Bilbao nel 1880. Fu un uomo che da giovane viaggiò sia in Francia che in Italia e al suo ritorno ricoprì la cattedra di lingua e cultura greca nell’università di Salamanca. Divenne rettore nel 1901, ruolo che ricoprì fino al 1914 quando fu destituito per la sua attività contro la monarchia. Dopo dieci anni venne esiliato per la sua opposizione al regime di Primo de Rivera. Fuggì e su una nave francese raggiunse il suolo transalpino dove rimase sino al 1930. Allo scoppio delle guerra civile appoggiò il franchismo, pur criticando l’atteggiamento terroristico dei militari. Per averli attaccati viene un ennesima volta destituito e messo agli arresti domiciliari. Muore d’infarto nel 1936. 


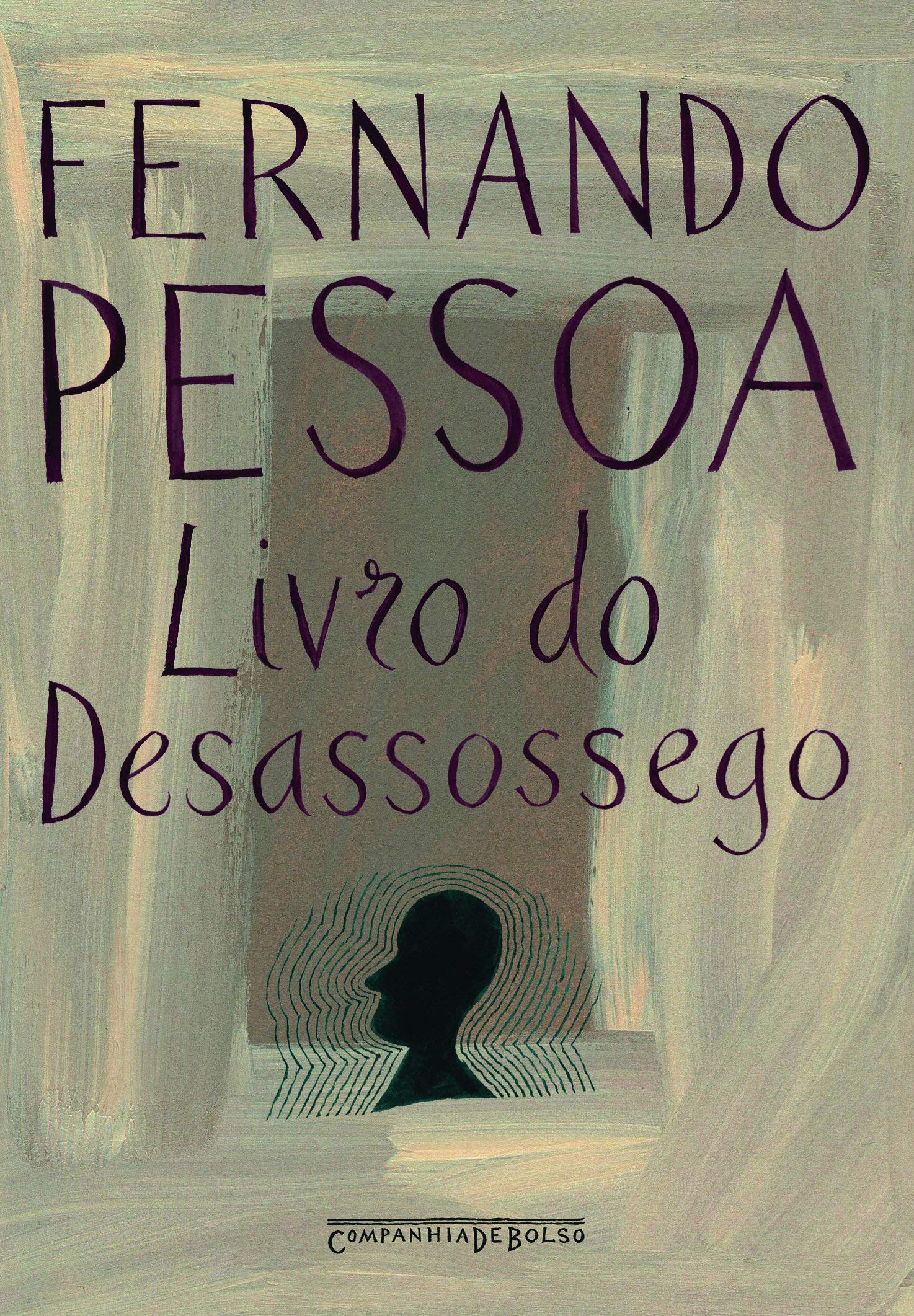










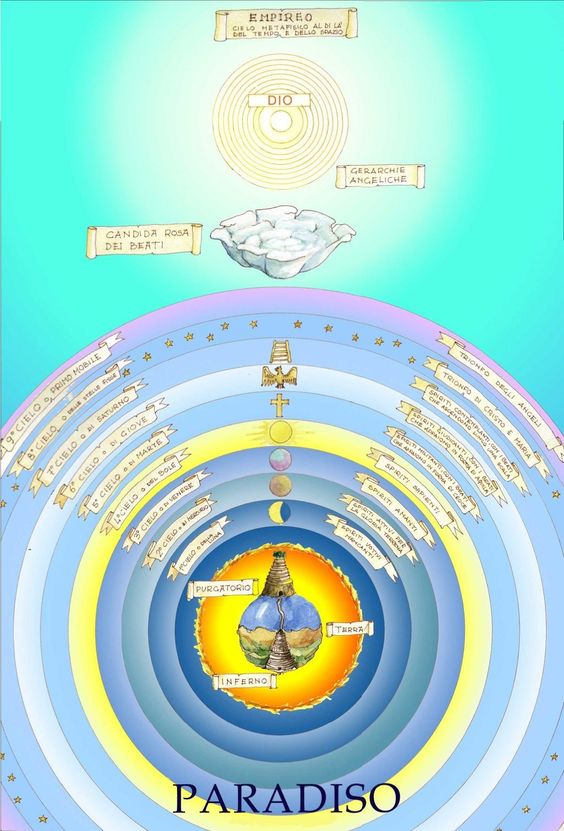

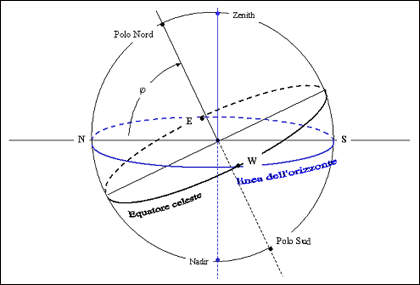

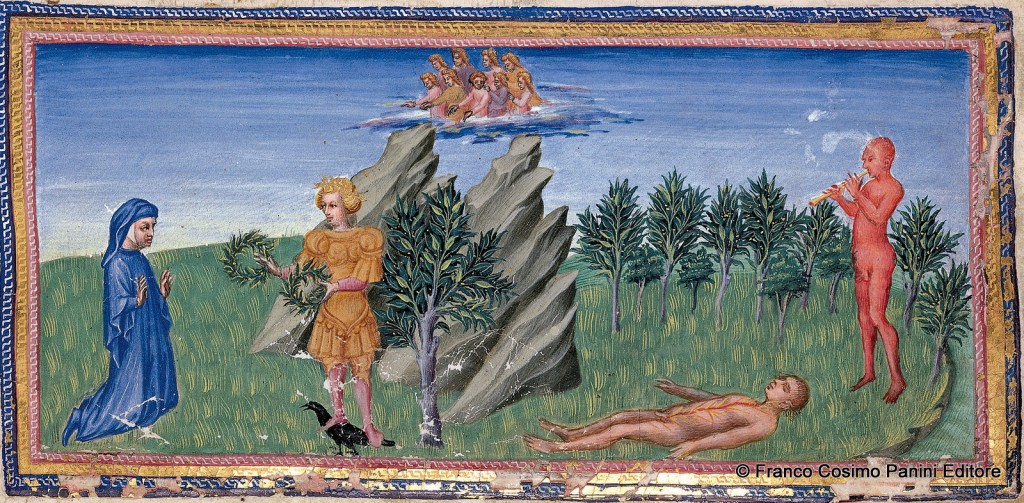


 Se i primi due canti ci avevano introdotti nell’atmosfera paradisiaca, il primo in cui Dante si era “trasumanato” (neologismo dal forte valore semantico) ed il secondo, pur così teologico, ci aveva illustrato il problema delle macchie lunari, è qui nel terzo che Dante incontra i primi personaggi che sono così diversi dalle immagini sia infernali che purgatoriali, da non rendersi conto nemmeno della loro “spiritualità”. Il loro essere è tanto diafano da essere scambiato per immagine riflessa e sarà solo Beatrice a chiarire la loro vera essenza. A parlare con lui sarà Piccarda Donati, sorella e figlia di quella famiglia che tanto dolore procurerà a Dante. Avevamo incontrato, non da molto, il di lei fratello, Forese, in un bel dialogo amicale nel XXIII canto del Purgatorio. Ed era stato proprio lui ad informare Dante dell’abisso infernale in cui era caduto Corso e della beatitudine della sorella (quasi a rappresentare una scala in cui il fratello maggiore era punito per la sua prepotenza, il mediano, Forsese scontava, pentendosi, il peccato di gola e la piccolina, Piccarda, si era salvata). Tuttavia nelle sue parole notiamo una incredibile violenza di cui i maschi si macchiavano nei confronti delle donne. Scelta la via delle Clarisse, quasi a sfuggire il clima di violenza che la circondava, Piccarda si trova strappata alla sua volontà di essere monaca per giacere al fianco di un uomo che non desiderava per problemi politici; stessa sorte sembra subire Costanza – la cui luminosità maggiore è forse determinata dall’importanza del personaggio – a cui venne strappato il velo. Il fatto è che per quest’ultima Dante sembra seguire una “diceria” piuttosto che la verità, in quanto è accertato che Costanza non si sia mai monaca. Ma non importa se Dante abbia qui dato retta ad una voce mandata in giro dai Guelfi per screditare il partito imperiale. Quello che importa è che egli disegni, con i tratti tenui che vogliono caratterizzare la femminilità, una forma non detta di stupro verso il mondo femminile.
Se i primi due canti ci avevano introdotti nell’atmosfera paradisiaca, il primo in cui Dante si era “trasumanato” (neologismo dal forte valore semantico) ed il secondo, pur così teologico, ci aveva illustrato il problema delle macchie lunari, è qui nel terzo che Dante incontra i primi personaggi che sono così diversi dalle immagini sia infernali che purgatoriali, da non rendersi conto nemmeno della loro “spiritualità”. Il loro essere è tanto diafano da essere scambiato per immagine riflessa e sarà solo Beatrice a chiarire la loro vera essenza. A parlare con lui sarà Piccarda Donati, sorella e figlia di quella famiglia che tanto dolore procurerà a Dante. Avevamo incontrato, non da molto, il di lei fratello, Forese, in un bel dialogo amicale nel XXIII canto del Purgatorio. Ed era stato proprio lui ad informare Dante dell’abisso infernale in cui era caduto Corso e della beatitudine della sorella (quasi a rappresentare una scala in cui il fratello maggiore era punito per la sua prepotenza, il mediano, Forsese scontava, pentendosi, il peccato di gola e la piccolina, Piccarda, si era salvata). Tuttavia nelle sue parole notiamo una incredibile violenza di cui i maschi si macchiavano nei confronti delle donne. Scelta la via delle Clarisse, quasi a sfuggire il clima di violenza che la circondava, Piccarda si trova strappata alla sua volontà di essere monaca per giacere al fianco di un uomo che non desiderava per problemi politici; stessa sorte sembra subire Costanza – la cui luminosità maggiore è forse determinata dall’importanza del personaggio – a cui venne strappato il velo. Il fatto è che per quest’ultima Dante sembra seguire una “diceria” piuttosto che la verità, in quanto è accertato che Costanza non si sia mai monaca. Ma non importa se Dante abbia qui dato retta ad una voce mandata in giro dai Guelfi per screditare il partito imperiale. Quello che importa è che egli disegni, con i tratti tenui che vogliono caratterizzare la femminilità, una forma non detta di stupro verso il mondo femminile.


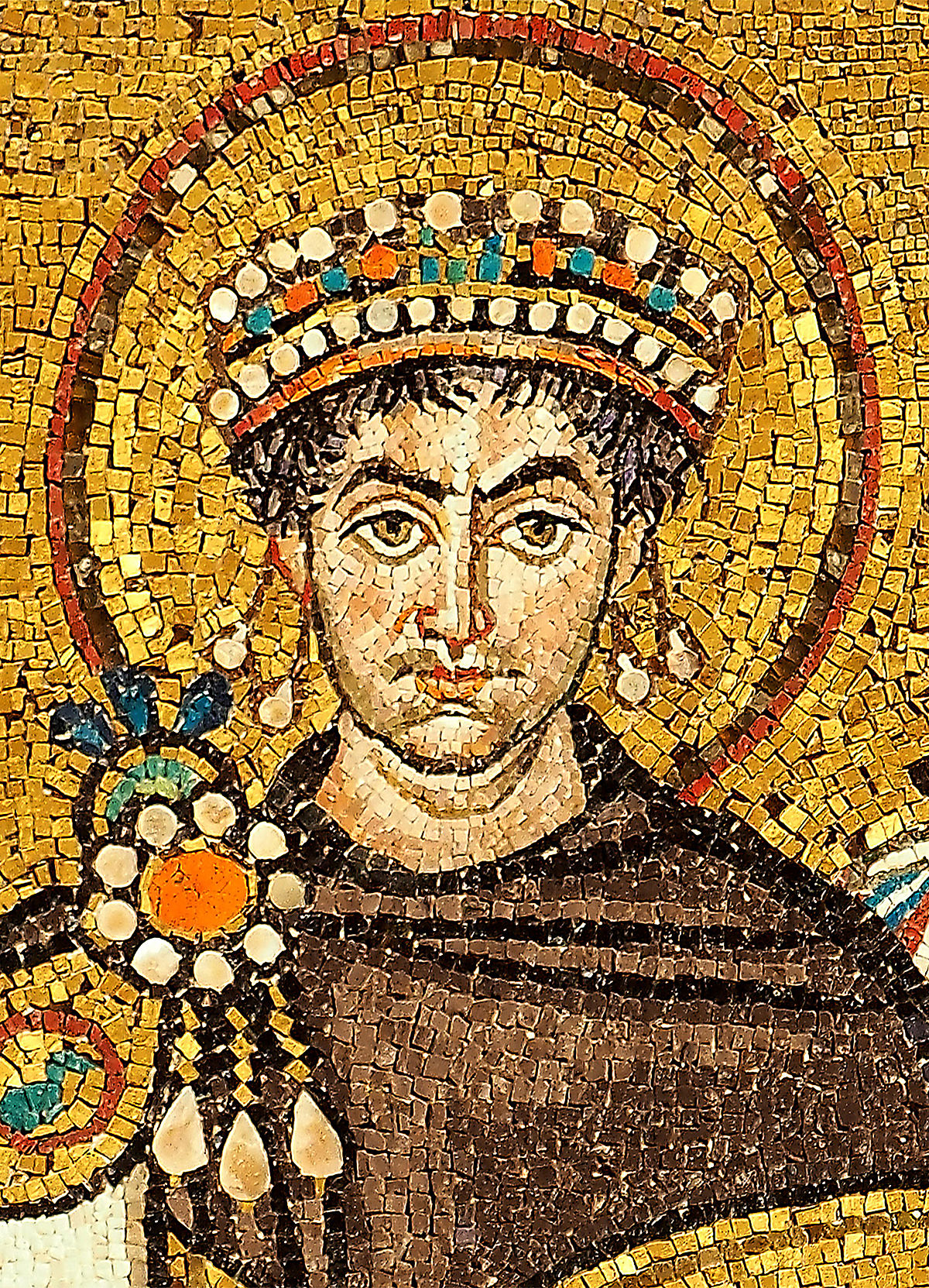

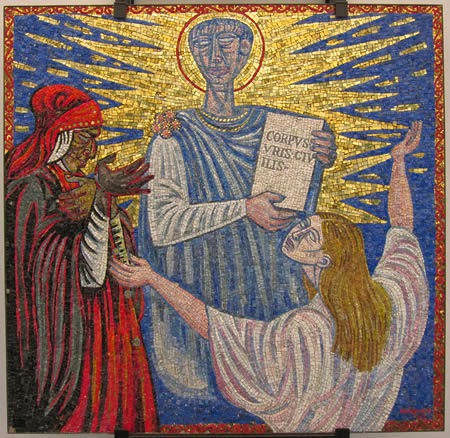
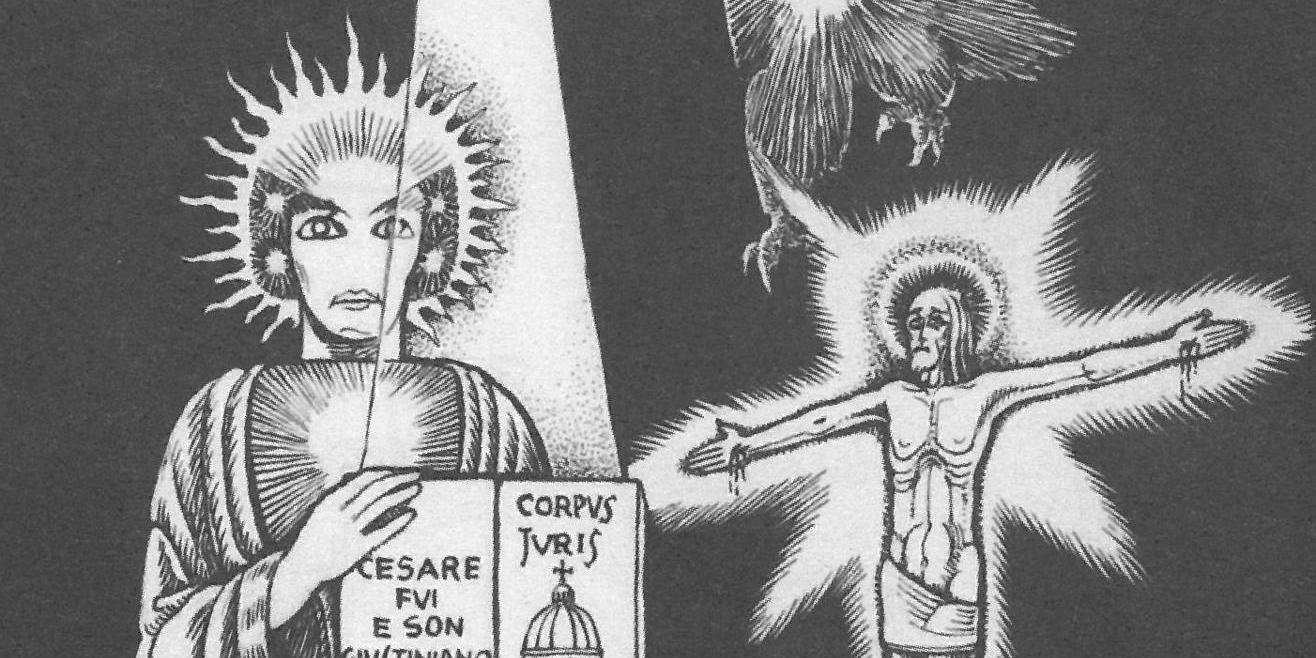



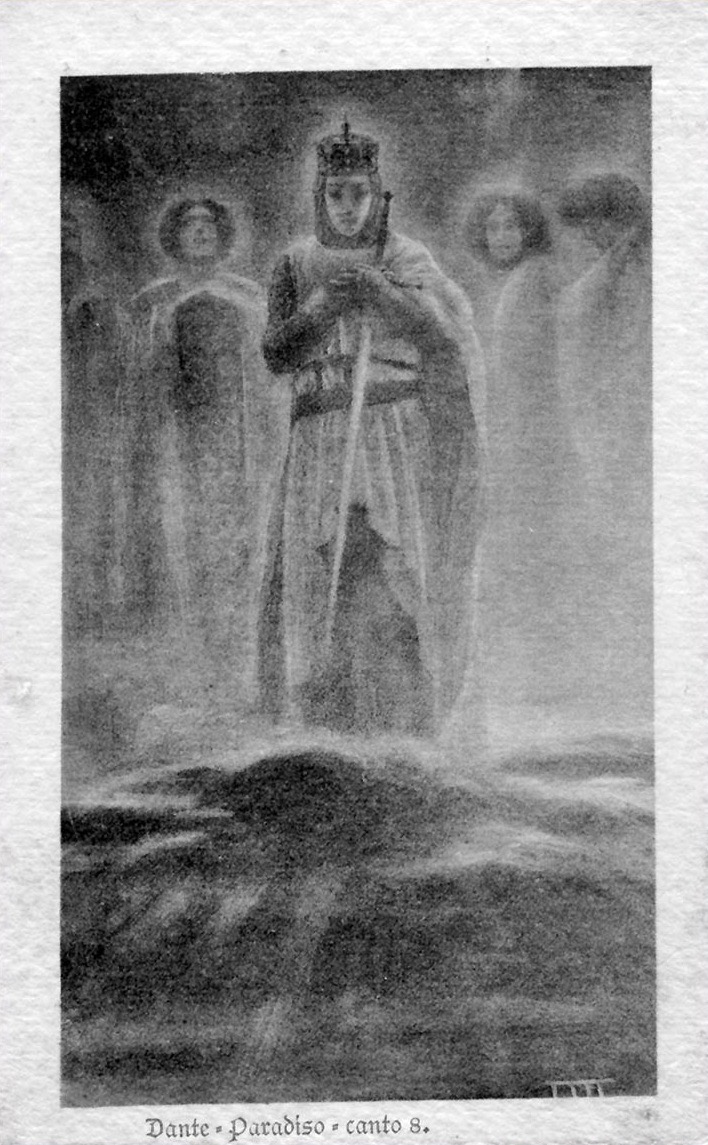

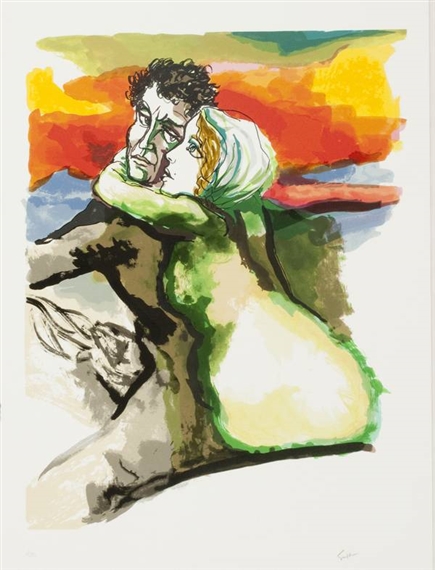















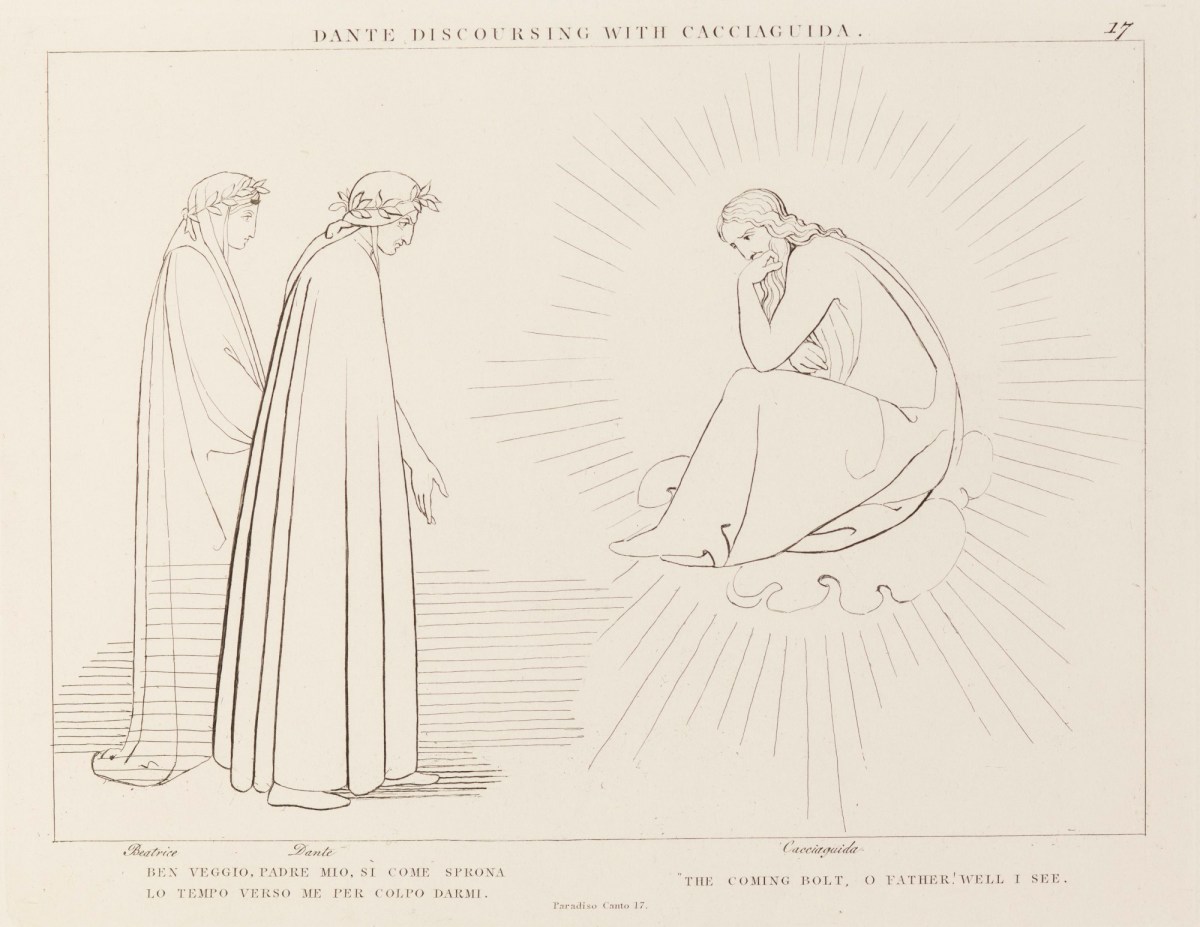





















 Come sùbito lampo che discetti
Come sùbito lampo che discetti In un luogo distante circa seimila miglia (da questo) arde il mezzogiorno e in esso la terra proietta già il cono d’ombra quasi all’altezza del nostro orizzonte , quando l’atmosfera del cielo, alta sopra di noi comincia a farsi tale che qualche stella comincia a esser visibile fin quaggiù sulla terra, e via via che l’aurora avanza, luminosa ancella del Sole, progressivamente il cielo sembra nascondere le sue stelle, sino alla più luminosa. Non diversamente i cori degli angeli che in eterno tripudiano intorno al punto dalla cui luce fui sopraffatto, che circondano e sono al contempo circondati, a poco a poco svanirono dalla mia vista: per cui il non vedere nulla e l’affetto mi spinsero a rivolgere gli occhi verso Beatrice. Se si potesse concetrare tutto in un’unica espressione di lode, questa sarebbe inadeguata ad esaurire tale compito. La bellezza che io vidi va al di là delle nostre capacità umane, ma solo Dio creatore può gioirne appieno. Mi dichiaro vinto da questo passaggio del mio poema, più che mai poeta comico o tragico si sentisse sovrastato da qualche punto del tema assunto a oggetto della sua poesia, perché come la luce del sole batte su occhi traballanti, alòlo stesso modo il sorriso di Beatrice fa venir meno il mio intelletto a me stesso. Dal giorno in cui vidi il suo viso nella vita terrena, sino a questa visione, non sono stato impedito dal seguire precisamente il mio canto, ma ora è inevitabile che il mio poetare venga meno nel seguire la sua bellezza, come ciascun poeta quando arriva al limite della sua capacità espressiva. Così, rispetto al mio fare poetico, che sta portando a termine l’ardua impresa, l’affido a poeta in grado di poterla cantare nel modo in cui, con atteggiamento e parole di sicura guida riniziò a dirmi: «Noi siamo usciti fuori dal Primo Mobile verso il cielo che è pura luce: luce intellettuale (non fisica), piena d’amore, amore del vero bene, che infonde pienezza di gioia, gioia che sovrasta ogni dolcezza. Qui vedrai i beati e gli angeli del Paradiso ed i primi con l’aspetto che prenderanno nel giorno del giudizio universale». Come un lampo improvviso che disperda sin da subito la capacità visiva, privando l’occhio dal cogliere oggetti diventati troppo intensi per lui, così una luce intensa mi circondò col suo splendore e mi lasciò fasciato da talò luminosità da non poter veder nulla. «La carità di Dio, che riempie della sua pace questo cielo, accoglie vsempre in sé chi vi entri con un siffatto saluto, affinché l’anima possa ricevere il suo ardore, come una candela la fiamma». Queste poche parole non mi giunsero più velocemente di quanto io compresi di quanto di sollevarmi al di sopra delle mie capacità, e ripresi a vedere con una più accentuata capacità visiva tale che non vi è luce così fulgenre che i miei occhi non potessero osservare; e vidi una luce riplendente di fulgore che scorreva tra due rive adorne di mirabile fioritura primaverile. Da tale fiume emergevano faville vive che si posavano sui fiori come rubini incastonati nell’oro, poi, come inebriate dal profumo, si rigettavano nel fiume e mentre esse si immergevano altre sgorgavano all’esterno. «Il grande desiderio che ora arde in te e ti stimola, di sapere cos’è ciò che vedi, tanto mi piace quanto più cresce d’intensità; ma è necessario che tu beva quest’acqua, prima che la sete (il tuo desiderio) possa essere saziata», così mi disse la luce degli occhi miei. E quindi aggiunse: «Il fiume e le faville splendenti come pietre preziose che entrano eed escono nell’acqua del fiume, costituiscono velate prefigurazioni del loro autentico essere. Non perchè tali cose siano imperfette, ma per ancora tua incapacità, che non possiedi occhi così potenti». Non vi è bambino che corra velocemente verso la mammella materna se si sveglia un po’ più tardi del solito, di quanto feci io, per rendere i miei occhi più efficaci, chinandomi sull’acqua del fiume che scorre perché ci si renda migliori, e come gli occhi miei bevvero di quell’acqua, mi parve che il fiume da lungo diventasse circolare (allagasse l’intero spazio). Poi come persone sotto la maschera, diverse da come sembrano essere, se si svestono di essa, allo stesso modo i fiori e le faville si trasformarono in uno spettacolo ancora più festante, in quanto eserciti di Dio. Oh, splendore di Dio, grazie al quale potei osservare l’alto trionfo dell’autentico regno, dammi la forza affinché affinché rioesca a descriverlo così come lo vidi! Luce è lassù che rende visibile il Creatore a colui che nel contemplarlo trova il suo appagamento. Questa luce si estende in forma circolare tanto che la siua circonferenza sarebbe troppo grande a contenere il sole. L’insieme di tale luminosità deriva da un unico raggio proveniente da Dio che si riflette sulla superficie esterna del Primo Mobile, ricevendo così la vita e la forza, tali da essere trasmessi ai cieli inferiori. E come un pendio che si riflette in uno specchio d’acqua ai suoi piedi , quasi per compiacersi della sua bellezza quando, in primavera, è verde e ricco di fiori , così allo stesso modo vidi tutte le anime beate, stando sopra tutt’intorno a quella luce, rispecchiarsi in essa disposti in innumerevoli gradini. E se l’ultimo gradino contiene una tale quantità di luce, quanta ne accoglie nei petali più lontani dalla luce, quindi più estesi! La mia capacità visiva non si smarriva per la vastità e la profondità, ma riusciva a cogliere la quantità e la qualità di quella beatitudine. Nell’Empireo il concetto di lontananza e vicinanza non hanno valore, perché dove Dio governa senza altro mezzo, le leggi fisiche non contano. Nel giallo (luogo degli stami e dei pistilli) della candida rosa che si distende progressivamente amplisandosi ed emana un profumo di lode al Signore, come persona che non dice ma desidera, mi condusse Beatrice e disse: «Osserva quanto è numerosa la riunione dei beati! Guarda la nostra città per quanto si estende; osserva i seggi come sono pieni, c he poca gente manca a riempirli. Ed in quel gran seggio su cui hai posto gli occhi, su cui è posta la corona imperiale, prima che tu ti sieda a questo banchetto di felicità eterna (prima della tua morte) si poserà l’anima che sarà nel mondo Augusta (imperiale) del nobile Arrigo, che giungerà in Italia per riportarla sulla retta via, prima di quanto essa sia preparata ad accoglierlo. La sordida avarizia che vi strega vi ha reso simili ad un infante che piuttosto muore di fame, pur di scacciare la balia. E in quel tempo sarà a capo della Chiesa un tale (Clemente V) che apertamente e nascostamente si distaccherà dal suo cammino. Ma Dio lo sopporterà poco a capo della Chiesa, tanto da essere gettato nel profondo là dove paga il suo peccato di simonia Niccolò III, facendo sprofondare più in basso Bonifacio VIII».
In un luogo distante circa seimila miglia (da questo) arde il mezzogiorno e in esso la terra proietta già il cono d’ombra quasi all’altezza del nostro orizzonte , quando l’atmosfera del cielo, alta sopra di noi comincia a farsi tale che qualche stella comincia a esser visibile fin quaggiù sulla terra, e via via che l’aurora avanza, luminosa ancella del Sole, progressivamente il cielo sembra nascondere le sue stelle, sino alla più luminosa. Non diversamente i cori degli angeli che in eterno tripudiano intorno al punto dalla cui luce fui sopraffatto, che circondano e sono al contempo circondati, a poco a poco svanirono dalla mia vista: per cui il non vedere nulla e l’affetto mi spinsero a rivolgere gli occhi verso Beatrice. Se si potesse concetrare tutto in un’unica espressione di lode, questa sarebbe inadeguata ad esaurire tale compito. La bellezza che io vidi va al di là delle nostre capacità umane, ma solo Dio creatore può gioirne appieno. Mi dichiaro vinto da questo passaggio del mio poema, più che mai poeta comico o tragico si sentisse sovrastato da qualche punto del tema assunto a oggetto della sua poesia, perché come la luce del sole batte su occhi traballanti, alòlo stesso modo il sorriso di Beatrice fa venir meno il mio intelletto a me stesso. Dal giorno in cui vidi il suo viso nella vita terrena, sino a questa visione, non sono stato impedito dal seguire precisamente il mio canto, ma ora è inevitabile che il mio poetare venga meno nel seguire la sua bellezza, come ciascun poeta quando arriva al limite della sua capacità espressiva. Così, rispetto al mio fare poetico, che sta portando a termine l’ardua impresa, l’affido a poeta in grado di poterla cantare nel modo in cui, con atteggiamento e parole di sicura guida riniziò a dirmi: «Noi siamo usciti fuori dal Primo Mobile verso il cielo che è pura luce: luce intellettuale (non fisica), piena d’amore, amore del vero bene, che infonde pienezza di gioia, gioia che sovrasta ogni dolcezza. Qui vedrai i beati e gli angeli del Paradiso ed i primi con l’aspetto che prenderanno nel giorno del giudizio universale». Come un lampo improvviso che disperda sin da subito la capacità visiva, privando l’occhio dal cogliere oggetti diventati troppo intensi per lui, così una luce intensa mi circondò col suo splendore e mi lasciò fasciato da talò luminosità da non poter veder nulla. «La carità di Dio, che riempie della sua pace questo cielo, accoglie vsempre in sé chi vi entri con un siffatto saluto, affinché l’anima possa ricevere il suo ardore, come una candela la fiamma». Queste poche parole non mi giunsero più velocemente di quanto io compresi di quanto di sollevarmi al di sopra delle mie capacità, e ripresi a vedere con una più accentuata capacità visiva tale che non vi è luce così fulgenre che i miei occhi non potessero osservare; e vidi una luce riplendente di fulgore che scorreva tra due rive adorne di mirabile fioritura primaverile. Da tale fiume emergevano faville vive che si posavano sui fiori come rubini incastonati nell’oro, poi, come inebriate dal profumo, si rigettavano nel fiume e mentre esse si immergevano altre sgorgavano all’esterno. «Il grande desiderio che ora arde in te e ti stimola, di sapere cos’è ciò che vedi, tanto mi piace quanto più cresce d’intensità; ma è necessario che tu beva quest’acqua, prima che la sete (il tuo desiderio) possa essere saziata», così mi disse la luce degli occhi miei. E quindi aggiunse: «Il fiume e le faville splendenti come pietre preziose che entrano eed escono nell’acqua del fiume, costituiscono velate prefigurazioni del loro autentico essere. Non perchè tali cose siano imperfette, ma per ancora tua incapacità, che non possiedi occhi così potenti». Non vi è bambino che corra velocemente verso la mammella materna se si sveglia un po’ più tardi del solito, di quanto feci io, per rendere i miei occhi più efficaci, chinandomi sull’acqua del fiume che scorre perché ci si renda migliori, e come gli occhi miei bevvero di quell’acqua, mi parve che il fiume da lungo diventasse circolare (allagasse l’intero spazio). Poi come persone sotto la maschera, diverse da come sembrano essere, se si svestono di essa, allo stesso modo i fiori e le faville si trasformarono in uno spettacolo ancora più festante, in quanto eserciti di Dio. Oh, splendore di Dio, grazie al quale potei osservare l’alto trionfo dell’autentico regno, dammi la forza affinché affinché rioesca a descriverlo così come lo vidi! Luce è lassù che rende visibile il Creatore a colui che nel contemplarlo trova il suo appagamento. Questa luce si estende in forma circolare tanto che la siua circonferenza sarebbe troppo grande a contenere il sole. L’insieme di tale luminosità deriva da un unico raggio proveniente da Dio che si riflette sulla superficie esterna del Primo Mobile, ricevendo così la vita e la forza, tali da essere trasmessi ai cieli inferiori. E come un pendio che si riflette in uno specchio d’acqua ai suoi piedi , quasi per compiacersi della sua bellezza quando, in primavera, è verde e ricco di fiori , così allo stesso modo vidi tutte le anime beate, stando sopra tutt’intorno a quella luce, rispecchiarsi in essa disposti in innumerevoli gradini. E se l’ultimo gradino contiene una tale quantità di luce, quanta ne accoglie nei petali più lontani dalla luce, quindi più estesi! La mia capacità visiva non si smarriva per la vastità e la profondità, ma riusciva a cogliere la quantità e la qualità di quella beatitudine. Nell’Empireo il concetto di lontananza e vicinanza non hanno valore, perché dove Dio governa senza altro mezzo, le leggi fisiche non contano. Nel giallo (luogo degli stami e dei pistilli) della candida rosa che si distende progressivamente amplisandosi ed emana un profumo di lode al Signore, come persona che non dice ma desidera, mi condusse Beatrice e disse: «Osserva quanto è numerosa la riunione dei beati! Guarda la nostra città per quanto si estende; osserva i seggi come sono pieni, c he poca gente manca a riempirli. Ed in quel gran seggio su cui hai posto gli occhi, su cui è posta la corona imperiale, prima che tu ti sieda a questo banchetto di felicità eterna (prima della tua morte) si poserà l’anima che sarà nel mondo Augusta (imperiale) del nobile Arrigo, che giungerà in Italia per riportarla sulla retta via, prima di quanto essa sia preparata ad accoglierlo. La sordida avarizia che vi strega vi ha reso simili ad un infante che piuttosto muore di fame, pur di scacciare la balia. E in quel tempo sarà a capo della Chiesa un tale (Clemente V) che apertamente e nascostamente si distaccherà dal suo cammino. Ma Dio lo sopporterà poco a capo della Chiesa, tanto da essere gettato nel profondo là dove paga il suo peccato di simonia Niccolò III, facendo sprofondare più in basso Bonifacio VIII».  Con questo canto Dante entra nel Paradiso vero e proprio, uscendo da quel luogo fisico che ancora il Primo mobile rappresentava. E lo fa attraverso la “difficile” descrizione di ciò che la sua vista può permettergli di ammirare: cioè, per meglio dire, della capacità visiva che, grazie a Dio, fuori da quella umana, consentirà a lui di osservare la “verità” che solo gli angeli e i beati “conoscono perchè la vivono”. Tale facoltà visiva, tuttavia, sembra contrastare con la capacità della parola: tanto aumenta l’una quanto diminuisce l’altra. Infatti dapprima riesce a percepire l’allontanamento degli angeli, lasciando il cielo vuoto, a preparare un nuovo spettacolo; quando si rivolge a Beatrice affinché possa illustrare ciò che accade, la sua bellezza o la sua essenza divina è talmente forte da non poter trovare parole umane che la possano rappresentare; riappare, cioè il topos dell’ineffabile. E questo accade anche quando, dopo un momentaneo accecamento, riacquisendo la facoltà visiva, si trova di fronte ad un lago di luce in cui ciò che era si trasformerà in ciò che sarà per sempre. Infatti Beatrice gli rivelerà che lui sta assistendo a ciò che avverrà il giorno del giudizio universale, quando corpo e anima si riuniranno a cantare le lodi del Signore. Dopo tanta ineffabile poesia, dopo essere stati invasi da immagini che rimandavano alla luce, allo splendore, a raggi riflessi, non poteva mancare un “accenno” a chi parteciperà a tale esplosione di gioia e luce e a chi ne sarà escluso: torna la storia, l’urgenza politica e Clemente V e Arrigo VII riceveranno da Dio pena e gloria, ma nella realtà tale esito non avrà effetti.
Con questo canto Dante entra nel Paradiso vero e proprio, uscendo da quel luogo fisico che ancora il Primo mobile rappresentava. E lo fa attraverso la “difficile” descrizione di ciò che la sua vista può permettergli di ammirare: cioè, per meglio dire, della capacità visiva che, grazie a Dio, fuori da quella umana, consentirà a lui di osservare la “verità” che solo gli angeli e i beati “conoscono perchè la vivono”. Tale facoltà visiva, tuttavia, sembra contrastare con la capacità della parola: tanto aumenta l’una quanto diminuisce l’altra. Infatti dapprima riesce a percepire l’allontanamento degli angeli, lasciando il cielo vuoto, a preparare un nuovo spettacolo; quando si rivolge a Beatrice affinché possa illustrare ciò che accade, la sua bellezza o la sua essenza divina è talmente forte da non poter trovare parole umane che la possano rappresentare; riappare, cioè il topos dell’ineffabile. E questo accade anche quando, dopo un momentaneo accecamento, riacquisendo la facoltà visiva, si trova di fronte ad un lago di luce in cui ciò che era si trasformerà in ciò che sarà per sempre. Infatti Beatrice gli rivelerà che lui sta assistendo a ciò che avverrà il giorno del giudizio universale, quando corpo e anima si riuniranno a cantare le lodi del Signore. Dopo tanta ineffabile poesia, dopo essere stati invasi da immagini che rimandavano alla luce, allo splendore, a raggi riflessi, non poteva mancare un “accenno” a chi parteciperà a tale esplosione di gioia e luce e a chi ne sarà escluso: torna la storia, l’urgenza politica e Clemente V e Arrigo VII riceveranno da Dio pena e gloria, ma nella realtà tale esito non avrà effetti.
 L’assenza improvvisa di Beatrice e al suo posto l’apparizione di un vecchio, non produce su Dante lo sesso effetto che ebbe la scomparsa, anch’essa improvvisa di Virgilio, in quanto essa dà al nostro soltanto una sensazione di vuoto, che si colma subito vedendola divisa da uno spazio inesistente, seduta circondata dal raggio di Dio. Solo ora si innalza una preghiera che sembra portare a compimento ciò che nella Vita nuova “Apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei”. E sembra che la preghiera in suo onore sia la degna chiusura di un rapporto, con un cambio pronominale che la rende più vicina in quanto è proprio grazie a lei che egli ora è giunto da “schiavo” a “libero”. E dopo averlo ringraziato, Beatrice si allontana da lui, rivolgendosi a Dio. Nel volgere lo sguardo verso il Signore, la donna prediletta si allontana definitivamente con un congedo che equivale a un addio.
L’assenza improvvisa di Beatrice e al suo posto l’apparizione di un vecchio, non produce su Dante lo sesso effetto che ebbe la scomparsa, anch’essa improvvisa di Virgilio, in quanto essa dà al nostro soltanto una sensazione di vuoto, che si colma subito vedendola divisa da uno spazio inesistente, seduta circondata dal raggio di Dio. Solo ora si innalza una preghiera che sembra portare a compimento ciò che nella Vita nuova “Apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei”. E sembra che la preghiera in suo onore sia la degna chiusura di un rapporto, con un cambio pronominale che la rende più vicina in quanto è proprio grazie a lei che egli ora è giunto da “schiavo” a “libero”. E dopo averlo ringraziato, Beatrice si allontana da lui, rivolgendosi a Dio. Nel volgere lo sguardo verso il Signore, la donna prediletta si allontana definitivamente con un congedo che equivale a un addio.
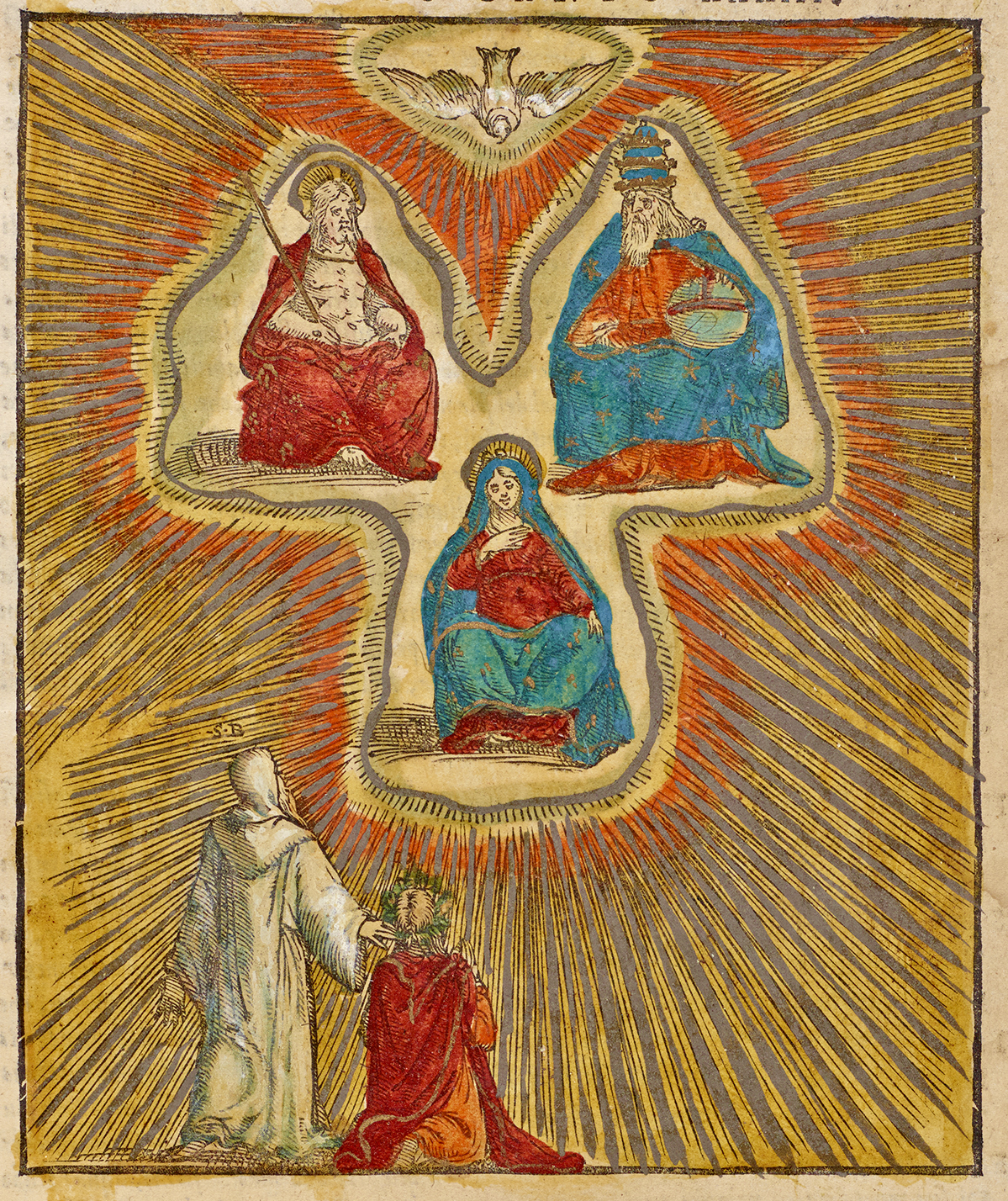

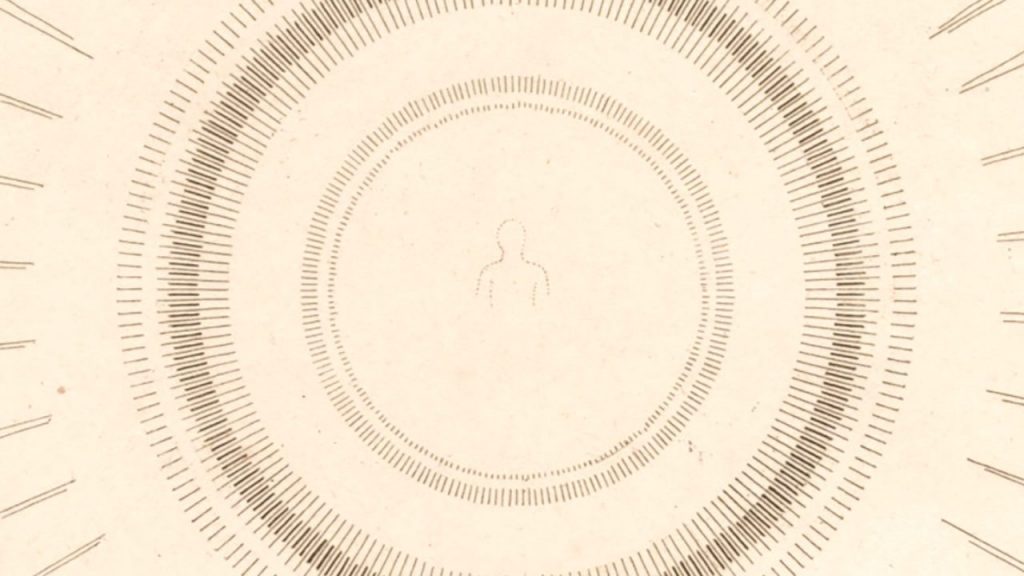
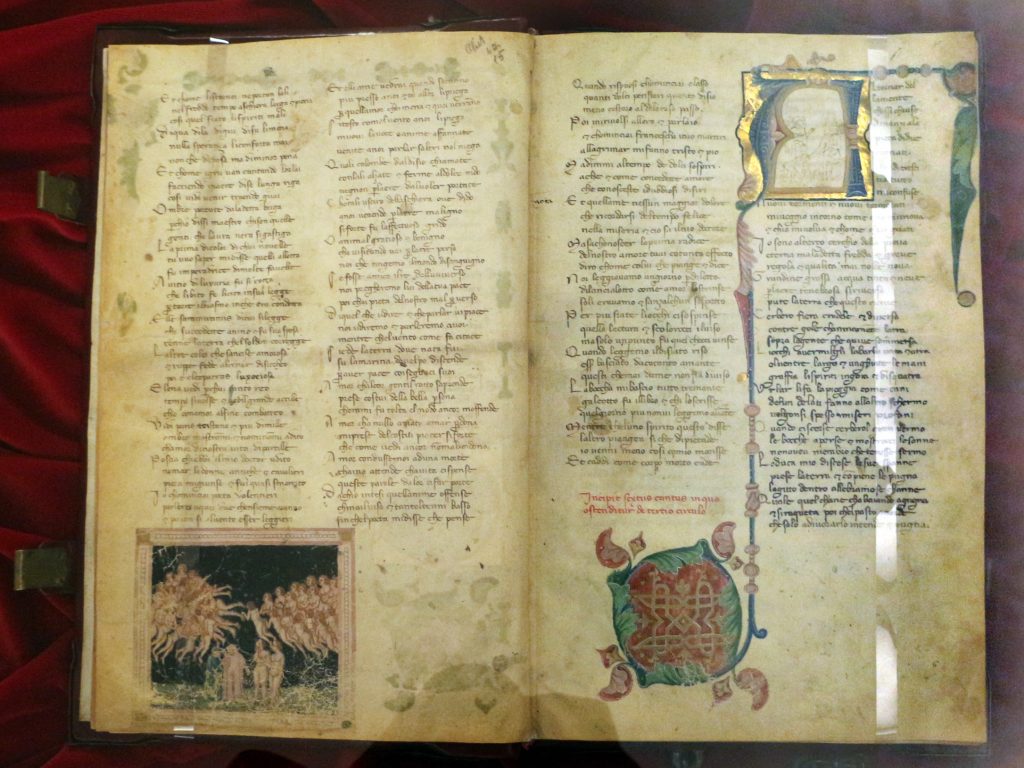 E’ questo non solo il canto con cui si chiude la cantica del Paradiso, ma quello che conclude l’intera Comedìa. Era stato Virgilio a promettere a Dante (altro viaggio, dirà nel I canto infernale) che egli sarebbe stato tra le beati genti, guidato da Beatrice, ma soprattutto come nel II canto sarà la Vergine Maria a sollecitare Beatrice affinchè vada in soccorso a colui che per lei uscì dalla volgare schiera. Ed è proprio dalla Vergine Maria, a cui Bernardo nel canto precedente aveva invitato Dante a rivolgere lo sguardo, che prende avvio il canto, con una preghiera umanissima, in cui si sottolinea la gioia provata da Lei nel beneficare e quindi Le chiede di intercedere affinché il pellegrino possa ora trovare compimento al suo viaggio osservando la Dei imago.
E’ questo non solo il canto con cui si chiude la cantica del Paradiso, ma quello che conclude l’intera Comedìa. Era stato Virgilio a promettere a Dante (altro viaggio, dirà nel I canto infernale) che egli sarebbe stato tra le beati genti, guidato da Beatrice, ma soprattutto come nel II canto sarà la Vergine Maria a sollecitare Beatrice affinchè vada in soccorso a colui che per lei uscì dalla volgare schiera. Ed è proprio dalla Vergine Maria, a cui Bernardo nel canto precedente aveva invitato Dante a rivolgere lo sguardo, che prende avvio il canto, con una preghiera umanissima, in cui si sottolinea la gioia provata da Lei nel beneficare e quindi Le chiede di intercedere affinché il pellegrino possa ora trovare compimento al suo viaggio osservando la Dei imago. 
 Diploma di filiazione alla Carboneria (1820)
Diploma di filiazione alla Carboneria (1820)

 Caspar David Friedrich: Uomo e donna di fronte alla luna (1820)
Caspar David Friedrich: Uomo e donna di fronte alla luna (1820)

 Franz Gareis: Novalis (1799)
Franz Gareis: Novalis (1799)
 Scipione Vannutelli: Maria Stuarda si avvia al patibolo (1861)
Scipione Vannutelli: Maria Stuarda si avvia al patibolo (1861) Autoritratto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Autoritratto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

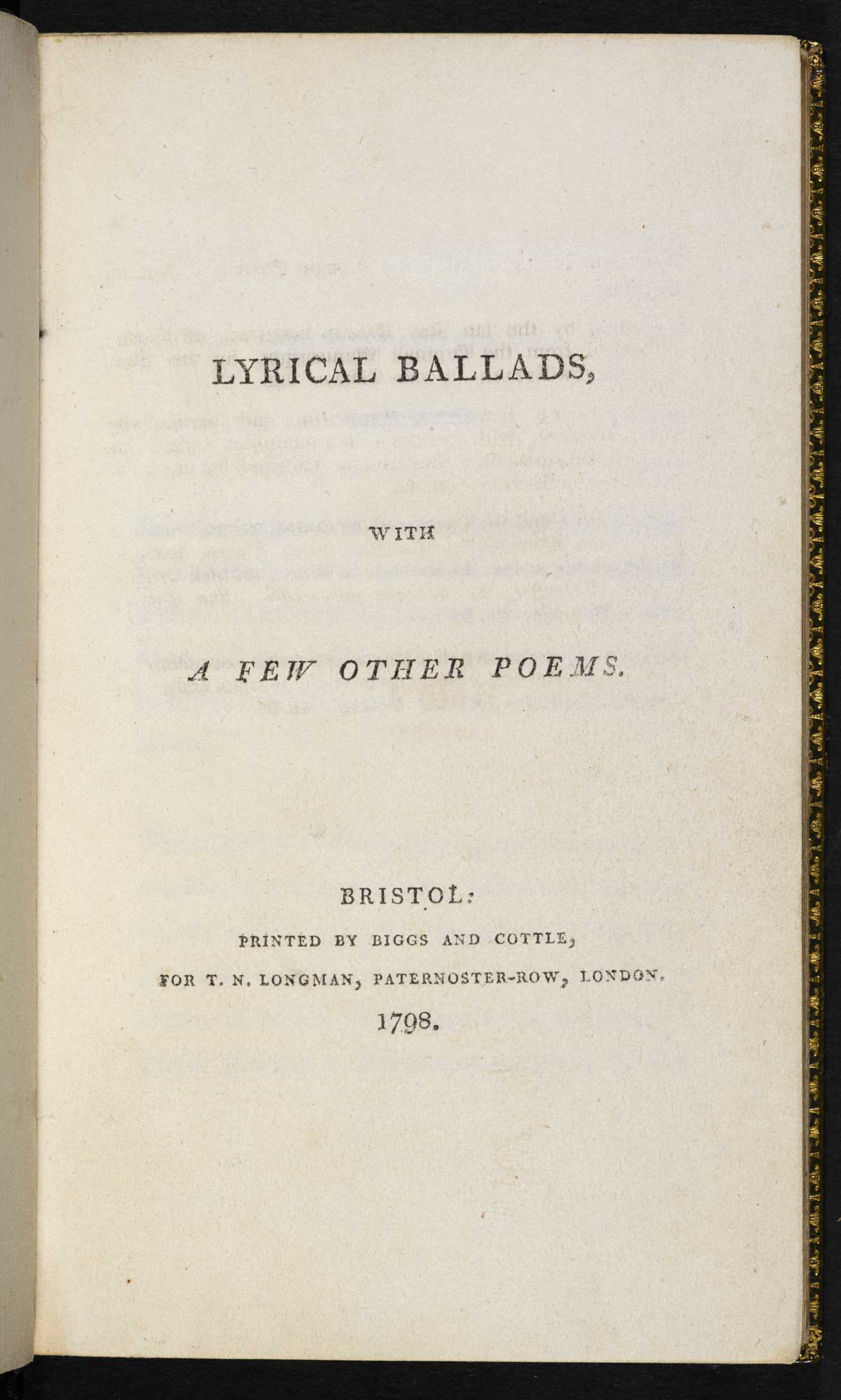






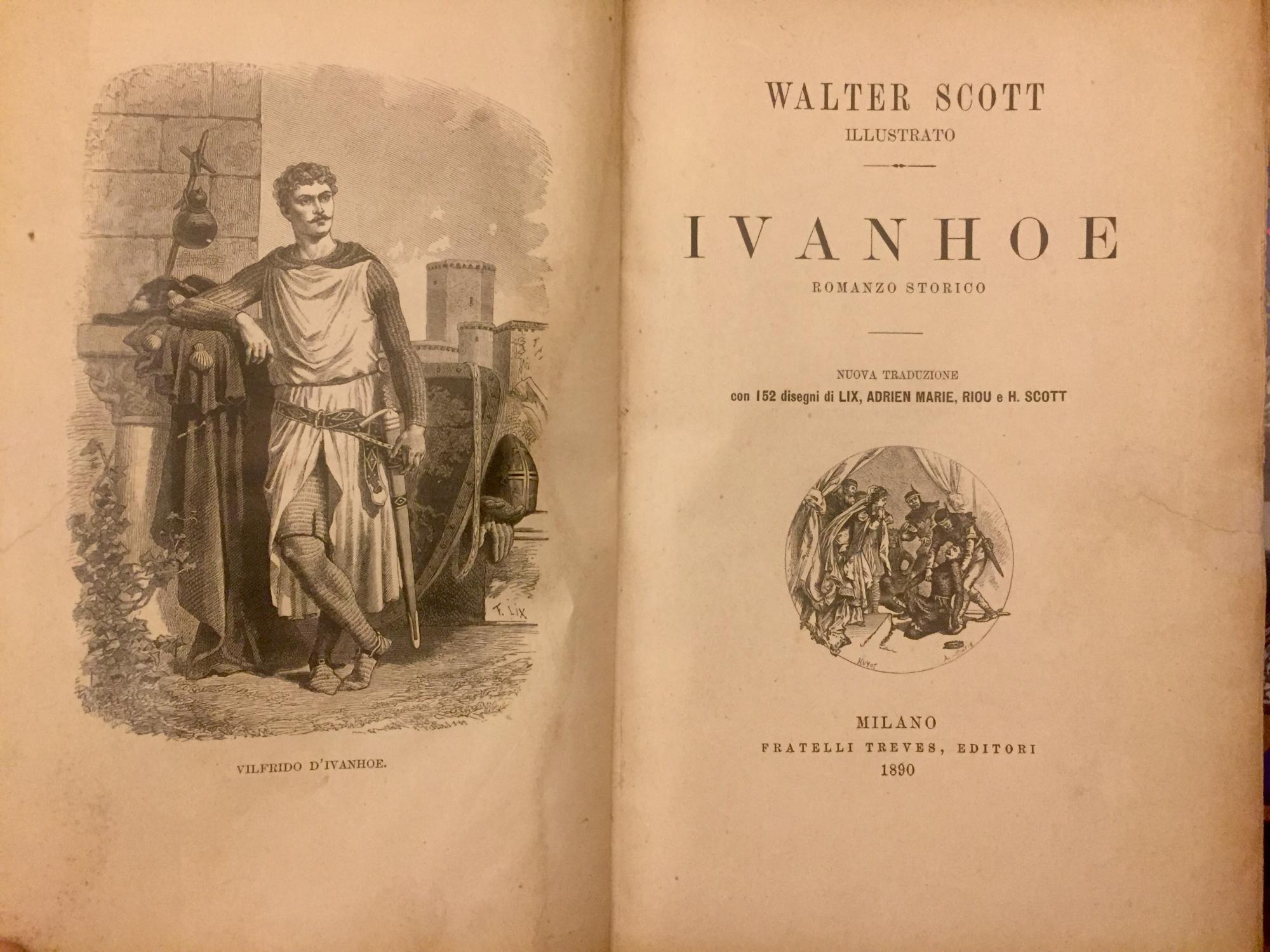



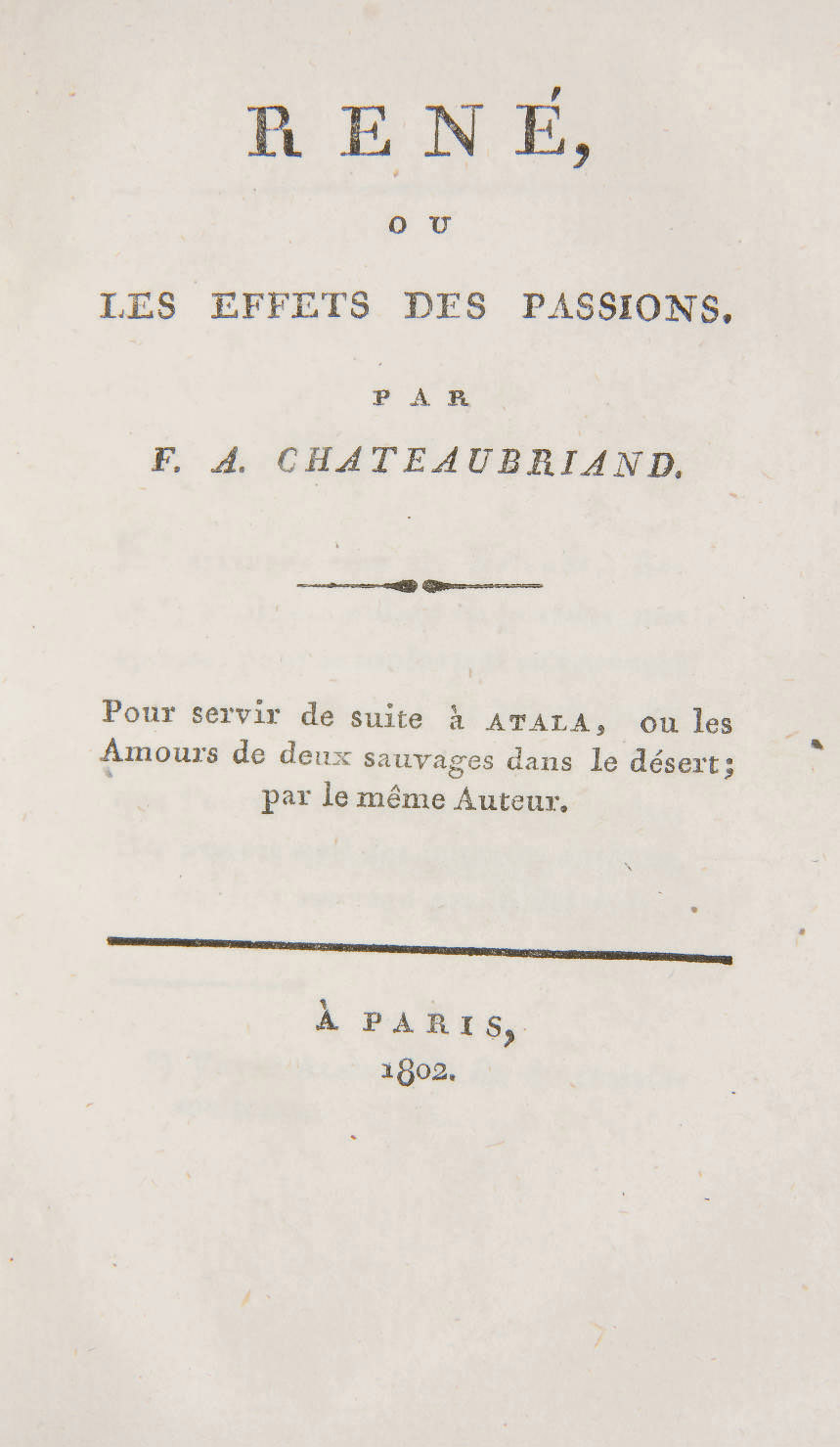
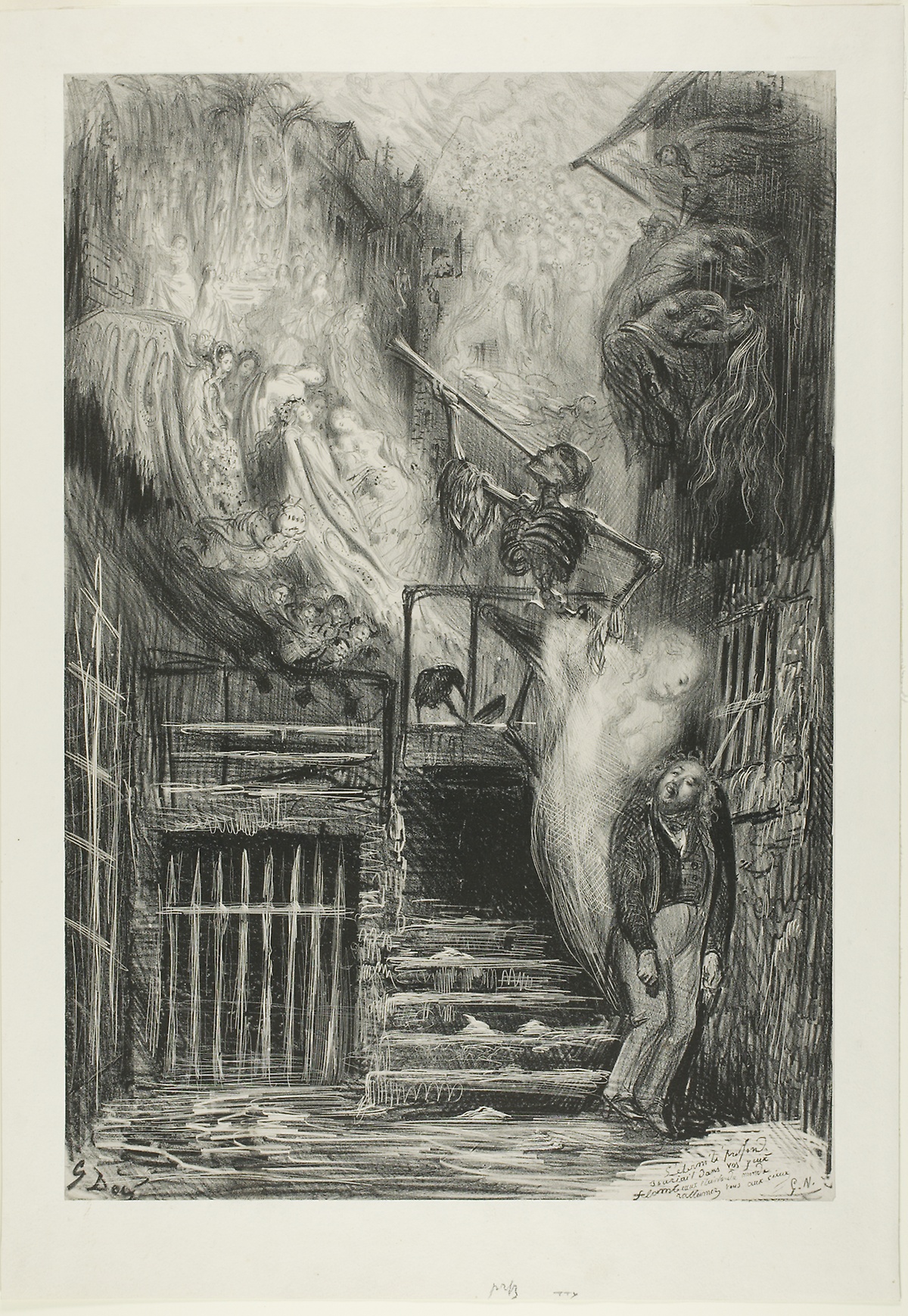

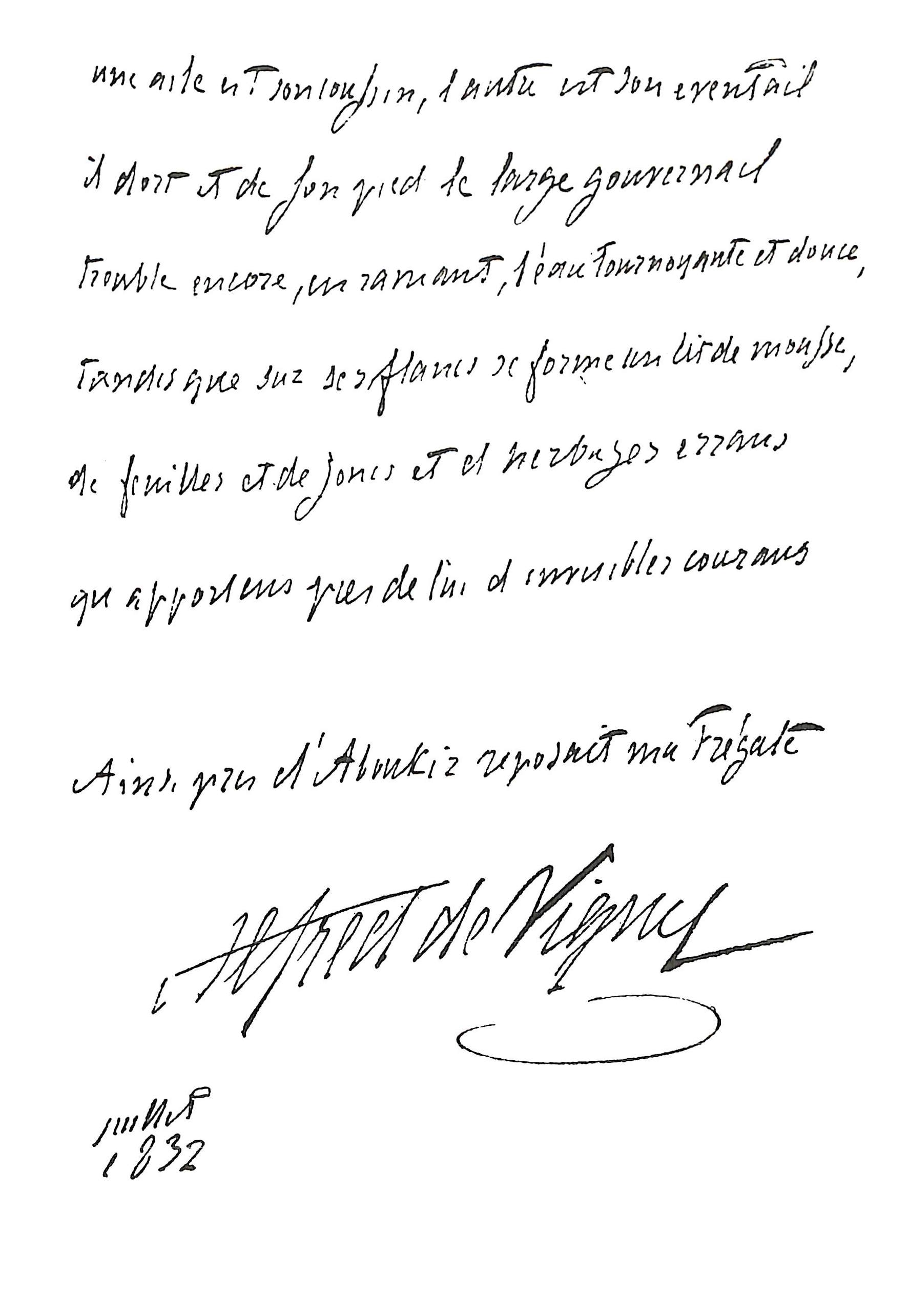

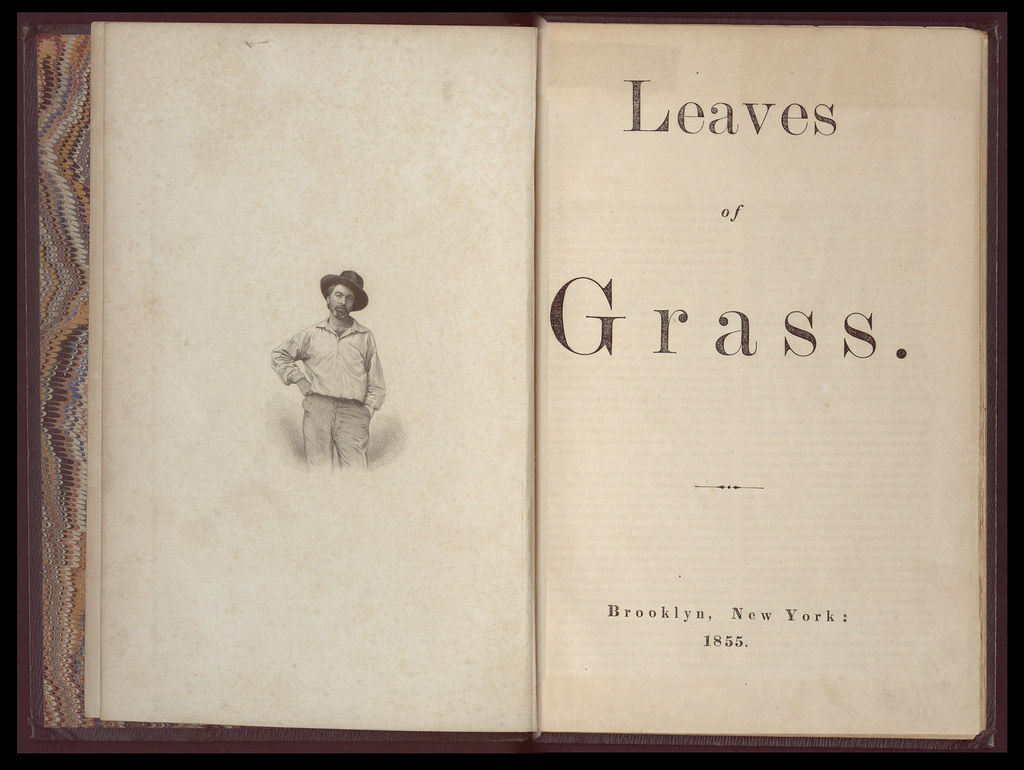


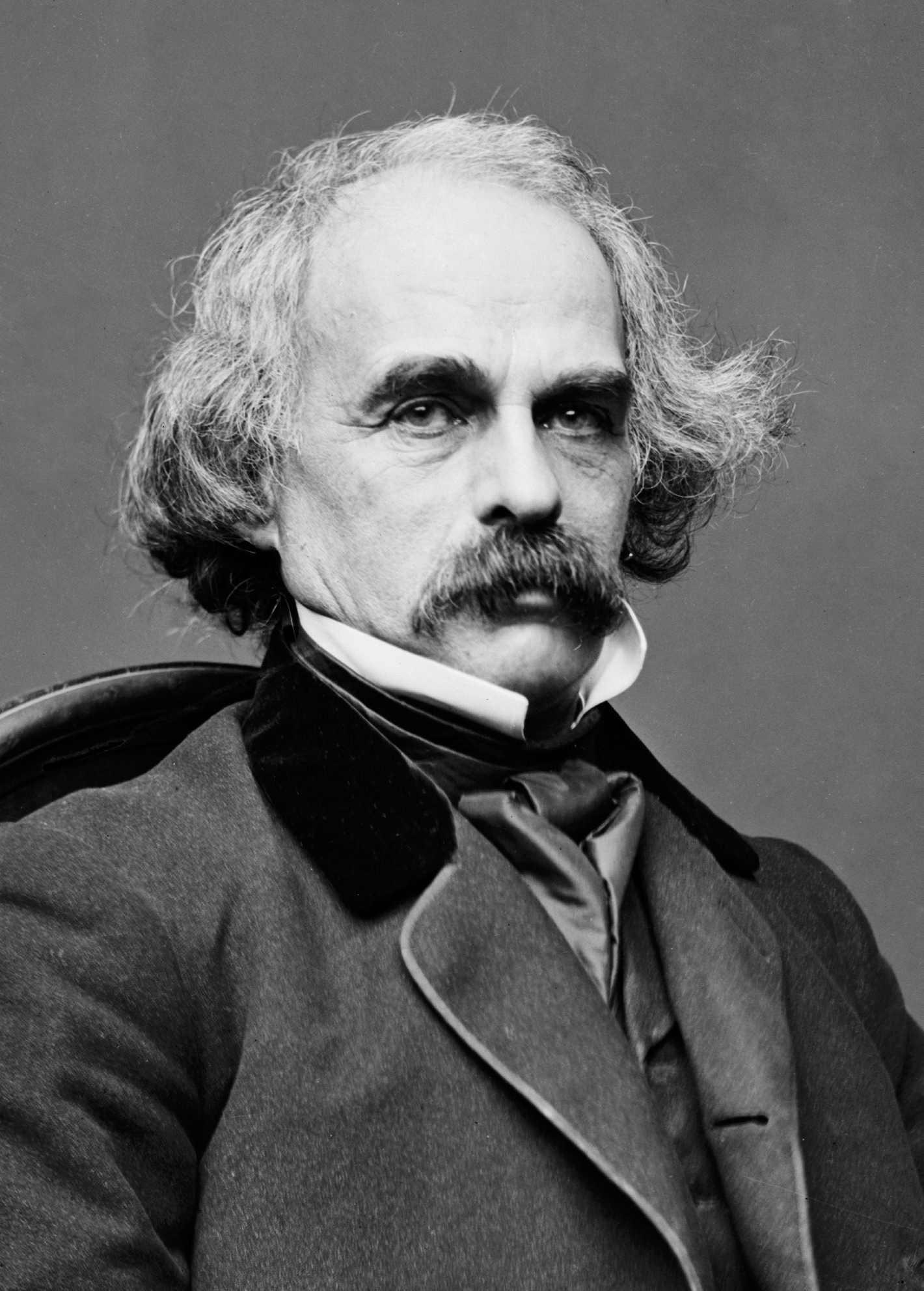






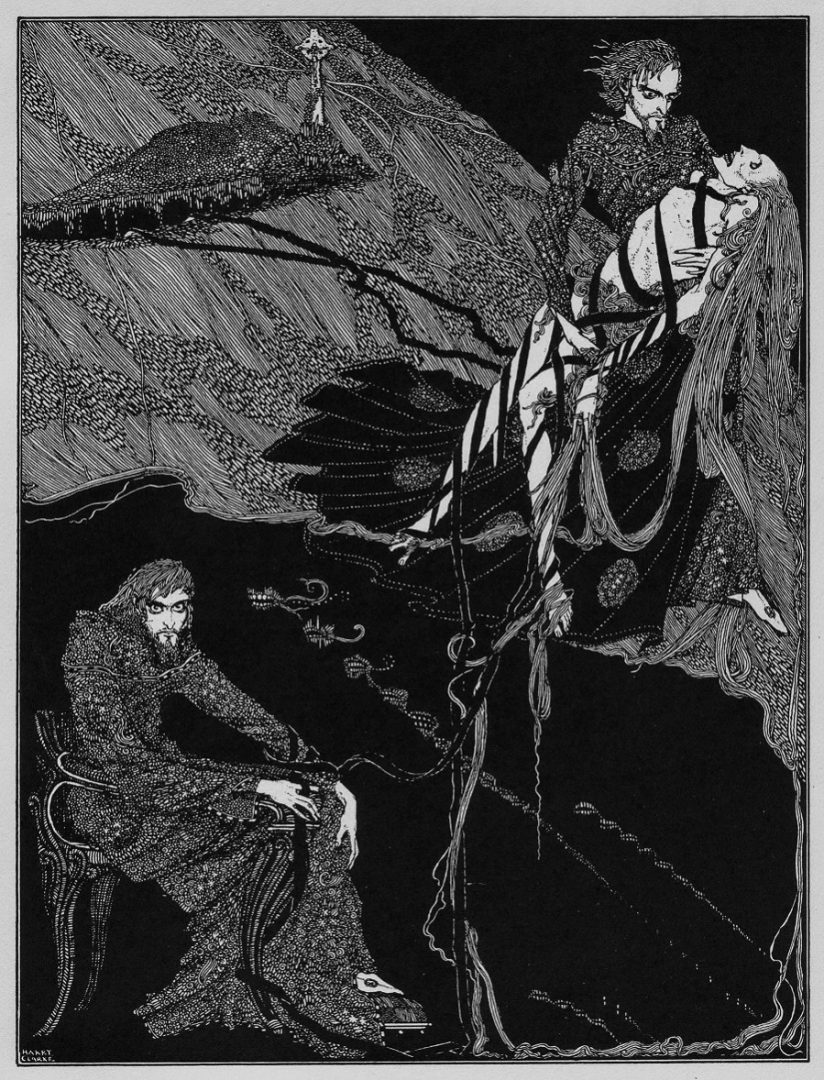

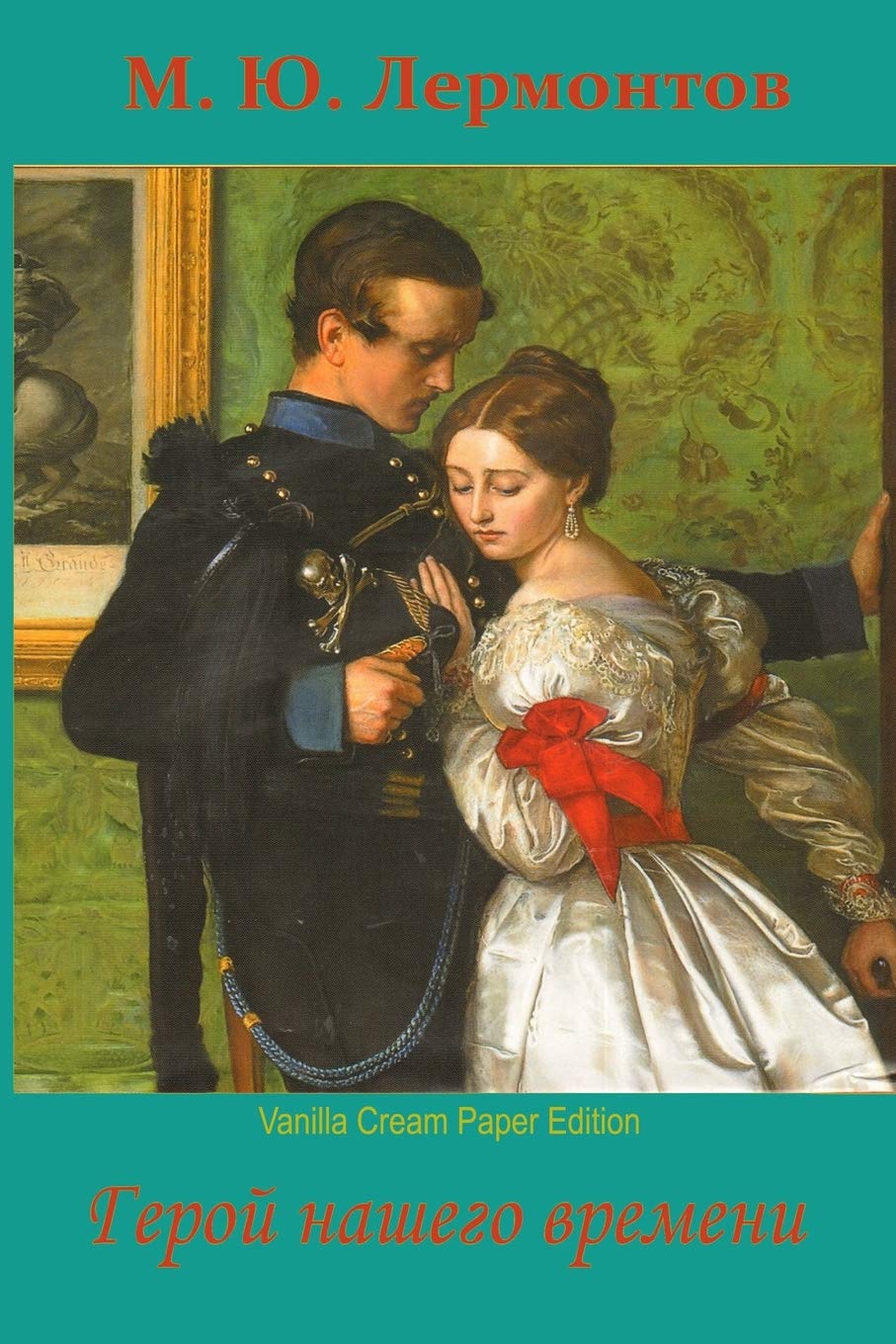


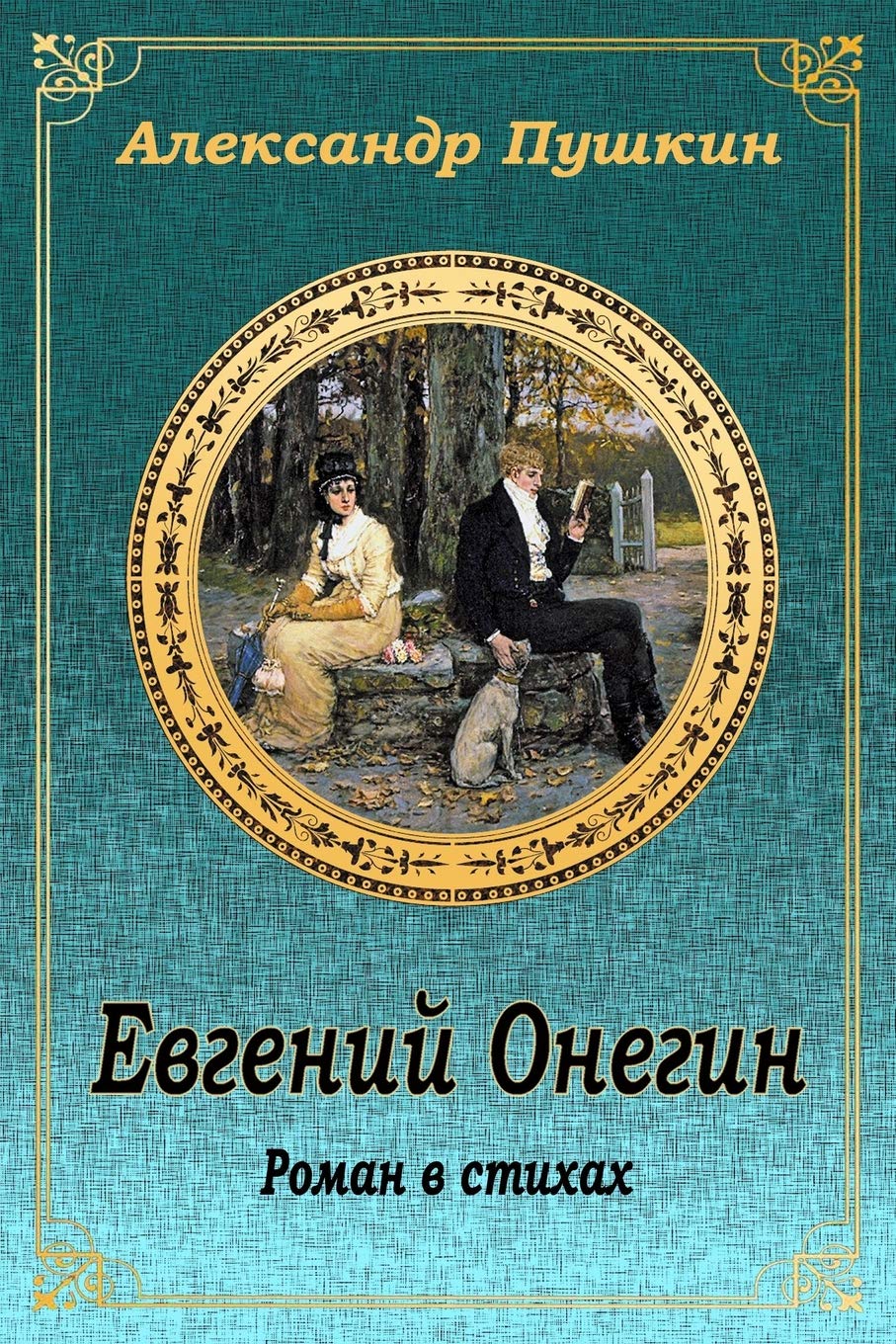

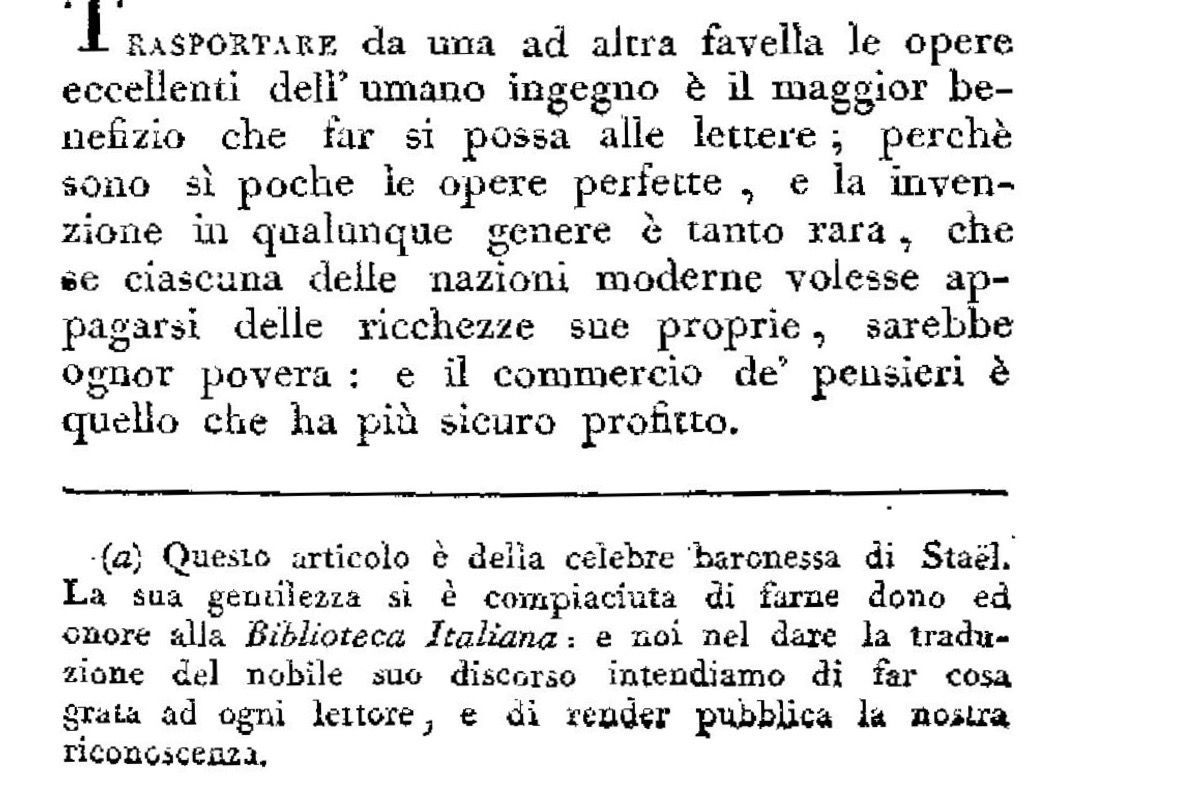



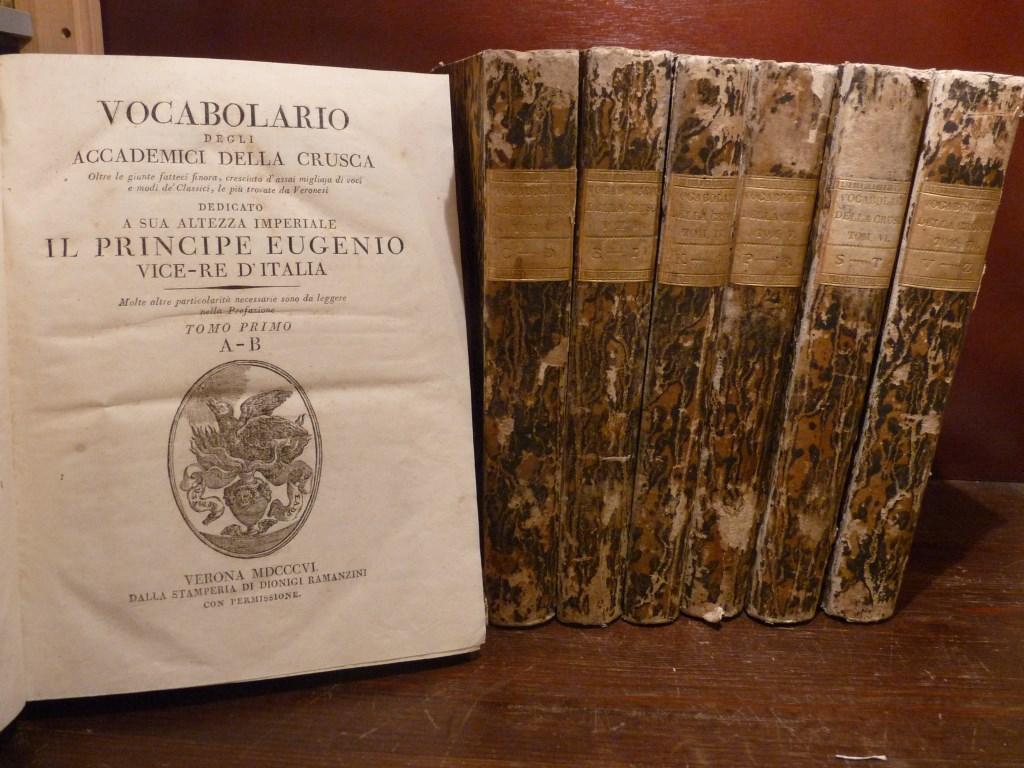
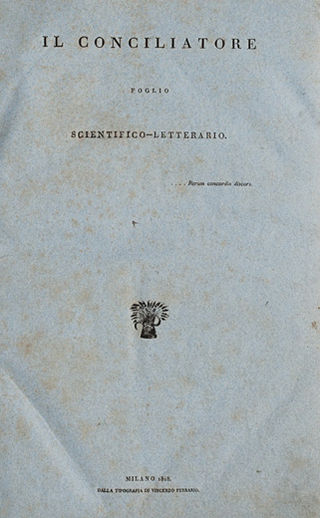


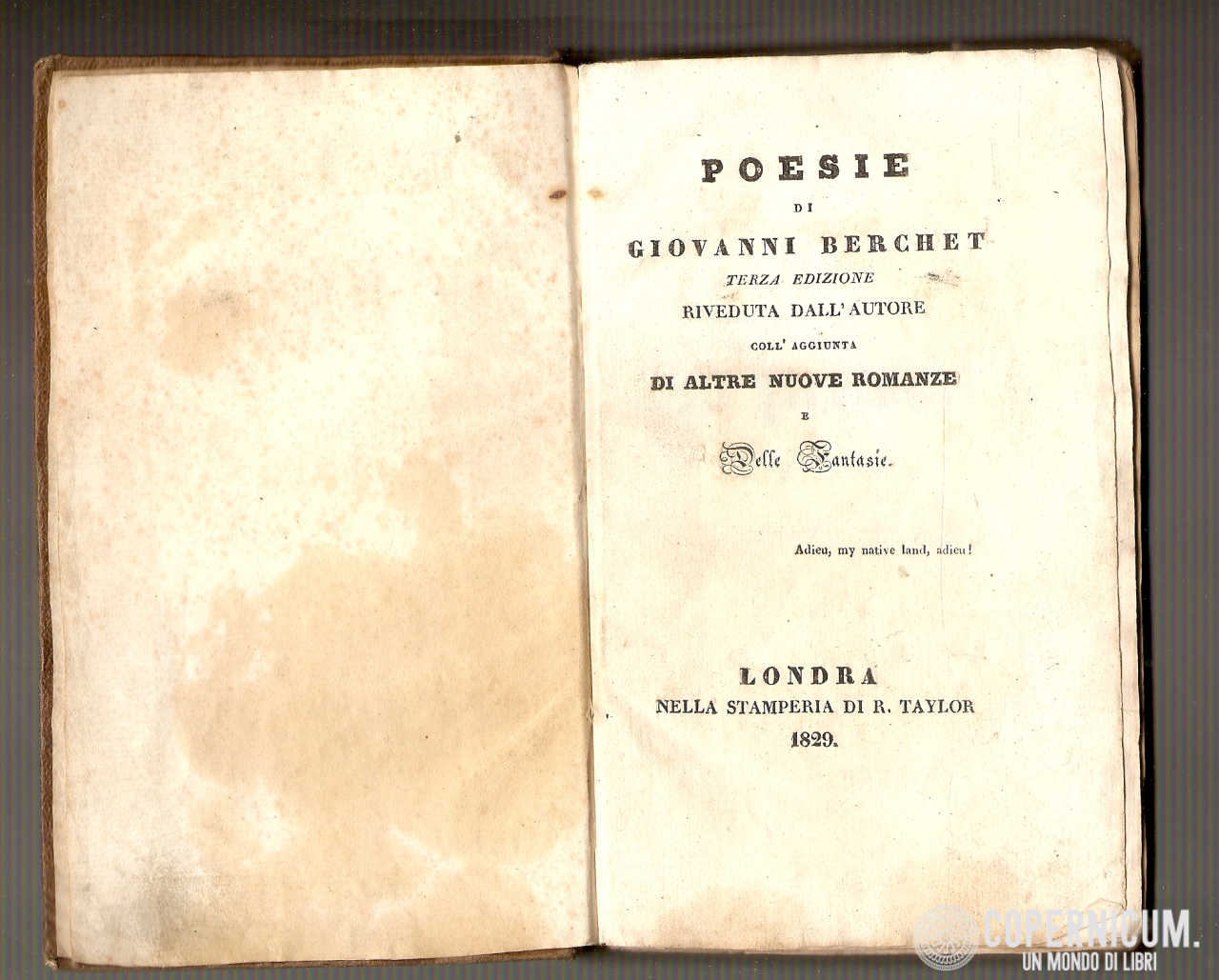





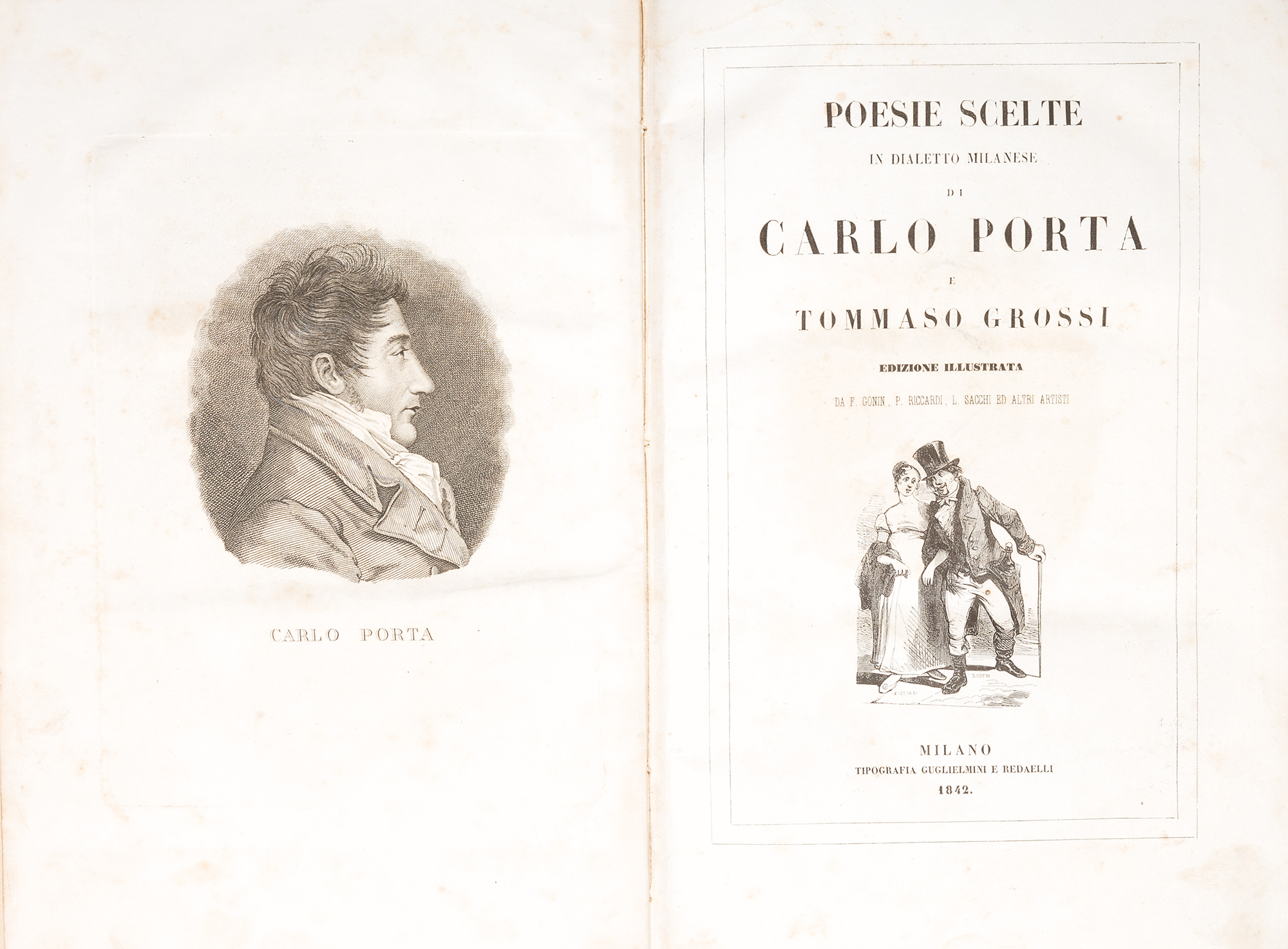









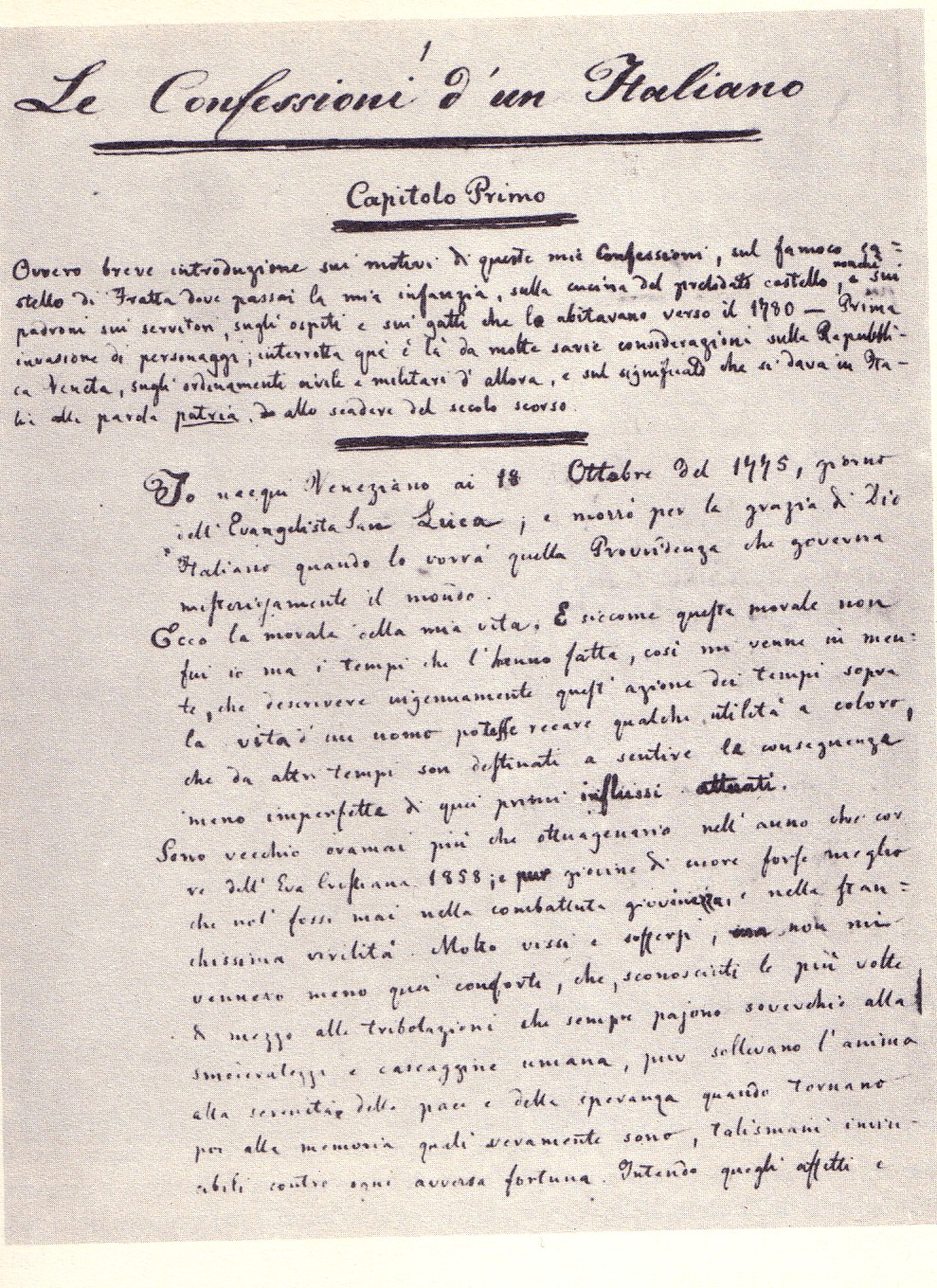
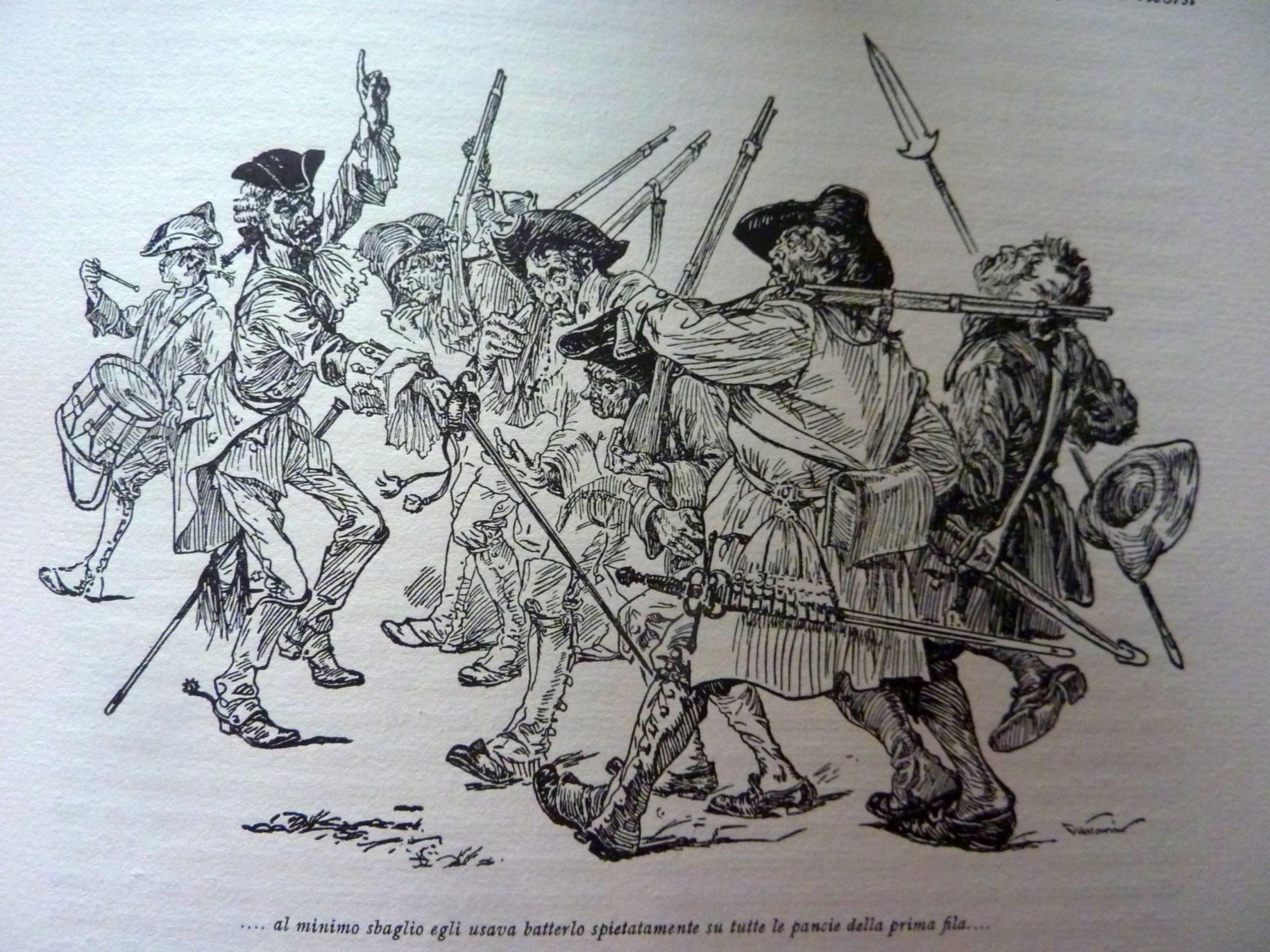

 “In uno stile misurato e dimesso, privo di enfasi e di toni patetici, l’autore offre in questo episodio, uno dei più celebri de Le mie prigioni, un esempio del processo di trasformazione da lui vissuto in carcere. I ruoli sociali separano Pellico dal suo carceriere e, soprattutto, lo sdegno e l’odio, impediscono all’autore di cogliere l’umanità di Shiller. Per questo motivo il centro ideologico dell’episodio, e che vale come chiave di lettura dell’intera opera, consiste nella preghiera con cui Pellico si rivolge a Dio affinché lo liberi dal tormento di odiare il suo prossimo e l’aiuti a scoprire l’altrui umanità.”
“In uno stile misurato e dimesso, privo di enfasi e di toni patetici, l’autore offre in questo episodio, uno dei più celebri de Le mie prigioni, un esempio del processo di trasformazione da lui vissuto in carcere. I ruoli sociali separano Pellico dal suo carceriere e, soprattutto, lo sdegno e l’odio, impediscono all’autore di cogliere l’umanità di Shiller. Per questo motivo il centro ideologico dell’episodio, e che vale come chiave di lettura dell’intera opera, consiste nella preghiera con cui Pellico si rivolge a Dio affinché lo liberi dal tormento di odiare il suo prossimo e l’aiuti a scoprire l’altrui umanità.”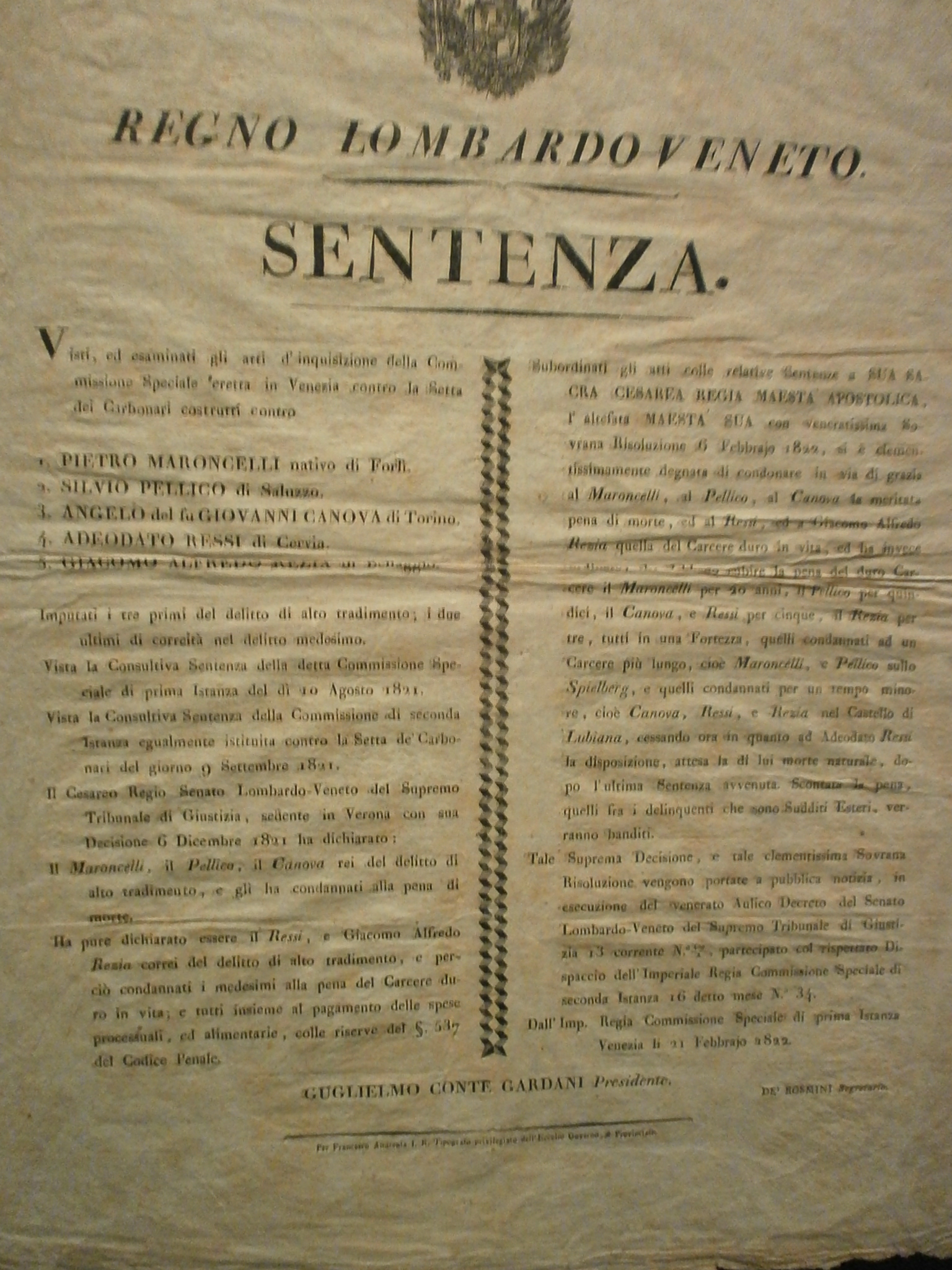

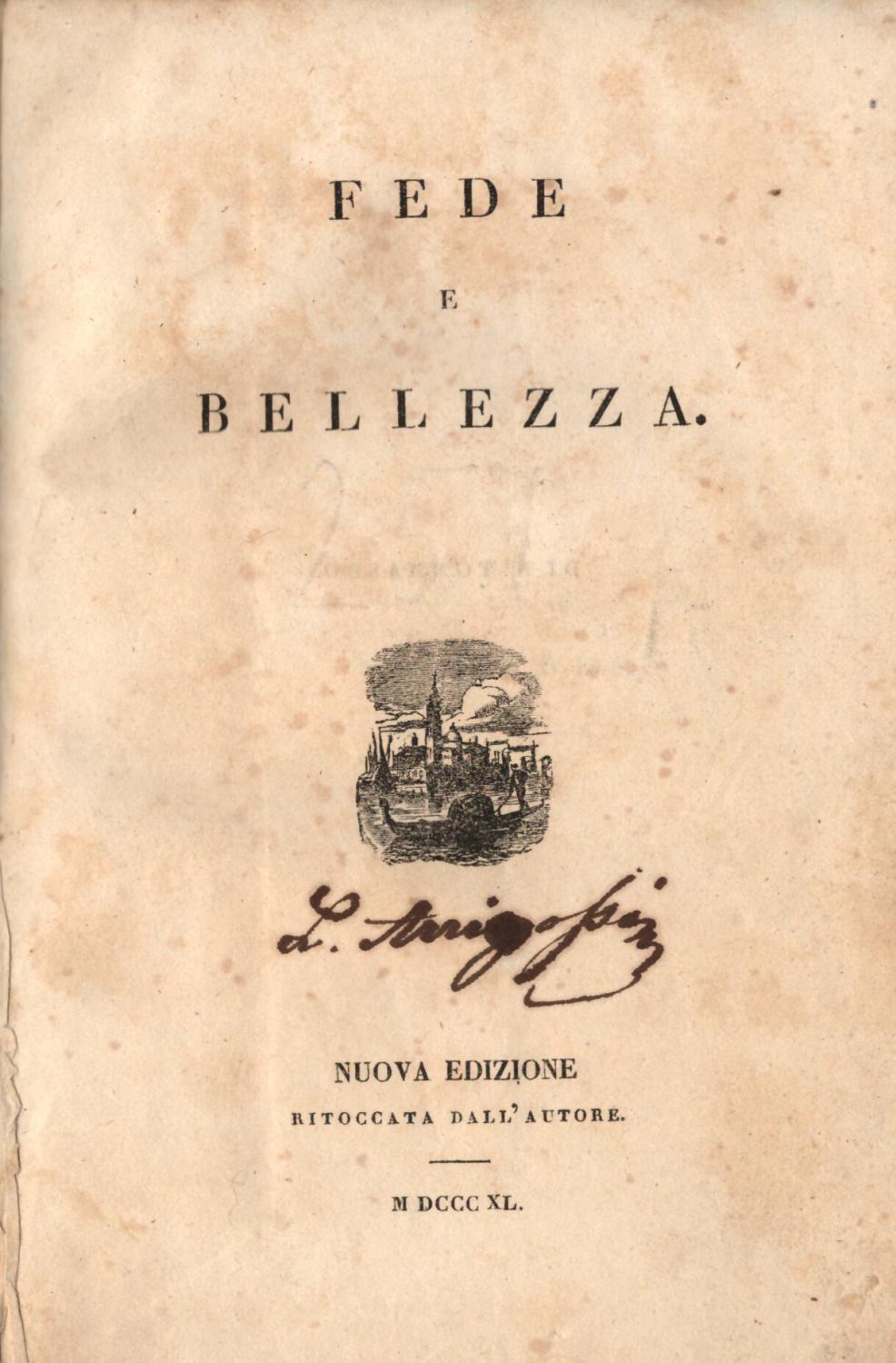
 François-Xavier Fabre: Ritratto di Ugo Foscolo (1807)
François-Xavier Fabre: Ritratto di Ugo Foscolo (1807)
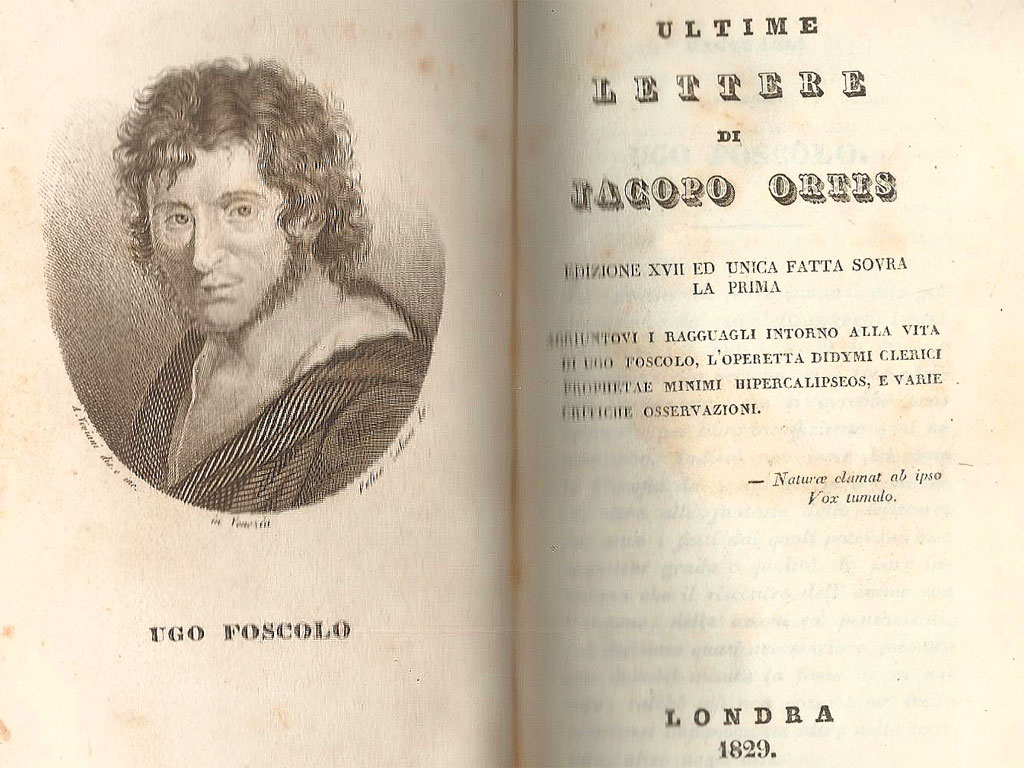















 L’Europa napoleonica
L’Europa napoleonica

 Johann Joachim Winckelmann:
Johann Joachim Winckelmann:














 Alfieri e la contessa d’Albany
Alfieri e la contessa d’Albany