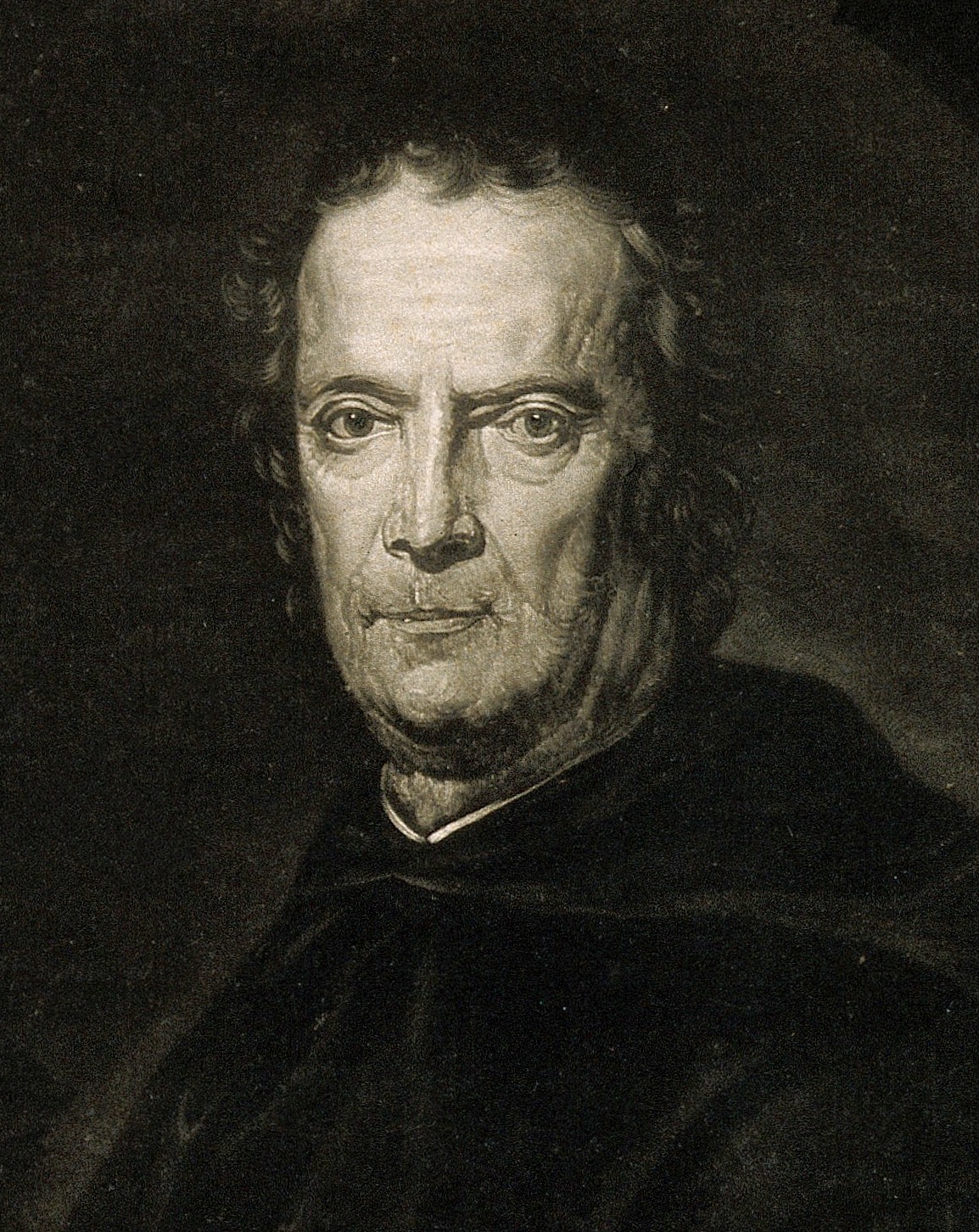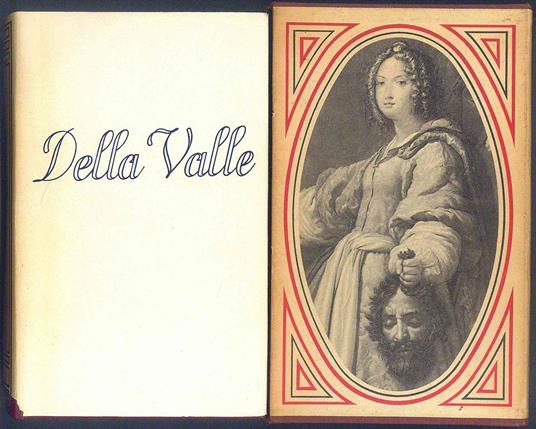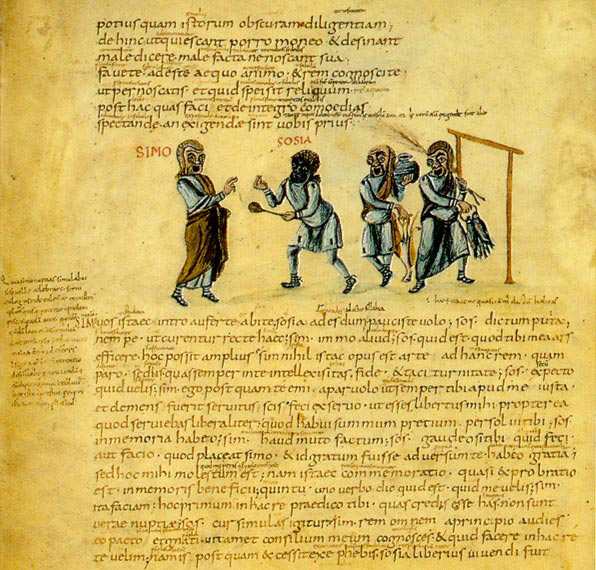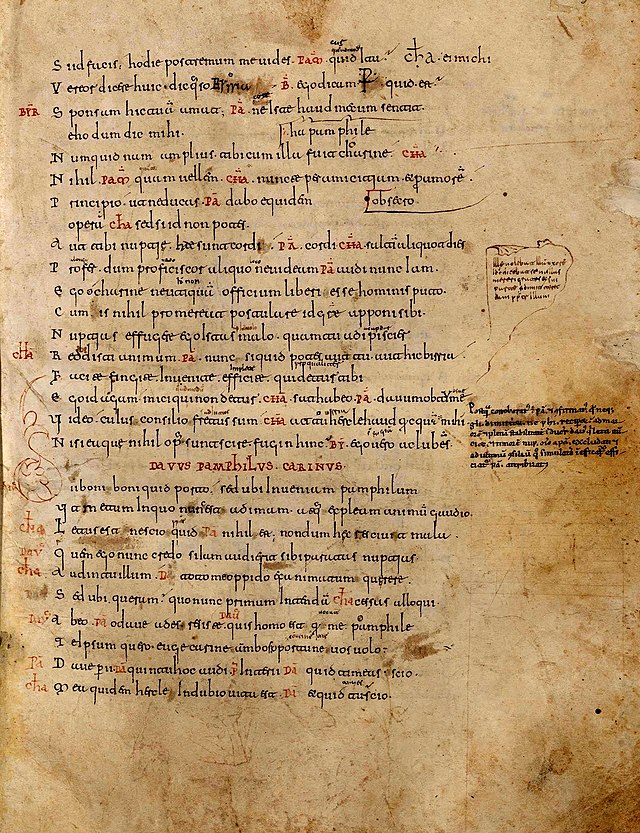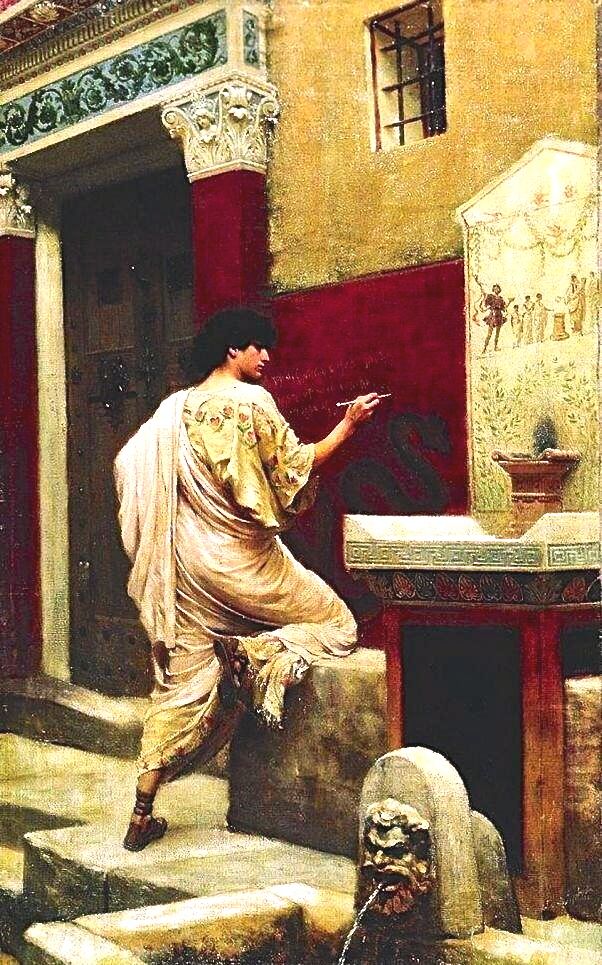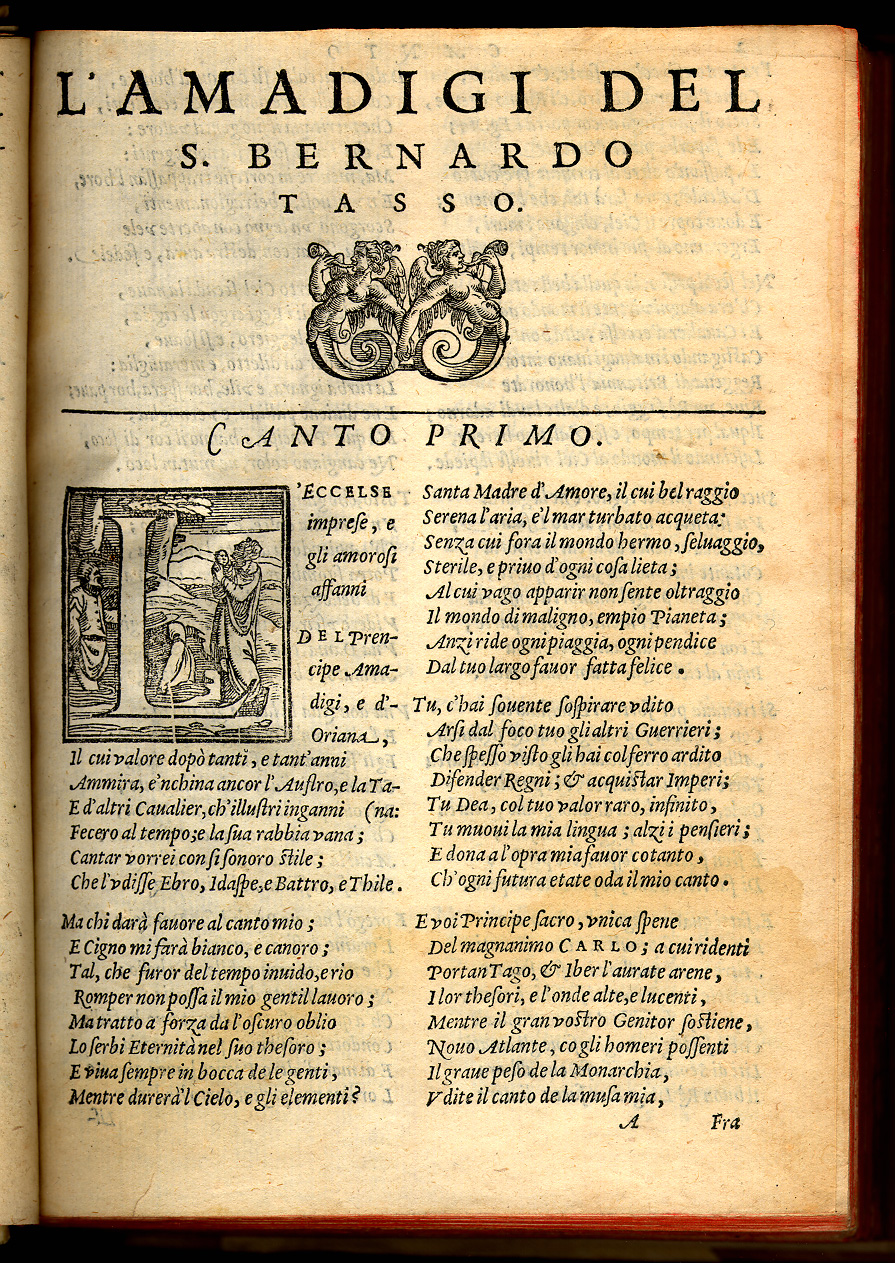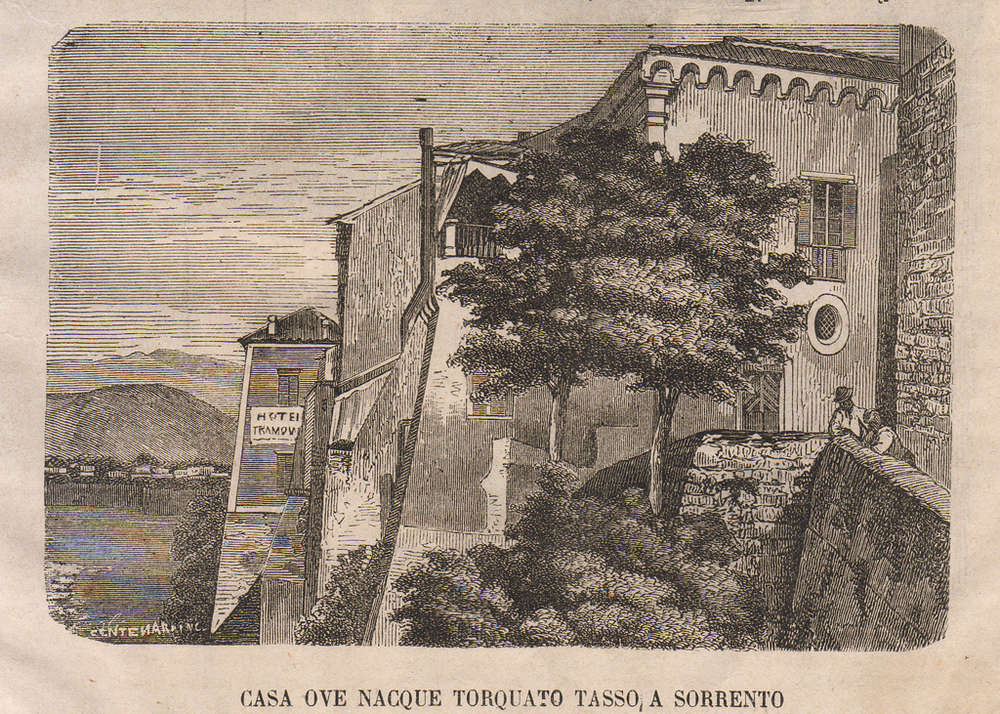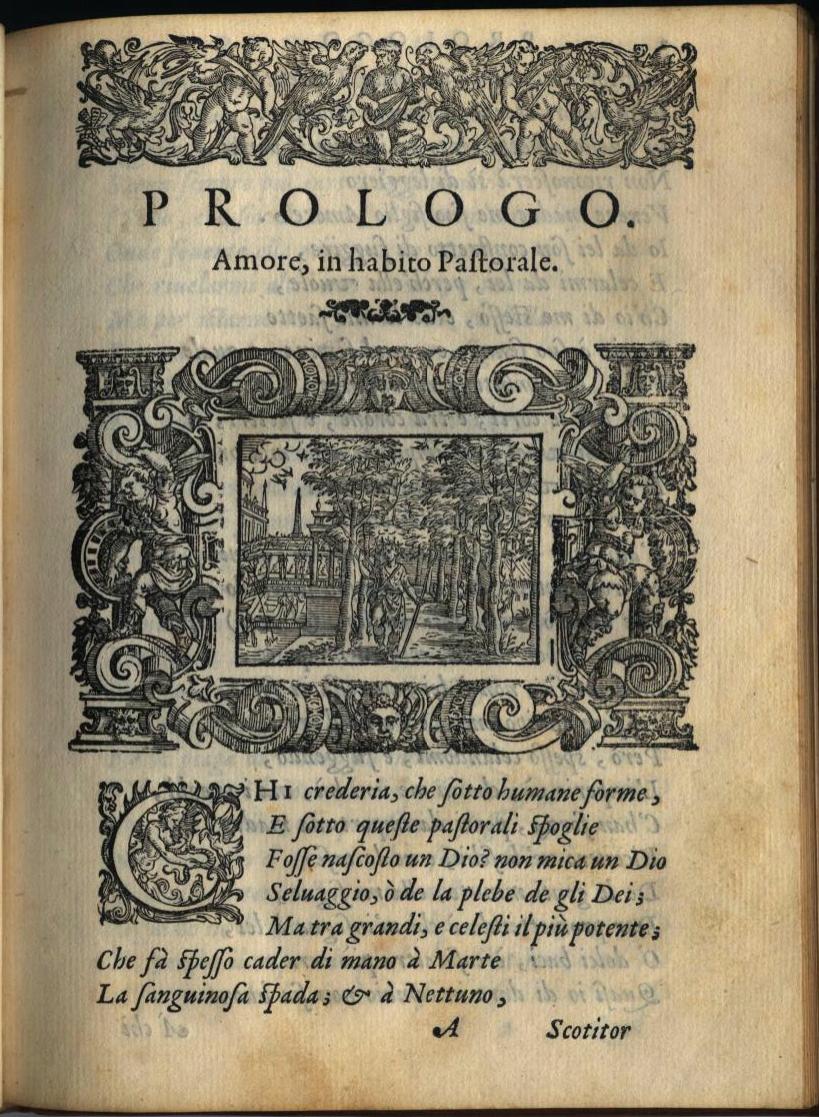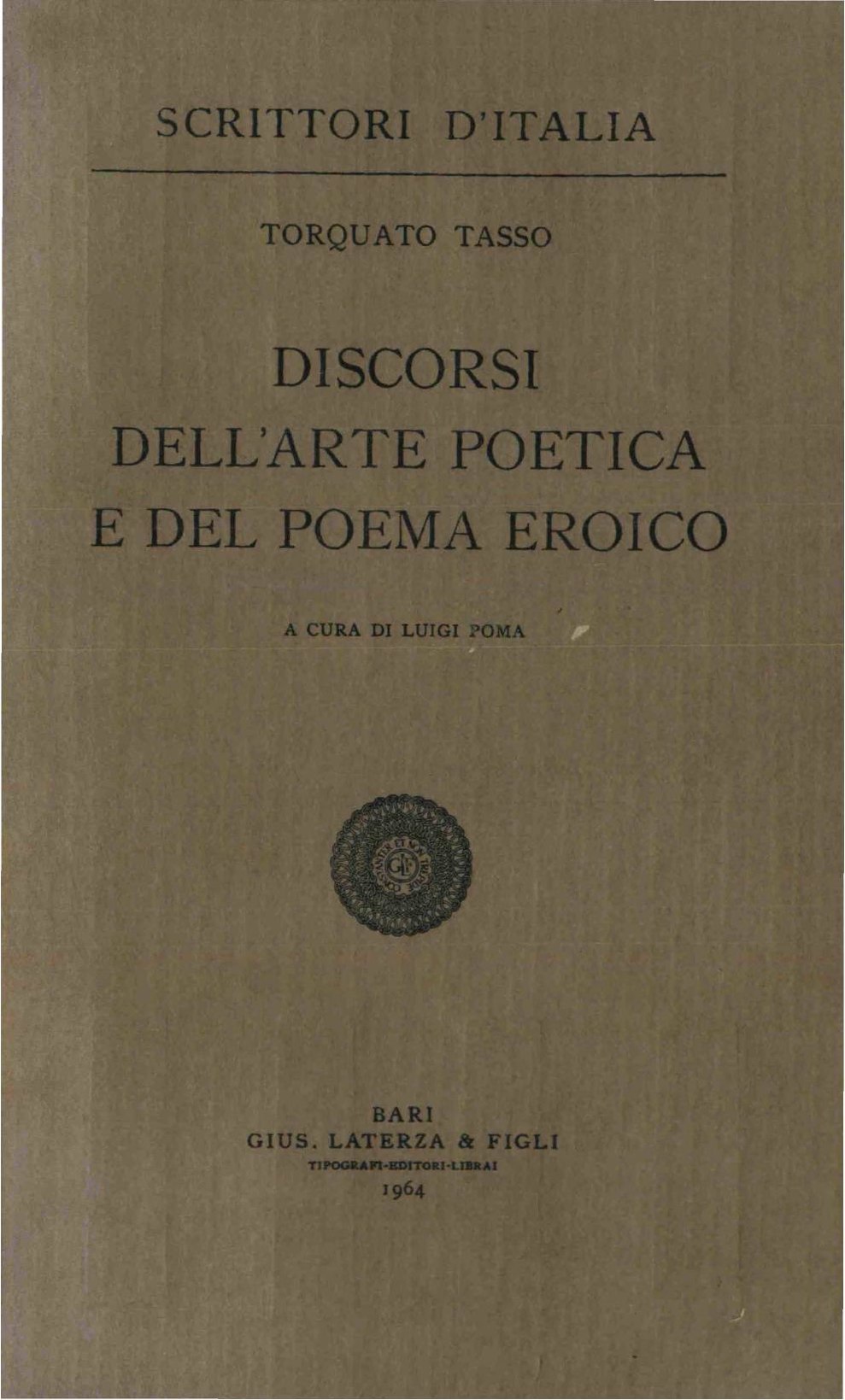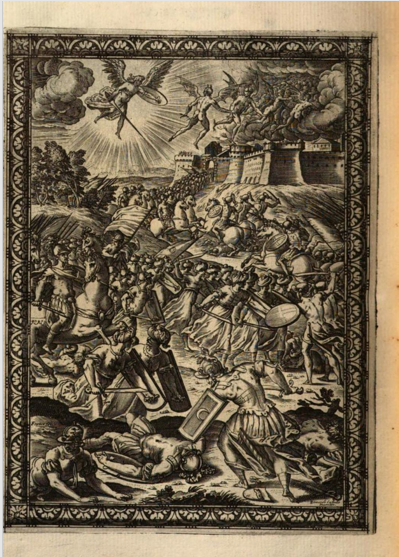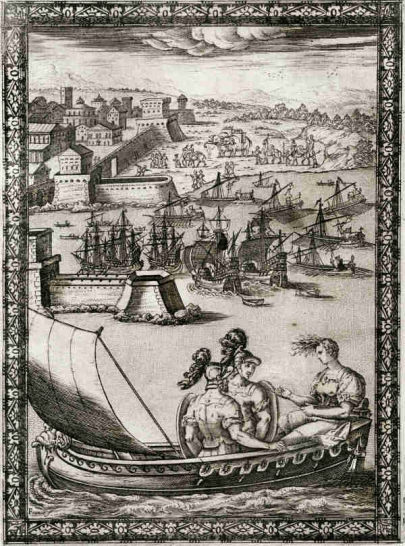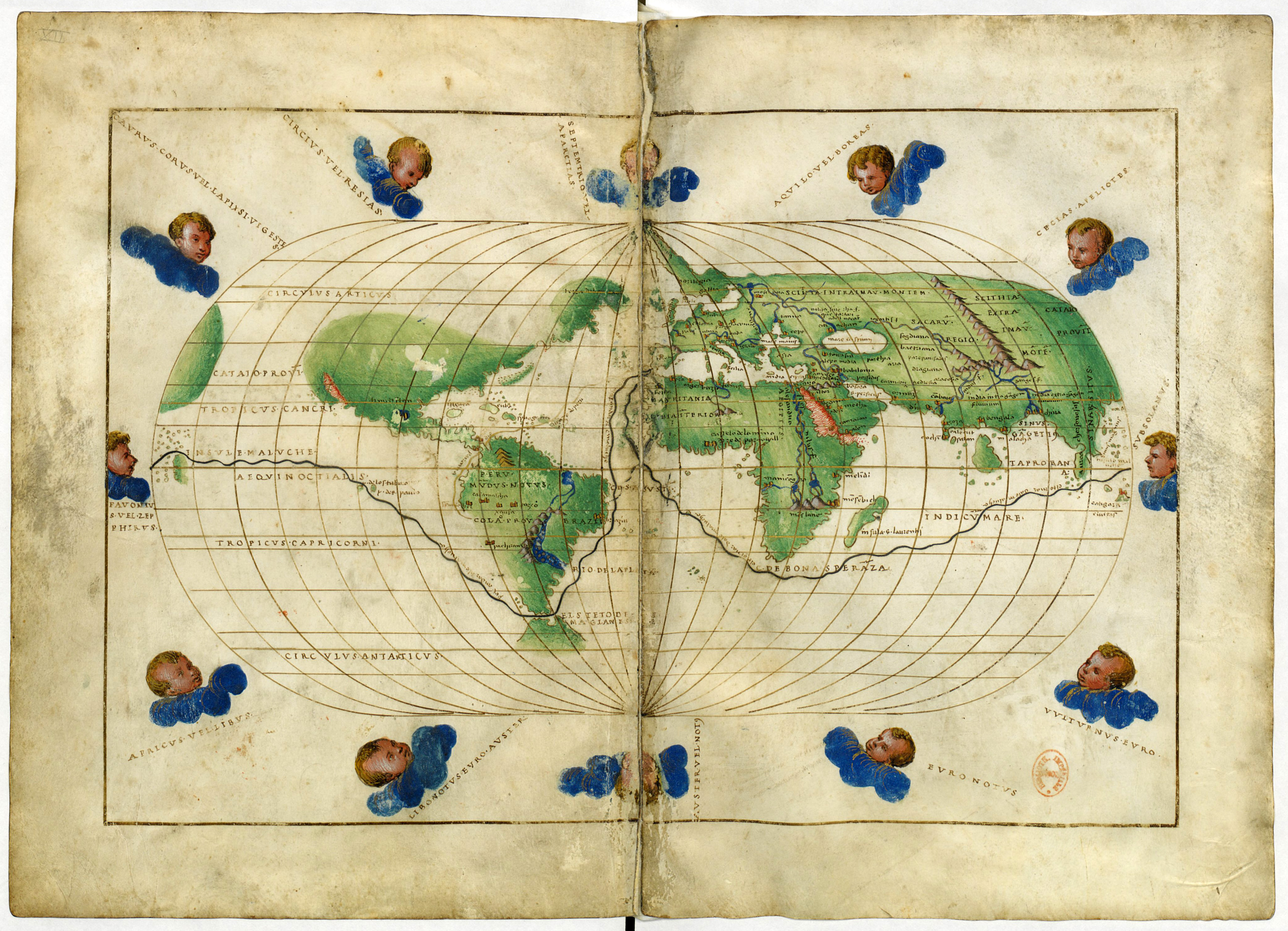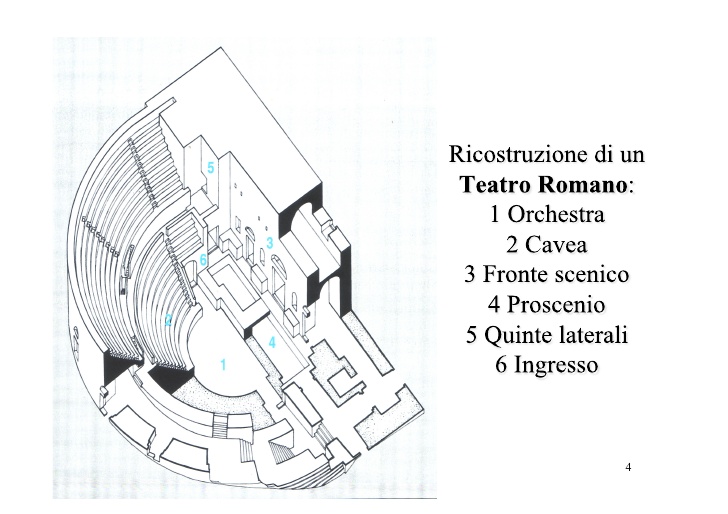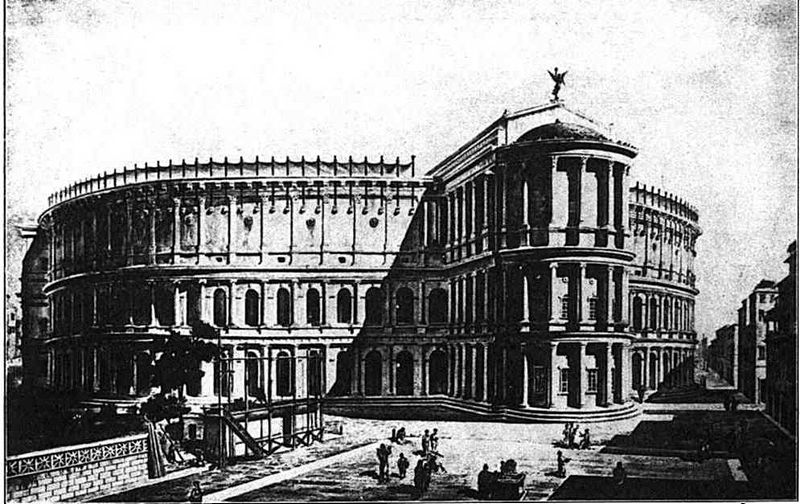Ritratto attribuito a Torquato Tasso
Ritratto attribuito a Torquato Tasso
Torquato Tasso nasce l’11 marzo del 1544 a Sorrento da Bernardo, poeta cortigiano presso il principe Sanseverino nel vicereame di Napoli e da una nobildonna di Pistoia, Porsia de’ Rossi. Al seguito paterno, inizia, da bambino, i primi studi a Napoli; ma, quando il padre dovrà seguire il suo protettore, accusato di tradimento dal viceré, lo seguirà, raggiungendo Roma, e sarà lì, appena dodicenne, che apprenderà la dolorosissima notizia della morte della madre, rimasta a Sorrento con la figlia maggiore, Cornelia, cui era fortemente legato.

Bernardo Tasso
Quando, nel 1556, uno stato di tensione tra il Filippo II e il papa Paolo IV spinge Bernardo ad abbandonare Roma per raggiungere Urbino, il giovane Torquato viene inviato a Bergamo, da dove, in seguito, s’allontanerà per raggiungere il padre. E’ un periodo felice per il giovane Torquato, che in quella piccola città, in quel piccolo microcosmo dei Della Rovere, proietta la “beltà” e “cortesia” della corte. Qui inizia a comporre alcune liriche.
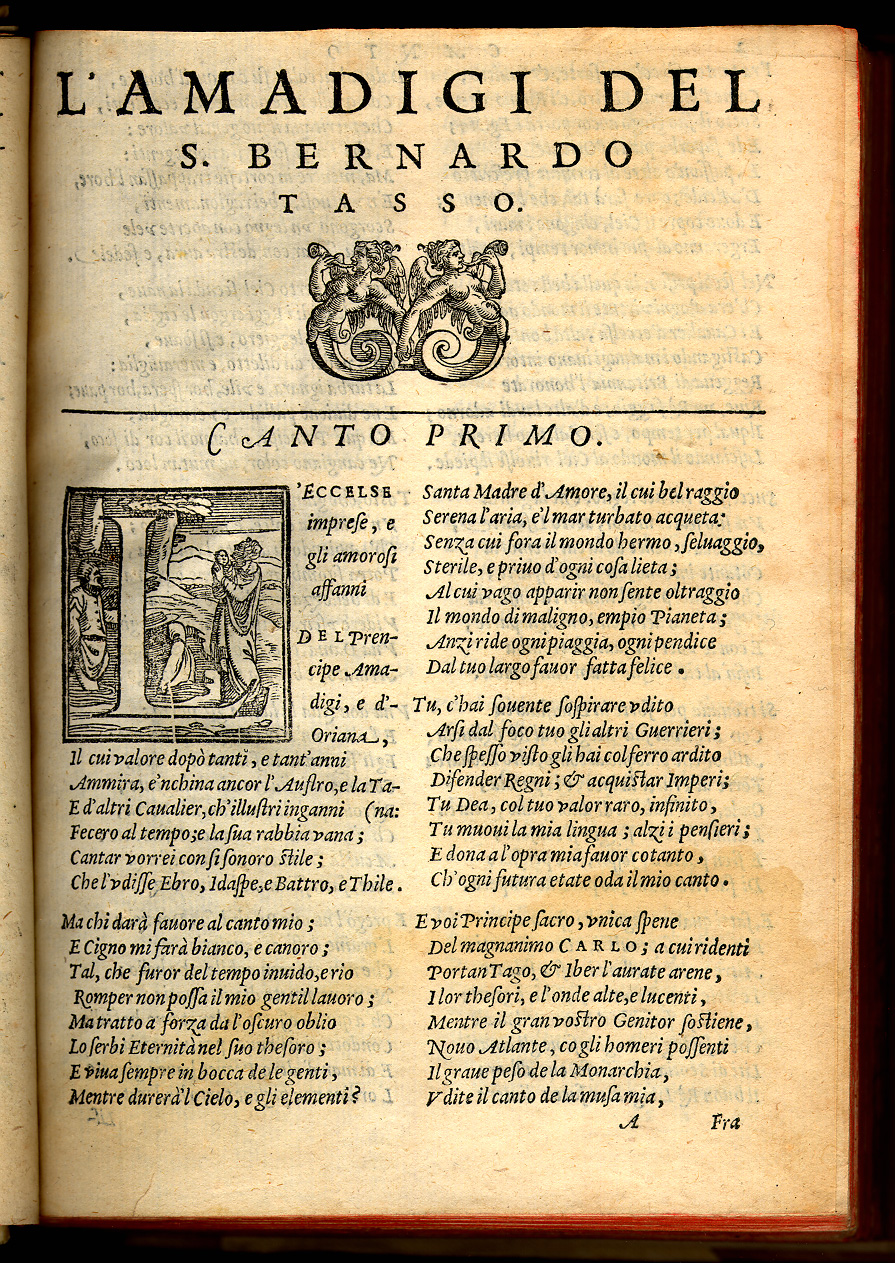
Edizione pubblicata a Venezia nel 1581 del’Amadigi di Bernardo Tasso
Nel 1559 il padre si trasferisce a Venezia per stampare la sua opera l’Amadigi; qui il figlio lo raggiungerà e seguirà, per volere paterno, studi di diritto. Il giovane Tasso stringe amicizia con letterati e pubblica anche un consistente nucleo di sue prove poetiche. Quindi dà vita ad un abbozzo di poema epico, il Gierusalemme. e il poema cavalleresco Rinaldo che pubblica nella città lagunare nel 1562.
Da Venezia si sposta a Bologna, in compagnia di un caro amico, dove inizia a lavorare a opere dal carattere normativo, tra cui gli importantissimi Discorsi dell’arte poetica. Quindi pubblica, per nobildonne, appassionate ed eleganti poesie.

Edizione veneziana del Rinaldo del Tasso 1840
Nel 1565 si trova a Ferrara, guidata in questo periodo da Alfonso II. Dopo quattro anni gli muore l’amato padre. L’ambiente cortigiano dà una certa tranquillità al nostro, che potrà redigere il dramma pastorale Aminta rappresentato con successo a corte. Intanto riprende il lavoro sulla Gierusalemme che conclude nel 1575. Non sicuro del valore dell’opera la sottopone ad alcuni revisori, che non gli lesinano anche severe critiche. Il Tasso comincerà così anche a dubitare che l’opera non sia, a livello d’ortodossia, corretta. Nel 1576, tornato a Ferrara, Tasso comincia a mostrare i primi segni d’inquietudine psichica. La prima crisi si ha quando, pensando che volesse lasciare Ferrara per Firenze, il duca gli mette alcuni “controllori” alle spalle. Temendo che lo vogliano accusare d’eresia, si sottopone, volontariamente, al tribunale dell’Inquisizione.
L’anno successivo, mentre parla con cortesia con la duchessa, temendo d’essere spiato da un servo, lo aggredisce con un coltello. Il poeta, creduto che fosse preda di una crisi di nervi, viene curato: ma lui pensa che lo vogliano avvelenare. Viene rinchiuso in un convento; da qui scappa e raggiunge a Sorrento la sorella Cornelia. Per sapere se ella provi un vero e proprio affetto per lui, finge di essere un pastore, che reca la notizia della morte di Torquato. Solo dopo il reale dispiacere della sorella, si rivelerà.
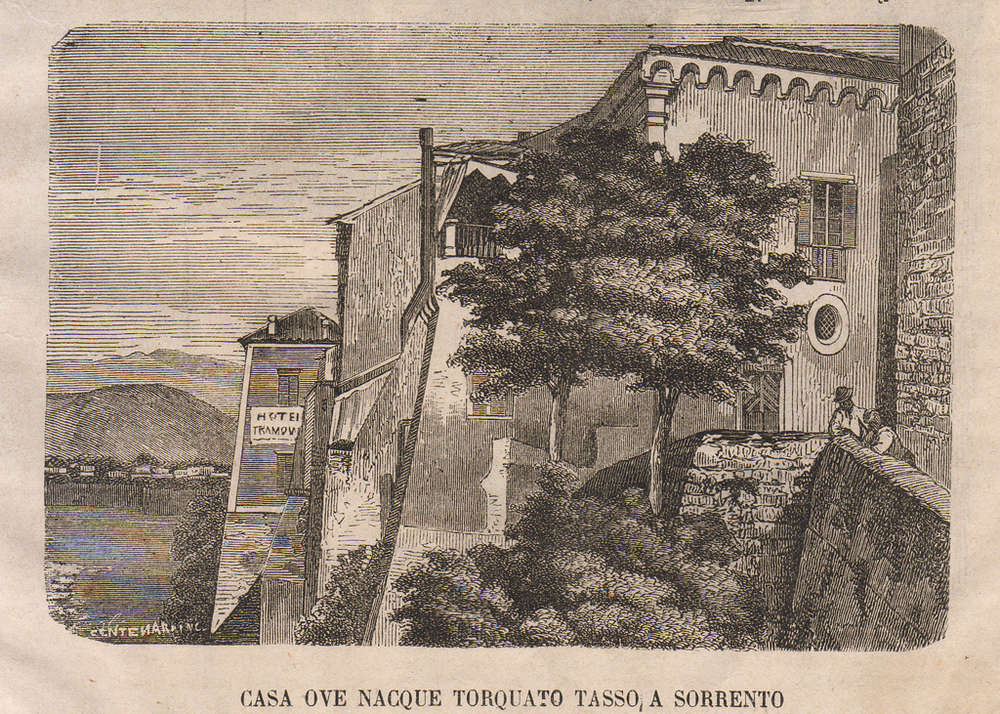
Non riesce più a trovare pace: viaggia senza sosta; torna a Roma, poi a Mantova, Padova, Reggio, Urbino e Torino. Qui sembra volersi fermare, ma gli riprende la nostalgia di Ferrara e riparte. La città del duca Alfonso II è in grande fermento, dove fervono i preparativi del matrimonio tra lo stesso duca e Margherita Gonzaga. Sentendosi trascurato, ingiuria pubblicamente Alfonso che lo rinchiude a Sant’Anna, dove rimarrà fino al 1586. E’ un periodo in cui, pur in mezzo a veri e propri momenti di follia, continuerà a lavorare incessantemente alla Liberata, che, nella nuova edizione vedrà la luce nel 1581. Dopo la pubblicazione si formano, tra gli intellettuali italiani, due vere e proprie fazioni che si dividono per il primato tra il Furioso e la Liberata.
Viene rilasciato per intercessione del principe di Gonzaga. In questa città finirà e revisionerà i Discorsi e le Rime. Ma viene ripreso da un forte senso di inquietudine che lo riporterà a vagare di città in città, dal 1588 al 1592, dove, ancora a Roma, pubblicherà la Conquistata, e il 1593, in cui, stanco e malato, raggiungerà Napoli. Qui vedrà la luce l’edizione definitiva dei Discorsi, che prenderanno il nome di Discorsi sopra il poema eroico.
 Eugene Delacroix Tasso a Sant’Anna (1839)
Eugene Delacroix Tasso a Sant’Anna (1839)
Nel 1595 va, per l’ultima volta a Roma, pensando che gli spetti l’incoronazione poetica. Ma appena giunto, lo stato fisico si mostra fortemente compromesso. Viene condotto al monastero di Sant’Onofrio sul Gianicolo e, dopo aver ottenuto l’assoluzione papale, muore serenamente.
E’ evidente che, seppur presentata in modo sommario, la vita del Tasso appare fortemente contrassegnata da eventi in parte personali e in parte storici. Egli infatti vive in modo drammatico la perdita della madre, da cui deriverà quel lungo girovagare che può esser visto come terrore di un luogo stabilito, da cui nasce quel senso di soffocamento che diventerà, purtroppo per lui, vera e propria mania di persecuzione. Tutto questo, se inserito nel periodo storico in cui Tasso si trova ad esistere, si rifletterà su due fondamentali piani: la politica culturale della Chiesa e la situazione di Ferrara, città in cui egli riuscirà a vivere il periodo più felice della sua vita. La Controriforma (o la Riforma cattolica) amplifica in lui il concetto di soffocamento / protezione che si risolve nella ricerca / fuga biografica, quando si trova in una città; Ferrara, luogo in cui si sono svolte le fondamentali esperienze intellettuali di Boiardo e Ariosto non è più la città Rinascimentale: chiusa nella difensiva, obbediente ai valori della Spagna e della Chiesa, che sembra ricercare l’ultimo splendore intellettuale (in Tasso, appunto) prima di “morire”, e l’illusione per il poeta che essa possa ancora rappresentare la grande corte in cui lui possa trovare sia protezione che gloria. Ma sarà proprio il duca Alfonso a interrompere tale illusione, chiudendolo, per pazzia, a Sant’Anna.
Ci piace sottolineare un pensiero di Marco Vallora riguardo l’immaginazione tassiana che “s’illumina dagli estremi bagliori del Rinascimento che muore, che s’avvita e avvince ai tormentosi contorcimenti del manierismo che va confluendo nella Controriforma, che riverbera come in uno specchio brunito le luci e le ombre di quel Barocco che si sta clamorosamente annunziando all’orizzonte”.

Franz Catel: Morte di Torquato Tasso (1834)
Opere
L’attività letteraria di Torquato Tasso si può dividere in:
- Opere normative che, sotto l’egida di Aristotele, tentano di definire il poema cavalleresco sotto nuove prospettive che obbediscano anche (ma non solo) alle nuove direttive culturali della Chiesa;
- Rime, in cui opera ancora l’insegnamento petrarchesco, ma rivissuto nella nuova sensibilità tassiana;
- Il dramma pastorale con l’Aminta che rappresenta un vero e proprio capolavoro letterario dell’intero Cinquecento ed il teatro classico con la tragedia Il re Torrismondo;
- Il poema cavalleresco, sin dall’adolescenza con la Gierusalemme ed il Rinaldo; questo genere troverà la sua sistemazione nella Gerusalemme liberata; ma anche questa straordinaria operazione sarà figlia delle paure del Tasso, che la trasformerà nella nuova e decisamente meno riuscita, Gerusalemme conquistata.
- Un ricchissimo Epistolario, di circa 1700 lettere, fonte incredibile di notizie sia umane che letterarie.

Ludovico Ariosto: Rime (edizione 1584)
RIME
La composizione delle Rime tassiane coprono un periodo che va da metà degli anni Cinquanta, fino quasi alla morte del poeta. Editando, secondo la sua volontà, l’intero corpus, furono lasciate fuori le poesie con riferimenti personali e all’attualità, mentre le altre dovevano seguire un piano di stampa di tipo tematico: liriche amorose; d’encomio o di lode per principi e belle donne; religiose e sparse. Nelle liriche d’amore Tasso, su un fondo tipicamente petrarchesco, accentua l’aspetto immaginifico, soffermandosi sugli abiti e i movimenti femminili. Numerose sono anche le comparazioni che il poeta fa tra donna e natura e viceversa, accentuando, così, aspetti sentimentali e patetici, che tuttavia apriranno alla lirica barocca. Le rime encomiastiche cambiano oggetto e quindi riferimento letterario: prevale la poesia classica di Pindaro ed Orazio, e appaiono quindi più formali. Le sacre rispettano la cultura controriformista del tempo e il senso d’angoscia per la paura di cadere nel peccato. Tuttavia tali Rime non valgono per il contenuto in esse elaborato, quanto per la perizia tecnica che il poeta, sin dalla gioventù, sa mostrare in esse. Basti pensare ai madrigali. Il madrigale, infatti, era un genere in endecasillabi già utilizzato da Petrarca, che prevedeva due o tre terzine e si chiudeva con uno o due distici a rima baciata. Tasso muta il genere e ne fa una composizione in cui s’alternano settenari ed endecasillabi alla ricerca di una più netta musicalità (non è un caso che molti madrigali del Tasso verranno poi musicati da Monteverdi).
ECCO MORMORAR L’ONDE
Ecco mormorar l’onde
e tremolar le fronde
a l’aura mattutina e gli arboscelli
e sovra i rami i vaghi augelli
cantar soavemente
e rider l’oriente;
ecco già l’alba appare
e si specchia nel mare
e rasserena il cielo
e le campagne e imperla il dolce gielo
e gli alti monti indora.
O bella e vaga Aurora
l’aura è tua messaggera, e tu de l’aura
ch’ogni arso cor ristaura.
Ecco mormorare le acque e tremare i ramoscelli e gli alberelli alla brezza mattutina, e cantare dolcemente i soavi uccelli sopra i verdi rami e risplendere il cielo ad oriente. Ecco che ormai appare l’alba e si specchia nel mare e rasserena il cielo, e la delicata rugiada rende perlate le campagne e colora d’oro gli alti monti. O bella e dolce Aurora, la brezza è tua messaggera, e tu lo sei della brezza che conforta ogni cuore d’oro.
Si è preso come esempio questo madrigale perché in esso troviamo degli interessantissimi spunti che aprono alla poesia successiva. In primo luogo, come detto precedentemente è una poesia in cui l’immagine prevale sul contenuto; per ben 11 versi si ha qui la descrizione della natura. Poi improvvisa la rivelazione: l’aura è un senhal con cui il poeta nasconde la realtà femminile, così ci è detto negli ultimi versi. L’aura è messaggera dell’alba, come l’alba è messaggera d’amore che ristora ogni cuore arso d’amore.

Tiziano: Francesco Maria della Rovere
Ma il capolavoro dell’arte lirica di Tasso è certamente la Canzone al Metauro, presumibilmente scritta ad Urbino, dove il nostro cercava protezione presso il duca Francesco Maria Della Rovere:
CANZONE AL METAURO
O del grand’Appennino
figlio piccolo sì, ma glorïoso
e di nome più chiaro assai che d’onde,
fugace peregrino
a queste tue cortesi amiche sponde
per sicurezza vengo e per riposo.
L’alta Quercia che tu bagni e feconde
con dolcissimi umori, ond’ella spiega
i rami sì ch’i monti e i mari ingombra,
mi ricopra con l’ombra.
L’ombra sacra, ospital, ch’altrui non niega
al suo fresco gentil riposo e sede,
entro al più denso mi raccoglia e chiuda,
sì ch’io celato sia da quella cruda
e cieca dea, ch’è cieca e pur mi vede,
ben ch’io da lei m’appiatti in monte o ’n valle,
e per solingo calle
notturno io mova e sconosciuto il piede;
e mi saetta sì che ne’ miei mali
mostra tanti occhi aver quanti ella ha strali.
Oimè! dal dì che pria
trassi l’aure vitali e i lumi apersi
in questa luce a me non mai serena,
fui de l’ingiusta e ria
trastullo e segno, e di sua man soffersi
piaghe che lunga età risalda a pena.
Sassel la gloriosa alma sirena,
appresso il cui sepolcro ebbi la cuna:
così avuto v’avessi o tomba o fossa
a la prima percossa!
Me dal sen de la madre empia fortuna
pargoletto divelse. Ah! di quei baci,
ch’ella bagnò di lagrime dolenti,
cono sospir mi rimembra e de gli ardenti
preghi che se ’n portar l’aure fugaci:
ch’io non dovea giunger più volto a volto
fra quelle braccia accolto
con nodi così stretti e sì tenaci.
Lasso! e seguii con mal sicure piante,
qual Ascanio o Camilla, il padre errante.
In aspro esiglio e ’n dura
povertà crebbi in quei sì mesi errori;
intempestivo senso ebbi a gli affanni;
ch’anzi stagion, matura
l’acerbità de’ casi e de’ dolori
in me rendé l’acerbità de gli anni.
L’egra spogliata sua vecchiezza e i danni
narrerò tutti. Or che non sono io tanto
ricco de’ propri guai che basti solo
per materia di duolo?
Dunque altri ch’io da me dev’esser pianto?
Già scarsi al mio voler sono i sospiri,
e queste due d’umor sì larghe vene
non agguaglian le lagrime a le pene.
Padre, o buon padre, che dal ciel rimiri,
egro e morto ti piansi, e ben tu lo sai,
e gemendo scaldai
la tomba e il letto: or che ne gli alti giri
tu godi, a te si deve onor, non lutto:
a me versato il mio dolor sia tutto.

Piacesi Walter: Canzone del Metauro (1984)
O figlio piccolo sì, ma glorioso, del grande Appennino, e illustre per fama molto più che per l’abbondanza delle acque, io, errante costretto alla fuga, giungo a queste tue sponde generose e amiche per cercare sicurezza e riposo. L’alta Quercia (simbolo della stemma dei Della Rovere) che tu bagni e fecondi con le tue acque dolcissime, grazie alle quali quella dispiega i rami così da coprire monti e mari, mi ricopra con la sua ombra. L’ombra sacra, ospitale, che a nessuno nega riposo e accoglienza con la sua gentile frescura, mi accolga e mi richiuda nel più fitto fogliame, così che io sia nascosto a quella crudele e cieca dea (la Fortuna) che è cieca eppure mi vede, ben-ché io mi nasconda da lei sui monti o nelle valli e io muova di notte, senza essere visto da nessuno, i miei passi lungo sentieri solitari; e mi colpisce così che, nelle mie sventure, mostra di a-vere tanti occhi quante sono le sue frecce. // Ohimé! Dal giorno che per la prima volta respirai l’aria che mantiene in vita e aprii gli occhi a questa vita che per me non è mai serena, fui trastullo e bersaglio della Fortuna ingiusta e malvagia, e di sua mano subii ferite che a malapena il passare degli anni rimargina. Lo sa la gloriosa e sublime sirena (Partenope, attorno al cui sepolcro era sorta, secondo la tradizione Napoli), presso il cui sepolcro io nacqui: oh, se avessi avuto in quel luogo tomba onorata o misera sepoltura al primo colpo (che la Fortuna m’inferse)! La malvagia fortuna strappò me, ancora fanciullo, dal seno della madre. Ah! sospirando, ricordo quei baci che ella bagnò di dolorose lacrime e le appassionate preghiere che i venti fugaci hanno portato via; infatti io non avrei più potuto accostare il mio volto al suo, accolto tra quelle braccia con legami così stretti e così tenaci. Me infelice! e seguii con passi poco sicuri mio padre, nel suo vagabondare, come Ascanio o Camilla (il primo segue Enea dopo la disfatta di Troia; la seconda il padre Métabo, re dei Volsci). // Sono cresciuto in un esilio doloroso e dura povertà, durante quel triste vagabondare ho acquisito una precoce sensibilità alle sofferenze: perché la durezza della sorte e dei dolori, fece maturare in me, prima del tempo, la giovinezza. Racconterò tutto sulla vecchiezza malata e misera di mio padre e sui fatti dolorosi che accaddero. Forse che non sono io tanto pieno dei miei dolori, da non essere sufficiente da solo, come esempio di dolore? Dunque chi altri, se non me stesso, dev’essere oggetto di pianto da parte mia? Ormai i miei sospiri di dolore sono pochi a confronto di quanto vorrei, e queste due fonti così abbondanti d’acqua, non rendono le lacrime pari alle pene (che provo). Padre, o buon padre, che guardi dal cielo, ti piansi quand’eri malato e poi quando sei morto, e tu lo sai bene, e piangendo scaldai il tuo letto e poi la tua tomba: ora sei beato in cielo: a te è dovuto onore, non lutto; il mio dolore sia tutto riversato su di me.
La canzone non è terminata e s’interrompe al sessantesimo verso. Ci sono tre stanze in cui il poeta, stando a ciò che egli esprime nei versi, cerca sicurezza ad Urbino, in un momento assai difficile della sua vita, quando, nel 1578, dopo i primi dissidi col duca, cerca protezione presso il Della Rovere. Questa canzone, pertanto, come molte altre liriche tassiane, è d’occasione, cioè nasce dall’“occasione” appunto di una richiesta d’accoglimento presso la corte urbinate. Da qui il tono sostenuto e liricamente atteggiato nell’encomio dei primi versi; infatti la grande quercia, in quanto rappresenta lo stemma dei Della Rovere e l’intera città d’Urbino, bagnata dal piccolo fiume Metauro, metaforizza appunto la grandezza storica (e qui il richiamo storico alle guerre puniche) e geografica (il suo estendersi dalle montagne, l’Appennino, e il mare, l’Adriatico). Ma, a livello psichico, potrebbe anche metaforizzare il grembo materno: i verbi di accoglimento fino alla chiusura, in un intricato abbraccio, la volontà di nascondersi alla “cieca dea”, cioè la fortuna o il destino, stanno a significare nella duplicità dell’animo del poeta, il polo della sicurezza, o meglio, la ricerca di tale polo, qui esemplificato nell’accoglienza presso una corte e tra le “braccia” di un principe.
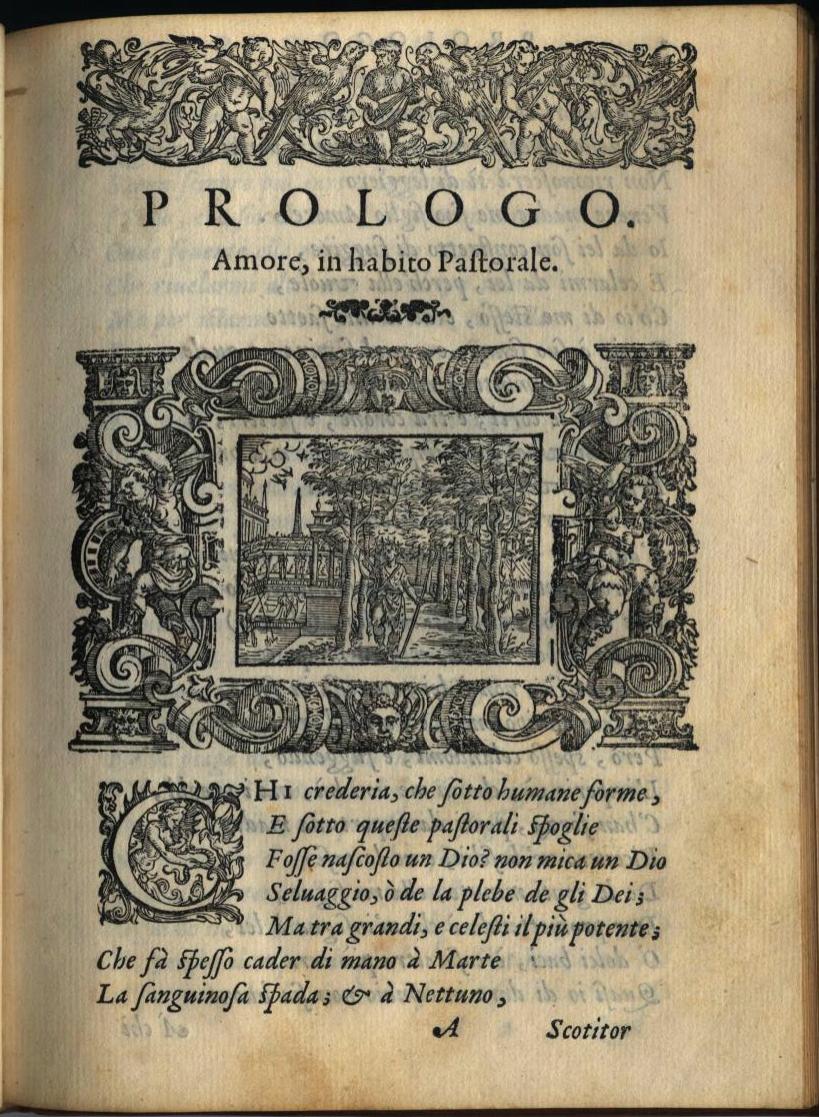
Aminta nell’edizione Manunzio (1590)
AMINTA
E’ certamente, tra le opere minori del Tasso, quella più riuscita; sicuramente questo è determinato dal clima sereno in cui fu composta, nel periodo felice, precedente i suoi turbamenti psichici quando, protetto e amato come grande letterato nella corte Ferrarese, riusciva a donare ad essa un dramma pastorale, per le vacanze estive del 1573, e recitata nella splendida isoletta di Belvedere sul Po, di fronte a tutta la corte.
Il giovane pastore Aminta ama la ninfa Silvia che, seguace di Diana e dedita unicamente alla caccia, disprezza il suo amore. L’amico Tirsi e l’esperta Dafne cercano di aiutare Aminta. Alla fine Tirsi spinge Aminta a dichiararsi apertamente e raggiungere la ninfa mentre sta bagnandosi presso una fonte. Ma prima che il pastore giunga, Silvia sta per essere aggredita da un satiro e fugge. Aminta giunge appena in tempo, ma la ragazza, invece di ringraziarlo, scappa ancora. Subito dopo Nerina (altra ninfa) afferma che Silvia, fuggendo, è stata aggredita dai lupi e di lei è rimasto solo un velo insanguinato. Aminta, disperato perché crede che il velo testimoni la morte della ragazza, si getta da una rupe. Silvia, che morta non è, saputa la storia del pastore, si pente e corre da lui e piange il corpo del pastore. Ma nemmeno lui è morto: un cespuglio ne ha attutito la caduta. Risvegliato dalle lacrime della Ninfa si risveglia e così i due potranno amarsi senza più inibizioni.
Il genere dell’opera corrisponde ad un dramma pastorale in 5 atti in settenari ed endecasillabi; tutto ciò rappresenta una novità in quanto egli applica la struttura della tragedia antica in quanto:
- rispetta le regole aristoteliche sull’unità di tempo, azione e luogo;
- rispetta la divisione in atti, la presenza di un prologo e di un coro alla fine di ciascuno di esso;
- la presenza di elementi “tragici” come il tentativo del suicidio che tuttavia mescola con temi tratti dalla commedia: la presenza di un satiro dalla sessualità libera e disinvolta e il lieto fine.
Tutto ciò diventa possibile per lui perché, non essendo la favola pastorale un genere presente nella letteratura classica, egli può non rispettare le regole di qualcosa di codificato, ma cercare, viceversa, d’impostare egli stesso le regole per un genere che riprendendo temi dalla classicità (si pensi alle Bucoliche di Virgilio, ma anche all’Arcadia di Sannazzaro) le codifica dentro uno schema preciso.
L’opera ebbe da subito vasta eco nella corte ferrarese, soprattutto perché era stata scritta a tema: per meglio dire, dietro i personaggi rappresentati vi si poteva cogliere l’elegante riferimento a uomini e donne della corte di Astolfo. Ma la sua “durabilità” va certamente oltre la riconoscibilità che il pubblico di allora poteva trovarvi. E’ che in essa vi si trova racchiuso tutto il mondo tassiano per il tema dell’amore, che, motivo dominante dell’opera, viene qui cantato nella piena riaffermazione di un piacere rinascimentale accompagnato da un’estrema sensualità e il rifiuto di ogni rigidezza morale. Ma tale tema viene poi accompagnato da una forte ambiguità: l’amore è libertà, nessuna costrizione, ma è rivolto ad una corte che, seppur “ancora” splendida, è il centro di ogni norma e costrizione. Sin d’ora quindi, anche nel periodo felice del nostro si riafferma l’amore/odio per la corte, l’amore /odio per la libertà.
S’EI PIACE, EI LICE
(I, 565-632)
O bella età de l’oro,
non già perché di latte
se ’n corse il fiume e stillò mele il bosco:
non perché i frutti loro
dier da l’aratro intatte
le terre e gli angui errar senz’ira o tosco:
non perché nuvol fosco
non spiegò allor suo velo,
ma in primavera eterna,
ch’ora s’accende e verna,
rise di luce e di sereno il cielo;
né portò peregrino
o guerra o merce a gli altrui lidi il pino.
Ma sol perché quel vano
nome senza soggetto,
quell’idolo d’errori, idol d’inganno,
quel che da ’l volgo insano
Onor poscia fu detto,
che di nostra natura il feo tiranno,
non mischiava il suo affanno
fra le liete dolcezze
de l’amoroso gregge;
né fu sua dura legge
nota a quell’alme in libertate avezze,
ma legge aurea e felice
che Natura scolpì: S’ei piace, ei lice.
Allor tra fiori e linfe
traen dolci carole
gli Amoretti senz’archi e senza faci;
sedean pastori e ninfe
meschiando a le parole
vezzi e susurri ed a i susurri i baci
strettamente tenaci;
la verginella ignude
scopria sue fresche rose
ch’or tien ne ’l velo ascose,
e le poma de ’l seno acerbe e crude;
e spesso in fonte o in lago
scherzar si vide con l’amata il vago.
Tu prima, Onor, velasti
la fonte de i diletti,
negando l’onde a l’amorosa sete:
tu a’ begli occhi insegnasti
di starne in sé ristretti,
e tener lor bellezze altrui secrete:
tu raccogliesti in rete
le chiome a l’aura sparte:
tu i dolci atti lascivi
festi ritrosi e schivi,
a i detti il fren ponesti, a i passi l’arte;
opra è tua sola, o Onore,
che furto sia quel che fu don d’Amore.
E son tuoi fatti egregi
le pene e i pianti nostri.
Ma tu, d’Amore e di Natura donno,
tu domator de’ regi,
che fai tra questi chiostri
che la grandezza tua capir non ponno?
Vattene e turba il sonno
a gl’illustri e potenti:
noi qui negletta e bassa
turba, senza te lassa
viver ne l’uso de l’antiche genti.
Amiam, ché non ha tregua
con gli anni umana vita e si dilegua.
Amiam, ché ’l Sol si muore e poi rinasce:
a noi una breve luce
s’asconde, e’ l sonno eterna notte adduce.

Aminta nell’edizione Manunzio (1590)
O bella età dell’oro, non soltanto perché scorreva il latte nei fiumi e il bosco grondava di miele, non perché le terre producevano i loro frutti senza essere state dissodate dall’aratro e i serpenti strisciavano senza aggressività o veleno; non perché allora nessuna nuvola fosca oscurava il sole, e in una primavera eterna, che ora si alterna alla torrida estate e al gelido inverno, il cielo risplendeva di luce e di sereno, le navi erranti non portavano guerra o merci verso gli altri paesi. // Ma soltanto perché quel vuoto nome senza consistenza, quella falsa e ingannevole divinità, quello che fu poi chiamato Onore dal popolo ignorante, che lo rese tiranno della natura umana, non mescolava l’affanno ai sereni piaceri della schiera degli innamorati, e la sua crudele legge non fu conosciuta da quelle anime abituate alla libertà, ma una legge beata e felice che la natura ha scolpito: “Ciò che piace è lecito”. // Allora gli Amorini, senza arco né fiaccole, intrecciavano leggiadre danze, i pastori e le ninfe sedevano insieme mescolando tenerezze e sussurri alle parole e baci appassionati a sussurri, le fanciulle scoprivano senza veli le loro fresche bellezze e il seno acerbo e seducente, che sono ora nascoste dagli abiti; e spesso si vedeva l’innamorato scherzare con l’amata in una fonte o in lago. // Tu, Onore, per primo hai nascosto la fonte dei piaceri, negando l’acqua alla sete dell’amore; tu hai insegnato ai begli occhi a starsene pudicamente abbassati e a tenere le loro bellezze nascoste agli altri; tu raccogliesti in una rete i capelli sparsi all’aria; tu rendesti ritrosi e vergognosi i dolci atti amorosi, imponesti limiti alle parole e regole ai movimenti; solo per causa tua o Onore, ciò che prima fu un dono spontaneo d’Amore ora è un furto. // Le nostre sofferenze, i nostri pianti sono tue illustri imprese. Ma tu, signore di Amore e di Natura, tu, dominatore dei re, che cosa fai tra questi boschi solitari che non possono contenere la tua grandezza? Vattene e turba il sonno agli uomini illustri e ai potenti: lascia noi, gente dimenticata ed umile, vivere qui, senza di te, secondo gli usi dei popoli antichi. Amiamo, poiché la vita umana non si ferma con il tempo ed è fugace. // Amiamo, perché il sole muore e poi risorge: la sua breve luce si nasconde a noi, e il sonno della morte porta la notte eterna.

Edizione inglese dell’Aminta
E’ evidente che ci troviamo di fronte a un passo dove sembra si possa ripercorrere la gaiezza umanistico-rinascimentale della gioia dell’amore, rivivendola nel mito di una età dell’oro, che il nostro sembra indicare esistere nell’allegra brigata nobile lì raccolta in vacanza a Bellosguardo dove assiste al suo dramma pastorale. Ma forse è qui la difficile contraddizione con cui il lettore d’oggi (e sicuramente lo spettatore ieri) deve confrontarsi. Il brano è recitato dal coro dei pastori alla fine del I atto: ora, seppur idealizzato, è proprio l’essere pastori che situa il loro canto lontano da chi pastore non è, cioè il nobile, che, infatti, non vive in campagna. E’ chiaro che ci troviamo di fronte a un gioco letterario, ma se l’opera, come già detto, è a tema, proprio nei protagonisti i nobili spettatori si riconoscevano, e dovevano riconoscersi in esseri che criticavano l’età, in cui, finita quella dell’oro, veniva a censurarli l’onore (cui non è certo difficile riconoscere la morale cattolica controriformistica)? Certo la vacanza estiva “allentava” e in qualche modo poteva “plaudire” al dettato tassiano. Ma le contraddizioni interne erano dell’autore, e tali rimarranno fino ad esplodere nella follia.
DISCORSI SULL’ARTE POETICA
Il capolavoro di Torquato Tasso viene elaborato dopo una lunga meditazione che lo porta a riflettere sul ruolo che il poema epico/cavalleresco, che ha dato fama e gloria a Boiardo e ad Ariosto, in questo nuovo periodo e in questa stessa città deve assumere e quale fine, chi lo scrive, si deve prefiggere. A tale scopo dà vita un’opera teorica che inizia nel 1562 e termina, dopo averla rivista e corretti, nel 1587. E’ un testo in tre libri, in cui il nostro ragiona su cosa il poema debba centrarsi, in che modo si debba intendere il fantastico, quale forma e quale stile debba avere, sempre paragonando il poema su cui sta lavorando a quello dell’Ariosto. Esso s’inserisce nel dibattito teorico della seconda metà del ’500 sulla natura della struttura del poema eroico, ma per Tasso si tratta di un’opera che si sviluppa mentre lavora alla Gersulamme e pertanto si configura come un continuo rapporto tra teoria e pratica.
LA MATERIA DEL POEMA EROICO
La materia, che argomento può ancora comodamente chiamarsi, o si finge, ed allora par che il poeta abbia parte non solo ne la scelta, ma ne la invenzione ancora; o si toglie da l’istorie. Ma molto meglio è, a mio giudicio, che da l’istoria si prenda; perché dovendo l’epico cercare in ogni parte il verisimile (presupongo questo, come principio notissimo), non è verisimile ch’una azione illustre, quali sono quelle del poema eroico, non sia stata scritta, e passata a la memoria de’ posteri con l’aiuto d’alcuna istoria. (…)
Dovendo il poeta con la sembianza de la verità ingannare i lettori, e non solo persuader loro che le cose da lui trattate sian vere, ma sottoporle in guisa a i lor sensi, che credano non di leggerle, ma di esser presenti, e di vederle, e di udirle, è necessitato di guadagnarsi ne l’animo loro questa opinion di verità; il che facilmente con l’autorità de l’istoria gli verrà fatto.
La materia, che può essere anche chiamata comodamente argomento, o è tratta dalla finzione, e allora è evidente che il poeta abbia parte non solo nella scelta (dell’argomento stesso), ma anche nella capacità inventiva; oppure si trae dalla storia. Secondo il mio pensiero è molto meglio che si prenda dalla storia, perché dovendo l’autore epico trattare soprattutto il verosimile (presuppongo che questo principio sia notissimo), non è dunque verosimile se non un’azione illustre, come quelle del poema eroico, che non sia stata già scritta e ricordata dai posteri con l’aiuto di qualche documento. (…)
Dovendo il poeta “ingannare” il lettore con l’imitazione della realtà, non solo convincerli che le cose da lui scritte siano vere, ma sottoporle ai loro sensi in modo tale che essi credano non solo di leggerle, ma d’essere presenti, vederle, udirle. E’ quindi necessario che egli dia ai lettori questa impressione di verità, che certamente con l’autorità della storia verrà fatto loro.
Cominciamo subito a notare come il Tasso sottolinei la distanza che separa la sua concezione da quella di Ariosto: infatti, basandosi sull’autorità aristotelica, secondo cui l’arte è imitazione della realtà (principio notissimo), il compito del poeta epico non è quello di porre la propria storia in un non-tempo, come appunto nell’Orlando Furioso, ma di cercare il verisimile, cioè trarlo dalla storia, per dare a lui maggiore autorità. Infatti Tasso è estremamente consapevole di come l’attenzione di un lettore sia maggiormente attratta da una storia che il lettore stesso sa esser stata reale.
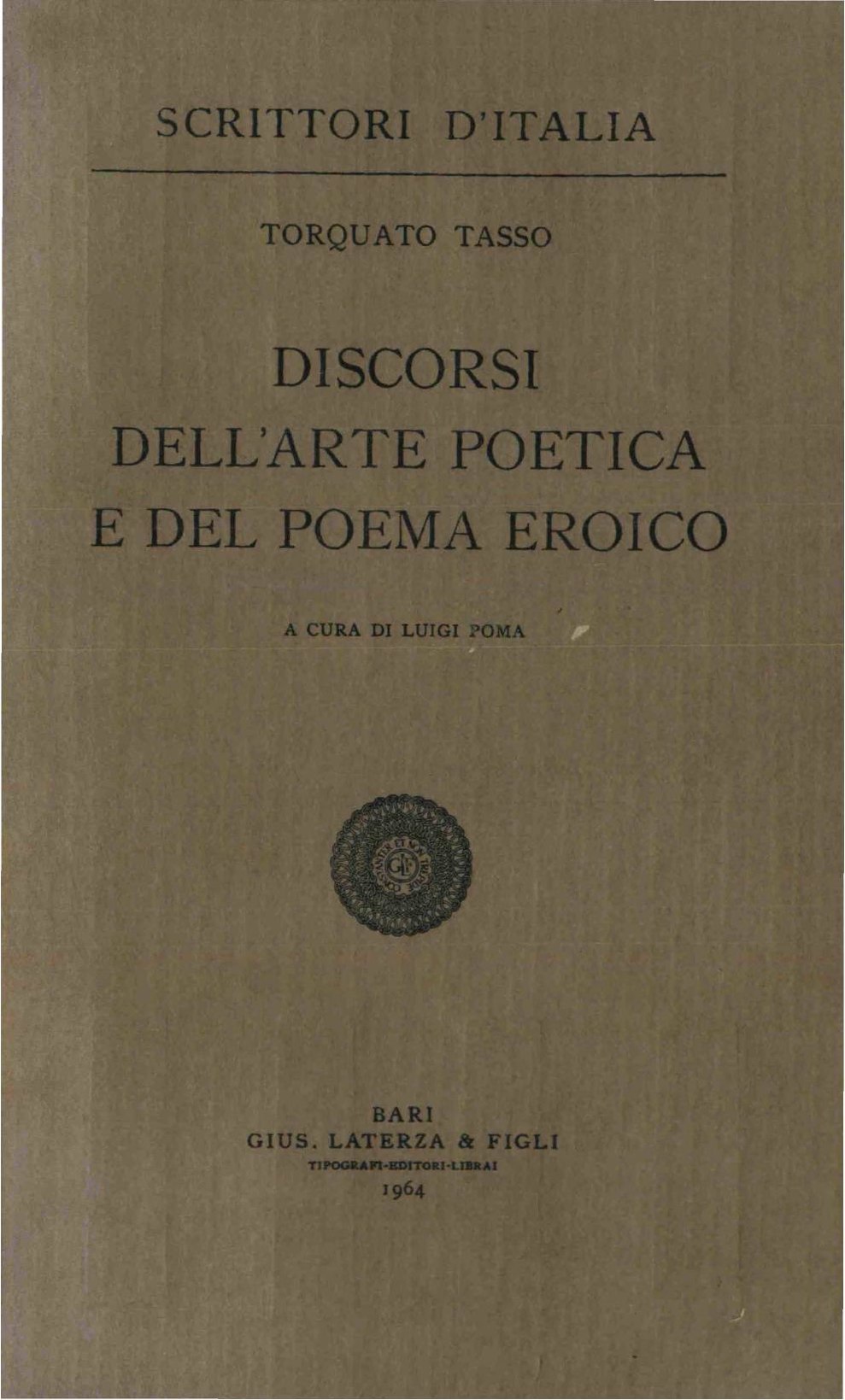
Edizione del 1964
IL MERAVIGLIOSO CRISTIANO
Deve dunque l’argomento del poema epico esser tolto da l’istorie; ma l’istoria, o è di religione tenuta falsa da noi, o di religione che vera crediamo, quale è oggi la cristiana, e vera fu già l’ebrea. Né giudico che l’azioni de’ gentili ci porgano comodo soggetto, onde perfetto poema epico se ne formi: perché in que’ tali poemi, o vogliamo ricorrer talora a le deità che da’ gentili erano adorate, o non vogliamo ricorrervi; se non vi ricorriamo mai, viene a mancarvi il meraviglioso; se vi ricorriamo, resta privo il poema in quella parte del verisimile. Poco dilettevole è veramente quel poema, che non ha seco quelle maraviglie, che tanto muovono non solo l’animo de gl’ignoranti, ma de’ giudiziosi ancora: parlo di quelli anelli, di quelli scudi incantati, di que’ corsieri volanti, di quelle navi converse in ninfe, di quelle larve che fra’ combattenti si tramettono, e d’altre cose sí fatte; de le quali, quasi di sapori, deve il giudizioso scrittore condire il suo poema; perché con esse invita ed alletta il gusto de gli uomini vulgari, non solo senza fastidio, ma con sodisfazione ancora de’ piú intendenti. Ma non potendo questi miracoli esser operati da virtú naturale, è necessario ch’a la virtú sopranaturale ci rivolgiamo; e rivolgendoci a le deità de’ gentili, subito cessa il verisimile; perché non può esser verisimile a gli uomini nostri quello, ch’è da lor tenuto non solo falso, ma impossìbile; ma impossibil’è che dal potere di quell’idoli vani e senza soggetto, che non sono e non furon mai, procedano cose, che di tanto la natura e l’umanità trapassino. (…)
Attribuisca il poeta alcune operazioni, che di gran lunga eccedono il poter degli uomini, a Dio, a gli angioli suoi, a’ demoni, o a coloro a’ quali da Dio o da’ demoni è concessa questa podestà, quali sono i santi, i maghi e le fate. Queste opere, se per se stesse saranno considerate, meravigliose parranno; anzi miracoli sono chiamati nel commune uso di parlare. Queste medesime, se si avrà riguardo a la virtù ed a la potenza di chi l’ha operate, verisimili saranno giudicate, perché avendo gli uomini nostri bevuta ne le fasce insieme co ’l latte questa opinione, ed essendo poi in loro confermata da i maestri de la nostra santa Fede, cioè che Dio e i suoi ministri, e i demoni ed i maghi, permettendolo lui, possino far cose sovra le forze de la natura meravigliose; e leggendo e sentendo ogni dì ricordarne novi esempi, non parrà loro fuori del verisimile quello, che credono non solo esser possibile, ma stimano spesse fiate esser avvenuto, e poter di novo molte volte avvenire. (…)
Può essere dunque una medesima azione e meravigliosa e verisimile: meravigliosa, riguardandola in sé stessa, e circonscritta dentro a i termini naturali; verisimile, considerandola divisa da questi termini ne la sua cagione, la quale è una virtú sopranaturale, potente, ed avvezza ad operar simili meraviglie.
Dunque l’argomento del poema epico dev’essere tratto dalla storia; ma la storia o appartiene ad una religione ritenuta da noi falsa, o crediamo essere vera, come oggi è la religione cristiana e ieri l’ebrea. Non ritengo che le favole mitologiche ci porgano un utile soggetto da cui formare un poema epico; infatti o ricorriamo alla mitologia o meno, ma se non vi ricorriamo manca (nel poema) il meraviglioso, se vi ricorriamo mancherà il verosimile. Poco piacevole è infatti un poema, non solo per gli illetterati ma anche per i colti in cui manchi il meraviglioso: parlo di anelli (fatati), scudi incantati, cavalli volanti, navi trasformate in dee, di fantasmi che si intromettono nei duelli, e di altre azioni straordinarie, con cui, come fossero un condimento, un accorto scrittore condisce il suo poema, perché così invita e fa gradire agli ignoranti senza creare loro dei fastidi, con soddisfazione anche dei competenti. Ma tali miracoli, non potendo avvenire nella realtà naturale, è necessario per noi rivolgerci a quella soprannaturale, e, come già detto, se prendessimo le divinità pagane cesserebbe il verosimile, in quanto è ritenuto giustamente falso ciò che loro non credono, e quindi impossibile; ma è altrettanto impossibile che da quegli idoli senza consistenza, mai esistiti, derivino cose che oltrepassino la natura e l’umanità. (…)
Alcune operazioni, che eccedono la capacità umana, vengano attribuite a Dio, agli angeli, ai diavoli, o a coloro la cui forza derivi dagli angeli o dai diavoli, come i santi, i maghi e le fate. Queste azioni, prese per sé, saranno ritenute meravigliose, tanto che nella nostra lingua sono definite miracoli. Queste stesse, se si penserà alla virtù e alla potenza di chi l’ha fatte nascere, saranno giudicate verosimili; infatti i nostri uomini credono ciò sin dalla più tenera età, quando l’hanno imparata sin da quando erano in fasce e bevevano il latte, cioè che Dio ed i suoi ministri e i diavoli e i maghi, con la sua volontà, possono fare veri e propri miracoli, e sentendo spesso che ciò è avvenuto, credono possa avvenire ancora. (…)
Un’azione può dunque essere sia meravigliosa che verosimile: meravigliosa guardandola in se stessa e considerandola nella sua natura; verosimile considerandola divisa dalla realtà nei suoi fondamenti, in quanto è sovrannaturale, potente ed abituata a creare tali meraviglie.

Edizione del 1587
E’ chiaro come qui Tasso, in linea con la Controriforma, cerchi di fare un poema cattolico: abbiamo già visto come sia necessario, per fare ciò, ricorrere alla storia; appare chiaro, ora, per Tasso, far sì che all’interno di essa, affinché vi sia anche la possibilità del divertimento, non possa mancare l’elemento fantastico. Occorre a lui, pertanto, giustificare quest’ultimo sulla linea di un confronto con l’epica antica e confortato da uno stretto ragionamento che si muove su linee razionali; infatti se il poema per interessare deve ricorrere alla storia, creando così il verosimile, non può inserire in essa ciò che verosimile non è, altrimenti cadrebbe anche la prima verosimiglianza; ora se l’apparato mitologico è, per un cattolico, una bella favola ma certamente falsa, essa non può inficiare l’operazione del poema. Allora, per far sì che tale poema esista anche nella necessaria componente fantastica si ricorrerà al meraviglioso cristiano, cioè al miracoloso divino e demoniaco, pertanto a ciò che il lettore credente crede, in quanto uomo di fede.
Altri punti fondamentali che il poeta tocca nei libri successivi sono:
-
unità/varietà: critica Ariosto per l’estrema varietà dell’opera che, a ben guardare non narra una storia (ma ne ammette la piacevolezza per il lettore che ha bisogno di tale varietà); ma critica anche il poeta Trissino che, scrivendo l’Italia liberata dai Goti, poema in cui vuole imitare Virgilio e toglie qualsiasi varietà, non ha raggiunto per il lettore la piacevolezza dell’Orlando; lui inaugura la teoria della varietà nell’unità: racconto una sola storia in cui poi inserisco episodi diversi (guerre, incendi, amori, operazioni divine e diaboliche);
- stile: lo stile dev’essere “magnifico”, sublime, così come scrive Dante nel suo De vulgari eloquentia. Ma affinché non risultiu troppo magniloquente dev’essere integrato con momenti “lirici”.
LA GERUSALEMME LIBERATA
L’idea di un poema che celebrasse l’impresa della prima crociata, giunge a Tasso sin da giovanissimo, tanto che già a 15 anni si mette all’opera e compone il primo canto della Gierusalemme. Gli enormi problemi che tale progetto porta con sé non sfuggono al precoce poeta: il rapporto tra storia e fantasia, il concetto di meraviglioso (nonché la presenza di un modello così ingombrante come l’Orlando Furioso), tanto da decidere di rinviare l’opera a tempi più opportuni. Passa solo un anno e comincia a lavorare al Rinaldo, pubblicato a Venezia nel 1562. Questo poema cerca di risolvere il problema del moderno poema eroico: infatti si discuteva se dovesse essere ariostesco, cioè suscitare interesse e piacere attraverso la varietà, o dovesse seguire più pedissequamente il modello omerico o virgiliano. Tasso supera il problema prendendo a modello l’Amadigi del padre, cioè inserendo un solo protagonista all’interno di una serie di avventure. Intorno agli anni ’70 il Tasso lavora alacremente al suo capolavoro che licenzia, nella prima stesura, nel 1575. L’attesa per la pubblicazione presso la corte è enorme: lo stesso duca vorrebbe che l’opera fosse resa pubblica sin da subito. Tasso tuttavia non è esente da dubbi e manda una copia a Padova e una Roma affinché lettori qualificati possano giudicarla. Le critiche giungono (alcune impietose, soprattutto da parte religiosa) e il poeta inizia così il lavoro di revisione; ma intanto il poema comincia a circolare senza il suo permesso. Ciò è dovuto al suo essere rinchiuso a Sant’Anna e non aver alcun controllo su ciò che del suo lavoro venisse fatto fuori. Infatti nel 1581 circola già un’edizione che molto probabilmente contiene in sé alcune correzioni tassiane, (ed è l’opera che noi tutt’oggi leggiamo); ma il poeta continua a lavorarci cercando di cancellare ogni forma potesse allontanare anche il solo sospetto di non essere cattolicamente ortodossa. Uscirà infatti nel 1593, a Roma, la Gerusalemme conquistata. Ma i lettori di un tempo, la critica d’oggi, ritenendo valida l’edizione dell’81 e considerando la Conquistata opera altra rispetto alla Liberata, accettano soltanto quest’ultima come splendido esempio di letteratura del secondo Cinquecento.

Edizione del 1771
Il tema fondamentale della Gerusalemme Liberata è la guerra dei Cristiani contro i Musulmani promossa da Urbano II durante la prima Crociata e la conquista di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione nel 1099.

Sante Peranda: Ritratto di Afonso II d’Este (seconda metà del XVI sec.)
Vediamone la struttura e i principali motivi attraverso l’opera stessa:
PROEMIO
(1-5)
Canto l’arme pietose e ’l capitano
che ’l gran sepolcro liberò di Cristo.
Molto egli oprò co ’l senno e con la mano,
molto soffrí nel glorioso acquisto;
e in van l’Inferno vi s’oppose, e in van
s’armò d’Asia e di Libia il popol misto.
Il Ciel gli diè favore, e sotto a i santi
segni ridusse i suoi compagni erranti.
Musa, tu che di caduchi allori
non circondi la fronte in Elicona,
ma su nel cielo infra i beati cori
hai di stelle immortali aurea corona,
tu spira al petto mio celesti ardori,
tu rischiara il mio canto, e tu perdona
s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte
d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte.
Sai che là corre il mondo ove piú versi
di sue dolcezze il lusinghier Parnaso,
e che ’l vero, condito in molli versi,
i piú schivi allettando ha persuaso.
Cosí a l’egro fanciul porgiamo aspersi
di soavi licor gli orli del vaso:
succhi amari ingannato intanto ei beve,
e da l’inganno suo vita riceve.
Tu, magnanimo Alfonso, il quale ritogli
al furor di fortuna e guidi in porto
me peregrino errante, e fra gli scogli
e fra l’onde agitato e quasi absorto,
queste mie carte in lieta fronte accogli,
che quasi in voto a te sacrate i’ porto.
Forse un dí fia che la presaga penna
osi scriver di te quel ch’or n’accenna.
È ben ragion, s’egli averrà ch’in pace
il buon popol di Cristo unqua si veda,
e con navi e cavalli al fero Trace
cerchi ritòr la grande ingiusta preda,
ch’a te lo scettro in terra o, se ti piace,
l’alto imperio de’ mari a te conceda.
Emulo di Goffredo, i nostri carmi
intanto ascolta, e t’apparecchia a l’armi.
Canto le armi pie e il capitano (Goffredo di Buglione) che liberò il venerabile sepolcro di Cristo (dai musulmani). Egli compì molte imprese con la saggezza e con la forza, molti patimenti subì durante la conquista (di Gerusalemme); e invano l’inferno si oppose alla sua impresa, e invano le diverse popolazioni dell’Asia e dell’Africa, unite insieme, presero le armi (contro di lui). Dio gli fu favorevole ed egli ricondusse sotto le insegne sacre (la croce) i suoi compagni dispersi. // O musa, tu che non circondi la fronte (dei poeti) sull’Elicona con gli allori che hanno vita breve, ma hai una corona d’oro di stelle immortali nel cielo fra i cori dei beati, infondi tu nel mio cuore profondi sentimenti religiosi, illumina tu la mia poesia, e perdonami se intreccio episodi di fantasia e gli eventi storici, se abbellisco in parte le carte con altri piaceri, diversi dai tuoi. // Sai che tutti (il mondo) accorrono là, dove l’ingannevole Parnaso diffonde (versi) maggiormente le sue dolcezze e che la verità storica, se arricchita di versi piacevoli ha persuaso, allettandoli, anche i più restii (ad accettare la verità). Allo stesso modo porgiamo al fanciullo malato (egro) i bordi della tazza (che contiene il farmaco) ricoperti (spersi) di dolce liquido e così egli, ingannato, beve farmaci amari e riacquista la salute dal suo inganno. // Tu, magnanimo Alfonso, che sottrai alla violenza della tempesta (fortuna) e guidi nel porto me, esule disperso, trasportato con forza (agitato) e quasi inghiottito (absorto) dalle onde, accogli benevolmente (in lieta fronte) questo mio poema (carte), che offro a te, come se le avessi consacrate (sacrate) con un voto. Forse un giorno succederà che la mia penna che presagisce (le glorie di Alfonso), avrà l’ardire di scrivere su di te quello che ora è solo accennato. // Se avverrà che il popolo cristiano non sia mai in pace e che, con navi e cavalli, tenti di sottrarre (ritor) la nobile e immeritata preda (il sepolcro di Cristo) ai feroci Turchi (il fero Trace), è cosa giusta (è ben ragion) che ti conceda il potere (scettro) in terra o, se vuoi, il supremo comando dei mari. Emulo di Goffredo, ascolta intanto i miei versi (i nostri carmi) e preparati a combattere.
Questo proemio si può benissimo ripartire in tre elementi fondamentali:
- Stanza 1: vi è la materia del poema, cioè la presa di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione, nell’ultima fase della guerra. Ma tale stanza è importante anche perché ci mostra la presa di distanza da Ariosto e il modello imperante virgiliano: infatti Canto l’arme pietose e il capitano traduce in modo “letterale” l’Arma virumque cano dell’Eneide; inoltre l’aggettivo pietose rimanda in modo diretto al concetto di pietas virgiliana; il rimarcare poi il nome del protagonista vuole significare, inoltre, ricercare l’unità nel poema, cioè la figura unitaria che non permette di disperdessi in mille rivoli, ma il centro da cui dipartono e poi tornano i protagonisti;
- Stanze 2-3: invocazione alla Musa. Come già chiarito nei Discorsi sull’arte poetica, Tasso intende la Musa come intelligenza angelica capace di ispirare dall’alto una poesia sacra (come in Dante, che nel Paradiso, invita Apollo “Entra nel petto mio, spira tue” ad ispirarlo). Egli, quindi, chiede scusa se, per allettare i lettori, intesse fregi al ver, cioè abbellisce, con il meraviglioso, la verità storica, riprendendo anche qui il concetto classico sia lucreziano che oraziano del miscere utile dulci (mescolare l’utile al dilettevole).
- Stanze 4-5: motivo encomiastico. Tale motivo Tasso lo intreccia con quello personale. Infatti egli è un peregrino che cerca conforto dal duca Alfonso. Ma se i cavalieri erranti (verso 8) vengono richiamati nella giusta via per combattere per la vera fede da Goffredo, il duca, nuovo comandante, chiamerà a sé l’errante Tasso a dargli affetto e protezione.
 Goffredo di Buglione in un anacronistico affresco del 1420 ad opera di un anonimo pittore italiano
Goffredo di Buglione in un anacronistico affresco del 1420 ad opera di un anonimo pittore italiano
Quindi il primo canto prosegue con Dio che volge lo sguardo sugli eserciti cristiani e sui loro principi, e vede Goffredo pieno di sacro ardore verso i pagani, ma gli altri principi pieni di brame (amore, gloria personale) che li fanno deviare dal loro vero compito. Allora chiama l’arcangelo Gabriele e gli ordina di andare presso Goffredo e d’imporgli la fine della guerra. A tale scopo, per sua volontà, egli sarà il comandante e chiamerà presso sé tutti gli altri principi per l’alto compito a lui affidato. A questo punto Tasso ci illustrerà i più grandi cavalieri dell’esercito cristiano, tra cui spiccano Tancredi, il cui cuore arde per la pagana Clorinda, che l’ha affascinato mentre bevono su una fontana (ma lei è restia all’amore) e Rinaldo, ancora fanciullo, ispirato da Marte, quando è in assetto da guerra e da Amore, quando è libero dalla corazza. I comandanti, anche su invito di Pietro l’Eremita accettano e si mettono in marcia verso Gerusalemme. Dall’altra parte Aladino, preoccupato, guarda le sue difese.
Canto II: Il diabolico mago Ismeno consiglia ad Aladino di rubare ai cristiani un’immagine della Madonna, che, se posta nella moschea di Gerusalemme, avrebbe reso la città inespugnabile. Ma tale immagine improvvisamente sparisce e Aladino per vendetta decide d’uccidere tutti i cristiani. Affinché ciò non avvenga s’incolpa del misfatto Sofronia, ma Olindo, innamorato di lei, s’incolpa a sua volta per liberarla. A sottrarre i due dalla morte interviene la bella guerriera Clorinda, già apparsa al cavaliere cristiano Tancredi, che se ne innamora perdutamente. Nella seconda parte del canto intervengono gli ambasciatori di Aladino, il mellifluo Alete e l’impetuoso Argante, che invitano Goffredo ad abbandonare l’impresa, se non vorrà anche l’intervento dell’esercito egiziano. Ma Goffredo risponde loro in modo risoluto e s’alza, infine, il grido di sfida di tutto il campo cristiano; ma non viene meno alle consuetudini che si usano verso gli ambasciatori e dona ad Alete un elmo e ad Argante una spada.
Canto III: la narrazione si apre con la marcia risoluta dei cristiani per la conquista di Gerusalemme, al cui approssimarsi si commuovono perché luogo della nascita di Cristo. Dall’alto di una torre vengono scorti ed Erminia li mostra ad Aladino, avendoli conosciuti in quanto è stata loro prigioniera. Clorinda intanto si muove verso i nemici, finché incontra Tancredi:
ERMINIA E TANCREDI, PRIGIONIERI D’AMORE
(17-28)
Porta sí salda la gran lancia, e in guisa
vien feroce e leggiadro il giovenetto,
che veggendolo d’alto il re s’avisa
che sia guerriero infra gli scelti eletto.
Onde dice a colei ch’è seco assisa,
e che già sente palpitarsi il petto:
«Ben conoscer déi tu per sí lungo uso
ogni cristian, benché ne l’arme chiuso.
Chi è dunque costui, che cosí bene
s’adatta in giostra, e fero in vista è tanto?»
A quella, in vece di risposta, viene
su le labra un sospir, su gli occhi il pianto.
Pur gli spirti e le lagrime ritiene,
ma non cosí che lor non mostri alquanto:
ché gli occhi pregni un bel purpureo giro
tinse, e roco spuntò mezzo il sospiro.
Poi gli dice infingevole, e nasconde
sotto il manto de l’odio altro desio:
«Oimè! bene il conosco, ed ho ben donde
fra mille riconoscerlo deggia io,
ché spesso il vidi i campi e le profonde
fosse del sangue empir del popol mio.
Ahi quanto è crudo nel ferire! a piaga
ch’ei faccia, erba non giova od arte maga.
Egli è il prence Tancredi: oh prigioniero
mio fosse un giorno! e no ’l vorrei già morto;
vivo il vorrei, perch’in me desse al fero
desio dolce vendetta alcun conforto.»
Cosí parlava, e de’ suoi detti il vero
da chi l’udiva in altro senso è torto;
e fuor n’uscí con le sue voci estreme
misto un sospir che ’ndarno ella già preme.
Clorinda intanto ad incontrar l’assalto
va di Tancredi, e pon la lancia in resta.
Ferirsi a le visiere, e i tronchi in alto
volaro e parte nuda ella ne resta;
ché, rotti i lacci a l’elmo suo, d’un salto
(mirabil colpo!) ei le balzò di testa;
e le chiome dorate al vento sparse,
giovane donna in mezzo ’l campo apparse.
Lampeggiàr gli occhi, e folgoràr gli sguardi,
dolci ne l’ira; or che sarian nel riso?
Tancredi, a che pur pensi? a che pur guardi?
non riconosci tu l’altero viso?
Quest’è pur quel bel volto onde tutt’ardi;
tuo core il dica, ov’è il suo essempio inciso.
Questa è colei che rinfrescar la fronte
vedesti già nel solitario fonte.
Ei ch’al cimiero ed al dipinto scudo
non badò prima, or lei veggendo impètra;
ella quanto può meglio il capo ignudo
si ricopre, e l’assale; ed ei s’arretra.
Va contra gli altri, e rota il ferro crudo;
ma però da lei pace non impetra,
che minacciosa il segue, e: «Volgi» grida;
e di due morti in un punto lo sfida.
Percosso, il cavalier non ripercote,
né sí dal ferro a riguardarsi attende,
come a guardar i begli occhi e le gote
ond’Amor l’arco inevitabil tende.
Fra sé dicea: «Van le percosse vote
talor, che la sua destra armata stende;
ma colpo mai del bello ignudo volto
non cade in fallo, e sempre il cor m’è colto.»
Risolve al fin, benché pietà non spere,
di non morir tacendo occulto amante.
Vuol ch’ella sappia ch’un prigion suo fere
già inerme, e supplichevole e tremante;
onde le dice: «O tu, che mostri avere
per nemico me sol fra turbe tante,
usciam di questa mischia, ed in disparte
i’ potrò teco, e tu meco provarte.
Cosí me’ si vedrà s’al tuo s’agguaglia
il mio valore». Ella accettò l’invito:
e come esser senz’elmo a lei non caglia,
gía baldanzosa, ed ei seguia smarrito.
Recata s’era in atto di battaglia
già la guerriera, e già l’avea ferito,
quand’egli: «Or ferma», disse «e siano fatti
anzi la pugna de la pugna i patti».
Fermossi, e lui di pauroso audace
rendé in quel punto il disperato amore.
«I patti sian», dicea «poi che tu pace
meco non vuoi, che tu mi tragga il core.
Il mio cor, non piú mio, s’a te dispiace
ch’egli piú viva, volontario more:
è tuo gran tempo, e tempo è ben che trarlo
omai tu debbia, e non debb’io vietarlo.
Ecco io chino le braccia, e t’appresento
senza difesa il petto: or ché no ’l fiedi?
vuoi ch’agevoli l’opra? I’ son contento
trarmi l’usbergo or or, se nudo il chiedi».
Distinguea forse in piú duro lamento
i suoi dolori il misero Tancredi,
ma calca l’impedisce intempestiva
de’ pagani e de’ suoi che soprarriva.
 Paolo Finoglio: Tancredi e Clorinda
Paolo Finoglio: Tancredi e Clorinda
Impugna così saldamente la lunga lancia ed avanza in un modo al contempo gentile e fiero il giovane (Tancredi) che, vedendolo dalla torre, il re (Aladino) suppone che sia scelto fra i guerrieri eletti. Quindi dice a colei (Erminia) che sta seduta vicina a lui e che già sente battere forte il cuore: «Per averli frequentati a lungo, tu devi ben conoscere tutti i cristiani, anche se sono nascosti nelle loro armature. // Chi è dunque costui, che si prepara così bene al combattimento ed è così fiero nell’aspetto?» Ad Erminia, invece della risposta, viene sulle labbra un sospiro e negli occhi il pianto. Ella trattiene i sospiri e le lacrime ma non fino al punto di non mostrarli per nulla: un delicato rossore si diffonde intorno agli occhi gonfi di pianto e il sospiro a metà si fa rauco. // Poi, fingendo e nascondendo sotto un falso odio un diverso desiderio (l’amore per Tancredi) dice ad Aladino: «Ahimè! Lo conosco bene ed ho buoni motivi per riconoscerlo tra altri mille cavalieri, poiché spesso lo vidi riempire i campi di battaglia e le fosse del sangue del mio popolo. Ah quanto è crudele nel colpire! Per guarire le ferite da lui inferte non servono le erbe medicamentose né la magia. // Egli è il principe Tancredi: oh fosse mio prigioniero un giorno! E non lo vorrei morto, lo vorrei vivo, perché la dolce vendetta possa dare qualche sollievo al mio crudele desiderio». Così ella parlava, e chi ascoltava le sue parole ne interpretava in altro modo il senso; e mescolato con le sue ultime parole uscì un sospiro, che invano lei tentò di soffocare. // Clorinda intanto va a contrastare l’assalto di Tancredi, lancia in resta. Si colpirono sulle visiere degli elmi e i pezzi delle lance infrante volarono alti, a Clorinda rimase scoperta una parte del volto, perché rotti i lacci che lo tenevano fermo, l’elmo le cadde dalla testa; ella si rivelò quindi, in mezzo al campo di battaglia, come una giovane donna dai capelli biondi sparsi al vento. // I suoi occhi lampeggiarono e i suoi sguardi furono folgoranti, dolci anche nella rabbia: come sarebbero, allora, nella gioia dell’amore? Tancredi, a che cosa pensi ancora? Che cosa guardi ancora? Non riconosci quel viso altero? Questo è il viso per cui ardi tutto d’amore, te lo dica il tuo cuore dove è impressa la sua immagine. Questo è la donna che vedesti rinfrescarsi la fronte nella fonte solitaria. // Tancredi, che prima non aveva badato al pennacchio e all’insegna raffigurata nello scudo, ora vedendola rimane impietrito; lei si copre per quanto può il capo nudo e attacca Tancredi: egli indietreggia, va all’assalto di altri guerrieri ruotando la spada crudele, ma non ottiene tregua da lei, che lo segue minacciosa e grida: «Girati» e di due morti insieme lo minaccia. // Colpito, il cavaliere non risponde ai colpi, e non è accorto a difendersi dalla spada come, invece, è attento a contemplare i begli occhi e il volto da cui Amore tende l’arco al quale non si può sfuggire. Diceva fra sé: «A volte vanno a vuoto i colpi portati dal suo braccio, mai un colpo del suo bel volto cade nel vuoto: il mio cuore né è sempre colpito». // Decide infine, benché non speri in alcuna pietà, di non morire tacendo come un amante segreto. Vuole che lei sappia che sta colpendo un suo prigioniero indifeso, supplice e tremante, per cui le dice: «O tu, che fra tutti questi combattenti sembri avere solo me come nemico, usciamo da questa mischia così io potrò misurarmi in disparte con te, e tu provarti con me. // Così si vedrà se al tuo valore si avvicina il mio». Ella accettò l’invito e, come se l’essere senza elmo non le importasse, andava baldanzosa ed egli la seguiva smarrito. Già si era disposta a combattere e già aveva ferito Tancredi, quando egli disse: «Fermati, prima che il duello inizi, ne siano fissate le regole» // Lei si fermò, e l’amore disperato rese coraggioso lui che fino a quel punto era stato timoroso. Diceva: «I patti siano, poiché non vuoi essere in pace con me, che allora tu mi strappi il cuore. Il mio cuore, che non è più mio, se tu non vuoi che viva, è pronto ad accettare la morte: esso è tuo da molto tempo, e ora che tu lo prenda ed io non debba impedirtelo. // Ecco, io abbasso le braccia e ti offro il petto senza difesa: perché non lo colpisci? Vuoi che ti agevoli l’opera? Io sono contento di togliermi la corazza, proprio ora, se vuoi che il mio petto sia nudo». Il povero Tancredi forse avrebbe potuto esprimersi con parole più struggenti il suo profondo tormento, ma glielo impedì il sopraggiungere inopportuno delle truppe pagane e cristiane.

Tancredi d’Altavilla
L’inizio del canto è ripreso dal modello omerico e prende il nome di teichoscopìa (guardare dall’alto delle mura della città): come Elena indica a Priamo i grandi eroi dell’esercito greco, Erminia fa lo stesso con i cavalieri cristiani. Ma qui l’episodio omerico si complica sentimentalmente, trasformando un episodio epico in un episodio lirico. Infatti quello che emerge in questo passo del terzo canto è uno dei temi che contraddistinguerà l’intera opera: il tema dell’amore impossibile. Infatti gli episodi sono due e ambedue strettamente legati: Erminia dalla torre vede Tancredi, di cui è fortemente innamorata, ma egli non può riamarla perché è a sua volta profondamente innamorato di Clorinda, che rifiuta il suo amore, perché donna-guerriera. Quindi Erminia e Clorinda, musulmane entrambe, rappresentano donne contrapposte: l’una tutta emozioni, l’altra tutta azione; e vengono significativamente posta una sull’alto di una torre; l’altra in pieno campo di battaglia. Tancredi, preda, da ambedue è disegnato come “passivo”: sordo all’amore di Erminia, succube di Clorinda. Non è un caso che egli impetri il suo amore, svestendosi della propria identità di cavaliere e addirittura della propria vita. Ma non ultimo, nella parte iniziale, la duplicità delle parole tassiane nel discorso di Erminia, ed è l’autore stesso a significarci l’ambiguità di fondo quando afferma de’ suoi detti il vero da chi l’udiva in altro senso è torto.
Il canto prosegue con l’approcciarsi dell’esercito pagano in fuga e del cristiano all’inseguimento. Un soldato di questi, passando dietro a Clorinda, vede parte del capo scoperta e la ferisce lievemente. Appena Tancredi se ne accorge, lo ferisce e alla sua fuga si dà all’inseguimento. Clorinda, li guarda un po’, poi si unisce ai suoi compagni e caccia i cristiani che può colpire e fugge da quelli che potrebbero a loro volta colpire. I soldati pagani indietreggiano e tentano di ripiegare dentro le mura. I cristiani vengono quasi accerchiati dal loro ripiegamento; infatti Argante, collocato su una collina, li attacca con un piccolo drappello d’artiglieria. Si riaccende la battaglia, da una parte Clorinda ed Armida, dall’altra il principe Dudone, danno vita ad un intenso scontro, finché giungono Tancredi e Rinaldo che riescono a indebolire il fronte avversario. Argante riceve da Tancredi un colpo, ma il suo cavallo è colpito; mentre tenta di liberarsi, Argante uccide Dudone, proprio con la spada, dono di Goffredo. Rinaldo vorrebbe sin da subito vendicare il cavaliere ucciso, ma viene fermato da Goffredo che decide di scavare fossati e trincee attorno alla città. Si fanno solenni esequie verso Dudone. Subito dopo si entra nella foresta da cui trarre la legna per fabbricare le armi d’assedio.

Immagine per il canto IV
Canto IV: Il Diavolo, deciso di difendere la città dai cristiani, indice un concilio:
IL CONCILIO INFERNALE
(3-6)
Chiama gli abitator de l’ombre eterne
il rauco suon de la tartarea tromba.
Treman le spaziose atre caverne,
e l’aer cieco a quel romor rimbomba;
né sí stridendo mai da le superne
regioni del cielo il folgor piomba,
né sí scossa giamai trema la terra
quando i vapori in sen gravida serra.
Tosto gli dèi d’Abisso in varie torme
concorron d’ogn’intorno a l’alte porte.
Oh come strane, oh come orribil forme!
quant’è ne gli occhi lor terrore e morte!
Stampano alcuni il suol di ferine orme,
E ’n fronte umana han chiome d’angui attorte,
e lor s’aggira dietro immensa coda
Che quasi sferza si ripiega, e snoda.
Qui mille immonde Arpie vedresti e mille
Centauri e Sfingi e pallide Gorgoni,
molte e molte latrar voraci Scille,
e fischiar Idre e sibilar Pitoni,
e vomitar Chimere atre faville,
e Polifemi orrendi e Gerioni;
e in novi mostri, e non piú intesi o visti,
diversi aspetti in un confusi e misti.
Chiama i diavoli dell’inferno il suono rauco della tromba infernale. Tremano gli scuri anfratti e l’aria nera rimbomba a quel rumore; mai la folgore piomba dall’alto del cielo in modo così assordante, mai la terra trema scossa dai vapori che piena trattiene. // Subito gli dei infernali accorrono da tutte le parti in varie schiere verso la reggia di Satana. Oh, che forme orribili; oh, che forme strane! Quanto terrore e morte c’è nei loro sguardi! Alcuni camminano con i piedi d’animali feroci e hanno sulla fronte capelli di serpenti ritorti e dietro loro c’è un’immensa coda, che sferza, si piega e si snoda. // Qui si possono vedere tantissime orribili Arpie, e tantissimi Centauri, Sfingi, pallide Gorgoni, moltissime Scille lamentarsi latrando, Idri soffiare, Pitoni strisciare e le Chimere vomitare scure scintille e spaventosi Polifemi e Gerioni; ed anche nuovi mostri, mai sentiti e visti, mescolati e confusi in diverse forme.
In questo passo, il poeta mostra una straordinaria capacità di utilizzare diverse fonti: la prima è soprattutto virgiliana, ma non manca la lettura attenta di Dante e degli scrittori cristiani del Cinquecento.
In questo concilio si decide che il mago Idraote, re di Damasco, ordini a sua nipote Armida di recarsi in campo cristiano in apparenza per chiedere ai cavalieri aiuto, in realtà per distoglierli dalla guerra:
LA MAGA ARMIDA
(29-36)
Argo non mai, non vide Cipro o Delo
d’abito o di beltà forme sí care:
d’auro ha la chioma, ed or dal bianco velo
traluce involta, or discoperta appare.
Cosí, qualor si rasserena il cielo,
or da candida nube il sol traspare,
or da la nube uscendo i raggi intorno
piú chiari spiega e ne raddoppia il giorno.
Fa nove crespe l’aura al crin disciolto,
che natura per sé rincrespa in onde;
stassi l’avaro sguardo in sé raccolto,
e i tesori d’amore e i suoi nasconde.
Dolce color di rose in quel bel volto
fra l’avorio si sparge e si confonde,
ma ne la bocca, onde esce aura amorosa,
sola rosseggia e semplice la rosa.
Mostra il bel petto le sue nevi ignude,
onde il foco d’Amor si nutre e desta.
Parte appar de le mamme acerbe e crude,
parte altrui ne ricopre invida vesta:
invida, ma s’a gli occhi il varco chiude,
l’amoroso pensier già non arresta,
ché non ben pago di bellezza esterna
ne gli occulti secreti anco s’interna.
Come per acqua o per cristallo intero
trapassa il raggio, e no ’l divide o parte,
per entro il chiuso manto osa il pensiero
sí penetrar ne la vietata parte.
Ivi si spazia, ivi contempla il vero
di tante meraviglie a parte a parte;
poscia al desio le narra e le descrive,
e ne fa le sue fiamme in lui piú vive.
Lodata passa e vagheggiata Armida
fra le cupide turbe, e se n’avede.
No ’l mostra già, benché in suo cor ne rida,
e ne disegni alte vittorie e prede.
Mentre, sospesa alquanto, alcuna guida
che la conduca al capitan richiede,
Eustazio occorse a lei, che del sovrano
principe de le squadre era germano.
Come al lume farfalla, ei si rivolse
a lo splendor de la beltà divina,
e rimirar da presso i lumi volse
che dolcemente atto modesto inchina;
e ne trasse gran fiamma e la raccolse
come da foco suole esca vicina,
e disse verso lei, ch’audace e baldo
il fea de gli anni e de l’amore il caldo:
«Donna, se pur tal nome a te conviensi,
ché non somigli tu cosa terrena,
né v’è figlia d’Adamo in cui dispensi
cotanto il Ciel di sua luce serena,
che da te si ricerca? ed onde viensi?
qual tua ventura o nostra or qui ti mena?
Fa’ che sappia chi sei, fa’ ch’io non erri
ne l’onorarti; e s’è ragion, m’atterri»
Risponde: «Il tuo lodar troppo alto sale,
né tanto in suso il merto nostro arriva.
Cosa vedi, signor, non pur mortale,
ma già morta a i diletti, al duol sol viva;
mia sciagura mi spinge in loco tale,
vergine peregrina e fuggitiva.
Ricovro al pio Goffredo, e in lui confido
tal va di sua bontate intorno il grido.
Mai Argo, mai Cipro, né Delo videro un così bel portamento o un così bel corpo: (Armida) ha i capelli biondi ed appaiono ora avvolti da un velo bianco, ora completamente scoperti. Così, a volte si rasserena il cielo, o il sole appare appena coperto da una candida nube, oppure i raggi del sole, uscendo dietro una nuvola, si irradiano più chiari e raddoppiano la loro luminosità. // L’aria intorno le crea nuovi riccioli, già per natura ondulati. Il timido sguardo sta chiuso in sé e nasconde le sue armi d’amore e i suoi sguardi. Dolce color rosa si sparge e si mescola in quel bel volto bianco come l’avorio, ma nella bocca, da cui escono sospiri d’amore, sola e semplice risplende la rosa (il color rosa). // Mostra il petto il suo candore, da cui trova alimento il fuoco d’Amore. Appare una parte delle mammelle turgide e crudeli (per le ferite d’amore), un’altra la nasconde la gelosa veste; gelosa, ma se sottrae allo sguardo (le bellezze custodite) il pensiero d’amore non si ferma, perché non appagato da ciò che appare, s’addentra nei segreti interni. // Come un raggio di luce attraversa l’acqua o il cristallo rimanendo intero senza dividerlo o frantumarlo, il pensiero osa entrare così profondamente nei luoghi ricoperti dalla veste. Qui trova spazio e trova la certezza di tanta meraviglia in ogni parte; poi (il pensiero) le racconta e le descrive al desiderio, e rende le fiamme d’amore ancor più vive. // Lodata e desiderata passa Armida tra i desiderosi soldati e se ne rende conto. Non lo dà a vedere, benché ne goda e ne tragga motivo per progettare vittorie amorose e prede di amanti: Mentre piuttosto dubbiosa chiede che qualcuno la guidi dal capitano, Eustazio si presentò a lei, che era fratello minore del capo delle truppe cristiane. // Come una farfalla verso la luce, egli volle ammirare da vicino gli occhi (di Armida), che un atto di pudore fa dolcemente abbassare e ne derivò una gran fiamma d’amore e la raccolse come dal fuoco è solito raccogliere un’esca vicina, e disse verso la donna, che lo rendevano audace e e fiero nella giovanile età e pronto all’amore: // «Donna, se tale nome a te si conviene, perché non somigli a una donna terrena, non c’è figlia d’Adamo in cui il Cielo abbia voluto mostrare così tanto la sua serena luce, che cosa stai cercando? E da dove vieni? Quale tuo o nostro destino, ti conduce qui? Dimmi chi sei, affinché io non erri nel renderti onore e se è giusto che io mi prostri davanti a te, come cosa divina». // Risponde: «La tua lode vola troppo in alto, non così il nostro merito. Tu vedi una donna, o cavaliere, non solo mortale, ma già morta ai piaceri e viva solo al dolore; la mia sventura mi spinge in questo luogo, vergine pellegrina e in fuga. Mi rifugio presso il pio Goffredo, e confido in lui, tale è la fama della sua virtù».
L’apparizione di Armida rappresenta la sensualità, l’eros represso dei cavalieri, che attraverso lei riscoprono il loro essere uomini peccatori e non cavalieri integerrimi al cospetto di Dio (così si presenta a lei Eustazio, fratello più giovane di Goffredo). Ma lei, proprio per questo è demoniaca, così come l’austero medioevo aveva disegnato la donna, così come la Chiesa controriformistica voleva riproporre: il poeta indugia sul suo corpo, come un guerriero fa di fronte ad un’apparizione estranea, inusuale in un campo di battaglia; i capelli e il bianco viso rimandano ad una ispirazione petrarchesca, ma Tasso va oltre e ci fa soffermare lo sguardo sulle mammelle, trattenute a stento da una veste e sul pensiero che varca l’abito alla scoperta della sua nudità. La voluttà dei sensi contro il dovere della guerra; nel periodo tassiano peccato contro salvezza.

Jacques Blanchard: Armida
Quindi Eustazio la porta da Goffredo, a cui lei racconta, da attrice consumata le sue peripezie: figlia del re di Damasco, rimasta orfana fu affidata allo zio. Costui pensa di farne la moglie del figlio, ma quest’ultimo è rozzo e villano, pertanto rifiuta le nozze. Il malvagio zio, temendola in quanto erede legittima, pensa di darle il veleno, ma, avvisata dal ministro Aronte, fugge, e si rifugia nel suo castello. L’usurpatore, diffamandola, vuole attaccar battaglia contro ambedue. Per questo lei chiede aiuto a Goffredo offrendogli tributi e fedeltà, se l’aiuterà ad ottenere la libertà. Ma Goffredo non fidandosi e temendo d’indebolire l’esercito, promette d’aiutarla dopo aver liberato Gerusalemme. Allora lei scoppia in un pianto disperato, maledicendo la propria sfortuna. Eustazio prende le sue difese e, adducendo la norma cavalleresca secondo cui un cavaliere di ventura deve difendere una donna, convince molti cavalieri. A Goffredo non rimane che affidarle dieci cavalieri, scelti proprio da Eustazio.
Canto V: strettamente legato al precedente. Armida con le armi ammaliatrici cerca di conquistare quanti più cavalieri possibili, per indebolire l’esercito avversario. Nel frattempo Goffredo dispone che i cavalieri di ventura eleggano un capo in sostituzione di Dudone. Eustazio lo chiede a Rinaldo, sperando in un suo rifiuto. Ma la candidatura di Rinaldo irrita Gernando, orgoglioso discendente del re di Svezia. Spinto da una furia infernale la sua ira cresce a tal punto che non esita ad oltraggiare Rinaldo in campo aperto: il giovane cavaliere, colpito nell’onore, allora sfida apertamente Gernando e lo uccide. Il gesto di Rinaldo non può essere, tuttavia, ignorato; accusato da Arnaldo e difeso da Tancredi, vene consigliato dallo stesso Goffredo ad allontanarsi dal campo, finché le acque non si plachino. Intanto Armida continua la sua opera di seduzione anche con Tancredi e Goffredo: ma il primo non si lascia irretire, fermo nella pietas cristiana e nell’esperienza della vita e il secondo ha il cuore occupato solo dalla bella Clorinda. Nel giorno stabilito Armida si presenta a Goffredo per ricevere l’aiuto promesso; il Capitano fa scrivere i nomi dei cavalieri e li fa porre in un’urna da cui vengono estratti i nomi dei dieci “fortunati” che partiranno con lei; ma altri, come Eustazio, la seguono. Alla fine arriva un messaggero polveroso che annuncia a Goffredo l’arrivo dell’esercito egiziano.
Canto VI: Il re Aladino sovrintende ai lavori di rafforzamento per Gerusalemme, ma Argante gli rimprovera di essere poco coraggioso; quindi propone una sfida con cinque grandi cavalieri cristiani. Viene mandato un araldo in campo cristiano: la proposta viene accettata. Argante esce dalla città accompagnato da Clorinda e da mille cavalieri, secondo la volontà del re Aladino. Va incontro a lui Tancredi, ma vista Clorinda e rimanendone ammaliato cerca di raggiungerla; allora si lancia in duello Ottone, che viene abbattuto; Tancredi, infine, si riprende e ingaggia un grandioso duello con Argante: ma la notte interrompe il combattimento e i due vengono divisi. Tutti hanno ammirato l’arduo scontro tra i due campioni, solo Erminia ha sofferto vedendo il duello dalla torre del castello. Vuole ora accorrere dall’amato e curargli la ferite, col cuore che oscilla tra l’amore per Tancredi e l’onore per la sua bandiera. Erminia, infine, decisa per l’amore, vedendo le armi di Clorinda appese alla parete, decide di vestirsene, di uscire dalla città, sicura che le guardie non l’avrebbero fermata, e di andare verso il campo cristiano.
ERMINIA NELLA NOTTE
(90-103)
Essa veggendo il ciel d’alcuna stella
già sparso intorno divenir piú nero,
senza fraporvi alcuno indugio appella
secretamente un suo fedel scudiero
ed una sua leal diletta ancella,
e parte scopre lor del suo pensiero.
Scopre il disegno de la fuga, e finge
ch’altra cagion a dipartir l’astringe.
Lo scudiero fedel súbito appresta
ciò ch’al lor uopo necessario crede.
Erminia intanto la pomposa vesta
si spoglia, che le scende insino al piede,
e in ischietto vestir leggiadra resta
e snella sí ch’ogni credenza eccede;
né, trattane colei ch’a la partita
scelta s’avea, compagna altra l’aita.
Co ’l durissimo acciar preme ed offende
il delicato collo e l’aurea chioma,
e la tenera man lo scudo prende,
pur troppo grave e insopportabil soma.
Cosí tutta di ferro intorno splende,
e in atto militar se stessa doma.
Gode Amor ch’è presente, e tra sé ride,
come allor già ch’avolse in gonna Alcide.
Oh! con quanta fatica ella sostiene
l’inegual peso e move lenti i passi,
ed a la fida compagnia s’attiene
che per appoggio andar dinanzi fassi.
Ma rinforzan gli spirti Amore e spene
e ministran vigore a i membri lassi,
sí che giungono al loco ove le aspetta
lo scudiero, e in arcion sagliono in fretta.
Travestiti ne vanno, e la piú ascosa
e piú riposta via prendono ad arte,
pur s’avengono in molti e l’aria ombrosa
veggon lucer di ferro in ogni parte;
ma impedir lor viaggio alcun non osa,
e cedendo il sentier ne va in disparte,
ché quel candido ammanto e la temuta
insegna anco ne l’ombra è conosciuta.
Erminia, benché quinci alquanto sceme
del dubbio suo, non va però secura,
ché d’essere scoperta a la fin teme
e del suo troppo ardir sente or paura;
ma pur, giunta a la porta, il timor preme
ed inganna colui che n’ha la cura.
«Io son Clorinda», disse «apri la porta,
ché ’l re m’invia dove l’andare importa».
La voce feminil sembiante a quella
de la guerriera agevola l’inganno
(chi crederia veder armata in sella
una de l’altre ch’arme oprar non sanno?),
sí che ’l portier tosto ubidisce, ed ella
n’esce veloce e i duo che seco vanno;
e per lor securezza entro le valli
calando prendon lunghi obliqui calli.
Ma poi ch’Erminia in solitaria ed ima
parte si vede, alquanto il corso allenta,
ch’i primi rischi aver passati estima,
né d’esser ritenuta omai paventa.
Or pensa a quello a che pensato in prima
non bene aveva; ed or le s’appresenta
difficil piú ch’a lei non fu mostrata
dal frettoloso suo desir, l’entrata.
Vede or che sotto il militar sembiante
ir tra feri nemici è gran follia;
né d’altra parte palesarsi, inante
ch’al suo signor giungesse, altrui vorria.
A lui secreta ed improvisa amante
con secura onestà giunger desia;
onde si ferma, e da miglior pensiero
fatta piú cauta parla al suo scudiero:
«Essere, o mio fedele, a te conviene
mio precursor, ma sii pronto e sagace.
Vattene al campo, e fa’ ch’alcun ti mene
e t’introduca ove Tancredi giace,
a cui dirai che donna a lui ne viene
che gli apporta salute e chiede pace:
pace, poscia ch’Amor guerra mi move,
ond’ei salute, io refrigerio trove;
e ch’essa ha in lui sí certa e viva fede
ch’in suo poter non teme onta né scorno.
Di’ sol questo a lui solo; e s’altro ei chiede,
di’ non saperlo e affretta il tuo ritorno.
Io (ché questa mi par secura sede)
in questo mezzo qui farò soggiorno».
Cosí disse la donna, e quel leale
gía veloce cosí come avesse ale.
E ’n guisa oprar sapea, ch’amicamente
entro a i chiusi ripari era raccolto,
e poi condotto al cavalier giacente,
che l’ambasciata udia con lieto volto;
e già lasciando ei lui, che ne la mente
mille dubbi pensier avea rivolto,
ne riportava a lei dolce risposta:
ch’entrar potrà, quando piú lice, ascosta.
Ma ella intanto impaziente, a cui
troppo ogni indugio par noioso e greve,
numera fra se stessa i passi altrui
e pensa: «or giunge, or entra, or tornar deve».
E già le sembra, e se ne duol, colui
men del solito assai spedito e leve.
Spingesi al fine inanti, e ’n parte ascende
onde comincia a discoprir le tende.
Era la notte, e ’l suo stellato velo
chiaro spiegava e senza nube alcuna
e già spargea rai luminosi e gelo
di vive perle la sorgente luna.
L’innamorata donna iva co ’l cielo
le sue fiamme sfogando ad una ad una,
e secretari del suo amore antico
fea i muti campi e quel silenzio amico.
 Julien de Parme. Erminia indossa l’armatura di Clorinda (1775)
Julien de Parme. Erminia indossa l’armatura di Clorinda (1775)
Erminia, vedendo il cielo già trapunto di stelle farsi sempre più scuro, senza indugio chiama segretamente un fedele scudiero e una cara e fedele ancella e li mette al corrente, almeno in parte, del suo piano. Svela il suo progetto di fuga, ma finge che siano altri i motivi che la inducono a partire. // Lo scudiero fedele subito prepara ciò che ritiene necessario allo scopo. Erminia, intanto, si spoglia della sfarzosa veste, che le scende fino ai piedi, per rimanere comunque bellissima vestita in modo semplice succinto e snella più di quanto si potrebbe credere, né l’aiuta nessun’altra all’infuori di colei che si era scelta come compagna per la salvezza. // Così il durissimo acciaio preme ed appesantisce il suo delicato collo e la chioma dorata, e la tenera mano afferra lo scudo, benché sia un peso troppo grande e insopportabile. Così Erminia splende tutta ricoperta di ferro e con un atteggiamento militare doma la propria natura di donna. Amore, che assiste alla vestizione, gode e ride tra sé, come quando costrinse Ercole a vestire abiti femminili. // Oh con quanta fatica Erminia sostiene il peso sproporzionato alle sue forze e muove i passi lentamente, e alla fidata compagna si sostiene che va davanti a lei, per fornirle l’appoggio. Ma l’amore e la speranza rinforzano gli spiriti vitali e forniscono forza alle membra infiacchite, finché giungono nel luogo dove le aspetta lo scudiero e salgono in fretta sul cavallo. // Vanno travestiti, e prendono di proposito la via più lontana e nascosta, eppure incontrano molte persone e l’aria scura rifulge in ogni luogo dal balenio del ferro delle armi; ma nessuno osa impedire il loro cammino, e cedendo il passo si mette in disparte, che la bianca armatura (di Clorinda) e l’insegna temuta è da tutti riconosciuta. // Erminia, benché da questo fatto si senta meno dubbiosa, non è però del tutto rassicurata perché teme alla fine d’essere scoperta e del suo ardire ora prova paura; ma pure, giunta alla porta, soffoca il timore e inganna colui che vi è preposto. Disse: «Sono Clorinda, apri la porta, perché il re mi manda dove è necessario che io vada». // La voce femminile, simile a quella della guerriera, facilita l’inganno (chi avrebbe creduto vedere armata in sella un’altra donna incapace d’adoperare le armi?) tanto che il portiere subito ubbidisce, e lei, con i due che stanno insieme, esce veloce e per sicurezza, scendendo dentro la valle prendono lunghi e tortuosi cammini. // Mai poi che Erminia si vede in un solitario e profondo luogo, rallenta la corsa, perché crede d’aver superato i primi ostacoli, né teme di esser più trattenuta. Solo ora pensa a ciò che prima non aveva soppesato bene; ora le sovviene la difficoltà dell’entrata (nel campo cristiano) che non le fu mostrata dall’impetuoso suo desiderio. // Comprende ora che sotto l’armatura di Clorinda andare tra i nemici è gran follia, né vorrebbe mostrarsi ad altri, prima di giungere al suo signore (Tancredi); desidera arrivare a lui sicura del suo onore, come segreta ed improvvisa amante; perciò si ferma e resa più cauta, con maggior ponderazione, parla al suo scudiero: «O mio fedele, è necessario che tu mi preceda, ma sii pronto e astuto. Vai al campo (cristiano), e fa in modo che qualcuno ti conduca da Tancredi ferito, e gli dirai che a lui s’avvicinerà una donna che porterà salvezza e pace; pace, dal momento in cui Amore mi muove guerra, e dove egli trovi salvezza, che io possa trovare sollievo; e che lei ha così fiducia in lui che non teme, sotto la sua protezione, di ricevere offese e umiliazioni. Digli soltanto questo, e se lui chiede altro, digli di non saperlo e affretta il tuo ritorno. Io (che questo mi sembra un luogo sicuro) in questo posto aspetterò». Così disse la donna e quello scudiero leale già correva, come avesse le ali. // E sapeva destreggiarsi in quest’opera, tanto da essere raccolto amichevolmente entro il campo, e quindi condotto da Tancredi ferito, che ascoltò l’ambasciata con volto lieto; e già mentre lo lasciava, perché nella mente combattevano mille pensieri, faceva riportare a lei una dolce risposta: che potrà entrare, quanto più vuole, nascosta. // Ma lei nel frattempo, impaziente, a cui ogni attesa sembra troppo incresciosa e grave, conta in se stessa le mosse dello scudiero e pensa: «Ora arriva, ora entra, ora comincia a tornare». E già le sembra, e se ne dispiace, molto meno svelto del solito. Si spinge infine un poco avanti e sale da dove comincia a vedere le tende. // Era notte, e il suo stellato cielo dispiegava chiaro, senza alcuna nuvola, e già la sorgente luna spargeva i suoi aloni luminosi e rugiada di vive perle. La donna innamorata va sfogando con il cielo le sue fiamme d’amore e testimoni segreti della sua passione rende i campi e quel silenzio amico.
Il personaggio d’Erminia, nella notte, vestendosi da Clorinda, va verso l’innamorato ferito. Ma ciò che manca in lei è la risolutezza. Il suo stato d’animo, infatti, è tormentato da dubbi, mosso tra paura e desiderio, tra amore e dovere. Vorrebbe essere forte, decisa, risoluta, ma sa di non esserlo. Allora ci prova, vestendosi come Clorinda, cioè prendendone il posto, e sognando, per una volta, ad essere ciò che non è. In Erminia, infatti, troviamo vari stati d’animo ed un vissuto interiorizzato che ne fanno un personaggio “moderno”: ella, cioè sembra collocarsi tra la fine dell’epica e l’inizio del romanzo contemporaneo. Ciò è esemplificativo del bifrontismo tassiano: Erminia già sulla torre mostrava di dire cose contrarie al suo sentire, qui invece si copre di ferro, mentre dentro è fragile; instabilità psicologica, volontà scissa tra l’essere e il voler essere: il suo è un personaggio fortemente anti epico.
Il canto prosegue con Erminia ansiosa, ma un raggio di luna colpisce il suo cimiero, che viene riconosciuto da alcuni cavalieri cristiani che la scambiano per Clorinda. Viene quindi assalita ed è costretta a fuggire.

Eugène Delacroix: Erminia (1856)
Il canto VII si apre con la fuga di Erminia:
LA PARENTESI IDILLICA DI ERMINIA
(1 – 22)
Intanto Erminia infra l’ombrose piante
d’antica selva dal cavallo è scorta,
né piú governa il fren la man tremante,
e mezza quasi par tra viva e morta.
Per tante strade si raggira e tante
il corridor ch’in sua balia la porta,
ch’al fin da gli occhi altrui pur si dilegua,
ed è soverchio omai ch’altri la segua.
Qual dopo lunga e faticosa caccia
tornansi mesti ed anelanti i cani
che la fèra perduta abbian di traccia,
nascosa in selva da gli aperti piani,
tal pieni d’ira e di vergogna in faccia
riedono stanchi i cavalier cristiani.
Ella pur fugge, e timida e smarrita
non si volge a mirar s’anco è seguita.
Fuggí tutta la notte, e tutto il giorno
errò senza consiglio e senza guida,
non udendo o vedendo altro d’intorno,
che le lagrime sue, che le sue strida.
Ma ne l’ora che ’l sol dal carro adorno
scioglie i corsieri e in grembo al mar s’annida,
giunse del bel Giordano a le chiare acque
e scese in riva al fiume, e qui si giacque.
Cibo non prende già, ché de’ suoi mali
solo si pasce e sol di pianto ha sete;
ma ’l sonno, che de’ miseri mortali
è co ’l suo dolce oblio posa e quiete,
sopí co’ sensi i suoi dolori, e l’ali
dispiegò sovra lei placide e chete;
né però cessa Amor con varie forme
la sua pace turbar mentre ella dorme.
Non si destò fin che garrir gli augelli
non sentí lieti e salutar gli albori,
e mormorar il fiume e gli arboscelli,
e con l’onda scherzar l’aura e co i fiori.
Apre i languidi lumi e guarda quelli
alberghi solitari de’ pastori,
e parle voce udir tra l’acqua e i rami
ch’a i sospiri ed al pianto la richiami.
Ma son, mentr’ella piange, i suoi lamenti
rotti da un chiaro suon ch’a lei ne viene,
che sembra ed è di pastorali accenti
misto e di boscareccie inculte avene.
Risorge, e là s’indrizza a passi lenti,
e vede un uom canuto a l’ombre amene
tesser fiscelle a la sua greggia a canto
ed ascoltar di tre fanciulli il canto.
Vedendo quivi comparir repente
l’insolite arme, sbigottír costoro;
ma li saluta Erminia e dolcemente
gli affida, e gli occhi scopre e i bei crin d’oro:
«Seguite», dice «aventurosa gente
al Ciel diletta, il bel vostro lavoro,
ché non portano già guerra quest’armi
a l’opre vostre, a i vostri dolci carmi».
Soggiunse poscia: «O padre, or che d’intorno
d’alto incendio di guerra arde il paese,
come qui state in placido soggiorno
senza temer le militari offese?»
«Figlio», ei rispose «d’ogni oltraggio e scorno
la mia famiglia e la mia greggia illese
sempre qui fur, né strepito di Marte
ancor turbò questa remota parte.
O sia grazia del Ciel che l’umiltade
d’innocente pastor salvi e sublime,
o che, sí come il folgore non cade
in basso pian ma su l’eccelse cime,
cosí il furor di peregrine spade
sol de’ gran re l’altere teste opprime,
né gli avidi soldati a preda alletta
la nostra povertà vile e negletta.
Altrui vile e negletta, a me sí cara
che non bramo tesor né regal verga,
né cura o voglia ambiziosa o avara
mai nel tranquillo del mio petto alberga.
Spengo la sete mia ne l’acqua chiara,
che non tem’io che di venen s’asperga,
e questa greggia e l’orticel dispensa
cibi non compri a la mia parca mensa.
Ché poco è il desiderio, e poco è il nostro
bisogno onde la vita si conservi.
Son figli miei questi ch’addito e mostro,
custodi de la mandra, e non ho servi.
Cosí me ’n vivo in solitario chiostro,
saltar veggendo i capri snelli e i cervi,
ed i pesci guizzar di questo fiume
e spiegar gli augelletti al ciel le piume.
Tempo già fu, quando piú l’uom vaneggia
ne l’età prima, ch’ebbi altro desio
e disdegnai di pasturar la greggia;
e fuggii dal paese a me natio,
e vissi in Menfi un tempo, e ne la reggia
fra i ministri del re fui posto anch’io,
e benché fossi guardian de gli orti
vidi e conobbi pur l’inique corti.
Pur lusingato da speranza ardita
soffrii lunga stagion ciò che piú spiace;
ma poi ch’insieme con l’età fiorita
mancò la speme e la baldanza audace,
piansi i riposi di quest’umil vita
e sospirai la mia perduta pace,
e dissi; ‘O corte, a Dio’ Cosí, a gli amici
boschi tornando, ho tratto i dí felici».
Mentre ei cosí ragiona, Erminia pende
da la soave bocca intenta e cheta;
e quel saggio parlar, ch’al cor le scende,
de’ sensi in parte le procelle acqueta.
Dopo molto pensar, consiglio prende
in quella solitudine secreta
insino a tanto almen farne soggiorno
ch’agevoli fortuna il suo ritorno.
Onde al buon vecchio dice: «O fortunato,
ch’un tempo conoscesti il male a prova,
se non t’invidii il Ciel sí dolce stato,
de le miserie mie pietà ti mova;
e me teco raccogli in cosí grato
albergo ch’abitar teco mi giova.
Forse fia che ’l mio core infra quest’ombre
del suo peso mortal parte disgombre.
Ché se di gemme e d’or, che ’l vulgo adora
sí come idoli suoi, tu fossi vago,
potresti ben, tante n’ho meco ancora,
renderne il tuo desio contento e pago».
Quinci, versando da’ begli occhi fora
umor di doglia cristallino e vago,
parte narrò di sue fortune, e intanto
il pietoso pastor pianse al suo pianto.
Poi dolce la consola e sí l’accoglie
come tutt’arda di paterno zelo,
e la conduce ov’è l’antica moglie
che di conforme cor gli ha data il Cielo.
La fanciulla regal di rozze spoglie
s’ammanta, e cinge al crin ruvido velo;
ma nel moto de gli occhi e de le membra
non già di boschi abitatrice sembra.
Non copre abito vil la nobil luce
e quanto è in lei d’altero e di gentile,
e fuor la maestà regia traluce
per gli atti ancor de l’essercizio umile.
Guida la greggia a i paschi e la riduce
con la povera verga al chiuso ovile,
e da l’irsute mamme il latte preme
e ’n giro accolto poi lo strige insieme.
Sovente, allor che su gli estivi ardori
giacean le pecorelle a l’ombra assise,
ne la scorza de’ faggi e de gli allori
segnò l’amato nome in mille guise,
e de’ suoi strani ed infelici amori
gli aspri successi in mille piante incise,
e in rileggendo poi le proprie note
rigò di belle lagrime le gote.
Indi dicea piangendo: «In voi serbate
questa dolente istoria, amiche piante;
perché se fia ch’a le vostr’ombre grate
giamai soggiorni alcun fedele amante,
senta svegliarsi al cor dolce pietate
de le sventure mie sí varie e tante,
e dica: ‘Ah troppo ingiusta empia mercede
diè Fortuna ed Amore a sí gran fede!’
Forse averrà, se ’l Ciel benigno ascolta
affettuoso alcun prego mortale,
che venga in queste selve anco tal volta
quegli a cui di me forse or nulla cale;
e rivolgendo gli occhi ove sepolta
giacerà questa spoglia inferma e frale,
tardo premio conceda a i miei martíri
di poche lagrimette e di sospiri;
onde se in vita il cor misero fue,
sia lo spirito in morte almen felice,
e ’l cener freddo de le fiamme sue
goda quel ch’or godere a me non lice».
 Joseph-Benoît Suvée: Erminia tra i pastori (1776)
Joseph-Benoît Suvée: Erminia tra i pastori (1776)
Frattanto Erminia è condotta (è scorta) dal cavallo fra gli alberi ombrosi dell’antica selva, e la sua mano tremante non riesce più a governare la griglia del cavallo, e sembra quasi esanime. Percorre tanti sentieri con il cavallo che la conduce a suo piacere, che alla fine fa perdere le tracce ai suoi inseguitori ed è ormai inutile che qualcuno la insegua. // Come i cani che dopo una lunga e faticosa battuta di caccia, tornano sconfortati e affannati dopo aver perso le tracce dell’animale selvatico inseguito che si è nascosto nel bosco (fuggendo) dall’aperta campagna, così ritornano stanchi i cavalieri cristiani, pieni d’ira e di vergogna sul volto. Erminia continua a fuggire e, paurosa e smarrita, non si volge indietro a guardare se è ancora inseguita. // Fuggì per tutta la notte e vagabondò per tutto il giorno senza meta e senza essere guidata, non vedendo e udendo altro intorno che le proprie lacrime e le proprie grida. Ma nell’ora in cui il sole slega i cavalli dal carro ornato e si inoltra nel grembo del mare, ella giunse alle limpide acque del bel fiume Giordano, scese in riva al fiume e qui si abbandonò in terra. // Non si ciba di nulla, perché si nutre solo delle proprie angosce e si disseta solo col proprio pianto, ma il sonno, che, col suo dolce oblio, è riposo e quiete dei miseri mortali, insieme con i sensi fece assopire i suoi dolori e distese sopra di lei le ali calme e serene; ma Amore, con diverse immagini oniriche, non cessa di turbare il suo riposo mentre ella dorme. // Non si risvegliò fino a quando non sentì cantare lieti gli uccelli e dare il saluto alle prime luci dell’alba, e mormorare il fiume e gli alberelli e la brezza scherzare con le acque e con i fiori. Apre i malinconici occhi e guarda quelle abitazioni solitarie di pastori e le sembra di udire una voce tra l’acqua e i rami che la fa tornare col pensiero al sospiro e al pianto. // Ma, mentre piange, i suoi lamenti sono interrotti da un suono nitido che giunge a lei, che sembra, ed è, una mescolanza di canti di pastori e di (suoni di) zampogne rustiche e rozze. Si alza e si dirige là (verso il luogo da dove provengono i suoni) a passi lenti e vede un uomo canuto che intreccia vimini sotto le ombre gradevoli, accanto al suo gregge, e ascolta il canto di tre fanciulli. // Costoro, vedendo apparire lì improvvisamente delle armi, cosa inconsueta (in un luogo tranquillo) si spaventano, ma Erminia li saluta e dolcemente li rassicura e scopre gli occhi e i bei capelli d’oro (togliendosi l’elmo): «Continuate il vostro piacevole lavoro», dice «o gente fortunata e cara a Dio, perché queste armi non portano la guerra alle vostre occupazioni e ai vostri dolci canti». // Poi soggiunse: «O padre, ora che la nostra terra arde tutt’intorno per il grande incendio della guerra, come potete stare qui dimorando tranquillamente senza temere gli attacchi dei soldati?». «Figlio», egli rispose «qui la mia famiglia e il mio gregge restarono sempre immuni da ogni aggressione e insulto, né il fragore della guerra (Marte) ha ancora disturbato questa lontana regione. // Sia ringraziato Dio, affinché protegga e onori l’umiltà dell’innocente pastore, o affinché, come il fulmine non colpisce le pianure ma le cime più alte, il furore dei soldati stranieri minacci soltanto le superbe teste dei grandi re e la nostra povertà bassa e disprezzata non alletti, come preda, i sodati avidi. // Per altri è bassa e disprezzata, (ma) a me è così cara che non desidero ricchezza né scettro regale, né la preoccupazione o il desiderio ambizioso e avido trovano posto nella tranquillità del mio cuore. Placo la mia sete nell’acqua limpida che non temo che venga inquinata da veleno, e questo gregge e l’orticello offrono alla mia umile mensa cibi non acquistati. // Perché poco è il desiderio e poco è ciò che ci occorre per vivere. Questi che io addito e mostro sono i miei figli, custodi della mandria, e non ho servi. Così trascorro la vita in un appartato luogo solitario, vedendo saltare gli agili capretti e i cervi e guizzare i pesci di questo fiume e gli uccellini aprire le ali al cielo. // Vi è stato un tempo, nella giovinezza quando si hanno le più grandi illusioni, in cui ebbi un desiderio diverso e disprezzai il mestiere di pastore e fuggii dal mio paese natale e vissi un tempo a Menfi, e nella reggia fui designato anch’io fra i servitori del re e, benché fossi il guardiano dei giardini, tuttavia vidi e conobbi le ingiustizie delle corti. // Solo allettato da una speranza temeraria, sopportai a lungo ciò che più dispiace; ma dopo che, insieme alla giovinezza, mi vennero a mancare la speranza e l’ardito entusiasmo, rimpiansi la tranquillità di questa umile vita e dissi: ‘O corte addio’. Così, tornando ai boschi amici, ho vissuto i giorni felici». // Mentre il vecchio parla, Erminia ascolta attentamente, concentrata e serena, le sue dolci parole; e quelle sagge parole, che le scendono nel cuore, acquietano in parte le tempeste della passione. Dopo aver riflettuto molto, prende la decisione di soggiornare in quella solitudine appartata, almeno fino a quando la sorte non favorirà il suo ritorno. // Perciò dice al buon vecchio: «O fortunato, che un tempo hai sperimentato cosa sia il male, possa Dio non privarti del tuo stato così felice e muoverti a compassione per le mie disperate condizioni, e accoglimi presso di te in una dimora tanto gradevole poiché mi piacerebbe abitare presso di te. Forse avverrà che, fra queste ombre, il mio cuore si liberi dal suo dolore mortale. // Perché se tu fossi desideroso di pietre preziose e di oro, che il popolo adora come suoi idoli, potresti certamente, poiché tante ricchezze ho ancora con me, appagare il tuo desiderio». Quindi, versando dai begli occhi un pianto di dolore limpido e pieno di grazia, narrò in parte le sue vicissitudini, e intanto il pietoso pastore pianse a udire il pianto di lei. // Poi la consola con dolcezza e la accoglie come se ardesse tutto di amore paterno, e la conduce presso la vecchia moglie, che Dio gli ha dato di sentimenti uguali ai suoi. La fanciulla di origini regali si veste con umili indumenti e si copre i capelli con un ruvido velo, ma dagli sguardi e dai gesti non sembra un’abitatrice dei boschi. // L’abito umile non è sufficiente a nascondere il suo nobile aspetto e ciò che in lei vi è di altero e nobile e la sua regale maestà traspare all’esterno anche attraverso i gesti delle umili occupazioni. Guida il gregge ai pascoli e lo riconduce all’ovile con l’umile verga e dalle pelose mammelle munge il latte e poi lo comprime in forme, dopo averlo fatto cagliare, mescolandolo. // Spesso, quando le pecorelle giacevano distese all’ombra durante la calura estiva ella incide il nome dell’amato in mille forme sulla corteccia dei faggi e degli allori e incide su innumerevoli alberi le tristi vicende del suo amore singolare e infelice, e rileggendo poi le proprie scritte rigò le guance con belle lacrime. // Poi diceva piangendo: «Amiche piante, conservate questa dolorosa storia, perché, se accadrà che sotto le gradevoli ombre si fermi un giorno qualche amante fedele, egli senta risvegliarsi nel cuore una dolce pietà per le mie vane e numerose sventure e dica: ‘Ah, la sorte e l’amore diedero una ricompensa troppo ingiusta e crudele ad una fedeltà così grande!’ // Forse accadrà, se Dio benevolo ascolta qualche appassionata preghiera dei mortali, che un giorno giunga anche in questi boschi colui al quale forse ora non importa nulla di me, e volgendo gli occhi dove giacerà sepolto questo mio corpo (che ora è) debole e fragile, conceda ai miei tormenti una tarda ricompensa di poche lacrime e di sospiri, // cosicché, se durante la vita il mio cuore fu infelice, almeno la mia anima sia felice dopo la morte e la mia fredda cenere (il mio cadavere) possa godere della fiamma d’amore di Tancredi, di cui ora a me non è concesso godere». Così parla ai sordi tronchi e fa sgorgare due fonti di pianto dai begli occhi.
Il passo rappresenta quasi una digressione all’interno del poema, passando da un registro epico ad uno idillico. Nella prima parte è evidente il richiamo alla fuga ariostesca di Angelica: ambedue le fanciulle fuggono per selve; ma è presente anche il richiamo dell’amore inciso sugli alberi: si tratta cioè di quello che, pur nella diversità abissale nella concezione del poema, per tale genere diventeranno topoi. Ma tornando alla fuga non si può non sottolineare come quella di Angelica rappresenti una fuga da (i suoi numerosi spasimanti), mentre quella di Erminia sia una fuga verso un luogo di pace, idillico, appunto, un luogo dove trovare, anche se l’adesione è problematica, un eden di pace contro la guerra. Questo è sottolineato, anche, dalla quasi mancanza di psicologia nell’Angelica ariostesca, simbolo di un desiderio mai appagato e descritta, a volte, con ironia; viceversa l’Erminia tassiana vive fortemente, in modo interiore, la fuga, diventando quasi una figura in cui si rispecchiano le angosce del poeta. Fortemente intento a costruire per sé una realtà cristologica, fa di Erminia una figura che, fuggendo di notte (peccato) si risveglia all’alba (purificata) in eden quasi paradisiaco. Ma questa adesione non porta alla certezza: questo è sottolineato soprattutto nel discorso contro le corti del pastore, che definisce “inique”. Ma è il luogo dove l’intellettuale cortigiano ha trovato sicurezza e che nell’Aminta è definito come luogo abitato dalle Muse. Ed è per questo che, tornando all’inizio del nostro commento, abbiamo definito l’adesione al mondo semplice e idillico di Erminia sia, in qualche modo, problematico. E’ pur vero che veste abiti semplici, ma il suo modo d’essere permane sempre nobile.

Ludovico Carracci: Erminia tra i pastori (1603)
Il canto prosegue con Tancredi che, credendo che la donna sia Clorinda e non vedendola arrivare va alla sua ricerca inutilmente. Quindi decide di tornare al campo cristiano, anche perché è vicino il giorno in cui dovrà riprendere il combattimento con Argante. Ma incontra un uomo che sembra un messaggero e gli chiede la via per il campo cristiano; il messaggero dice che è diretto proprio là, e lo conduce, invece, in un castello, cinto da un sozzo rivo: è questo il castello incantato di Armida. Tancredi riconosce il messo: Rambaldo, uno dei dieci che era partito con Armida e per suo amore aveva abiurato la religione cristiana facendosi pagano. I due mettono mani alle spade e a fatica Armida accorre in aiuto di Rambaldo facendolo scomparire nel buio. Tancredi varca una porta e si trova, così, intrappolato in una stanza. Nel frattempo Argante attende spasmodico l’alba del sesto giorno per riprendere il combattimento con l’eroe cristiano. Tutto è pronto, ma di Tancredi nessuno sa nulla. Si offre allora lo stesso Goffredo, ma glielo impedisce l’anziano Raimondo di Tolosa che si prepara a combattere; sale sul suo cavallo, prega e Dio gli manda in aiuto un angelo; comincia il combattimento dopo gli scherni di Argante che cerca Tancredi. L’angelo protettore fa sì che ad Argante si spezzi la lancia e si frantumi la spada, ma quando si arriva al corpo a corpo Belzebù decide di aiutare il pagano, trasformando un’ombra leggera nelle sembianze di Clorinda e facendola apparire ad Oradino, spingendolo a colpire Raimondo con una freccia. Il patto viene così violato e scoppia la battaglia fra i due eserciti. Le forze cristiane stanno per prevalere, ma un improvviso acquazzone blocca tutte le operazioni.

Immagine per il canto VIII
Nel canto VIII le forze del male continuano ad operare contro i cristiani e la furia Aletto mette zizzania tra loro. Il cavaliere Carlo il Danese narra la morte di Sveno, signore dei Danesi, che, desideroso di gloria, con uno stuolo di scelti compagni era partito per Gerusalemme. Una notte Sveno e i suoi sono assaliti da un gran numero di barbari; Sveno muore ucciso da Solimano e dei duemila restano solo in cento; Carlo cade svenuto. Al suo risveglio vede due eremiti; lo fanno alzare e vanno vicino al corpo di Sveno: uno dei due monaci prende dalla mano del principe morto la spada e l’affida a Carlo perché la consegni a Rinaldo che con essa possa vendicare la morte del giovane Sveno. Il racconto commuove tutti e fa venire in mente Rinaldo. Intanto tornano al campo cristiano quelli che erano usciti per depredare e raccogliere vitto per i Crociati, e fra le altre cose riportano indietro anche le armi e le vesti insanguinate di Rinaldo. Aliprando racconta il ritrovamento del corpo del giovane cavaliere, senza la testa e senza il braccio destro, e come gli sia stato rivelato che era stato assalito e ucciso da un gruppo di armati. Nella notte ad Argillano appare in sogno il cadavere di Rinaldo che regge nella mano sinistra la sua testa e lo invita a fuggire dalle tende cristiane e dal feroce Goffredo. Sbigottito si sveglia Argillano e raduna i guerrieri d’Italia rivelando loro il suo sogno e accusando Goffredo e i suoi Francesi. Ne nasce un tumulto; Baldovino accorre in aiuto di Goffredo e rivolge una preghiera a Dio affinché illumini la mente degli uomini. Goffredo, illuminato dal Cielo, parla agli uomini e frena gli audaci e fa mettere in catene Argillano; quindi decide che Gerusalemme sarebbe stata assalita due o tre giorni dopo.
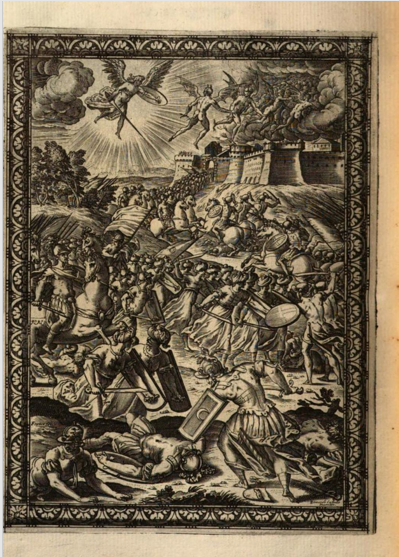
Immagine per il canto IX
Nel canto IX la furia Aletto, visto che non poteva più nulla contro i cristiani passa dai loro nemici ed incita Solimano, re dei Turchi, a sferrare un attacco contro Goffredo. Il piano escogitato dalla furia è chiaro: colpire i cristiani su due fronti; infatti va subito a Gerusalemme e spinge lo stesso re di Gerusalemme a muovere da un altro fronte contro l’esercito nemico. Infuria quindi la battaglia: Solimano fa orribile strage, come quella di Latino e dei suoi figli (Tasso non ci risparmia nulla: il taglio perpendicolare della testa del figlio maggiore, l’amputazione del braccio del fratello che lo sosteneva, un altro, più piccolo, caduto e calpestato dal cavallo del feroce pagano e i due gemelli, uno decollato e l’altro squartato; infine l’urlo disperato del padre cui ficca nel petto la spada da farlo vomitare sangue dalla ferita e dalla bocca). Goffredo si slancia in battaglia, cerca di raccogliere i dispersi e di rincuorare gli sbandati. Insieme al cavaliere Guelfo decidono di rispondere con attacchi ognuno su un lato; Dio allora rivolge lo sguardo nel campo di battaglia e fa intervenire l’arcangelo Gabriele, affinché ricacci i demoni nell’inferno. Nella battaglia contro i cristiani, si distinguono Argante e Clorinda, ma anche Argillano si libera dalle catene ed inizia una feroce lotta contro la guerriera pagana. Sarà proprio lui ad uccidere Lesbino, giovane paggio di Solimano, che piangerà amaramente sul suo corpo e ucciderà proprio lui che gliel’ha strappato. All’improvviso appaiono cinquanta cavalieri e dietro l’insegna della croce mettono in fuga l’esercito pagano. Chi sono costoro? Sono i cavalieri che Armida aveva fatto prigionieri. Ma Solimano, che assiste alla fuga dei suoi soldati, non cede all’impotenza della sconfitta:
SOLIMANO
(97-99)
Fatto intanto ha il Soldan ciò che è concesso
fare a terrena forza, or piú non pote;
tutto è sangue e sudore, e un grave e spesso
anelar gli ange il petto e i fianchi scote.
Langue sotto lo scudo il braccio oppresso,
gira la destra il ferro in pigre rote:
spezza, e non taglia; e divenendo ottuso
perduto il brando omai di brando ha l’uso.
Come sentissi tal, ristette in atto
d’uom che fra due sia dubbio, e in sé discorre
se morir debba, e di sí illustre fatto
con le sue mani altrui la gloria tòrre,
o pur, sopravanzando al suo disfatto
campo, la vita in securezza porre.
«Vinca» al fin disse «il fato, e questa mia
fuga il trofeo di sua vittoria sia.
Veggia il nemico le mie spalle, e scherna
di novo ancora il nostro essiglio indegno,
pur che di novo armato indi mi scerna
turbar sua pace e ’l non mai stabil regno.
Non cedo io, no; fia con memoria eterna
de le mie offese eterno anco il mio sdegno.
Risorgerò nemico ognor piú crudo,
cenere anco sepolto e spirto ignudo».

Intanto il Soldano ha fatto ciò che è concesso fare ad una forza terrena, di più non può; è tutto sangue e ferite e un grave e forte ansimare gli opprime il petto e lo scuote fino ai fianchi. Riposa sotto lo scudo il braccio fiaccato e gira la mano destra la spada in lenti giri: spazza, ma non taglia; e diventando inefficace ha perso la sua funzione. // Come se si sentisse in uno stato di prostrazione, rimase come un uomo preso tra due dubbi, pensa tra sé se debba morire e di tale evento fatto con le sue mani, togliere da mani altrui la gloria, oppure sopravvivendo alla rovina del suo esercito, porre la sua vita in sicurezza. «Vinca» disse infine «il destino, e questa mia fuga sia la sua vittoria. Veda il nemico le mie spalle, schernisca di nuovo la nostra vergognosa ritirata, finché di nuovo armato quindi mi veda turbare la sua pace e il regno in pericolo. Non cedo io, no; sarà con memoria eterna delle mie sconfitte, eterno anche il mio sdegno. Risorgerò nemico, ogni volta più crudele, anche quando sarò cenere e sepolto, anche quando sarò solo spirito».
C’è nella descrizione di questo guerriero turco qualcosa di tragicamente eroico: l’avevamo visto nel pieno della crudeltà guerresca, non risparmiare niente e nessuno (né adulti né fanciulli) ed ora lo vediamo sconfitto, ma non domo. E’ l’uomo che grande nel male è grande anche nell’azione e, sebbene vinto, non si lascia abbattere. E’ ciò che Tasso non è: un uomo che non conosce paura, per questo il poeta lo disegna con ammirazione.
Il canto X si apre con l’allontanamento scorato di Solimano che, salito in groppa a un cavallo si allontana dalla battaglia, decidendo infine di andare in Egitto. Giunta la notte si addormenta e gli appare in sogno il mago Ismeno, che, su un carro reso invisibile da una nube, lo porta tra le mura di Gerusalemme. Smontati dal carro, si avviano a piedi verso il monte su cui sorge la città, ai piedi del quale s’apre una grotta: al centro si trova una porta che nasconde un cammino sotterraneo. Arrivano in una sala dove sono a consiglio i capi arabi e il re Aladino. Il loro piano è rivolto alla prudenza ma Solimano appare, per la gioia di tutti, e spinge tutti loro alla lotta affermando che Francesi e Arabi mai potranno vivere su una stessa terra. Intanto Goffredo, completate le esequie dei caduti, chiama alla presenza di Pietro l’Eremita i cinquanta cavalieri che avevano salvato le sorti della battaglia e si fa raccontare cos’era successo con Armida; parla Guglielmo, il figlio minore di Goffredo, e racconta come Armida con arti magiche aveva mutato ogni loro pensiero e chiesto che si facessero pagani e combattessero contro i Cristiani, ma tutti si erano ribellati; come un giorno vi sia capitato Tancredi, che viene tenuto ancora prigioniero; come furono inviati in catene come dono al re d’Egitto, ma durante il viaggio vennero liberati da Rinaldo, che pertanto è ancora vivo. Ciò viene confermato anche da Pietro l’Eremita che predice le grandi future glorie della Casa d’Este, cui Rinaldo appartiene.

Il mago Ismeno e Solimano
Il canto XI si apre con l’invito di Pietro l’Eremita che spinge il capo cristiano a fare una processione per invocare l’aiuto del Cielo. Il mattino dopo si snoda la processione che si dirige verso il Monte Oliveto, mentre dalle mura i pagani che, dapprima guardano per loro gli strani riti, ma poi cominciano a gridare. I Cristiani, giunti sul colle, erigono l’altare per la celebrazione della Messa e viene poi deciso l’assalto per il mattino seguente. All’alba comincia l’attacco, mentre sulle mura di Gerusalemme tutti sono pronti alla difesa, soprattutto Solimano, Argante e Clorinda. Disposto l’esercito Goffredo dà il segnale della battaglia e comincia l’assalto alle mura; Clorinda, dall’alto, abbatte sette cristiani colle sue frecce. Intanto Goffredo attacca con una torre da un’altra parte, ma viene anche lui ferito da una freccia di Clorinda. L’attacco viene respinto: Argante e Solimano attaccano improvvisamente i Cristiani uscendo dalle mura, mentre Tancredi con altri cavalieri si difendono disperatamente. Goffredo, la cui ferita viene guarita da un angelo, ritorna alla battaglia ferendo Argante. La notte separa i combattenti.

Bernardo Castello; Illustrazione per il canto XI
Nel XII, durante la notte, i pagani cercano di riorganizzare le difese, mentre Clorinda e Argante decidono d’uscire per incendiare la grande torre dei cristiani; Ismeno darà loro aiuto preparando un miscuglio che la possa bene incendiare. Mentre Clorinda si veste, Arsete, suo fedele servitore, le chiede di rinunciare all’impresa, ma è inutile; allora le svela quali sono le sue vere origini: figlia di un re cristiano d’Etiopia, era nata bianca da madre nera e, per non urtare la gelosia del re, era stata abbandonata alla nascita con gran dolore della madre e raccolta da Arsete, che la nascose e la crebbe nella religione pagana, valorosa e ardita nelle armi. Clorinda lo rasserena dicendogli che sempre avrebbe seguito la fede nella quale era stata educata. A notte alta, Clorinda, Argante e Ismeno escono dalla città e incendiano la torre; accorrono due squadre di cristiani: breve è la battaglia; mentre Argante e Ismeno riescono a rientrare in città, Clorinda rimane fuori; allora si mescola ai soldati cristiani.
LA MORTE DI CLORINDA
(50 – 69)
Ma poi che intepidí la mente irata
nel sangue del nemico e in sé rivenne,
vide chiuse le porte e intorniata
sé da’ nemici, e morta allor si tenne.
Pur veggendo ch’alcuno in lei non guata,
nov’arte di salvarsi le sovenne.
Di lor gente s’infinge, e fra gli ignoti
cheta s’avolge; e non è chi la noti.
Poi, come lupo tacito s’imbosca
dopo occulto misfatto, e si desvia,
da la confusion, da l’aura fosca
favorita e nascosa, ella se ’n gía.
Solo Tancredi avien che lei conosca;
egli quivi è sorgiunto alquanto pria;
vi giunse allor ch’essa Arimon uccise:
vide e segnolla, e dietro a lei si mise.
Vuol ne l’armi provarla: un uom la stima
degno a cui sua virtú si paragone.
Va girando colei l’alpestre cima
verso altra porta, ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avien che d’armi suone,
ch’ella si volge e grida: «O tu, che porte,
che corri sí?» Risponde: «E guerra e morte».
«Guerra e morte avrai»; disse «io non rifiuto
darlati, se la cerchi», e ferma attende.
Non vuol Tancredi, che pedon veduto
ha il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l’uno e l’altro il ferro acuto,
ed aguzza l’orgoglio e l’ire accende;
e vansi a ritrovar non altrimenti
che duo tori gelosi e d’ira ardenti.
Degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno
teatro, opre sarian sí memorande.
Notte, che nel profondo oscuro seno
chiudesti e ne l’oblio fatto sí grande,
piacciati ch’io ne ’l tragga e ’n bel sereno
a le future età lo spieghi e mande.
Viva la fama loro; e tra lor gloria
splenda del fosco tuo l’alta memoria.
Non schivar, non parar, non ritirarsi
voglion costor, né qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
toglie l’ombra e ’l furor l’uso de l’arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro, il piè d’orma non parte;
sempre è il piè fermo e la man sempre ’n moto,
né scende taglio in van, né punta a vòto.
L’onta irrita lo sdegno a la vendetta,
e la vendetta poi l’onta rinova;
onde sempre al ferir, sempre a la fretta
stimol novo s’aggiunge e cagion nova.
D’or in or piú si mesce e piú ristretta
si fa la pugna, e spada oprar non giova:
dansi co’ pomi, e infelloniti e crudi
cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.
Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, ed altrettante
da que’ nodi tenaci ella si scinge,
nodi di fer nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge
con molte piaghe; e stanco ed anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.
L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue
su ’l pomo de la spada appoggia il peso.
Già de l’ultima stella il raggio langue
al primo albor ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico, e sé non tanto offeso.
Ne gode e superbisce. Oh nostra folle
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!
Misero, di che godi? oh quanto mesti
fiano i trionfi ed infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Cosí tacendo e rimirando, questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse,
perché il suo nome a lui l’altro scoprisse:
«Nostra sventura è ben che qui s’impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte rea vien che ci neghi
e lode e testimon degno de l’opra,
pregoti (se fra l’arme han loco i preghi)
che ’l tuo nome e ’l tuo stato a me tu scopra,
acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore,
chi la mia morte o la vittoria onore».
Risponde la feroce: «Indarno chiedi
quel c’ho per uso di non far palese.
Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese».
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi,
e: «In mal punto il dicesti»; indi riprese
«il tuo dir e ’l tacer di par m’alletta,
barbaro discortese, a la vendetta».
Torna l’ira ne’ cori, e li trasporta,
benché debili in guerra. Oh fera pugna,
u’ l’arte in bando, u’ già la forza è morta,
ove, in vece, d’entrambi il furor pugna!
Oh che sanguigna e spaziosa porta
fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna,
ne l’arme e ne le carni! e se la vita
non esce, sdegno tienla al petto unita.
Qual l’alto Egeo, perché Aquilone o Noto
cessi, che tutto prima il volse e scosse,
non s’accheta ei però, ma ’l suono e ’l moto
ritien de l’onde anco agitate e grosse,
tal, se ben manca in lor co ’l sangue vòto
quel vigor che le braccia a i colpi mosse,
serbano ancor l’impeto primo, e vanno
da quel sospinti a giunger danno a danno.
Ma ecco omai l’ora fatale è giunta
che ’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e ’l sangue avido beve;
e la veste, che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenera e leve,
l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e ’l piè le manca egro e languente.
Segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme;
parole ch’a lei novo un spirto ditta,
spirto di fé, di carità, di speme:
virtú ch’or Dio le infonde, e se rubella
in vita fu, la vuole in morte ancella.
«Amico, hai vinto: io ti perdon… perdona
tu ancora, al corpo no, che nulla pave,
a l’alma sí; deh! per lei prega, e dona
battesmo a me ch’ogni mia colpa lave».
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,
e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza.
Poco quindi lontan nel sen del monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v’accorse e l’elmo empié nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentí la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide, la conobbe, e restò senza
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!
Non morí già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l’acqua a chi co ’l ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise;
e in atto di morir lieto e vivace,
dir parea: «S’apre il cielo; io vado in pace».
D’un bel pallore ha il bianco volto asperso,
come a’ gigli sarian miste viole,
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso
sembra per la pietate il cielo e ’l sole;
e la man nuda e fredda alzando verso
il cavaliero in vece di parole
gli dà pegno di pace. In questa forma
passa la bella donna, e par che dorma.

Johann Friederich Overbeck, Stanza del Tasso: 1819-27, Morte di Clorinda
Clorinda, dopo che ebbe placata la sua ira nel sangue del nemico e fu tornata in sé vide che le porte erano chiuse e si trovò circondata dai nemici e si ritenne morta. Ma, vedendo che nessuno guardava verso di lei, escogitò un nuovo stratagemma per salvarsi. Si finge cristiana e si mescola tra i nemici senza dare nell’occhio, e nessuno la nota. // Poi, come un lupo silenzioso, si nasconde nel bosco, dopo aver di nascosto sbranato la preda ed essersi allontanata dalla confusione, Clorinda se ne andava favorita e nascosta dall’aria densa di fumo. Solo Tancredi la riconosce; egli è giunto lì poco prima, vi è giunto quando Clorinda ha ucciso Ariamone: ha visto, l’ha tenuta d’occhio e si è messo al suo inseguimento. // (Tancredi) vuole sfidarla a duello, la ritiene un uomo valoroso, degno di misurarsi con il suo valore. Ella tenta di aggirare la cima montuosa (procedendo) verso un’altra porta (della città), da dove ha intenzione di entrare. Egli la segue pieno d’impeto e perciò, molto prima che la raggiunga, accade che le sue armi risuonino e che ella si volti indietro e gridi: «O tu che corri così, che cosa porti?». Risponde: «O guerra o morte». // «Guerra e morte avrai», disse Clorinda, «io non mi rifiuto di dartela, se la cerchi», e lo attende ferma. Tancredi, che ha visto il suo nemico a piedi, non vuole usare il cavallo (per combattere) e scende. E impugna l’una e l’altra spada affilata e stimola il proprio orgoglio di guerriero e si accende d’ira; e si vanno a scontrare come due tori gelosi e ardenti di rabbia. // Le loro imprese degne di (compiersi) sotto un sole luminoso o in un teatro affollato, sarebbero da ricordare. Notte, che nella tua oscura profondità hai chiuso nell’oblio un evento così importante, voglia tu che io lo tragga dall’oblio e lo tramandi ai posteri nella chiara luce del poema. Resti vivo il loro ricordo, e risplenda tra la loro gloria il nobile ricordo delle tue tenebre. // Costoro non vogliono schivare i colpi, pararli o ritirarsi, in questo duello l’accortezza non conta. Non fanno finte o affondi, (non danno) colpi leggeri: l’oscurità e il furore impediscono di avvalersi delle tecniche guerresche. Ascolti le spade urtarsi violentemente nel centro della lama, il piede non si stacca dall’orma; il piede è sempre fermo e la mano sempre in movimento e nessun colpo di taglio o di punta della spada scende inutilmente. // La vergogna (di essere colpiti) incita l’orgoglio alla vendetta e poi la vendetta (di chi ha colpito) rinvigorisce l’orgoglio (di chi ha ricevuto il colpo); perciò alla brama di ferire e alla fretta si aggiunge sempre un nuovo stimolo e una nuova ragione. Di ora in ora il duello diventa più confuso e serrato, non serve usare la spada, si colpiscono con le impugnature e, inferociti e crudeli, cozzano insieme con gli elmi e con gli scudi. // Per tre volte il cavaliere stringe la donna con le robuste braccia ed altrettante ella si libera da quelle strette di feroce nemico e non d’amante. Tornano a combattere con la spada e si colpiscono procurandosi molte ferite; stanchi e sfiniti entrambi alla fine si ritraggono e, dopo una lunga fatica, riprendono fiato. // Si guardano reciprocamente e appoggiano il peso del loro corpo esangue sull’impugnatura della spada. Ormai si sta spegnendo la luce dell’ultima stella all’apparire dell’alba, che si dà luminosa ad oriente. Tancredi vede in maggior quantità il sangue del suo nemico e (vede) se stesso non molto ferito. Di ciò gioisce e insuperbisce. Oh la nostra folle mente, che esalta ogni minimo soffio della fortuna. // Misero, di cosa gioisci? Oh quanto tristi saranno i tuoi trionfi e infelice il tuo vanto! I tuoi occhi (se resterai vivo) pagheranno un mare di pianto per ogni goccia di quel sangue (che hai versato). Questi cruenti guerrieri, così facendo e continuando a guardarsi, cessarono di combattere per un po’. Alla fine Tancredi ruppe il silenzio e parlò affinché l’altro gli rivelasse la sua identità. // «La nostra sventura sta nel fatto che qui s’impiega tanto coraggio in un luogo dove il silenzio lo copre. Ma, dal momento che la nostra sorte ostile fa in modo di negarci la lode e la testimonianza degne di questa impresa, ti prego – ammesso che le preghiere trovino posto in guerra – di rivelarmi il tuo nome e la tua condizione, affinché io sappia, sia da sconfitto, sia da vincitore, chi renda onorata la mia morte o la mia vittoria. // Risponde la fiera Clorinda: «Chiedi invano ciò che sono solita non rivelare. Ma chiunque io sia, tu vedi dinanzi a te uno di quei due guerrieri che incendiarono la grande torre». A quelle parole Tancredi fu preso da una sdegnosa ira e disse: «Pagano irrispettoso, le tue parole e il tuo tacere allo stesso modo mi spingono alla vendetta». // Nei loro cuori ritorna l’ira e li spinge, benché debilitati, a combattere. Oh crudele duello, in cui la tecnica guerresca è al bando, in cui la forza fisica è perduta, in cui, invece, combatte soltanto la furia cieca di entrambi! Oh, che sanguinose e profonde ferite producono entrambe le spade, dovunque colpiscano, nell’armatura o nella carne viva! E se essi non muoiono (se la vita non esce) è la loro ira che non lo consente. // Come il profondo Egeo non si calma sebbene cessino di soffiare l’Aquilone e il Noto che in precedenza l’avevano tutto sconvolto e agitato, ma mantiene il rumore e il moto delle onde ancora agitate e grosse, così, sebbene in loro manchi, insieme al sangue versato, la forza che mosse le braccia a colpire, (Clorinda e Tancredi) mantengono ancora l’impeto iniziale e continuano, spinti da quello, ad aggiungere ferita a ferita. // Ma ecco che è ormai giunta è l’ora fatale in cui la vita di Clorinda deve (giungere) alla sua fine. Egli spinge nel bel petto di lei la spada dalla punta che vi si immerge e fa sgorgare copiosamente il sangue, e (il sangue) le riempie di un caldo fiume la veste, che, trapuntata d’oro fino, le stringeva il petto delicatamente e leggermente. Ella ormai si sente morire e le vacilla il piede debole e malfermo. // Egli persegue la vittoria, incalza e schiaccia, minacciando la fanciulla trafitta. Ella, mentre cadeva, parlando con voce afflitta, disse le sue ultime parole, parole che un nuovo sentimento le ispira, un sentimento di fede, carità e speranza una virtù che ora Dio le infonde; e se ella fu in vita una ribelle (perché musulmana), (Dio) la vuole devota a sé (ancella) nella morte. // «Amico, hai vinto, io ti perdono… anche tu perdona il mio corpo, che nulla teme, ma la mia anima; ah! Prega per lei e donami il battesimo che purifichi ogni mia colpa». In queste parole deboli risuona un non so che di flebile e dolce, che scende nel cuore di Tancredi e smorza ogni suo rancore e induce e costringe i suoi occhi a lacrimare. // Poco lontano da lì, dall’insenatura del monte, scaturiva mormorando un piccolo ruscello. Egli accorse là, riempì l’elmo alla fonte, e tornò triste per compiere il grande e sacro rito (del battesimo). Sentì tremare la mano, mentre liberò (dall’elmo) e scoprì il volto che non aveva ancora riconosciuto. La guardò, la riconobbe, e restò muto e immobile. Ahi vista! Ahi conoscenza! // Non morì ancora, perché raccolse tutte le sue forze vitali in quell’istante e li mise a sostegno del cuore e, reprimendo il suo affanno, si rivolse a donare con l’acqua la vita a colei che uccise con la spada. Mentre egli pronunciò la formula del sacro rito, ella assunse un’espressione di gioia e sorrise, e nel momento di morire, in modo lieto e sereno, sembrava dire: «Si apre il cielo per me, io vado in pace». // Ha il candido volto cosparso di un delicato pallore, come se le viole fossero mescolate ai gigli, e fissa gli occhi al cielo, e il cielo e il sole sembrano rivolti verso di lei per la pietà; alzando la mano nuda e fredda verso il cavaliere, gliela offre come pegno di pace, al posto delle parole. In questo modo muore la bella Clorinda, e sembra che dorma.

Tintoretto: La morte di Clorinda (1585)
E’ questo uno degli episodi più famosi del poema, in quanto in esso emergono, in forma difficilmente trattenuta, forti elementi di sensualità. Il loro duellare senza cavalli, come tori inferociti, il loro stringersi sempre più, carichi d’ira, il loro corpo a corpo, tanto che Tancredi cinge per ben tre volte le braccia intorno al corpo della donna, indicano che sì, vi è guerra tra i due, ma anche, per chi scrive una forte “tendenza” alla sessualità: ne fa spia il linguaggio: la spada che s’immerge nel bel seno facendo uscire un caldo fiume che bagna le mammelle mal trattenute, rappresenta una forte spia di un atteggiamento certamente ambiguo, da parte del poeta, verso l’amore. Tale ambiguità è accresciuta nel non riconoscere la donna, nel vedere in lei soltanto un fiero nemico: ma forse questo serve a Tasso per accentuare la trasformazione di Clorinda, da guerriera negatrice di ogni sessualità a donna solo dopo che questa dimensione non potrà più viverla. A confermare tale interpretazione è anche lo spazio e il tempo, che in Tasso assumono forte valore connotativo: lo spazio è separato, oscuro, non conosciuto, allo stesso tempo la notte nasconde, non fa vedere. Così come Tancredi non vede l’avversario: soltanto alla fine, preannunciato dall’inserto “commentativo” di Tasso che, a differenza di Ariosto, vive psicologicamente il futuro tormento, sarà testimone della doppia trasformazione di Clorinda, da guerriera a donna, da pagana a cristiana.
Tancredi nell’immenso dolore, venato da enormi “sensi di colpa” per aver ucciso ciò che più ama, trova conforto solo alle parole di Pietro l’Eremita. Nella notte prima dei funerali, la sogna Clorinda, che gli si mostra in tutta la sua bellezza celeste. Al mattino l’eroe si sveglia consolato. Si diffonde nella città la notizia delle morte di Clorinda; piange Arsete, mentre Argante giura di uccidere il rivale per vendicare l’amica.
Nel XIII Ismeno pensa a nuovi sistemi per rendere sempre più sicura la città di Gerusalemme; non lontano dalla città si estende la selva di Saron, popolata di streghe, violata dai Cristiani per procurarsi legna; qui si reca Ismeno e la popola di demoni; poi se ne torna dal re Aladino per rassicurarlo. Intanto Goffredo di Buglione decide di far ricostruire la torre e manda i fabbri nel bosco per tagliare l’occorrente:

Immagine per il canto XIII
LA SELVA INCANTATA
(17-46)
Ma in questo mezzo il pio Buglion non vòle
che la forte cittade in van si batta,
se non è prima la maggior sua mole
ed alcuna altra machina rifatta.
E i fabri al bosco invia che porger sòle
ad uso tal pronta materia ed atta.
Vanno costor su l’alba a la foresta,
ma timor novo al suo apparir gli arresta.
Qual semplice bambin mirar non osa
dove insolite larve abbia presenti,
o come pave ne la notte ombrosa,
imaginando pur mostri e portenti,
cosí temean, senza saper qual cosa
siasi quella però che gli sgomenti,
se non che ’l timor forse a i sensi finge
maggior prodigi di Chimera o Sfinge.
Torna la turba, e misera e smarrita
varia e confonde sí le cose e i detti
ch’ella nel riferir n’è poi schernita,
né son creduti i mostruosi effetti.
Allor vi manda il capitano ardita
e forte squadra di guerrieri eletti,
perché sia scorta a l’altra e ’n esseguire
i magisteri suoi le porga ardire.
Questi, appressando ove lor seggio han posto
gli empi demoni in quel selvaggio orrore,
non rimiràr le nere ombre sí tosto,
che lor si scosse e tornò ghiaccio il core.
Pur oltra ancor se ’n gian, tenendo ascosto
sotto audaci sembianti il vil timore;
e tanto s’avanzàr che lunge poco
erano omai da l’incantato loco.
Esce allor de la selva un suon repente
che par rimbombo di terren che treme,
e ’l mormorar de gli Austri in lui si sente
e ’l pianto d’onda che fra scogli geme.
Come rugge il leon, fischia il serpente,
come urla il lupo e come l’orso freme
v’odi, e v’odi le trombe, e v’odi il tuono:
tanti e sí fatti suoni esprime un suono.
In tutti allor s’impallidír le gote
e la temenza a mille segni apparse,
né disciplina tanto o ragion pote
ch’osin di gire inanzi o di fermarse,
ch’a l’occulta virtú che gli percote
son le difese loro anguste e scarse.
Fuggono al fine; e un d’essi, in cotal guisa
scusando il fatto, il pio Buglion n’avisa:
«Signor, non è di noi chi piú si vante
troncar la selva, ch’ella è sí guardata
ch’io credo (e ’l giurerei) che in quelle piante
abbia la reggia sua Pluton traslata.
Ben ha tre volte e piú d’aspro diamante
ricinto il cor chi intrepido la guata;
né senso v’ha colui ch’udir s’arrischia
come tonando insieme rugge e fischia».
Cosí costui parlava. Alcasto v’era
fra molti che l’udian presente a sorte:
l’uom di temerità stupida e fera,
sprezzator de’ mortali e de la morte;
che non avria temuto orribil fèra,
né mostro formidabile ad uom forte,
né tremoto, né folgore, né vento,
né s’altro ha il mondo piú di violento.
Crollava il capo e sorridea dicendo:
«Dove costui non osa, io gir confido;
io sol quel bosco di troncar intendo
che di torbidi sogni è fatto nido.
Già no ’l mi vieterà fantasma orrendo
né di selva o d’augei fremito o grido,
o pur tra quei sí spaventosi chiostri
d’ir ne l’inferno il varco a me si mostri».
Cotal si vanta al capitano, e tolta
da lui licenza il cavalier s’invia;
e rimira la selva, e poscia ascolta
quel che da lei novo rimbombo uscia,
né però il piede audace indietro volta
ma securo e sprezzante è come pria;
e già calcato avrebbe il suol difeso,
ma gli s’oppone (o pargli) un foco acceso.
Cresce il gran foco, e ’n forma d’alte mura
stende le fiamme torbide e fumanti;
e ne cinge quel bosco, e l’assecura
ch’altri gli arbori suoi non tronchi e schianti.
Le maggiori sue fiamme hanno figura
di castelli superbi e torreggianti,
e di tormenti bellici ha munite
le rocche sue questa novella Dite.
Oh quanti appaion mostri armati in guardia
de gli alti merli e in che terribil faccia!
De’ quai con occhi biechi altri il riguarda,
e dibattendo l’arme altri il minaccia.
Fugge egli al fine, e ben la fuga è tarda,
qual di leon che si ritiri in caccia,
ma pure è fuga; e pur gli scote il petto
timor, sin a quel punto ignoto affetto.
Non s’avide esso allor d’aver temuto,
ma fatto poi lontan ben se n’accorse;
e stupor n’ebbe e sdegno, e dente acuto
d’amaro pentimento il cor gli morse.
E, di trista vergogna acceso e muto,
attonito in disparte i passi torse,
ché quella faccia alzar, già sí orgogliosa,
ne la luce de gli uomini non osa.
Chiamato da Goffredo, indugia e scuse
trova a l’indugio, e di restarsi agogna.
Pur va, ma lento; e tien le labra chiuse
o gli ragiona in guisa d’uom che sogna.
Diffetto e fuga il capitan concluse
in lui da quella insolita vergogna,
poi disse: «Or ciò che fia? forse prestigi
son questi o di natura alti prodigi?
Ma s’alcun v’è cui nobil voglia accenda
di cercar que’ salvatichi soggiorni,
vadane pure, e la ventura imprenda
e nunzio almen piú certo a noi ritorni».
Cosí disse egli, e la gran selva orrenda
tentata fu ne’ tre seguenti giorni
da i piú famosi; e pur alcun non fue
che non fuggisse a le minaccie sue.
Era il prence Tancredi intanto sorto
a sepellir la sua diletta amica,
e benché in volto sia languido e smorto
e mal atto a portar elmo o lorica,
nulla di men, poi che ’l bisogno ha scorto,
ei non ricusa il rischio o la fatica,
ché ’l cor vivace il suo vigor trasfonde
al corpo sí che par ch’esso n’abbonde.
Vassene il valoroso in sé ristretto,
e tacito e guardingo, al rischio ignoto,
e sostien de la selva il fero aspetto
e ’l gran romor del tuono e del tremoto;
e nulla sbigottisce, e sol nel petto
sente, ma tosto il seda, un picciol moto.
Trapassa, ed ecco in quel silvestre loco
sorge improvisa la città del foco.
Allor s’arretra, e dubbio alquanto resta
fra sé dicendo: «Or qui che vaglion l’armi?
Ne le fauci de’ mostri, e ’n gola a questa
devoratrice fiamma andrò a gettarmi?
Non mai la vita, ove cagione onesta
del comun pro la chieda, altri risparmi,
ma né prodigo sia d’anima grande
uom degno; e tale è ben chi qui la spande.
Pur l’oste che dirà, s’indarno i’ riedo?
qual altra selva ha di troncar speranza?
Né intentato lasciar vorrà Goffredo
mai questo varco. Or s’oltre alcun s’avanza,
forse l’incendio che qui sorto i’ vedo
fia d’effetto minor che di sembianza;
ma seguane che pote». E in questo dire,
dentro saltovvi. Oh memorando ardire!
Né sotto l’arme già sentir gli parve
caldo o fervor come di foco intenso;
ma pur, se fosser vere fiamme o larve,
mal poté giudicar sí tosto il senso,
perché repente a pena tocco sparve
quel simulacro, e giunse un nuvol denso
che portò notte e verno; e ’l verno ancora
e l’ombra dileguossi in picciol ora.
Stupido sí, ma intrepido rimane
Tancredi; e poi che vede il tutto cheto,
mette securo il piè ne le profane
soglie e spia de la selva ogni secreto.
Né piú apparenze inusitate e strane,
né trova alcun fra via scontro o divieto,
se non quanto per sé ritarda il bosco
la vista e i passi inviluppato e fosco.
Al fine un largo spazio in forma scorge
d’anfiteatro, e non è pianta in esso,
salvo che nel suo mezzo altero sorge,
quasi eccelsa piramide, un cipresso.
Colà si drizza, e nel mirar s’accorge
ch’era di vari segni il tronco impresso,
simili a quei che in vece usò di scritto
l’antico già misterioso Egitto.
Fra i segni ignoti alcune note ha scorte
del sermon di Soria ch’ei ben possede:
«O tu che dentro a i chiostri de la morte
osasti por, guerriero audace, il piede,
deh! se non sei crudel quanto sei forte,
deh! non turbar questa secreta sede.
Perdona a l’alme omai di luce prive:
non dée guerra co’ morti aver chi vive».
Cosí dicea quel motto. Egli era intento
de le brevi parole a i sensi occulti:
fremere intanto udia continuo il vento
tra le frondi del bosco e tra i virgulti,
e trarne un suon che flebile concento
par d’umani sospiri e di singulti,
e un non so che confuso instilla al core
di pietà, di spavento e di dolore.
Pur tragge al fin la spada, e con gran forza
percote l’alta pianta. Oh meraviglia!
manda fuor sangue la recisa scorza,
e fa la terra intorno a sé vermiglia.
Tutto si raccapriccia, e pur rinforza
il colpo e ’l fin vederne ei si consiglia.
Allor, quasi di tomba, uscir ne sente
un indistinto gemito dolente,
che poi distinto in voci: «Ahi! troppo» disse
«m’hai tu, Tancredi, offeso; or tanto basti.
Tu dal corpo che meco e per me visse,
felice albergo già, mi discacciasti:
perché il misero tronco, a cui m’affisse
il mio duro destino, anco mi guasti?
Dopo la morte gli aversari tuoi,
crudel, ne’ lor sepolcri offender vuoi?
Clorinda fui, né sol qui spirto umano
albergo in questa pianta rozza e dura,
ma ciascun altro ancor, franco o pagano,
che lassi i membri a piè de l’alte mura,
astretto è qui da novo incanto e strano,
non so s’io dica in corpo o in sepoltura.
Son di sensi animati i rami e i tronchi,
e micidial sei tu, se legno tronchi».
Qual l’infermo talor ch’in sogno scorge
drago o cinta di fiamme alta Chimera,
se ben sospetta o in parte anco s’accorge
che ’l simulacro sia non forma vera,
pur desia di fuggir, tanto gli porge
spavento la sembianza orrida e fera,
tal il timido amante a pien non crede
a i falsi inganni, e pur ne teme e cede.
E, dentro, il cor gli è in modo tal conquiso
da vari affetti che s’agghiaccia e trema,
e nel moto potente ed improviso
gli cade il ferro, e ’l manco è in lui la tema.
Va fuor di sé: presente aver gli è aviso
l’offesa donna sua che plori e gema,
né può soffrir di rimirar quel sangue,
né quei gemiti udir d’egro che langue.
Cosí quel contra morte audace core
nulla forma turbò d’alto spavento,
ma lui che solo è fievole in amore
falsa imago deluse e van lamento.
Il suo caduto ferro intanto fore
portò del bosco impetuoso vento,
sí che vinto partissi; e in su la strada
ritrovò poscia e ripigliò la spada.

Alcasto tenta di entrare nel bosco incantato
Ma nel frattempo il pio Buglione non vuole che la città fortificata venga percorsa inutilmente (con macchine più piccole) se non vengono prima rifatte la grande torre e qualche altra macchina bellica. Ed invia al bosco fabbri che sono soliti offrire legna pronta e adatta a tale scopo. All’alba costoro vanno nella foresta, ma un timore strano all’apparire di essa, li blocca. // Come l’ingenuo bambino non osa guardare dove gli sembra siano presenti fantasmi inquietanti, o come prova paura nella notte tenebrosa, immaginando solo mostri o fatti straordinari, così (i fabbri) temevano, senza sapere che cosa sia ciò che li sgomenti, se non che forse la loro paura rappresentava ai loro sensi prodigi più spaventosi della Chimera o della Sfinge. // Torna il gruppo dei fabbri e, misera e smarrita, espone i fatti in modo diverso e confonde talmente le varie versioni che ne è schernita e non creduta. Allora Goffredo vi manda una forte e coraggiosa schiera di guerrieri, affinché accompagni l’altra e le infonda coraggio mentre lavora. // A questi, avvicinandosi al luogo in cui i demoni avevano trovato posto nell’orrida selva, guardando le nere ombre, il cuore tremò e si agghiacciò. Nonostante ciò andarono oltre, nascondendo la paura dietro un atteggiamento ardimentoso. E avanzarono molto, sino quasi alle soglie del luogo incantato. // Esce allora dal bosco un suono all’improvviso, che sembra un rimbombo della terreno che trema, e dentro si sente un mormorare di vento e lo sbattere del mare sugli scogli. E senti un ruggito come di un leone, il sibilo come di un serpente, e l’ululato di un lupo e il fremere d’un orso, e senti le trombe, ed un tuono, tanti e così strani suoni che mescolati tra loro ne producono uno solo. // Allora tutti impallidirono e la paura apparve in mille segni, né la disciplina militare o la ragione possono far sì che osino andare avanti o fermarsi, perché contro la misteriosa potenza che li colpisce le loro possibilità di difesa sono deboli e insufficienti. Infine fuggono, e uno di loro, informa Buglione, giustificando così l’accaduto: // «Signore, non vi è più nessuno di noi che si vanti di tagliare gli alberi nella selva, che quella è così difesa che io credo (e ci giurerei) che fra quegli alberi abbia preso dimora Satana. Il cuore di chi la guarda ha il cuore chiuso da tre strati di duro diamante, ne ha sentimento in cuore colui che si arrischia ad udire come insieme tuoni, ruggisca e sibili». // Così questo riferisce a Goffredo. Vi era lì per caso Alcaste che lo ascoltava, uomo di coraggio incosciente e feroce, disprezzatore degli uomini e della morte; non avrebbe temuto un orribile animale, né un mostro straordinario (rispetto) a un uomo forte, né un terremoto, un fulmine, il vento, né altro che il mondo abbia di violento. // Scrollava il capo, sorrideva e diceva: «Dove costui non ha coraggio d’andare, vado io; io solo ho intenzione di tagliare gli alberi di quel bosco che è diventato sede di oscuri fantasmi. Non mi impedirà l’andare un orrendo fantasma, né il fremito del bosco o degli uccelli, e neppure se tra quei così spaventosi luoghi mi si mostrasse la porta dell’inferno». // In questo modo si vanta col capitano, e ottenuta da lui la facoltà, il cavaliere s’avvia; e (giunto) osserva la selva e dopo ascolta quello strano rimbombo che usciva da essa, ma non indietreggia il passo, coraggioso, ma sicuro e sprezzante è come prima, e avrebbe già calpestato il terreno difeso dai diavoli, ma gli si oppose (o così a lui parve) un fuoco acceso. // Il gran fuoco cresce e propaga le fiamme scure e fumanti a forma di alte mura e ne circonda il bosco, e così lo rende protetto affinché gli alberi suoi non siano tagliati e schiantati in terra. Le fiamme più alte hanno forma di castelli grandissimi e forniti di torri e questa nuova città infernale ha le sue mura difese da macchine infernali. // Oh quanti mostri armati appaiono a guardia sugli alti merli e con quale faccia terribile! Fra questi alcuni lo guardano con occhi torvi, e agitando le armi altri lo minacciano. Infine anch’egli fugge, e troppo lenta è la fuga, come un leone quando è cacciato, eppure è fuga; e il petto è scosso da timore, sentimento a lui, fino adesso, ignoto. // Egli non si accorse d’aver avuto paura, ma allontanatosi se ne accorse, e n’ebbe stupore e rabbia, e un dolore acuto d’amaro pentimento gli morse il cuore. E infiammato e reso muto dalla triste vergogna, rivolse i passi altrove, perché non ha il coraggio di guardare gli altri in faccia. // Chiamato da Goffredo, ritarda e trova scuse per il ritardo, e desidera non andare. Ma infine va, lentamente; ma tiene la bocca chiusa o parla con aria trasognata. Goffredo deduce che egli abbia avuto paura e sia fuggito, per quella insolita vergogna che ora egli prova, quindi dice: «Che sarà mai? Forse questi sono incantesimi o straordinari prodigi della natura? // Ma se c’è qualcuno in cui la voglia di compiere un atto nobile lo spinga ad andare in quei selvatici luoghi, vada pure, e prenda su di sé il compito o perlomeno sia un per noi una fonte di conoscenza più certa». Così egli disse e nei tre giorni seguenti il grande bosco spaventevole fu affrontato dai cavalieri più famosi, eppure non ci fu nessuno che sia fuggito dalle sue minacce. // Intanto il principe Tancredi si era alzato (dal letto doveva giaceva ferito) per seppellire la sua amata, e benché sia pallido in volto e non adatto a portare elmo e corazza, tuttavia, dal momento che ha visto la necessità, non rifiuta l’impresa rischiosa, perché il suo coraggioso animo trasfonde forza al corpo, tanto che sembra abbondare. // Il valoroso se ne va verso il rischio ignoto raccolto in sé, silenzioso e guardingo, e riesce a sopportare la terribile vista della selva e il gran rumore del tuono e del terremoto. Passa oltre ed ecco che in quel posto silvano sorge improvvisa la città di fuoco. // Allora indietreggia, E dubbioso, si ferma un po’, dicendo fra sé: «Ora qui a cosa servono le armi? Mi getterò in bocca ai mostri e nella gola di questa fiamma divoratrice? Nessuno risparmi la vita, quando una causa giusta lo richieda per il vantaggio comune, ma un uomo degno non sia prodigo di un’anima grande, e così sarebbe chi qui la spreca. Che cosa dirà l’esercito, se torna indietro inutilmente? Quale speranza ha di tagliare un’altra selva? Né Goffredo lascerà mai il tentativo di accedere alla selva di Saron. Ora, se si va avanti, forse l’incendio che qui vedo divampare sarà negli effetti minori di quanto appaia. Avvenga ciò che deve avvenire». E così dicendo, saltò dentro. Oh straordinario coraggio! // Sotto l’armatura gli parve di non sentire né il caldo né il bruciore che avrebbe dovuto procurargli un fuoco intenso, ma, fossero state vere fiamme o solo immagini di esse, non poté saperlo, perché all’improvviso, appena toccato, quell’apparenza sparì all’improvviso, e arrivò una nuvola densa, che portò freddo e gelo, e il gelo e la notte si dileguarono in un momento. // Certo è stupefatto, ma rimane coraggioso Tancredi, e dopo, quando vede che tutto si è placato, avanza nel terreno del bosco profano e guarda al suo interno ogni angolo nascosto, non trova strane e paurose forme, né alcun impedimento od ostacolo, se non il bosco stesso che, essendo intricato e buio, impedisce la vista e ritarda il cammino. // Infine scorge un ampio slargo a forma d’anfiteatro, non c’è nessuna pianta in esso, ad eccezione che nel centro dove alto sorge un cipresso. Si porta là, e nell’osservarlo s’accorge che il tronco era stato inciso con geroglifici già usati nell’antico Egitto. // Fra segni sconosciuti, ne riconosce alcuno della lingua siriana, ch’egli conosce bene: «O tu che hai osato porre il tuo piede tra le regioni della morte, guerriero audace, ah, se non sei crudele quanto forte, ah, non disturbare questo luogo appartato. Perdona ormai le anime prive di vita, chi vive non porta guerra ai morti». Così diceva quella scritta. Egli era tutto preso a capire il senso oscuro delle brevi parole, e ascoltava intanto un fremere di vento tra gli alberi del bosco e tra le piante e le parve un suono di una flebile concerto di sospiri e singhiozzi umani, e un non che di pietoso, spaventoso e doloroso, gli preme il cuore. // Infine trae la spada, e con un gran colpo percuote la grossa pianta. Oh, meraviglia! La scorza recisa fa uscire sangue, rendendo intorno a sé la terra rossa. Tancredi prova ora paura, e tuttavia dà un colpo più forte e decide di vedere quale sarà il risultato. Allora, come uscisse da una tomba, sente un gemito dolente uscire dalla pianta, risolvendosi poi in parole distinte: «Ah, mi hai fatto troppo male, Tancredi, ora basta. Tu mi hai cacciato dal corpo che visse per me e con me, felice dimora dell’anima, perché tormenti anche il misero tronco cui mi legò un duro destino? Vuoi offendere, crudele, i tuoi avversari anche dopo che sono morti? Fui Clorinda, e non sono il solo umano che risieda nella pianta dalla scorza ruvida e dura, ma ancora altri, sia cristiani che pagani, che hanno lasciato il corpo sotto le alte mura di Gerusalemme, è costretto da un incantesimo insolito e strano qui, non so se chiamarlo corpo o nostra tomba, sei tu un assassino, se tronchi l’albero». Come talvolta il malato che in sogno vede un drago o una Chimera enorme cinta di fiamme, sebbene sospetti, anzi si accorga che non è forma vera, tuttavia desidera fuggire, tanto l’apparenza orrida e spaventosa gli incute terrore, così il timoroso amante non crede pienamente ai falsi inganni, tuttavia ne ha paura e si ritrae. // E dentro di lui il cuore è così dominato da vari sentimenti, che si agghiaccia e trema, e nell’emozione potente ed improvvisa gli cade la spada ed il timore è il sentimento meno forte. E’ fuori di sé per il terrore, capisce di aver offeso la sua donna che implora e piange, né sopporta di guardare quel sangue, né di sentire i lamenti di un malato che piange. // Così nessuna immagine turbò con profondo spavento quel cuore audace di fronte alla morte, ma una falsa immagine e finti lamenti ingannarono lui, che è solo debole, vulnerabile in amore. La sua spada caduta intanto un vento impetuoso la trasportò via dal bosco, così che vinto si allontanò; la ritrovò poi per via e la raccolse.

Tancredi tenta l’albero in cui si nasconde Clorinda
E’ una delle pagine in cui il male non si offre ai soldati cristiani sotto forma di una straordinaria bellezza, quindi come vera e propria tentazione, ma sotto forma d’incantesimo, terrore, di male assoluto. Esso è rappresentato attraverso una tecnica soggettiva: non esiste un quadro d’insieme in cui il lettore possa immaginare l’intera scena, ma è un climax ottenuto con la visione singolare con cui dapprima i fabbri, poi i guerrieri, quindi Alcaste e infine Tancredi osservano accrescere il potere demoniaco e la loro paura e con essi il lettore (suspance). Ma l’interesse bisogna riservarlo proprio al cavaliere Tancredi. Egli, ormai privo quasi di motivazioni per vivere, vinto da un senso di necessità più che di dovere, sebbene l’idea di sconfiggere il male gli dia un po’ di vigore, è pronto ad affrontare il demonio, e lo dimostra quando supera i boati, il fuoco, l’improvviso ghiaccio e freddo. Ma non riesce a superare il pianto dell’uomo (il rumore di sottofondo della selva) e l’urlo disperato di Clorinda. Egli non combatte più contro un bosco infestato dai diavoli, ma dentro a i chiostri de la morte, cioè dell’inferno. Ma l’inferno in cui sta, non è altro che la proiezione di ciò che vive dentro, e il pianto degli uomini e l’accusa di Clorinda gli esplodono dentro in un immane senso colpa.
Intanto il campo cristiano è afflitto dalla siccità; cominciano i lamenti; qualcuno, come il duce dei Greci Tatino, abbandona di notte il campo cristiano, seguito da altri quando si sparge la notizia. Goffredo allora volge al Cielo un’ardente preghiera, che viene ascoltata da Dio che ordina che cessi la persecuzione dei demoni contro i Crociati e manda sul campo una pioggia abbondante.

Carlo e Ubaldo con il vecchio mago
Il XIV con Dio che durante la notte vigila dal Cielo e manda il suo sguardo favorevole a Goffredo che vede in sogno Ugone, che gli consiglia di permettere il ritorno di Rinaldo. Il giorno dopo Guelfo, per ispirazione di Dio, propone a Goffredo, che acconsente, di richiamare l’eroe. Si offrono Carlo ed Ubaldo, che, dopo essere stati ricevuti da Pietro l’Eremita, vanno alla ricerca di Rinaldo; si dirigono verso il mare, raggiungendo Ascalona: qui appare loro un mago, un vecchio che era nato di fede pagana e li conduce con sé nella sua grotta sottomarina, nel grembo immenso della terra dove si convertì al cristianesimo e acquisì la sua grande cultura. Parlando di sé, li conduce nella meravigliosa dimora in cui abita e narra come Armida prese prigioniero Rinaldo e con quali arti lo trattiene; svela che si nasconde nell’oceano, nell’isola Fortuna, dove nessuna nave arriva mai, che incontreranno una giovinetta che tenterà di ammaliarli; infine raggiungeranno il castello posto sopra una montagna, dove troveranno Rinaldo. Finito di parlare, li porta a riposare.
XV: All’alba, il mago d’Ascalona accomiata i due cavalieri dopo aver dato loro un foglio, uno scudo e una verga. Sono accolti nella barca guidata dalla Fortuna, cominciano il viaggio attraverso il Mediterraneo, e sulle spiagge di Gaza e verso l’interno vedono le nuove truppe che stanno per andare contro l’esercito cristiano. Attraversano il Mediterraneo, passano oltre le rovine della grande Cartagine e dopo quattro giorni, oltrepassate le colonne d’Ercole, cominciano la navigazione nell’Oceano; chiedono alla Fortuna se altri mai hanno già intrapreso la navigazione nell’aperto Oceano; e la donna parla di Ercole e soprattutto di Ulisse, per cui è ignoto il mare che stanno solcando.
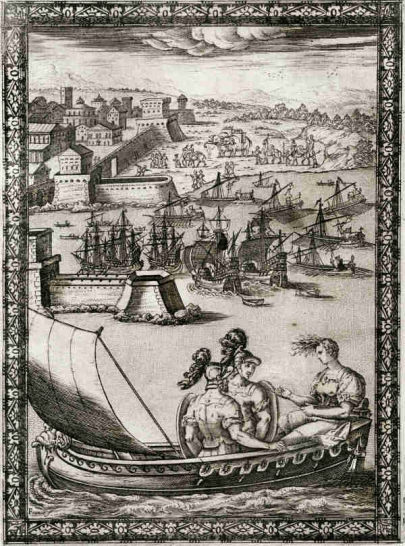
Carlo e Ubaldo sulla barca con Fortuna
LE SCOPERTE GEOGRAFICHE
(30-32)
Tempo verrà che fian d’Ercole i segni
favola vile a i naviganti industri,
e i mar riposti, or senza nome, e i regni
ignoti ancor tra voi saranno illustri.
Fia che ’l piú ardito allor di tutti i legni
quanto circonda il mar circondi e lustri,
e la terra misuri, immensa mole,
vittorioso ed emulo del sole.
Un uom de la Liguria avrà ardimento
a l’incognito corso esporsi in prima;
né ’l minaccievol fremito del vento,
né l’inospito mar, né ’l dubbio clima,
né s’altro di periglio e di spavento
piú grave e formidabile or si stima,
faran che ’l generoso entro a i divieti
d’Abila angusti l’alta mente accheti.
Tu spiegherai, Colombo, a un novo polo
lontane sí le fortunate antenne,
ch’a pena seguirà con gli occhi il volo
la fama c’ha mille occhi e mille penne.
Canti ella Alcide e Bacco, e di te solo
basti a i posteri tuoi ch’alquanto accenne,
ché quel poco darà lunga memoria
di poema dignissima e d’istoria.
Verrà un giorno che i confini posti da Ercole (le colonne d’Ercole) diventeranno leggenda senza importanza per gli arditi naviganti. Ed i mari finora nascosti e senza nome e regni sconosciuti saranno noti anche fra voi uomini. Accadrà che il più coraggioso di tutti i comandanti (Magellano) circuisca ed esplori quante terre il mare circonda e misuri così l’immenso cerchio della terra emulando vittoriosamente il quotidiano raggio del sole. // Un ligure (Colombo) avrà per primo il coraggio d’intraprendere un viaggio sconosciuto, e né il soffio minaccioso del vento, né il mare agitato, né un cattivo clima, né se un altro pericolo o uno spavento più grave e formidabile di quanto ora potessimo ritenere, faranno sì che il marinaio coraggioso tenga la sua grande anima rinserrata entro i confini di Gibilterra. // Tu spiegherai, o Colombo, le vele verso un nuovo mondo, che a stento gli occhi della fama, che ha mille occhi e mille ali, seguiranno il tuo volo. Ella s’accontenti di cantare Ercole e Bacco (famosi, nell’antichità, per i viaggi), ma ti basterà che la fama fornisca appena qualche accenno a chi verrà dopo di te, che sarà di lunga memoria per un poema degnissimo e per la storia.
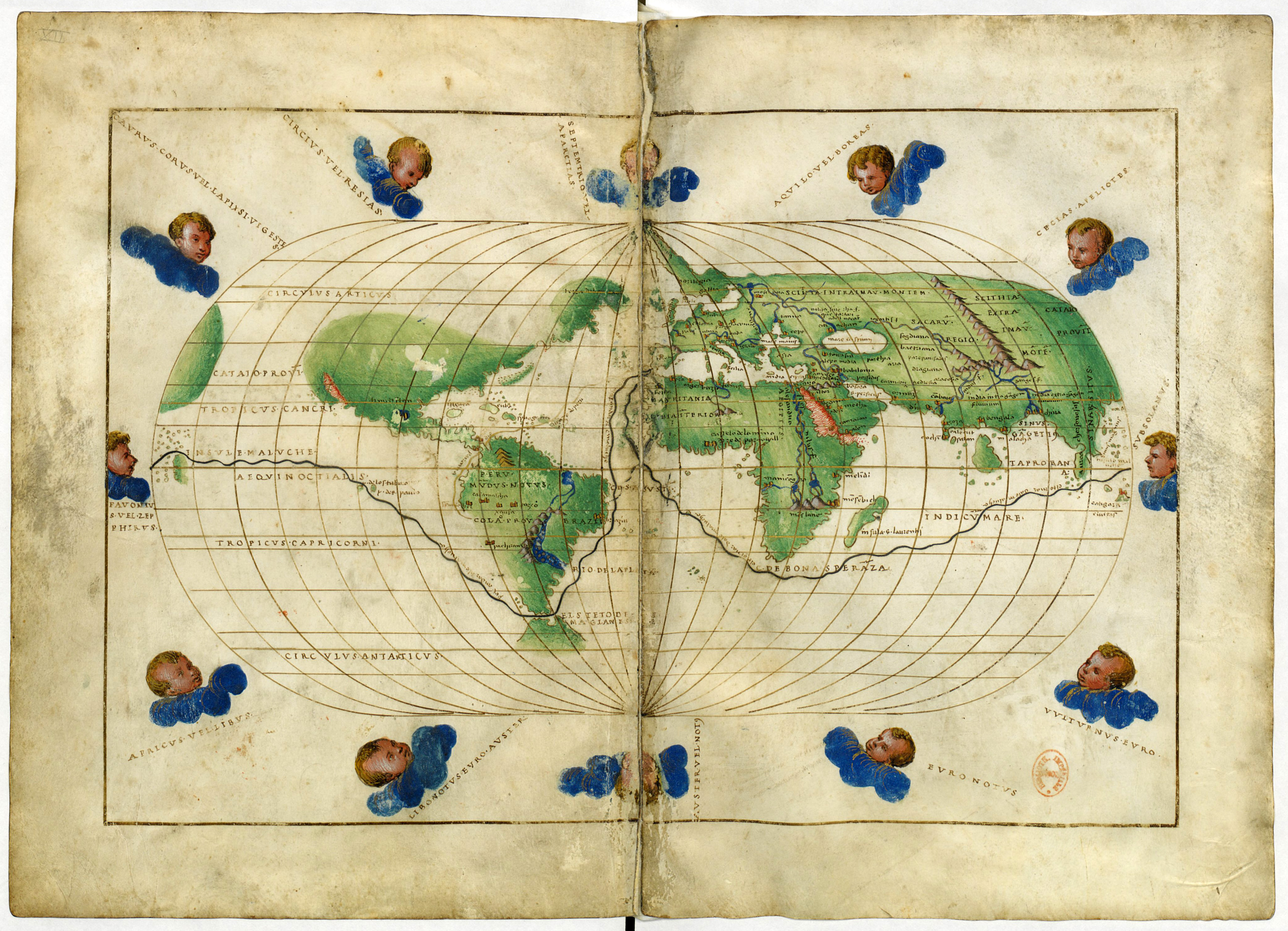
Carta geografica del 1548 con il Nuovo Mondo
Anche Tasso, come Ariosto, non può fare a meno d’inserire nel suo poema un accenno alle scoperte geografiche, che tanta eco ebbero nell’Europa dell’intero ’500. Quello che emerge è che lui le inserisca in un discorso di gloria umana, non disgiunta da quella divina, perché come prima di questo elogio al marinaio ligure, sottolinea come esse, per maggior sua gloria saranno tutte riportate alla vera religione.
Giungono finalmente nelle isole Felici, sette abitate e tre disabitate; sbarcano nell’isola dove si trova il palazzo d’Armida e s’incamminano verso un alto monte, vincendo via via gli ostacoli che loro si presentano per mezzo dei talismani del mago (un serpente con la verga, un leone con un fischio). Salgono il monte e giungono presso la fonte del riso che contiene pericoli mortali, rappresentati da due donzelle nude che nuotano nell’acqua e che cercano di allettarli a sé; ma memori dei consigli ricevuti, essi passano oltre.

François Lemoyne: Carlo e Ubaldo
XVI: Carlo e Ubaldo entrano nel palazzo d’Armida dalle cento entrate, e penetrano nel giardino incantato:
IL CASTELLO D’ARMIDA
(1-2; 8-22; 30-31; 35-40)
Tondo è il ricco edificio, e nel piú chiuso
grembo di lui, ché quasi centro al giro,
un giardin v’ha ch’adorno è sovra l’uso
di quanti piú famosi unqua fioriro.
D’intorno inosservabile e confuso
ordin di loggie i demon fabri ordiro,
e tra le oblique vie di quel fallace
ravolgimento impenetrabil giace.
Per l’entrata maggior (però che cento
l’ampio albergo n’avea) passar costoro.
Le porte qui d’effigiato argento
su i cardini stridean di lucid’oro.
Fermàr ne le figure il guardo intento,
ché vinta la materia è dal lavoro:
manca il parlar, di vivo altro non chiedi;
né manca questo ancor, s’a gli occhi credi.
Sulla porta del palazzo Carlo e Ubaldo vedono raffigurate storie di amanti famosi: la vicenda mitica dell’amore di Ercole per Onfale e quella di Antonio e Cleopatra, con la rappresentazione della battaglia di Azio. Distolto lo sguardo da queste immagini, i due cavalieri entrano nell’insidioso palazzo dalla struttura labirintica
Qual Meandro fra rive oblique e incerte
scherza e con dubbio corso or cala or monta,
queste acque a i fonti e quelle al mar converte,
e mentre ei vien, sé che ritorna affronta,
tali e piú inestricabili conserte
son queste vie, ma il libro in sé le impronta
(il libro, don del mago) e d’esse in modo
parla che le risolve, e spiega il nodo.
Poi che lasciàr gli aviluppati calli,
in lieto aspetto il bel giardin s’aperse:
acque stagnanti, mobili cristalli,
fior vari e varie piante, erbe diverse,
apriche collinette, ombrose valli,
selve e spelonche in una vista offerse;
e quel che ’l bello e ’l caro accresce a l’opre,
l’arte, che tutto fa, nulla si scopre.
Stimi (sí misto il culto è co ’l negletto)
sol naturali e gli ornamenti e i siti.
Di natura arte par, che per diletto
l’imitatrice sua scherzando imiti.
L’aura, non ch’altro, è de la maga effetto,
l’aura che rende gli alberi fioriti:
co’ fiori eterni eterno il frutto dura,
e mentre spunta l’un, l’altro matura.
Nel tronco istesso e tra l’istessa foglia
sovra il nascente fico invecchia il fico;
pendono a un ramo, un con dorata spoglia,
l’altro con verde, il novo e ’l pomo antico;
lussureggiante serpe alto e germoglia
la torta vite ov’è piú l’orto aprico:
qui l’uva ha in fiori acerba, e qui d’or l’have
e di piropo e già di nèttar grave.
Vezzosi augelli infra le verdi fronde
temprano a prova lascivette note;
mormora l’aura, e fa le foglie e l’onde
garrir che variamente ella percote.
Quando taccion gli augelli alto risponde,
quando cantan gli augei piú lieve scote;
sia caso od arte, or accompagna, ed ora
alterna i versi lor la musica òra.
Vola fra gli altri un che le piume ha sparte
di color vari ed ha purpureo il rostro,
e lingua snoda in guisa larga, e parte
la voce sí ch’assembra il sermon nostro.
Questi ivi allor continovò con arte
tanta il parlar che fu mirabil mostro.
Tacquero gli altri ad ascoltarlo intenti,
e fermaro i susurri in aria i venti.
«Deh mira» egli cantò «spuntar la rosa
dal verde suo modesta e verginella,
che mezzo aperta ancora e mezzo ascosa,
quanto si mostra men, tanto è più bella.
Ecco poi nudo il sen già baldanzosa
dispiega; ecco poi langue e non par quella,
quella non par che desiata inanti
fu da mille donzelle e mille amanti.
Cosí trapassa al trapassar d’un giorno
de la vita mortale il fiore e ’l verde;
né perché faccia indietro april ritorno,
si rinfiora ella mai, né si rinverde.
Cogliam la rosa in su ’l mattino adorno
di questo dí, che tosto il seren perde;
cogliam d’amor la rosa: amiamo or quando
esser si puote riamato amando».
Tacque, e concorde de gli augelli il coro,
quasi approvando, il canto indi ripiglia.
Raddoppian le colombe i baci loro,
ogni animal d’amar si riconsiglia;
par che la dura quercia e ’l casto alloro
e tutta la frondosa ampia famiglia,
par che la terra e l’acqua e formi e spiri
dolcissimi d’amor sensi e sospiri.
Fra melodia sí tenera, fra tante
vaghezze allettatrici e lusinghiere,
va quella coppia, e rigida e costante
se stessa indura a i vezzi del piacere.
Ecco tra fronde e fronde il guardo inante
penetra e vede, o pargli di vedere,
vede pur certo il vago e la diletta,
ch’egli è in grembo a la donna, essa a l’erbetta.
Ella dinanzi al petto ha il vel diviso,
e ’l crin sparge incomposto al vento estivo;
langue per vezzo, e ’l suo infiammato viso
fan biancheggiando i bei sudor piú vivo:
qual raggio in onda, le scintilla un riso
ne gli umidi occhi tremulo e lascivo.
Sovra lui pende; ed ei nel grembo molle
le posa il capo, e ’l volto al volto attolle,
e i famelici sguardi avidamente
in lei pascendo si consuma e strugge.
S’inchina, e i dolci baci ella sovente
liba or da gli occhi e da le labra or sugge,
ed in quel punto ei sospirar si sente
profondo sí che pensi: “Or l’alma fugge
e ’n lei trapassa peregrina”. Ascosi
mirano i due guerrier gli atti amorosi.
Dal fianco de l’amante (estranio arnese)
un cristallo pendea lucido e netto.
Sorse, e quel fra le mani a lui sospese
a i misteri d’Amor ministro eletto.
Con luci ella ridenti, ei con accese,
mirano in vari oggetti un solo oggetto:
ella del vetro a sé fa specchio, ed egli
gli occhi di lei sereni a sé fa spegli.
L’uno di servitú, l’altra d’impero
si gloria, ella in se stessa ed egli in lei.
«Volgi», dicea «deh volgi» il cavaliero
«a me quegli occhi onde beata bèi,
ché son, se tu no ’l sai, ritratto vero
de le bellezze tue gli incendi miei;
la forma lor, la meraviglia a pieno
piú che il cristallo tuo mostra il mio seno.
Deh! poi che sdegni me, com’egli è vago
mirar tu almen potessi il proprio volto;
ché il guardo tuo, ch’altrove non è pago,
gioirebbe felice in sé rivolto.
Non può specchio ritrar sí dolce imago,
né in picciol vetro è un paradiso accolto:
specchio t’è degno il cielo, e ne le stelle
puoi riguardar le tue sembianze belle.»

Cecco Bravo: Armida (1650)
Superba Armida si ricompone e prende commiato da Rinaldo, per tornare alle “sue magiche carte”. Rinaldo, invece, rimane nel giardino, dal quale l’incanto non gli consente di allontanarsi. Approfittando dell’assenza della maga, Carlo e Ubaldo entrano nel giardino: la vista dei cavalieri armati scuote Rinaldo:
Egli al lucido scudo il guardo gira,
onde si specchia in lui qual siasi e quanto
con delicato culto adorno; spira
tutto odori e lascivie il crine e ’l manto,
e ’l ferro, il ferro aver, non ch’altro, mira
dal troppo lusso effeminato a canto:
guernito è sí ch’inutile ornamento
sembra, non militar fero instrumento.
Qual uom da cupo e grave sonno oppresso
dopo vaneggiar lungo in sé riviene,
tal ei tornò nel rimirar se stesso,
ma se stesso mirar già non sostiene;
giú cade il guardo, e timido e dimesso,
guardando a terra, la vergogna il tiene.
Si chiuderebbe e sotto il mare e dentro
il foco per celarsi, e giú nel centro.
Ubaldo risveglia Rinaldo ai suoi doveri e questo arrossisce, si vergogna del suo sviamento e di avere lasciato il campo di battaglia.
(…)
Intanto Armida de la regal porta
mirò giacere il fier custode estinto.
Sospettò prima, e si fu poscia accorta
ch’era il suo caro al dipartirsi accinto;
e ’l vide (ahi fera vista!) al dolce albergo
dar, frettoloso, fuggitivo il tergo.
Volea gridar: «Dove, o crudel, me sola
lasci?», ma il varco al suon chiuse il dolore,
sí che tornò la flebile parola
piú amara indietro a rimbombar su ’l core.
Misera! i suoi diletti ora le invola
forza e saper, del suo saper maggiore.
Ella se ’l vede, e invan pur s’argomenta
di ritenerlo e l’arti sue ritenta.
Quante mormorò mai profane note
tessala maga con la bocca immonda,
ciò ch’arrestar può le celesti rote
e l’ombre trar de la prigion profonda,
sapea ben tutte, e pur oprar non pote
ch’almen l’inferno al suo parlar risponda.
Lascia gli incanti, e vuol provar se vaga
e supplice beltà sia miglior maga.
Corre, e non ha d’onor cura o ritegno.
Ahi! dove or sono i suoi trionfi e i vanti?
Costei d’Amor, quanto egli è grande, il regno
volse e rivolse sol co ’l cenno inanti,
e cosí pari al fasto ebbe lo sdegno,
ch’amò d’essere amata, odiò gli amanti;
sé gradí sola, e fuor di sé in altrui
sol qualche effetto de’ begli occhi sui.
Or negletta e schernita in abbandono
rimase, segue pur chi fugge e sprezza;
e procura adornar co’ pianti il dono
rifiutato per sé di sua bellezza.
Vassene, ed al piè tenero non sono
quel gelo intoppo e quella alpina asprezza;
e invia per messaggieri inanzi i gridi,
né giunge lui pria ch’ei sia giunto a i lidi.
Forsennata gridava: «O tu che porte
parte teco di me, parte ne lassi,
o prendi l’una o rendi l’altra, o morte
dà insieme ad ambe: arresta, arresta i passi,
sol che ti sian le voci ultime porte;
non dico i baci, altra piú degna avrassi
quelli da te. Che temi, empio, se resti?
Potrai negar, poi che fuggir potesti.

Annibale Carracci: Armida e Rinaldo
Il ricco edificio è di forma circolare e, nella sua parte più interna, che è quasi nel cerchio delle mura, vi è un giardino ornato oltre misura dei fiori più famosi che mai fiorirono. Intorno i demoni, mutati in costruttori, fecero un incredibile complicata serie di logge e (il giardino) è posto, impenetrabile, tra i sentieri tortuosi di quell’ingannevole labirinto. // I crociati Carlo e Ubaldo passarono per l’entrata più grande (perché l’ampio edificio ne aveva cento), qui le porte, effigiate d’argento, stridevano sui cardini di oro lucido. Fermarono il loro sguardo attento sulle figure scolpite, perché la materia è superata dall’arte con cui è lavorata: (alle figure) manca la parola, non servirebbe altro affinché sembrino vive, e non manca nemmeno questa, se credi a ciò che vedi.
Come il fiume Meandro sembra divertirsi fra rive tortuose e non ben definite e con un labirintico percorso ora discende e ora risale, devia alcune acque verso le fonti e altre verso il mare e mentre scorre si scontra con se stesso che rifluisce, così sono questi sentieri, e anche più inestricabilmente intrecciati, ma il libro contiene il loro disegno (il libro, dono del mago d’Ascalona) e il libro li descrive in modo da risolvere le difficoltà che esse presentano. // Dopo che Carlo ed Ubaldo lasciarono i sentieri intrecciati si aprì il bel giardino dall’aspetto sereno; ad un solo sguardo mostrò laghetti, acque cristalline, svariati fiori e piante, singolari erbe, soleggiate collinette, ombrose valli, selve e grotte e, pregio dell’opera, non si vede l’artificio magico che ha creato il tutto. // I decori e i luoghi ti sembrano (tanto bene sono mescolate le parti coltivate e quelle incolte) del tutto naturali. Sembra un artificio della natura che, per gioco, imiti, scherzando, la sua imitatrice. La brezza, che fa fiorire gli alberi, non è altro che un artificio della maga: con i fiori eterni, anche il frutto dura in eterno e, mentre il fiore spunta, il frutto matura. // Nello stesso albero e fra le stesse foglie accanto al fico che nasce, matura un altro fico; pendono da un unico ramo il frutto nuovo e quello vecchio, l’uno dall’aspetto maturo, l’altro acerbo, la lussureggiante vite ritorta si arrampica in alto e germoglia, dove il giardino è più soleggiato, qui essa ha sia l’uva acerba in fiori, sia l’uva di colore dorato e rosso e già gravida di succo. // Graziosi uccelli modulano, a gara, note sensuali; la brezza mormora e fa risuonare le acque che colpisce in vari modi. Quando tacciono gli uccelli, il vento soffia forte, quando cantano gli uccelli, scuote più lievemente, sia casualmente, sia ad arte; l’aura musicale ora accompagna ed ora alterna i versi degli uccelli. // Fra gli altri vola un uccello che ha le piume variegate di colori diversi ed ha il becco rosso, e muove la lingua abilmente e modula la voce in modo da imitare il parlare umano. Esso allora continuò con tale abilità che il suo parlare fu per noi motivo di grande stupore. Tacquero gli altri uccelli, intenti ad ascoltarlo, e i venti fermarono i sussurri nell’aria. // «Deh, guarda», cantò quello, «spuntare la rosa piccola e ancora in bocciolo dal suo stelo che, non ancora del tutto sbocciata, è tanto più bella quanto meno si mostra. Ecco che poi distende i suoi i suoi petali ormai spavalda; ecco che poi appassisce e non sembra la stessa, non sembra la stessa che prima fu desiderata da mille fanciulle e mille amanti. // Così muore, con il morire di un giorno, la bellezza e la giovinezza della vita mortale; e non ritrova più la sua bellezza e la sua giovinezza, per quanto la primavera ritorni. Cogliamo la rosa nel mattino luminoso di questo giorno, perché presto si oscura; cogliamo la rosa dell’amore: amiamo ora, quando, amando, si può ancora essere amati». // Tacque e il coro unanime degli uccelli, come per approvare le sue parole, riprende il canto. Le colombe raddoppiano i loro baci ed ogni animale si decide di darsi all’amore; sembra che la robusta quercia, il casto alloro, tutto il genere delle piante, la terra e l’acqua producano ed emanino dolcissimi sentimenti d’amore. // Fra una melodia così dolce, fra tante dolcezze allettatrici e piacevoli, procede quella coppia (di cavalieri) e, ferma e imperturbabile, si rende insensibile alle seduzioni del piacere. Ecco che lo sguardo penetra innanzi fra ramo a ramo e vede, o gli pare di vedere, infine con certezza l’amante (Rinaldo) e l’amata (Armida): egli è in grembo alla donna, lei in mezzo all’erbetta. // Ella ha il velo aperto sul petto e scioglie i capelli scomposti al vento estivo; si abbandona languida, e le lievi gocce di sudore rendono più luminoso il suo viso arrossato (per la passione): come un raggio sull’acqua, le risplende un sorriso fremente e passionale negli occhi umidi. E’ ricurva sopra di lui; ed egli le posa il capo sul grembo morbido e solleva il volto verso quello di lei e, rivolgendo a lei avidamente gli anelanti sguardi, si consuma e si strugge. Armida si china e ora assapora spesso i dolci baci dagli occhi e ora li succhia dalle labbra, e in quel momento si ode lui sospirare profondamente, tanto che pensi: “Ora l’anima gli sfugge e, pellegrina, trapassa in lei”. I due guerrieri guardano di nascosto gli atti amorosi. // Dal fianco dell’amante pendeva (insolito strumento) uno specchio lucido e nitido. Si alzò e lo pose fra le mani di lui, scelto come ministro ai riti d’Amore. Lei con occhi ridenti, lui con occhi accesi, guardano un unico oggetto in vari oggetti: lei si riflette nello specchio e lui si rispecchia negli occhi sereni di lei. // Rinaldo si vanta della propria schiavitù, Armida del proprio potere; lei si vanta di se stessa, lui di lei. «Rivolgi» diceva «rivolgi a me quegli occhi grazie ai quali, essendo tu felice, dono felicità, perché la mia passione è, se non lo sai, l’immagine fedele delle tue bellezze; il mio cuore riflette appieno, più dello specchio, la loro forma, la meraviglia (che suscitano). // Deh, dato che mi disdegni, almeno potessi mirare com’è bello il tuo volto, perché il tuo sguardo, che non trova appagamento altrove, gioirebbe felice rivolto verso sé. Non può lo specchio riflettere un’immagine così dolce, né in un piccolo specchio può essere contenuto il paradiso della tua bellezza: il cielo è uno specchio degno di te, e solo nelle stelle puoi ammirare la tua bellezza».

Tiepolo: Rinaldo abbandona Armida
Rinaldo volge lo sguardo al lucido scudo, nel quale si specchia e vede in quali condizioni si è ridotto e di quali effeminate raffinatezze è circondato; emanano profumi voluttuosi i capelli e il mantello; e guarda la spada, solo la spada, che ha accanto, effeminata per il troppo lusso: è ornata in modo tale che sembra un inutile orpello, non un fiero strumento di guerra. // Come un uomo oppresso da un sonno cupo e pesante, dopo un lungo delirare torna in sé, così si riebbe Rinaldo guardandosi nello scudo, ma non sopporta oltre di guardare se stesso, lo sguardo si abbassa e, guardando a terra, timido e dimesso, è colto dalla vergogna. Per nascondersi si chiuderebbe sotto il mare e dentro il fuoco e fin e fin nel centro della terra
Intanto Armida vide a distesa a terra morto il feroce custode della porta regale. Dapprima sospettò, poi fu certa che il suo caro (Rinaldo) stava accingendosi a partire; infatti lo vide (ah, vista terribile!) volgere frettolosamente la schiena alla loro dolce dimora. // Voleva gridare: «Dove, o crudele, sola mi lasci?», ma il dolore chiuse il varco alle parole, così che esse tornarono dietro flebili e più amare, a rimbombare nel suo cuore infelice! Una forza ed un sapere più forti delle sue arti magiche le rubavano i suoi piaceri. Lei capisce e invano si ingegna per trattenere Rinaldo e ritenta le sue magie. // Quante empie formule magiche mai mormorò una maga tessala con la sua bocca immonda, capace di fermare il moto degli astri e far tornare le ombre dall’inferno, lei tutte le sapeva bene, eppure non può far sì che almeno l’inferno le risponda. Lascia da parte le magie e vuol provare se la sua bellezza leggiadra e supplicante sia miglior maga. // Corre verso Rinaldo senza ritegno e cura per la propria dignità. Ah! dove sono ora i suoi trionfi e i suoi vanti? Costei che in passato poteva signoreggiare con un solo cenno sul regno d’Amore, per quanto grande sia, e mostrò ugualmente l’orgoglio di essere amata e il disprezzo verso i suoi amanti: amò solo se stessa e all’infuori di sé negli altri amò soltanto gli effetti d’amore provocati dai suoi begli occhi. // Ora rimasta sola, trascurata e disprezzata, insegue Rinaldo che fugge da lei e mostra di disprezzarla; e cerca di rendere più gradito, ornandolo di pianti, il dono della sua bellezza di per sé rifiutato. Se ne va, e al suo tenero piede non fanno ostacolo le nevi né le pendici scoscesi del monte; e manda innanzi le grida come messaggeri del suo dolore; ma non riesce a raggiungere Rinaldo prima che egli arrivi sulla spiaggia. // Gridava forsennata: «O tu che porti via una parte di me, e me ne lasci solo un’altra (il corpo) prendili o restituiscili entrambe, oppure a entrambe dà la morte: ferma, ferma i tuoi passi, solo per il tempo in cui io possa rivolgerti le mie ultime parole, non i baci: quelli li avrà da te qualche altra donna più degna. Che cosa temi, crudele, a fermarti? Potrai respingere (ogni mia offerta) dal momento che hai potuto fuggire».

Tiepolo: Rinaldo lascia Armida
Potremo individuare in questo passo quattro momenti:
- La descrizione del castello e della natura;
- Gli amori tra Rinaldo e Armida;
- La presa di coscienza del cavaliere e il suo allontanamento;
- La trasformazione di Armida;
-
Partiamo dal primo aspetto: qui Tasso mostra di poter giocare e confrontarsi con i grandi del passato fino agli immediati suoi predecessori nella descrizione di un locus amoenus. Tuttavia, qualcosa di estremamente particolare c’è: esso, infatti, è “labirintico” e dove, se non si ha una guida (il libro di Carlo e Ubaldo), si ci perde la ragione e quindi la fede. Poi è anche innaturale, in quanto i diavoli lo hanno costruito facendo in esso coincidere da una parte morte e vita (nello stesso ramo vi è la nascita e il raggiungimento della maturità) tra realtà e arte (il giardino confonde ciò che è “natura” da ciò che è “artificio”). Ancora rappresenta il trionfo dell’amore, riprendendo il tema classico della “rosa”: ma qui a cantare la “necessità di coglierla” non è un cavaliere “ringalluzzito”, ma un vero e proprio “mostro” diabolico, un uccello dalla voce quasi umana;
- A caratterizzare l’amore tra Rinaldo e Arminia è anch’esso un fatto innaturale; infatti essi non si guardano ma si specchiano: lei in un vero e proprio specchio, lui negli occhi di lei in cui vede la donna riflessa: torna l’“arte” a vincere sulla realtà: ma a questo punto è bene sottolineare che qui appare un oggetto che sarà estremamente presente, poi, nella poetica barocca; anche il rinsavimento di Rinaldo avviene per un’immagine riflessa; se nello specchio vede la bellezza, nello scudo vede la sua degradazione (da cavaliere a imbelle amante)
- Ma il personaggio più riuscito è certamente quello di Armida: da ammaliatrice di uomini a donna innamorata, ferita per l’abbandono. Ella dopo la fuga di Rinaldo non è più lei e se pur maturerà all’inizio l’idea di una vendetta, quello che conta e la morte di ciò che rappresenta, quando, prima si denigra di fronte a Rinaldo che la rifiuta (nessun arte magica le può essere utile) e infine, quando sale su un carro per andare via dall’isola, tutto ciò che la sua arte aveva prodotto (castello e giardino) sparirà nel nulla.
Alla fine, grazie anche all’intercessione di Ubaldo, Armida raggiunge il cavaliere e gli parla in modo accorato, lo prega di accettarla almeno come ancella o addirittura come schiava. Rinaldo le risponde che devono lasciarsi, e parte mentre la donna dà libero sfogo al suo dolore disperato minacciando infine vendetta. Partiti i tre guerrieri, Armida con le sue arti magiche, distrutto il suo palazzo e il giardino incantato, vola sul suo carro a Gaza nel campo del re d’Egitto.

Carlo e Ubaldo incontrano il mago di Ascalona
Il XVII inizia con il Califfo che a Gaza passa in rassegna il suo esercito, mentre giunge Armida circondata da cento donzelle e cento paggi. Il Califfo recatosi poi a mensa nella gran tenda; viene raggiunto da Armida, che promette di divenire moglie di colui che ucciderà Rinaldo. Per primo le risponde Adrasto, poi Tisaferno e quindi tutti. Rinaldo, intanto, con Carlo e Ubaldo si imbarca nella nave della Fortuna; dopo quattro giorni di navigazione giungono in Palestina; appare loro da lontano un albero luminoso con armi nuove appese e a guardia un vecchio, il mago d’Ascalona, che lietamente li riceve e fa vedere a Rinaldo, in uno scudo lucente, tutti i suoi antenati e le glorie della Casa d’Este. Quindi si dirigono verso Gerusalemme e giunti nella Città Santa, Rinaldo e i suoi compagni si separano dal mago e giungono al campo cristiano.
Nel XVIII Rinaldo s’incontra con Goffredo che lo accoglie e con gioia e gli racconta come la selva sia dominata da oscuri incantesimi; dopo aver ricevuto dimostrazioni di affetto da tutti i principi cristiani, l’eroe si offre per varcare la selva maledetta. Quindi su consiglio di Pietro l’Eremita va a pregare sul Monte Oliveto, dove, tra una natura bellissima, rimane fino all’alba. Finita la preghiera va verso la selva:

Scuola napoletana: La foresta incantata
RINALDO NELLA SELVA INCANTATA
(17-38)
Era là giunto ove i men forti arresta
solo il terror che di sua vista spira;
pur né spiacente a lui né pauroso
il bosco par, ma lietamente ombroso.
Passa piú oltre, e ode un suono intanto
che dolcissimamente si diffonde.
Vi sente d’un ruscello il roco pianto
e ’l sospirar de l’aura infra le fronde
e di musico cigno il flebil canto
e l’usignol che plora e gli risponde,
organi e cetre e voci umane in rime:
tanti e sí fatti suoni un suono esprime.
Il cavalier, pur come a gli altri aviene,
n’attendeva un gran tuon d’alto spavento,
e v’ode poi di ninfe e di sirene,
d’aure, d’acque, d’augei dolce concento,
onde meravigliando il piè ritiene,
e poi se ’n va tutto sospeso e lento;
e fra via non ritrova altro divieto
che quel d’un fiume trapassante e cheto.
L’un margo e l’altro del bel fiume, adorno
di vaghezze e d’odori, olezza e ride.
Ei stende tanto il suo girevol corno
che tra ’l suo giro il gran bosco s’asside,
né pur gli fa dolce ghirlanda intorno,
ma un canaletto suo v’entra e ’l divide:
bagna egli il bosco e ’l bosco il fiume adombra
con bel cambio fra lor d’umore e d’ombra.
Mentre mira il guerriero ove si guade,
ecco un ponte mirabile appariva:
un ricco ponte d’or che larghe strade
su gli archi stabilissimi gli offriva.
Passa il dorato varco, e quel giú cade
tosto che ’l piè toccata ha l’altra riva;
e se ne ’l porta in giú l’acqua repente,
l’acqua ch’è d’un bel rio fatta un torrente.
Ei si rivolge e dilatato il mira
e gonfio assai quasi per nevi sciolte,
che ’n se stesso volubil si raggira
con mille rapidissime rivolte.
Ma pur desio di novitade il tira
a spiar tra le piante antiche e folte,
e ’n quelle solitudini selvagge
sempre a sé nova meraviglia il tragge.
Dove in passando le vestigia ei posa,
par ch’ivi scaturisca o che germoglie:
là s’apre il giglio e qui spunta la rosa,
qui sorge un fonte, ivi un ruscel si scioglie,
e sovra e intorno a lui la selva annosa
tutte parea ringiovenir le foglie;
s’ammolliscon le scorze e si rinverde
piú lietamente in ogni pianta il verde.
Rugiadosa di manna era ogni fronda,
e distillava de le scorze il mèle,
e di novo s’udia quella gioconda
strana armonia di canto e di querele;
ma il coro uman, ch’a i cigni, a l’aura, a l’onda
facea tenor, non sa dove si cele:
non sa veder chi formi umani accenti,
né dove siano i musici stromenti.
Mentre riguarda, e fede il pensier nega
a quel che ’l senso gli offeria per vero,
vede un mirto in disparte, e là si piega
ove in gran piazza termina un sentiero.
L’estranio mirto i suoi gran rami spiega,
piú del cipresso e de la palma altero,
e sovra tutti gli arbori frondeggia;
ed ivi par del bosco esser la reggia.
Fermo il guerrier ne la gran piazza, affisa
a maggior novitate allor le ciglia.
Quercia gli appar che per se stessa incisa
apre feconda il cavo ventre e figlia,
e n’esce fuor vestita in strana guisa
ninfa d’età cresciuta (oh meraviglia!);
e vede insieme poi cento altre piante
cento ninfe produr dal sen pregnante.
Quai le mostra la scena o quai dipinte
tal volta rimiriam dèe boscareccie,
nude le braccia e l’abito succinte,
con bei coturni e con disciolte treccie,
tali in sembianza si vedean le finte
figlie de le selvatiche corteccie;
se non che in vece d’arco o di faretra,
chi tien leuto, e chi viola o cetra.
E cominciàr costor danze e carole,
e di se stesse una corona ordiro
e cinsero il guerrier, sí come sòle
esser punto rinchiuso entro il suo giro.
Cinser la pianta ancora, e tai parole
nel dolce canto lor da lui s’udiro:
«Ben caro giungi in queste chiostre amene
o de la donna nostra amore e spene.
Giungi aspettato a dar salute a l’egra,
d’amoroso pensiero arsa e ferita.
Questa selva che dianzi era sí negra,
stanza conforme a la dolente vita,
vedi che tutta al tuo venir s’allegra
e ’n piú leggiadre forme è rivestita».
Tale era il canto; e poi dal mirto uscia
un dolcissimo tuono, e quel s’apria.
Già ne l’aprir d’un rustico sileno
meraviglie vedea l’antica etade,
ma quel gran mirto da l’aperto seno
imagini mostrò piú belle e rade:
donna mostrò ch’assomigliava a pieno
nel falso aspetto angelica beltade.
Rinaldo guata, e di veder gli è aviso
le sembianze d’Armida e il dolce viso.
Quella lui mira in un lieta e dolente:
mille affetti in un guardo appaion misti.
Poi dice: «Io pur ti veggio, e finalmente
pur ritorni a colei da chi fuggisti.
A che ne vieni? a consolar presente
le mie vedove notti e i giorni tristi?
o vieni a mover guerra, a discacciarme,
che mi celi il bel volto e mostri l’arme?
giungi amante o nemico? Il ricco ponte
io già non preparava ad uom nemico,
né gli apriva i ruscelli, i fior, la fonte,
sgombrando i dumi e ciò ch’a’ passi è intrico.
Togli questo elmo omai, scopri la fronte
e gli occhi a gli occhi miei, s’arrivi amico;
giungi i labri a le labra, il seno al seno,
porgi la destra a la mia destra almeno».
Seguia parlando, e in bei pietosi giri
volgeva i lumi e scoloria i sembianti,
falseggiando i dolcissimi sospiri
e i soavi singulti e i vaghi pianti,
tal che incauta pietade a quei martíri
intenerir potea gli aspri diamanti;
ma il cavaliero, accorto sí, non crudo,
piú non v’attende, e stringe il ferro ignudo.
Vassene al mirto; allor colei s’abbraccia
al caro tronco, e s’interpone e grida:
«Ah non sarà mai ver che tu mi faccia
oltraggio tal, che l’arbor mio recida!
Deponi il ferro, o dispietato, o il caccia
pria ne le vene a l’infelice Armida:
per questo sen, per questo cor la spada
solo al bel mirto mio trovar può strada».
Egli alza il ferro, e ’l suo pregar non cura;
ma colei si trasmuta (oh novi mostri!)
sí come avien che d’una altra figura,
trasformando repente, il sogno mostri.
Cosí ingrossò le membra, e tornò oscura
la faccia e vi sparír gli avori e gli ostri;
crebbe in gigante altissimo, e si feo
con cento armate braccia un Briareo.
Cinquanta spade impugna e con cinquanta
scudi risuona, e minacciando freme.
Ogn’altra ninfa ancor d’arme s’ammanta,
fatta un ciclope orrendo; ed ei non teme:
raddoppia i colpi e la difesa pianta
che pur, come animata, a i colpi geme.
Sembran de l’aria i campi i campi stigi,
tanti appaion in lor mostri e prodigi.
Sopra il turbato ciel, sotto la terra
tuona: e fulmina quello, e trema questa;
vengono i venti e le procelle in guerra,
e gli soffiano al volto aspra tempesta.
Ma pur mai colpo il cavalier non erra,
né per tanto furor punto s’arresta;
tronca la noce: è noce, e mirto parve.
Qui l’incanto forní, sparír le larve.
Tornò sereno il cielo e l’aura cheta,
tornò la selva al natural suo stato:
non d’incanti terribile né lieta,
piena d’orror ma de l’orror innato.
Ritenta il vincitor s’altro piú vieta
ch’esser non possa il bosco omai troncato;
poscia sorride, e fra sé dice: «Oh vane
sembianze! e folle chi per voi rimane!»
 Giacinto Gimignani: Rinaldo nella selva vuole colpire il mirto sul quale
Giacinto Gimignani: Rinaldo nella selva vuole colpire il mirto sul quale
Armida è abbracciata
Era giunto nella selva, dove il terrore che ispira anche solo il guardarlo ferma i più deboli; tuttavia il bosco non gli sembra né sgradevole né terribile, ma dolcemente ombroso. // Precede oltre, e ode frattanto un suono che si diffonde molto soavemente. Nel suono sente il roco mormorare di un ruscello e il soffiare della brezza sui rami e il debole canto di un cigno canoro e l’usignolo che piange e gli risponde, organo e cetre e voci umane in canti: un unico suono contiene tanti e tali suoni. // Il cavaliere, come anche era successo agli altri crociati, si aspettava un fragore di tuono spaventoso e invece ode un dolce concerto di ninfe, sirene, brezze, acque e uccelli, cosicché, stupito, si ferma e poi procede tutto incerto e sospettoso; e sulla strada non trova altro impedimento che un fiume trasparente e calmo. // Entrambe le rive del bel fiume, ornato di fiori belli ed odorosi, profumano e risplendono. Esso allarga tanto il suo corso serpeggiante che nella sua insenatura ha sede il grande bosco, e non solo lo circonda dolcemente, ma lo penetra con un suo ruscelletto e lo divide: il ruscelletto bagna il bosco e il bosco lo ombreggia con un vicendevole scambio di acqua e di ombra. // Mentre il guerriero guarda dove è guadabile, ecco che compare un meraviglioso ponte: un ricco ponte d’oro che gli offriva un ricco passaggio su archi assai stabili. Passa il ponte dorato, e cade nell’acqua non appena ha messo piede sulla riva opposta; l’acqua se lo trascina giù velocemente, l’acqua che da bel ruscello si è trasformata in torrente. // Egli si volge indietro e lo vede ingrandito in gran piena, come se si fossero sciolte le nevi, tanto che si rigira in se stesso vorticoso con mille rapidissimi vortici. Ma il desiderio di vedere cose nuove lo spinge a scrutare tra le pianti secolari e folte e, in quei luoghi deserti e selvaggi una nuova e sorprendente meraviglia lo attira a sé. Dove posa i piedi nel passare, sembra che scaturisca una fonte o germogli un fiore: là si apre un giglio e là spunta una rosa, qui zampilla una fonte e là un ruscello scorre: e sopra e intorno a lui il vecchio bosco sembrava rinvigorire tutte le foglie; le cortecce si bagnano e le foglie di ogni albero rinvigoriscono più lietamente. // Ogni ramo stillava manna e dalle cortecce colava il miele e di nuovo si udiva quella piacevole insolita musica di canto e di lamenti; ma non sa dove si nascondesse il coro di voci umane che faceva da contrappunto ai cigni; alla brezza e all’acqua non riesce a capire chi produca suoni umani, né dove siano gli strumenti musicali. // Mentre continua a guardare e il pensiero non crede a quello che i sensi gli trasmettono come vero, vede in disparte un mirto e si dirige là dove il sentiero termina in una grande piazza. Lo straordinario mirto dispiega i suoi grandi rami, superbo più di un cipresso, e di una palma, e dirama le sue fronde sopra tutti gli alberi, e lì sembra essere il centro del bosco. // Il guerriero, fermo nella grande piazza, rivolge allora intensamente lo sguardo a una più straordinaria novità. Gli appare una quercia che, spaccatasi spontaneamente, apre fertile il tronco scavato, come fosse un ventre, e genera; ne esce fuori, vestita in modo singolare, una ninfa adulta, (oh, meraviglia!) e vede poi altre cento piante generare contemporaneamente cento ninfe dal ventre gravido. // Come le mostra il teatro o come talvolta ammiriamo dipinte le dee dei boschi, con le braccia nude e l’abito succinto, con belle calzature e con le trecce sciolte, così si vedevano nell’aspetto le finte ninfe, figlie delle cortecce di boschi; senonché, al posto dell’arco e della faretra, alcune hanno il liuto, alcune la viola, altre la cetra. // E cominciano a fare danze e girotondi e formano una corona con se stesse e circondano il guerriero, così come un punto è solito essere circondato dalla sua circonferenza. Circondano anche la pianta e si udirono tali parole tra il dolce loro canto: «Veramente gradito giungi in questi ameni luoghi appartati, o amore e speranza della nostra signora. // Giungi atteso a salvare la malata, bruciante e ferita per la passione amorosa. Questo bosco che prima era fosco, come una sede adatta alla vita senza gioia, vedi come si rallegra tutto al tuo arrivo e si riveste delle forme più belle». Questo era il canto, e poi dal mirto uscì un dolcissimo suono, ed esso si aprì. // Un tempo gli antichi vedevano immagini di dei nelle statue cave dei boschivi sileni, ma quel grande mirto dal tronco aperto mostrò le immagini più belle e rare: incontrò una donna che somigliava del tutto, nel suo falso aspetto, a una bellezza angelica. Rinaldo guarda e gli sembrava di vedere la figura d’Armida e il dolce viso. // Egli la vede al tempo stesso felice e addolorata: in un unico sguardo appaiono mille sentimenti. Poi dice: «Anch’io ti vedo e finalmente torni da colei dalla quale sei fuggito. A quale scopo torni? Per consolare, con la tua presenza, le mie solitarie notti e i giorni tristi? O vieni per muovere guerra, per cacciarmi, tu che mi nascondi il bel volto (sotto l’elmo) e mostri le armi? // Giungi come amante o come nemico? Non avrei preparato il ponte d’oro per un nemico, né avrei aperto per lui i ruscelli, i fiori, la fonte, eliminando i cespugli spinosi e ciò che impedisce il passaggio. Togli questo elmo ormai, scopri il volto e gli occhi al mio sguardo, se giungi come amico: congiungi le labbra alle mie labbra, il tuo petto al mio, porgi almeno la mano alla mia». Continuava a parlare e volgeva gli occhi in bei giri che destavano compassione e facevano impallidire il volto, simulando sospiri dolcissimi, soavi singhiozzi e dolci pianti, tanto che una pietà imprudente, di fronte a quelle sofferenze, avrebbe potuto intenerire i duri diamanti; ma il cavaliere accorto sì, non crudele, non vi bada più e stringe la spada sguainata. // Se ne va verso il mirto, allora Armida abbraccia il caro tronco e si pone in mezzo e grida: «Ah, non accadrà mai che tu mi faccia un oltraggio così grave da tagliare il mio albero! Deponi la spada, o crudele, o conficcala prima nelle vene dell’infelice Armida: attraverso questo petto, attraverso questo cuore, la spada può trovare la strada per raggiungere il mio bel mirto». // Egli alza la spada e non bada alle sue preghiere; ma ella si trasforma (oh eccezionali prodigi!) così come accade che un sogno mostri una figura nascere da un’altra, trasformarsi rapidamente. Così ingrossò il suo corpo, e il viso divenne cupo e ne sparirono il biancore e il rossore; diventò un gigante altissimo e si trasformò in un Briareo dalle cento braccia armate. // Impugna cinquanta spade e risuona con cinquanta scudi e minacciando freme d’ira. Anche le altre ninfe si rivestono di armi, diventando orrendi ciclopi; ma egli non ha paura: raddoppia i colpi al mirto ben difeso, che, come se fosse vivo, emette gemiti, quando è colpito. Gli spazi dell’aria sembrano spazi infernali, tanti appaiono in essi mostri e prodigi. // Sopra il cielo è sconvolto, sotto la terra tuona: il cielo lancia fulmini, la terra trema; giungono per far guerra i venti e i nubifragi e gli soffiano sul volto una terribile tempesta. Tuttavia il cavaliere non sbaglia mai un colpo, né si ferma per tanto furore; taglia il noce: è un noce, ma sembra un mirto. Qui l’incantesimo si esaurì e sparirono le apparizioni. //Tornò il sereno e la calma brezza, il bosco tornò alle sue condizioni naturali: non più terribile o ridente per gli incantesimi: ancora pieno di pauroso buio, ma quello naturale. Il vittorioso Rinaldo prova di nuovo se qualcos’altro gli impedisca di tagliare il bosco, poi sorride e dice tra sé: «Oh, felici immagini. E’ folle chi si ferma per causa vostra».
 François Lemoyne: Rinaldo e Armida nella selva incantata
François Lemoyne: Rinaldo e Armida nella selva incantata
Se a sconfiggere i cavalieri cristiani la prima volta sono stati i peccati che si sono materializzati in suoni e immagini orrorifiche, qui a voler sedurre Rinaldo è invece la tentazione, cui era già caduto. Il locus amoenus del giardino d’Armida, viene qui replicato nella selva infernale che, a seconda da chi viene tentata, cambia modus e forma (si pensi al cipresso per Tancredi, simbolo di morte – l’uccisione di Clorinda – e il mirto di Rinaldo, simbolo di poesia e d’amore – l’avvenuta maturazione sessuale per lo stesso – ). E’ evidente, tuttavia, che il giovane eroe cristiano per poter vincere l’amore sensuale e quindi peccaminoso debba prima purificarsi e, come novello Dante, va verso il monte Oliveto dove all’alba (simbolo della rinascita) prega e viene bagnato dalla rugiada (simbolo di acqua benedetta). Ma la forza “morale” tassiana ci lascia un po’ interdetti; non perché egli si serva, nella descrizione del locus amoenus, di tutta la tradizione tanto da arrivare ad utilizzare immagini del Paradiso dantesco, ma addirittura della sua opera, laddove questo luogo si presentava ricco di piacere e libertà nella sua favola pastorale Aminta.
Il canto prosegue con Rinaldo che, dopo aver vinto le forze del male nella selva, torna verso l’accampamento mentre nel campo si diffonde la notizia della fine dell’incantesimo. Si va a raccogliere il legname, si costruiscono arieti e catapulte. Intanto una colomba sorvola lo stuolo francese; la raccoglie Goffredo; reca un messaggio del Califfo d’Egitto ad Aladino. Quindi Goffredo delibera di affrettare l’assalto a Gerusalemme; e intanto manda Vafrino, scudiero di Tancredi, a riconoscere le forze del campo egiziano. Finiti i preparativi vien dato da tre lati l’assalto alla città; Rinaldo sconfigge l’empio Ismeno; la gran torre ricostruita arriva sotto le mura, e invano vi si oppone Solimano. Allora appare agli occhi di Goffredo l’angelo Michele. Rinaldo lascia a Goffredo l’onore di entrare per primo in Gerusalemme e di piantare la Croce sulle mura: esplodono grida di gioia e nello stesso istante Tancredi riesce a vincere la resistenza di Argante; dall’altra parte della città il re Aladino resiste strenuamente; ma quando vengono udite le grida di vittoria degli altri Cristiani, raddoppiano gli sforzi di Raimondo e dei suoi, e allora Aladino fugge in un luogo alto e fortificato, dove spera di continuare la disperata difesa: Gerusalemme è tutta nelle mani cristiane.

Illustrazione per il XVIII canto
Il canto XIX si apre con la lotta tra Argante e Tancredi: escono dalla città e si accende il combattimento, Argante rimane ucciso, mentre Tancredi cade ferito presso di lui e sviene. Nel frattempo Rinaldo assale il tempio di Salomone e lo conquista mentre Solimano e Aladino si rifugiano nella torre di David. Goffredo rimanda all’indomani l’assalto alla torre di David per poter raccogliere e curare i feriti. Intanto Vafrino, giunto nel campo pagano, può rendersi conto della grandezza dell’esercito raccolto; gira e, capitato vicino alla tenda del re egiziano, viene a sapere di una congiura contro Goffredo e del pericolo che corre Rinaldo. Il giorno dopo marcia con l’esercito egiziano, e alla sera, durante la sosta, gira di tenda in tenda e vede Armida con Adrasto, Tisaferno e Altamoro. Ma una giovane donna lo riconosce: è Erminia, che lo rassicura confessandogli il suo amore per Tancredi; è la stessa Erminia a svelargli le modalità della congiura e poi, spinta da Vafrino, racconta del suo amore per il principe cristiano. Insieme ritornano a Gerusalemme, per una strada diversa da quella seguita dall’esercito egiziano.

Nicolas Poussin: Erminia cura Tancredi
Arrivano sotto le mura della città e si imbattono nel corpo esanime di Tancredi; piange Erminia credendolo morto, ma all’improvviso sente un debole lamento uscire dalle labbra di Tancredi, e gli presta le prime cure; Tancredi apre gli occhi e riconosce Vafrino; intanto accorrono in molti e preparano una barella colla quale il principe viene trasportato nella città insieme al corpo di Argante, al quale vuole dare degna sepoltura, perché come un grande aveva combattuto. Vafrino va in cerca di Goffredo, lo trova presso il letto di Raimondo ferito e gli rende conto del suo operato, svelandogli congiure e pericoli. Goffredo decide di combattere gli Egizi in campo aperto. Viene la notte.

Il Guercino: Erminia cura Tancredi
Con il XX canto si arriva al termine dell’opera: Goffredo dispone l’esercito e rivolge loro un discorso d’incitamento, alla fine del quale pare a molti di vedere un lampo celeste. Nello stesso tempo anche il condottiero egizio ordina le sue schiere incitandole. I due eserciti sono schierati l’uno di fronte all’altro, infine viene dato il segnale della battaglia. Goffredo sventa la trama ordita contro di lui, mentre Rinaldo comincia a far grande strage intorno a sé, e ad un certo punto giunge dove si trova Armida che cerca di colpirlo con le sue frecce, ma mentre saetta, Amor lei piaga. Intanto dalla Torre il Sultano guarda la battaglia, e allora insieme ad Aladino esce a combattere; anche il ferito Tancredi si arma di scudo e spada e scende in battaglia. Raimondo uccide Aladino, conquista la rocca e nel sommo di lei scioglie al vento il vessillo crociato. Infuria la battaglia con morte di cavalieri cristiani per mano di Solimano, che rimane a sua volta ucciso da Rinaldo. L’esercito egiziano va in fuga e la battaglia finisce con Rinaldo che, guardandosi intorno, vede tutti abbattuti i vessilli nemici. Si ricorda allora di Armida che fuggiva sola e dolente.
RINALDO E ARMIDA
(123-136)
Piacquele assai che ’n quelle valli ombrose
l’orme sue erranti il caso abbia condutte.
Qui scese dal destriero e qui depose
e l’arco e la faretra e l’armi tutte.
«Armi infelici» disse «e vergognose,
ch’usciste fuor de la battaglia asciutte,
qui vi depongo; e qui sepolte state
poiché l’ingiurie mie mal vendicate.
Ah! ma non fia che fra tant’armi e tante
una di sangue oggi si bagni almeno?
S’ogn’altro petto a voi par di diamante,
osarete piagar feminil seno?
In questo mio, che vi sta nudo avante,
i pregi vostri e le vittorie sieno.
Tenero a i colpi è questo mio: ben sallo
Amor che mai non vi saetta in fallo.
Dimostratevi in me (ch’io vi perdono
la passata viltà) forti ed acute.
Misera Armida, in qual fortuna or sono,
se sol da voi posso sperar salute?
Poi ch’ogn’altro rimedio è in me non buono
se non sol di ferute a le ferute,
sani piaga di stral piaga d’amore,
e sia la morte medicina al core.
Felice me, se nel morir non reco
questa mia peste ad infettar l’inferno!
Restine Amor; venga sol Sdegno or meco
e sia de l’ombra mia compagno eterno,
o ritorni con lui dal regno cieco
a colui che di me fe’ l’empio scherno,
e se gli mostri tal che ’n fere notti
abbia riposi orribili e ’nterrotti.”
Qui tacque e, stabilito il suo pensiero,
strale sceglieva il piú pungente e forte,
quando giunse e mirolla il cavaliero
tanto vicina a l’estrema sua sorte,
già compostasi in atto atroce e fero,
già tinta in viso di pallor di morte.
Da tergo ei se le aventa e ’l braccio prende
che già la fera punta al petto stende.
Si volse Armida e ’l rimirò improviso,
ché no ’l sentí quando da prima ei venne:
alzò le strida, e da l’amato viso
torse le luci disdegnosa e svenne.
Ella cadea, quasi fior mezzo inciso,
piegando il lento collo; ei la sostenne,
le fe’ d’un braccio al bel fianco colonna
e’ ntanto al sen le rallentò la gonna,
e ’l bel volto e ’l bel seno a la meschina
bagnò d’alcuna lagrima pietosa.
Qual a pioggia d’argento e matutina
si rabbellisce scolorita rosa,
tal ella rivenendo alzò la china
faccia, del non suo pianto or lagrimosa.
Tre volte alzò le luci e tre chinolle
dal caro oggetto, e rimirar no ’l volle.
E con man languidetta il forte braccio,
ch’era sostegno suo, schiva respinse;
tentò piú volte e non uscí d’impaccio,
ché via piú stretta ei rilegolla e cinse.
Al fin raccolta entro quel caro laccio,
che le fu caro forse e se n’infinse,
parlando incominciò di spander fiumi,
senza mai dirizzargli al volto i lumi.
»O sempre, e quando parti e quando torni
egualmente crudele, or chi ti guida?
Gran meraviglia che ’l morir distorni
e di vita cagion sia l’omicida.
Tu di salvarmi cerchi? a quali scorni,
a quali pene è riservata Armida?
Conosco l’arti del fellone ignote,
ma ben può nulla chi morir non pote.
Certo è scorno al tuo onor, se non s’addita
incatenata al tuo trionfo inanti
femina or presa a forza e pria tradita:
quest’è ’l maggior de’ titoli e de’ vanti.
Tempo fu ch’io ti chiesi e pace e vita,
dolce or saria con morte uscir de’ pianti;
ma non la chiedo a te, ché non è cosa
ch’essendo dono tuo non mi sia odiosa.
Per me stessa, crudel, spero sottrarmi
a la tua feritade in alcun modo.
E, s’a l’incatenata il tòsco e l’armi
pur mancheranno e i precipizi e ’l nodo,
veggio secure vie che tu vietarmi
il morir non potresti, e ’l ciel ne lodo.
Cessa omai da’ tuoi vezzi. Ah! par ch’ei finga:
deh, come le speranze egre lusinga!”
Cosí doleasi, e con le flebil onde,
ch’amor e sdegno da’ begli occhi stilla,
l’affettuoso pianto egli confonde
in cui pudica la pietà sfavilla;
e con modi dolcissimi risponde:
«Armida, il cor turbato omai tranquilla:
non a gli scherni, al regno io ti riservo;
nemico no, ma tuo campione e servo.
Mira ne gli occhi miei, s’al dir non vuoi
fede prestar, de la mia fede il zelo.
Nel soglio, ove regnàr gli avoli tuoi,
riporti giuro; ed oh piacesse al Cielo
ch’a la tua mente alcun de’ raggi suoi
del paganesmo dissolvesse il velo,
com’io farei che ’n Oriente alcuna
non t’agguagliasse di regal fortuna».
Sí parla e prega, e i preghi bagna e scalda
or di lagrime rare, or di sospiri;
onde sí come suol nevosa falda
dov’arda il sole o tepid’aura spiri,
cosí l’ira che ’n lei parea sí salda
solvesi e restan sol gli altri desiri.
«Ecco l’ancilla tua; d’essa a tuo senno
Dispon», gli disse «e le fia legge il cenno».

Anonimo (scuola Guercino): Rinaldo ed Armida
Fu soddisfatta infine che il caso abbia portato il suo vagare senza meta in quelle oscure valli. Scese dal cavallo e depose in terra l’arco, le frecce e tutte le sue armi. «Armi disonorate» disse «e sfortunate, che, finita la battaglia, non siete riuscire a bagnarvi del sangue del nemico (Rinaldo) qui vi lascio; e qui, rimarrete sepolte, perché avete mal vendicato le offese a me recate. // Ah, ma non avverrà che tra tantissime armi, almeno una non sia bagnata dal sangue? Se ogni altro petto a voi (spade) vi è parso impenetrabile come fosse di diamante, avrete il coraggio di ferire a morte il mio petto di donna? Saranno qui, in lui, che sta nudo di fronte a voi, i vostri pregi e le vostre vittorie. Il mio petto è tenero ai vostri colpi, lo sa Amore, che mai colpisce in modo errato. // Mostratevi contro di me, che io vi perdono la passata vigliaccheria, forti e penetranti. Povera Armida, in quale condizione misera adesso sono, se posso sperare salvezza soltanto da voi? Dal momento che ogni altro rimedio non è per me efficace tranne quello che oppone ferite a ferite, una ferita mortale che guarisce la ferita d’amore che già porto nel cuore. Felice se, nel morire non porto con me questa ferita ad infettare l’inferno! Rimanga Amore; venga solo con me lo sdegno e sia dell’anima mia eterno compagno o ritorni dall’inferno, accompagnato d’Amore, per perseguitare colui che mi schernì e gli sia tale che nelle tremende notti abbia sonni orribili e agitati». // Così parlò e, decisa a darsi la morte, sceglieva la spada più acuminata e resistente, quando giunse il cavaliere (Rinaldo) e la vide così vicina alla morte, già pre-paratasi all’atto atroce e crudele, già col pallore della morte in viso. Dalle spalle egli le si avventa e gli prende la mano che già la terribile punta porta sul petto. // All’improvviso Armida si volse e lo guardò, che non lo sentì prima, quando egli s’avvicinava: gridò, distolse lo sguardo dal viso amato e svenne. Cadeva, come un fiore tagliato a metà, piegando il molle collo; lui la sostenne, le fece da colonna col suo braccio e le slacciò l’abito al petto (per facilitarne la respirazione) // e bagnò con qualche lacrima di pietà il suo bel volto e il seno. Come alle gocce di rugiada inargentata mattutina dai biancori dell’alba si rinvigorisce la rosa scolorita, così Armida rinvenendo non dal suo pianto e dalle sue lacrime, alzò la faccia reclinata. Tre volte rivolse lo sguardo e tre volte lo riabbassò dal caro Rinaldo, per non vederlo. // E con il braccio debole respinse sdegnosa il forte braccio, suo sostegno; ci provò più volte, ma non riuscì a liberarsi, che anzi lui la teneva più forte e la stringeva. Infine raccolta dentro quelle care braccia, che le era caro, ma voleva dissimularlo, parlando cominciò a spargere fiumi di lacrime, senza mai rivolgere gli occhi verso il suo viso. // «Sempre crudele, sia quando vai via per abbandonarmi, sia quando torni per impedirmi di morire, chi ti ha portato qui? Grande meraviglia che ad allontanarmi dalla morte e a ridarmi la vita sia colui che mi ha già ucciso. Cerchi di salvarmi? Quali offese, quali tormenti hai riservato per Armida? Conosco bene le astuzie del traditore Rinaldo, ma può fare ben poco chi non può morire. // Certo è sconveniente per il tuo onore, se per il tuo trionfo non si mostra incatenata una femmina ora presa a forza e prima tradita: questo è il maggiore tra i titoli guerreschi. Ci fu un tempo in cui io ti chiesi pace e vita, ora sarebbe dolce uscire dai pianti con la morte: ma non te la chiedo, perché se fosse un dono tuo, sarebbe per me una cosa odiosa. // Da me stessa, o crudele, spero liberarmi dalla tua crudeltà in ogni modo. E, seppure incatenata come una schiava, il veleno e una spada, i precipizi e il nodo di una corda non mancheranno; vedo vie sicure per cui tu non potrai impedirmi di morire, e ne lodo il Cielo. Smetti le tue false lusinghe. Ah, come recita bene e come lusingandomi rianima le mie speranze!». Così si lamentava e con piccoli fiumi di lacrime, che stilla dai begli occhi per rabbia e per amore; lui confonde il suo affettuoso pianto (a quello d’Armida) in cui rifulge la pietà, e in modo dolcissimi risponde: «Armida, ormai calma il cuore turbato, non gli scherni, ma un regno io riservo per te; non nemico, ma tuo servo e cavaliere. Guarda nei miei occhi, se non vuoi credere alle mie parole, l’ardore della mia fede. Nel trono, dove regnarono i tuoi antenati, giuro di riportarti; ed, oh, volesse il cielo che, con uno dei suoi raggi, venisse ad illuminarti, tale da liberarti dalla fede pagana, così farei che in Oriente alcuna donna possa competere con te per fortuna». Così parla e prega, e le preghiere bagna di lacrime e con sospiri; per cui allo stesso modo come avviene sul suolo nevoso, quando arde il sole o spira un’aria tiepida, così si dissolve l’ira di Armida e restano solo i desideri d’amore: «Ecco la tua ancella, disponi del suo volere», gli disse «ed ogni tuo cenno sia legge».
Si completa così la trasformazione di Armida, prima maga, poi donna, ora “femmina”. A caratterizzare il passo è il pianto, fiumi di pianto sia di lei che di lui, dove vengono mescolati vari sentimenti: rabbia, amore, pietà. Essi accentuano il pathos e sottolineano il modo attraverso cui Tasso mostra il mondo interiore dei suoi personaggi.
E’ il momento culminante: Goffredo, dopo aver ucciso Emireno, e fatto prigioniero Altamoro, invade e prende il campo degli Egizi. Poi, sul far della sera, sale al Santo Sepolcro e scioglie il voto.
L’ULTIMA OTTAVA
(144)
Cosí vince Goffredo, ed a lui tanto
avanza ancor de la diurna luce
ch’a la città già liberata, al santo
ostel di Cristo i vincitor conduce.
Né pur deposto il sanguinoso manto,
viene al tempio con gli altri il sommo duce;
e qui l’arme sospende, e qui devoto
il gran Sepolcro adora e scioglie il voto.
Così vince Goffredo, e a lui rimane ancora tanta parte del giorno, da quando ha liberato la città e conduce i vincitori al Santo Sepolcro. Senza neppure togliersi il mantello sanguinoso, il grande capitano viene al Tempio con gli altri principi e qui depone le armi, e qui devoto adora il grande Sepolcro e scioglie il voto.
Il poema si chiude con la vittoria di Goffredo, eroe che lascia di sé l’immagine di uomo devoto e porta a compimento la liberazione del Santo Sepolcro e prega umilmente su di esso.
L’opera si chiude, così come l’opera si era aperta: la presa di Goffredo, con l’immagine sopra descritta, certo sentita, ma in linea con le tendenze controriformistiche presenti in quel periodo ci dice che la storia è terminata. Si tratta di un vero e proprio epilogo che contraddice l’“opera aperta” d’Ariosto. In Tasso il poema segue altre linee
verisimiglianza vs fantasia
centralità vs dispersione
e attraverso queste direttive egli comincerà a dare segnali della fine di un genere e dell’inizio di un altro genere: il romanzo; non bisogna dimenticare infatti che, al di là delle azioni belliche, il poema viva maggiormente di analisi e introspezione psicologica: caratteristiche che saranno raccolte in modo parodico certo, con più Ariosto che Tasso, perché migliore è il riferimento verso l’epica del passato, nel primo grande romanzo europeo: il El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha di Cervantes.

![Goldoni Carlo : Mémoires [...] pour servir a l'histoire de sa vie, et a celle de son](https://www.gonnelli.it/photos/auctions/xlarge/10011.jpg)







 Ortensia e Dejanira
Ortensia e Dejanira

 Locandina dello spettacolo teatrale con la regia di Tony Servillo (2007)
Locandina dello spettacolo teatrale con la regia di Tony Servillo (2007)


 Anicet Charles Gabriel Lemonnier: Lecture de la tragédie de l’orphelin de la Chine de Voltaire dans le salone de signora Geoffrin (1812)
Anicet Charles Gabriel Lemonnier: Lecture de la tragédie de l’orphelin de la Chine de Voltaire dans le salone de signora Geoffrin (1812)
 L’Encyclopedie
L’Encyclopedie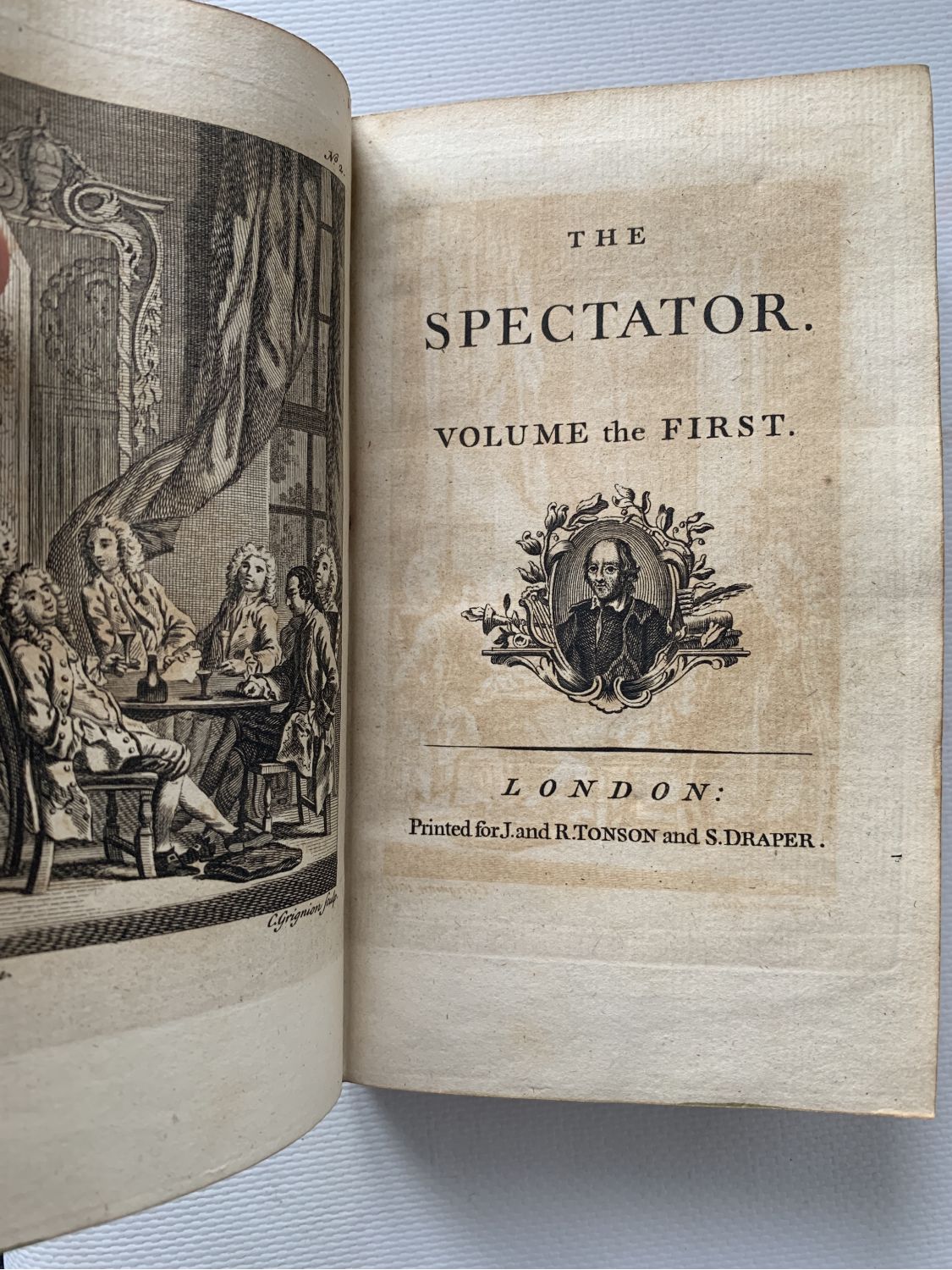

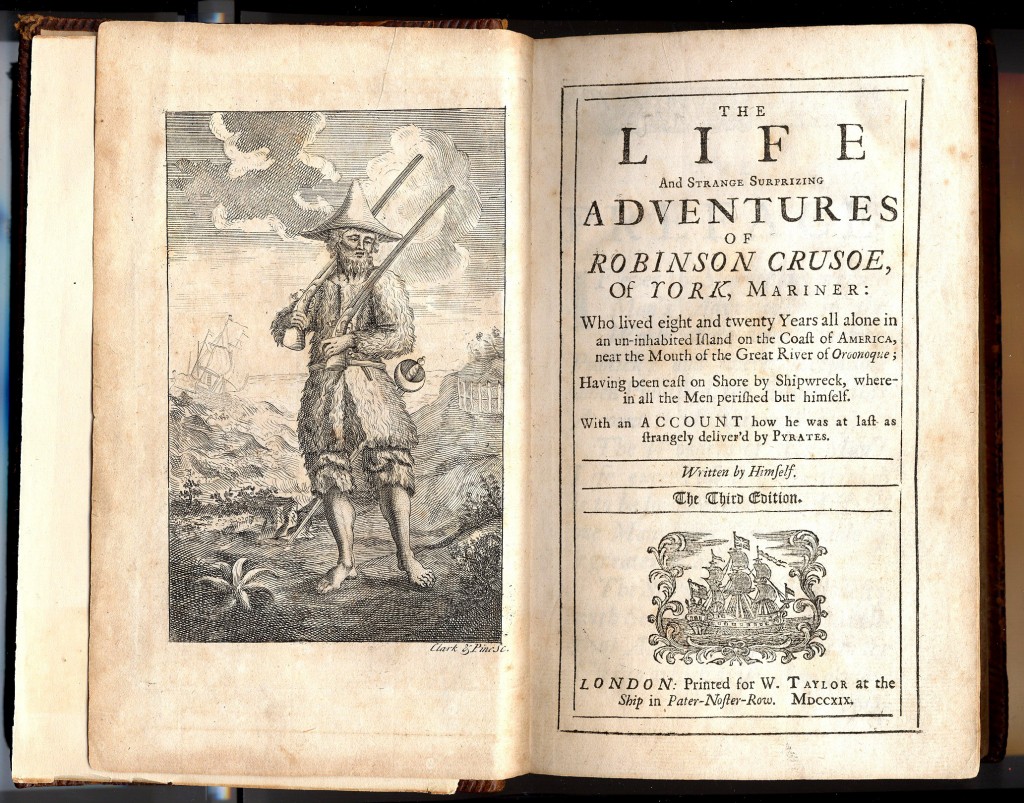 La prima edizione del romanzo di Daniel Defoe (1719)
La prima edizione del romanzo di Daniel Defoe (1719)
 Una delle incisioni che illustrano il romanzo di Richardson
Una delle incisioni che illustrano il romanzo di Richardson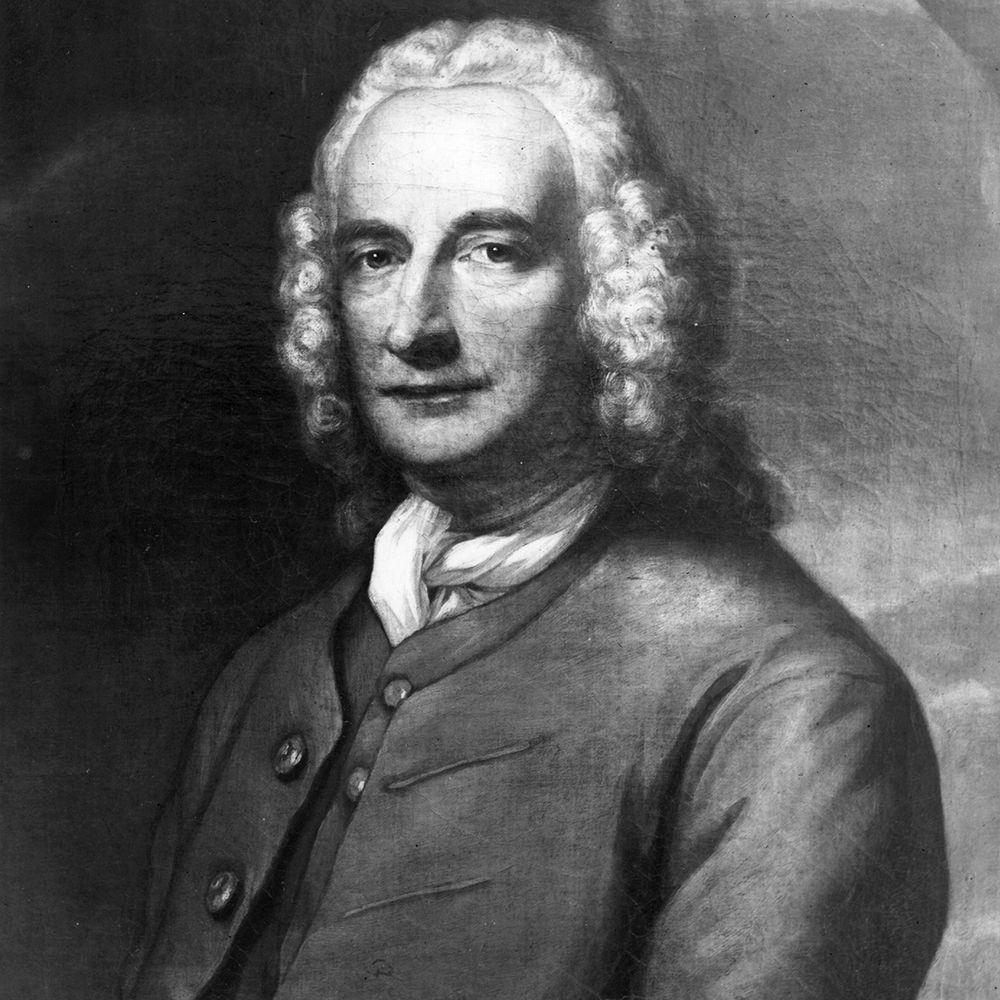 Ritratto di Henry Fielding
Ritratto di Henry Fielding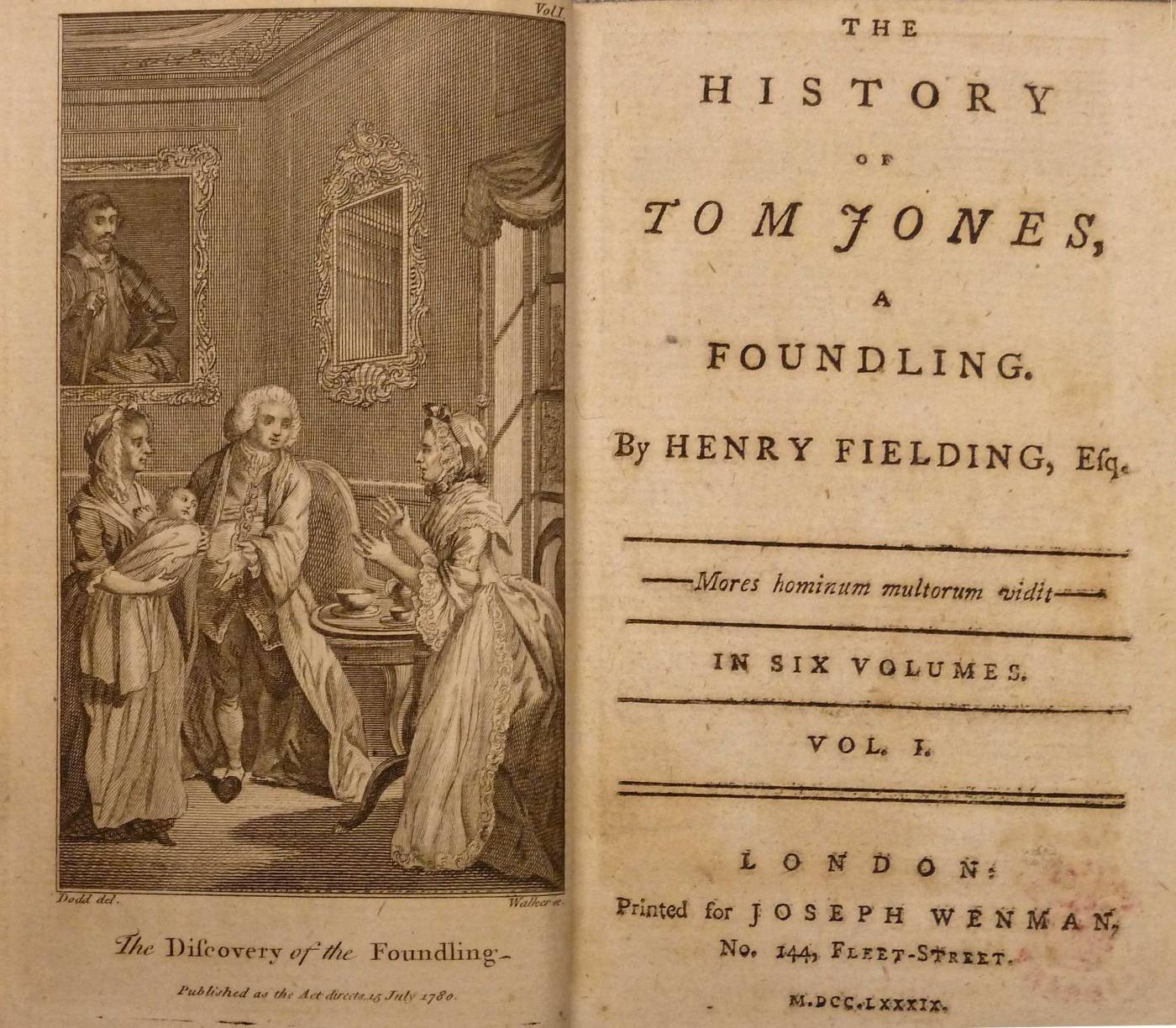


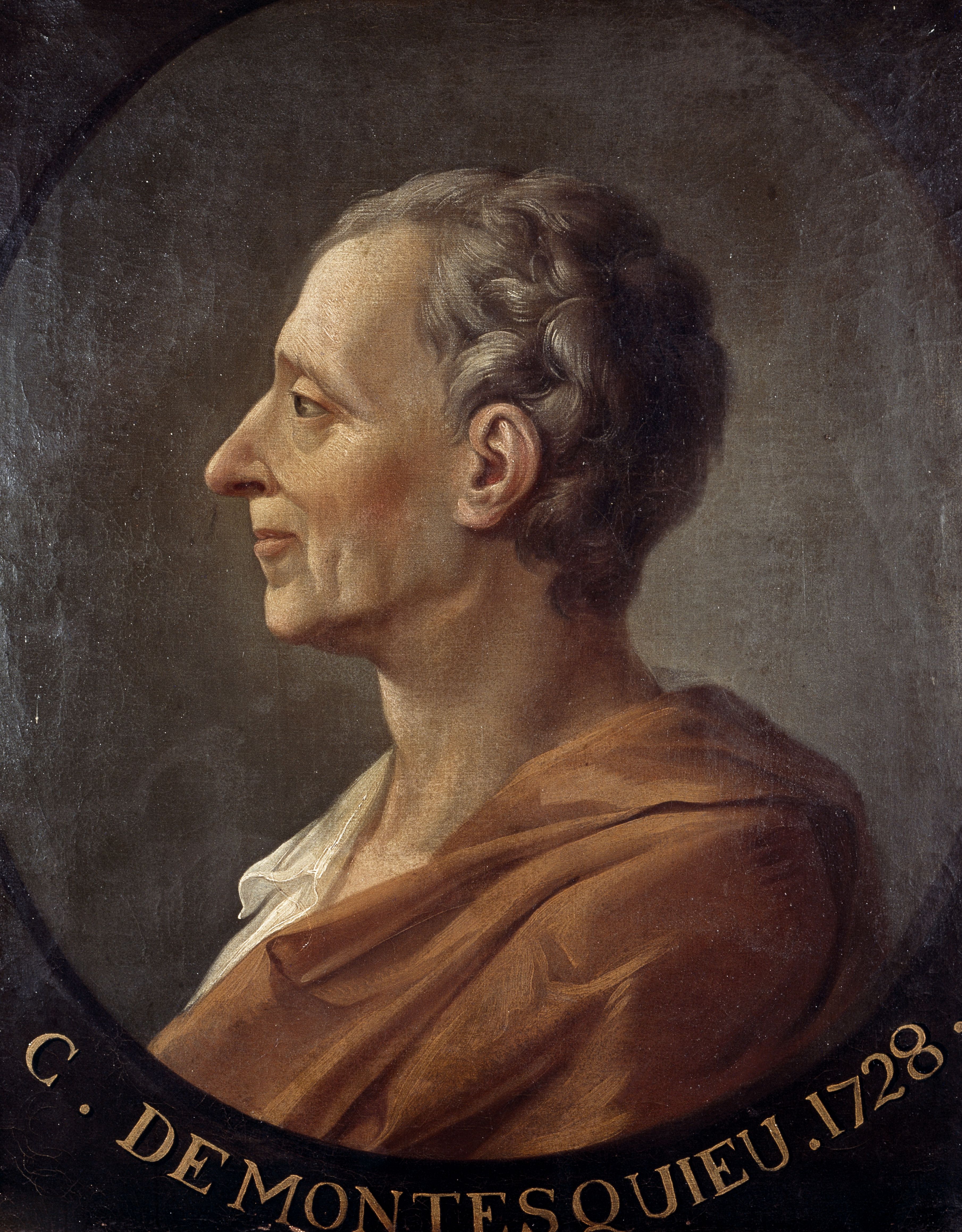
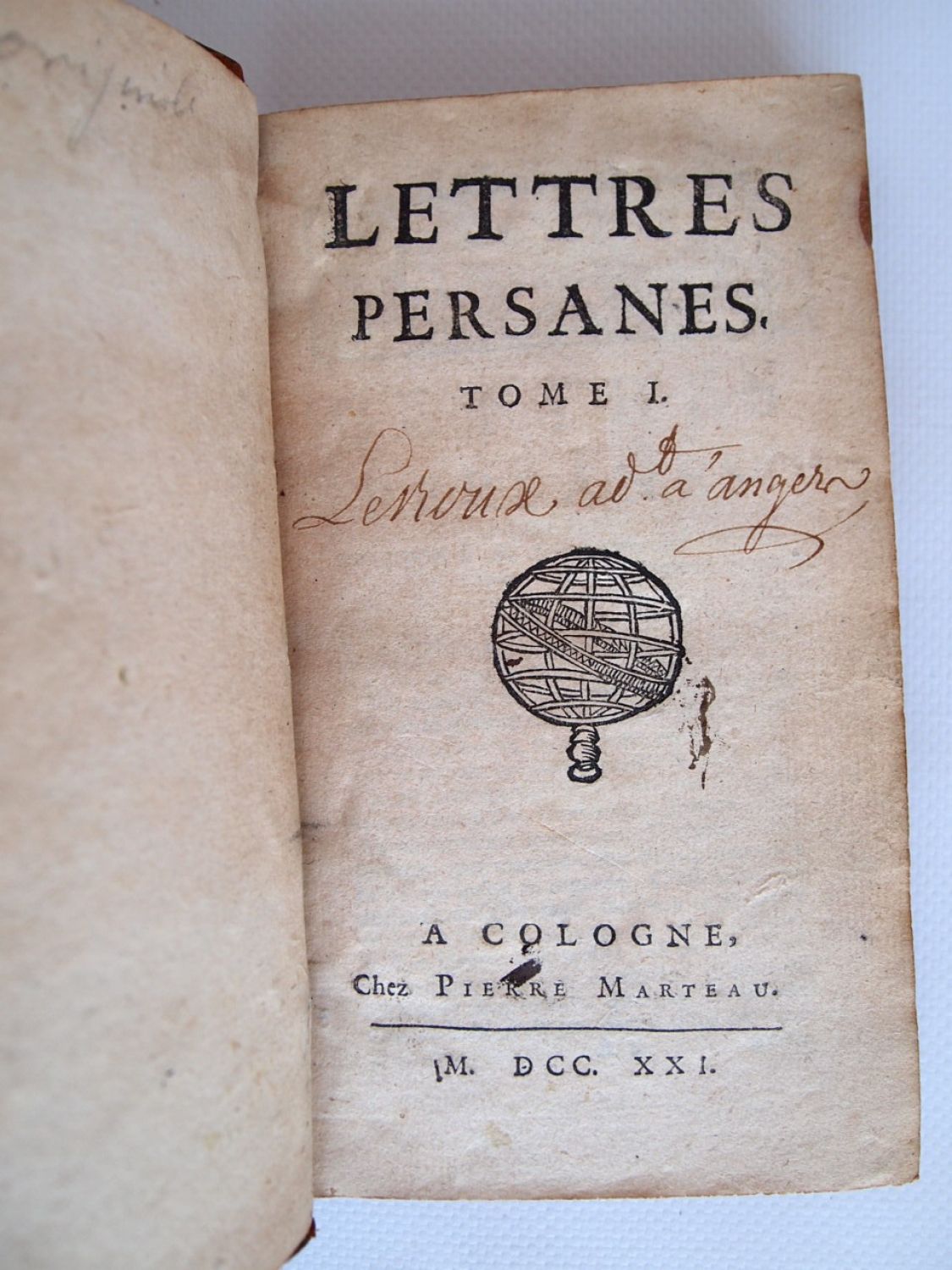




 LA LEGGE E LA FAME
LA LEGGE E LA FAME L’EDUCAZIONE PUBBLICA
L’EDUCAZIONE PUBBLICA

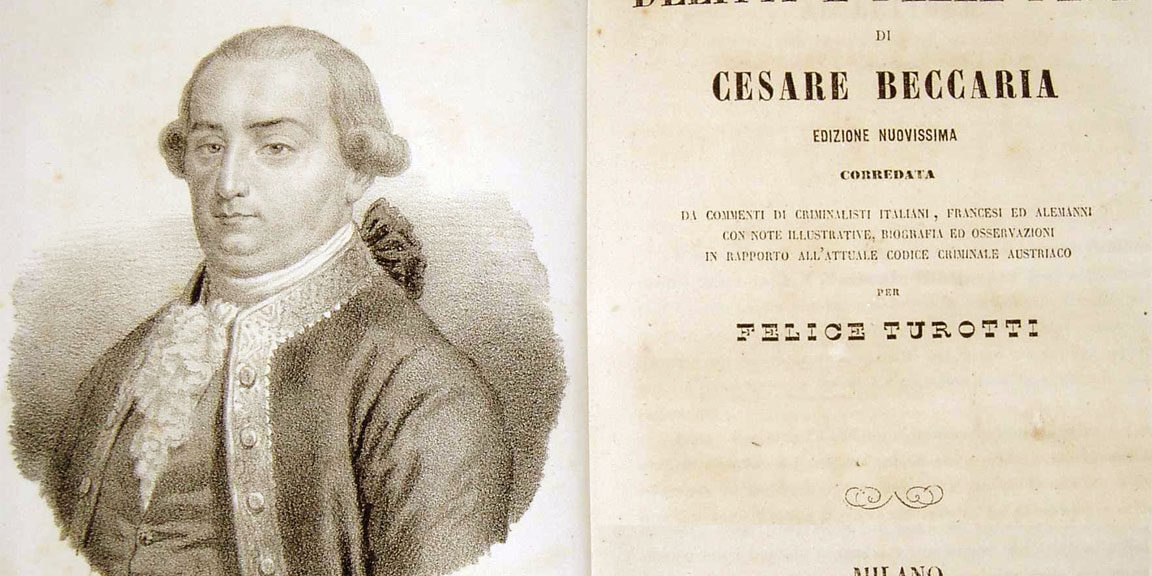
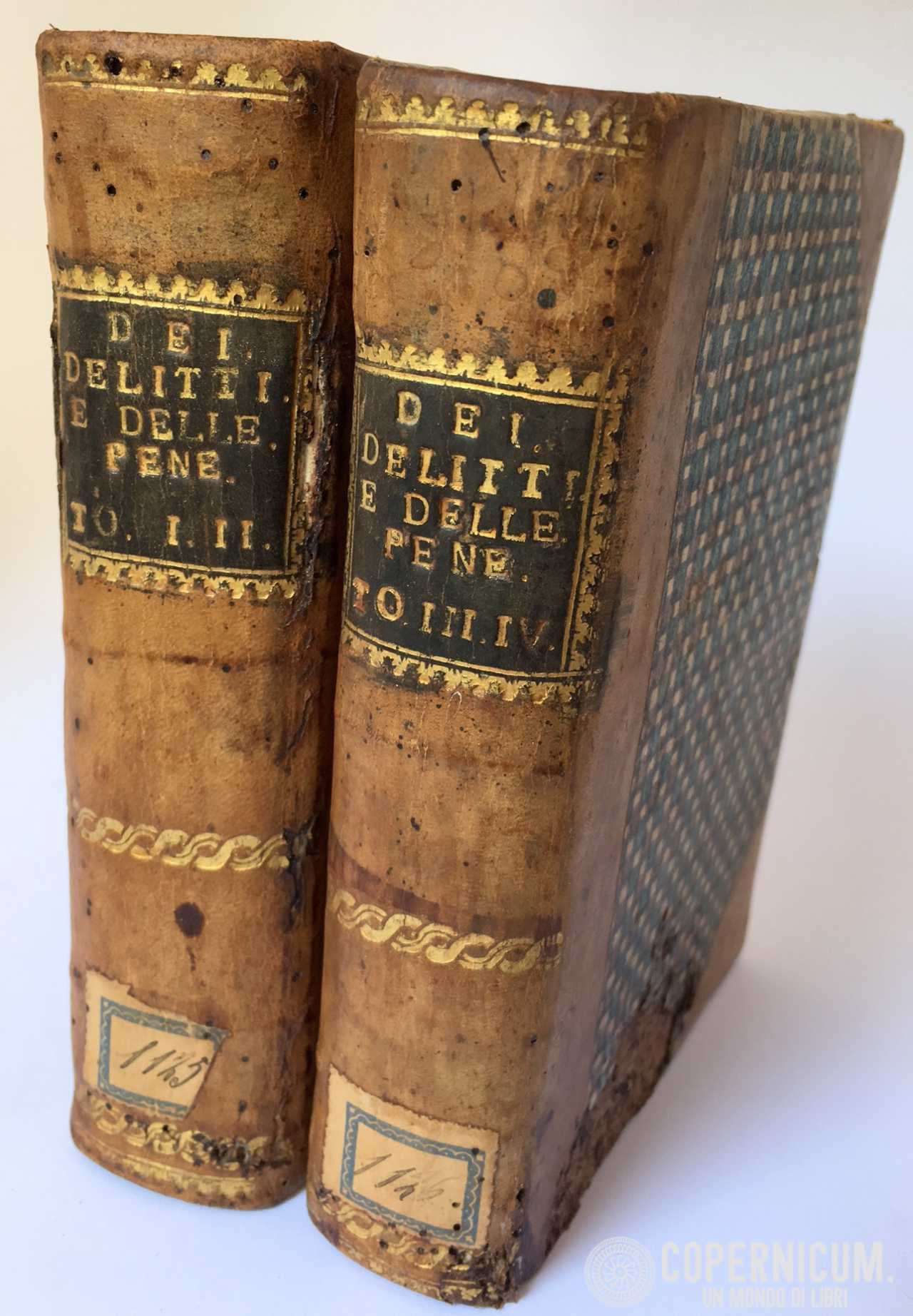



 Roma: Bosco Parrasio
Roma: Bosco Parrasio Edizione del 1757 dell’opera di Zappi
Edizione del 1757 dell’opera di Zappi Paolo Rolli
Paolo Rolli

 Busto del Muratori al Pincio di Roma
Busto del Muratori al Pincio di Roma
![Vico Giambattista : Principi di scienza nuova [...] d'intorno alla comune natura delle nazioni [...]. Tomo I (-](https://www.gonnelli.it/photos/auctions/xlarge/11375_2.jpg)

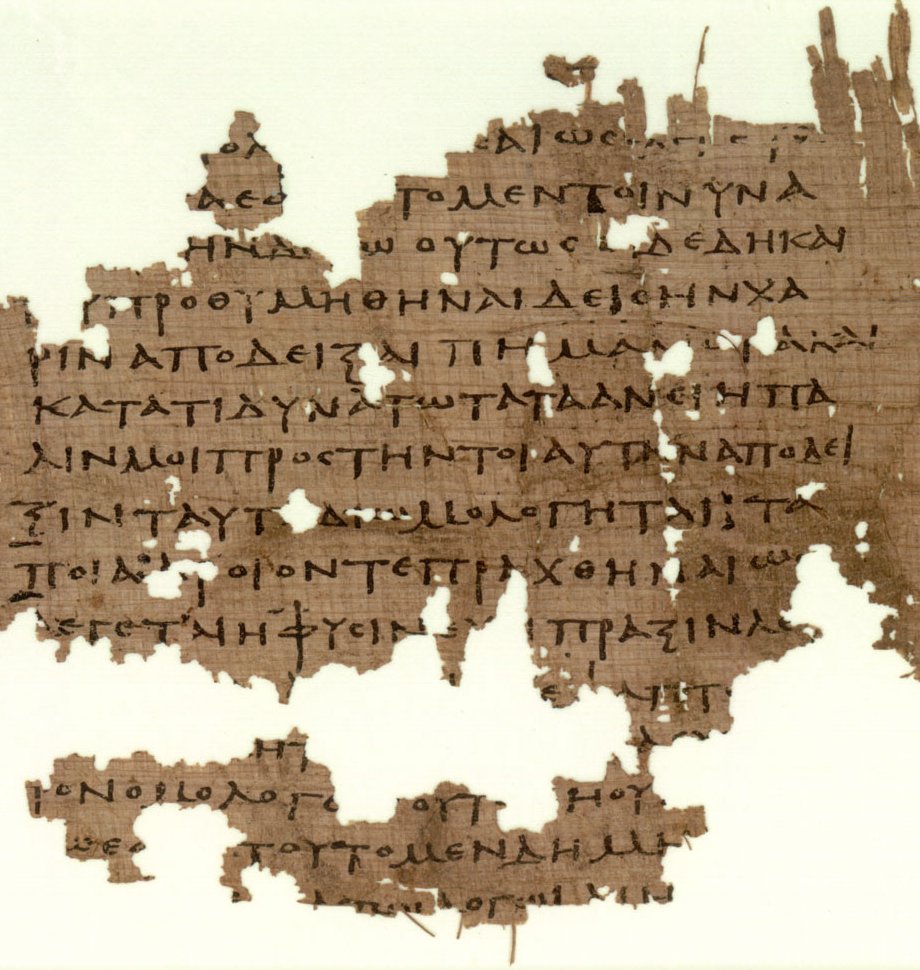










 Antonio de Pereda: Il sogno del cavaliere o La vita è un sogno
Antonio de Pereda: Il sogno del cavaliere o La vita è un sogno Fray Antonio Manuel de Hartalejo: Ritratto di Tirso de Molina
Fray Antonio Manuel de Hartalejo: Ritratto di Tirso de Molina
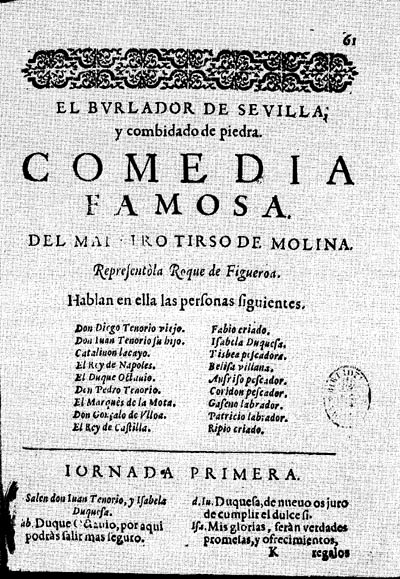
 Miguel De Cervantes
Miguel De Cervantes 
 Honoré Daumier: Don Chisciotte su Ronzinante (1870)
Honoré Daumier: Don Chisciotte su Ronzinante (1870)
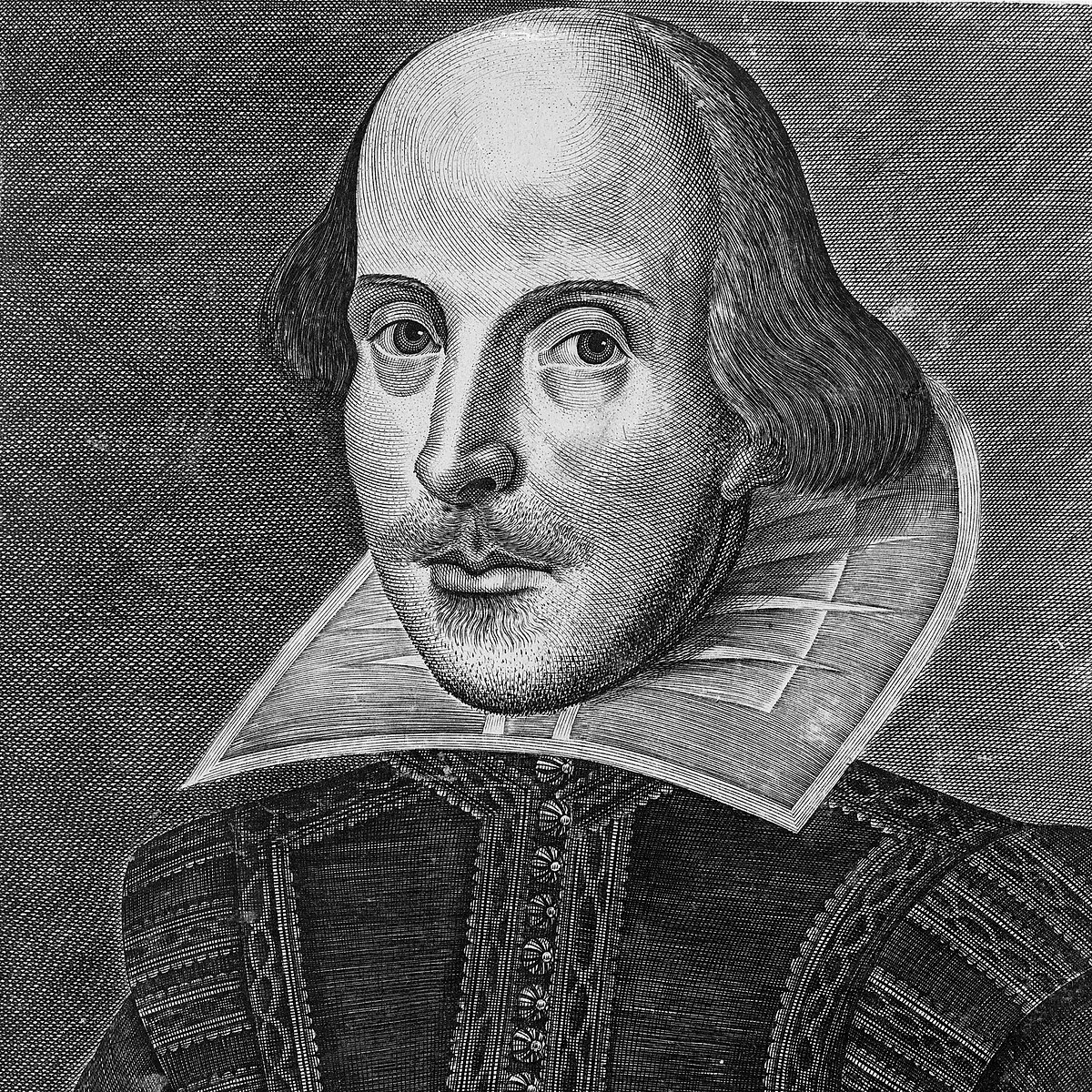 William Shakespeare
William Shakespeare John Donne
John Donne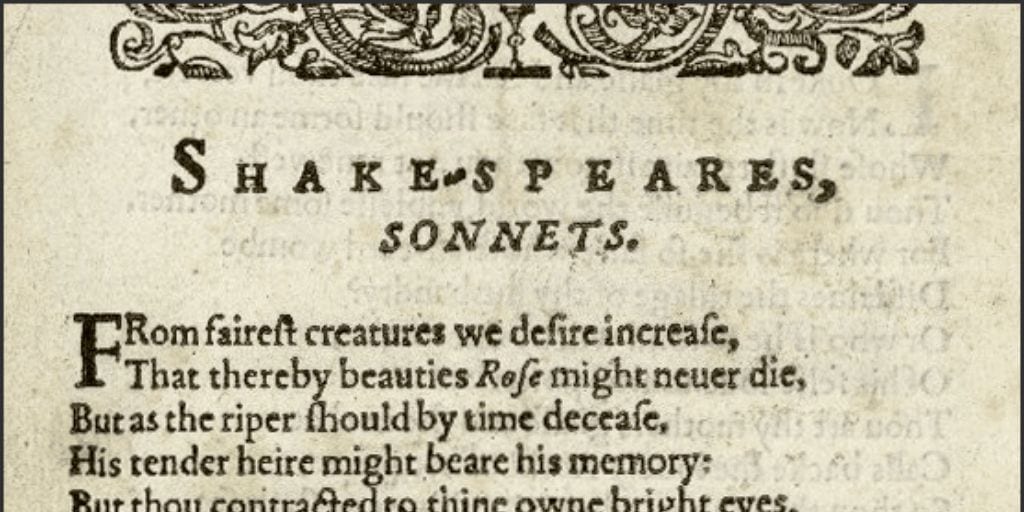
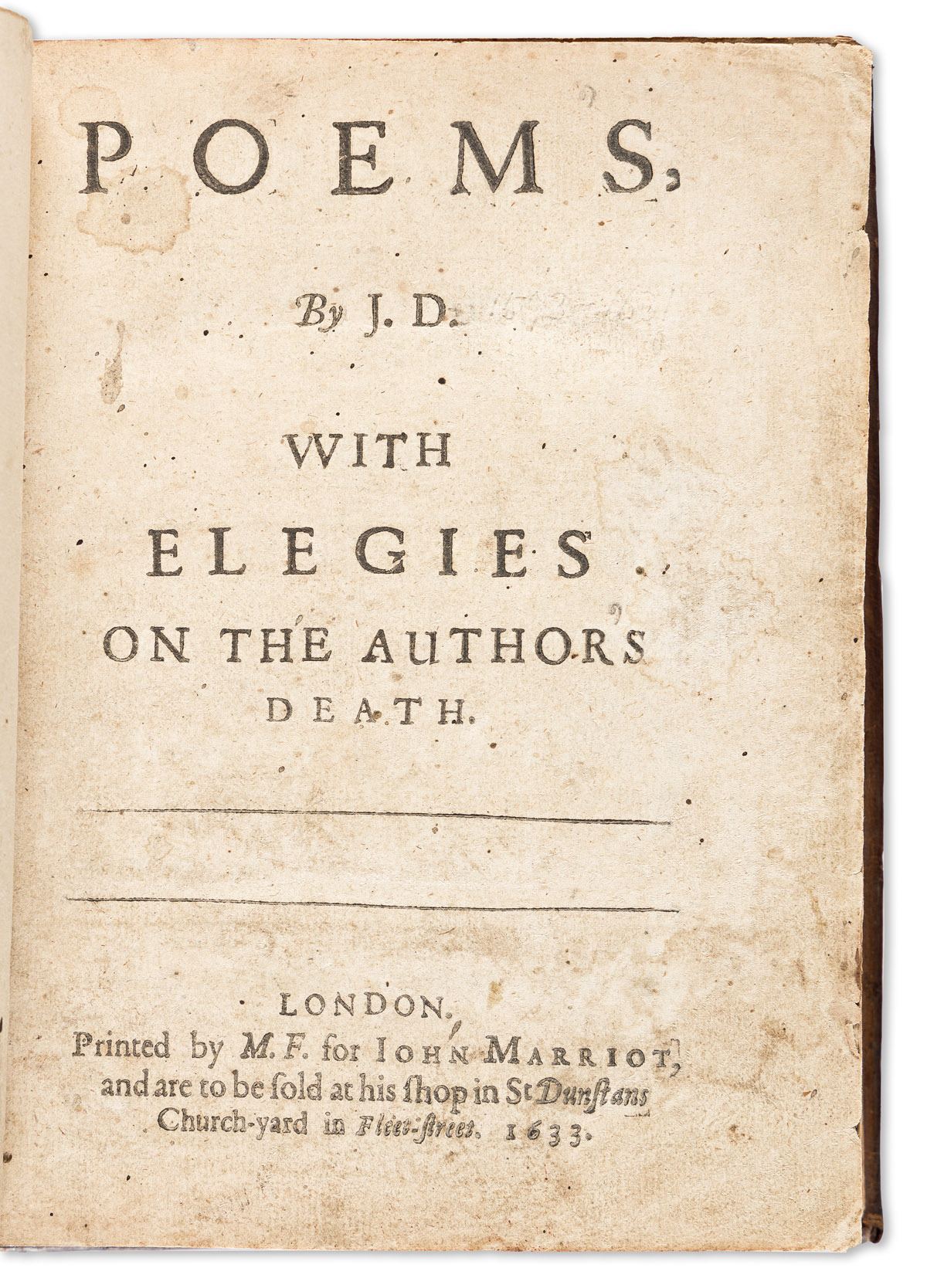






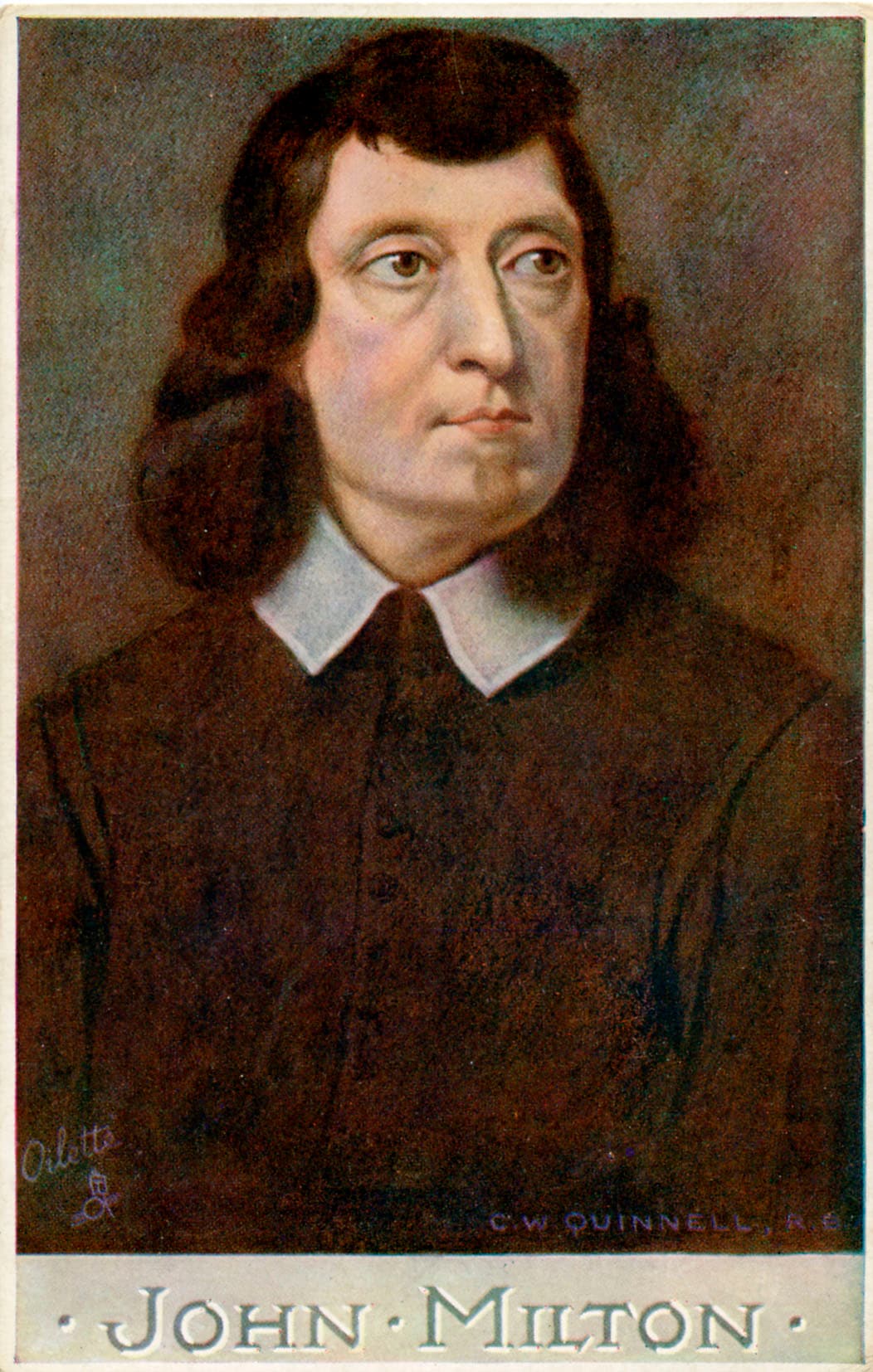
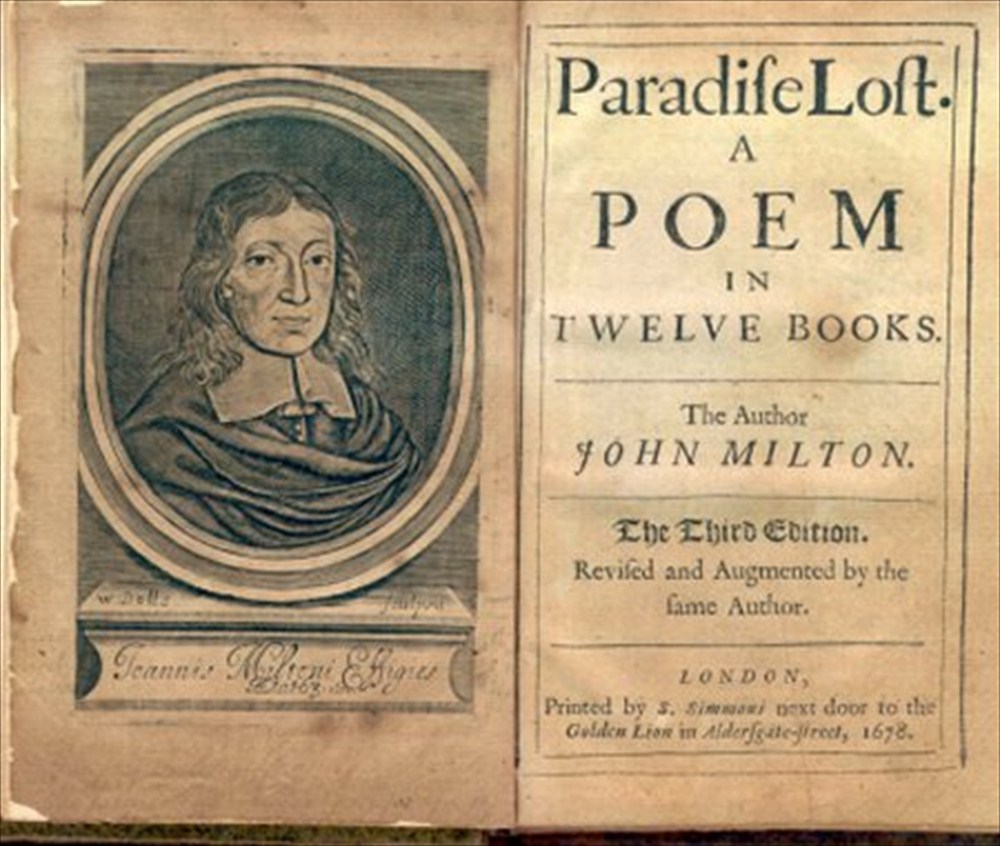

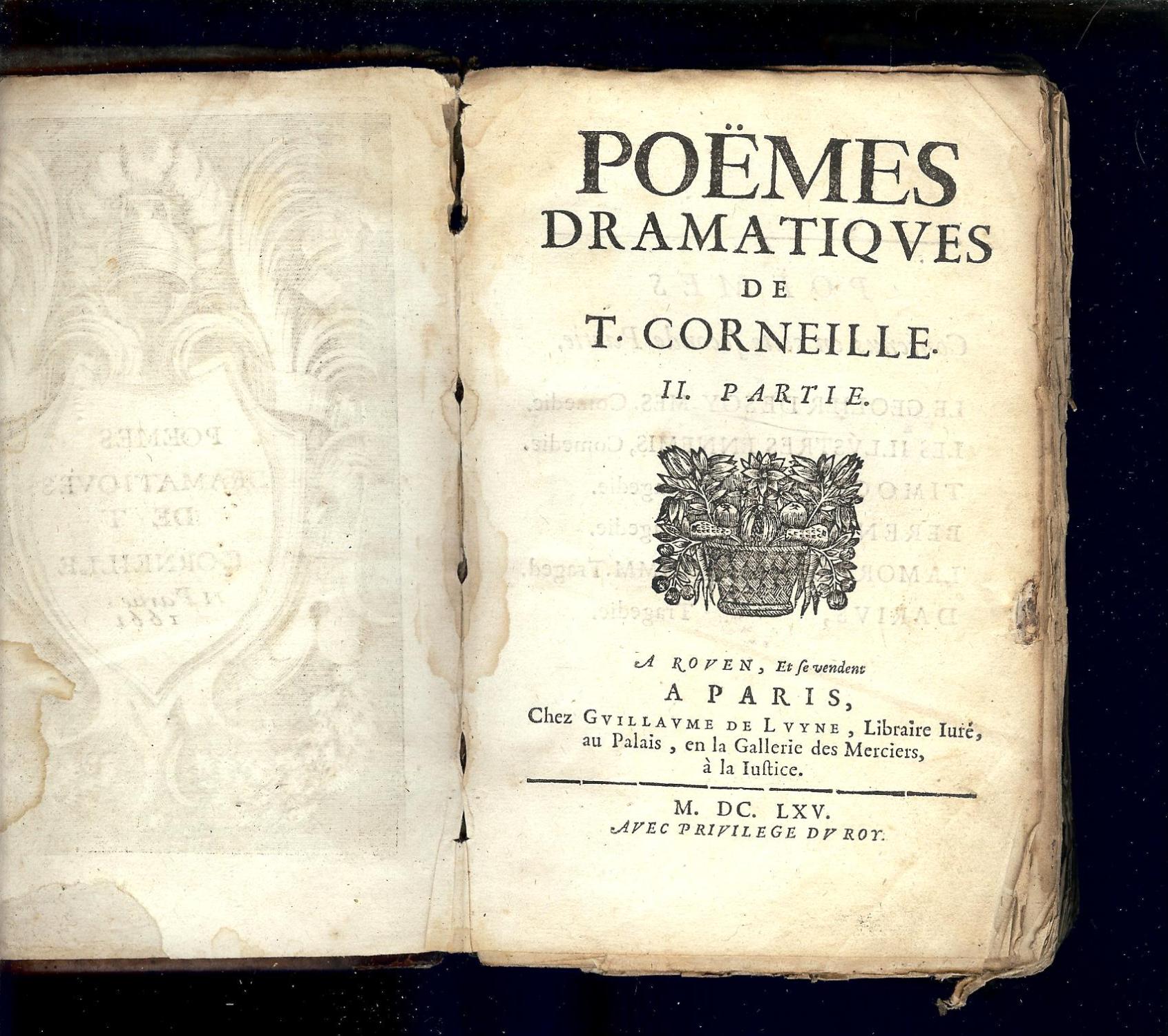
 Rappresentazione de Le Cid del 1875
Rappresentazione de Le Cid del 1875
 Pierre-Narcisse Guérin: Fedra e Ippolito (1815)
Pierre-Narcisse Guérin: Fedra e Ippolito (1815) Nicolas Mignard: Moliére (1658)
Nicolas Mignard: Moliére (1658)
 Cartina dell’Italia del ‘600
Cartina dell’Italia del ‘600
















 Justus Sustermans: Ritratto di Galileo Galilei
Justus Sustermans: Ritratto di Galileo Galilei