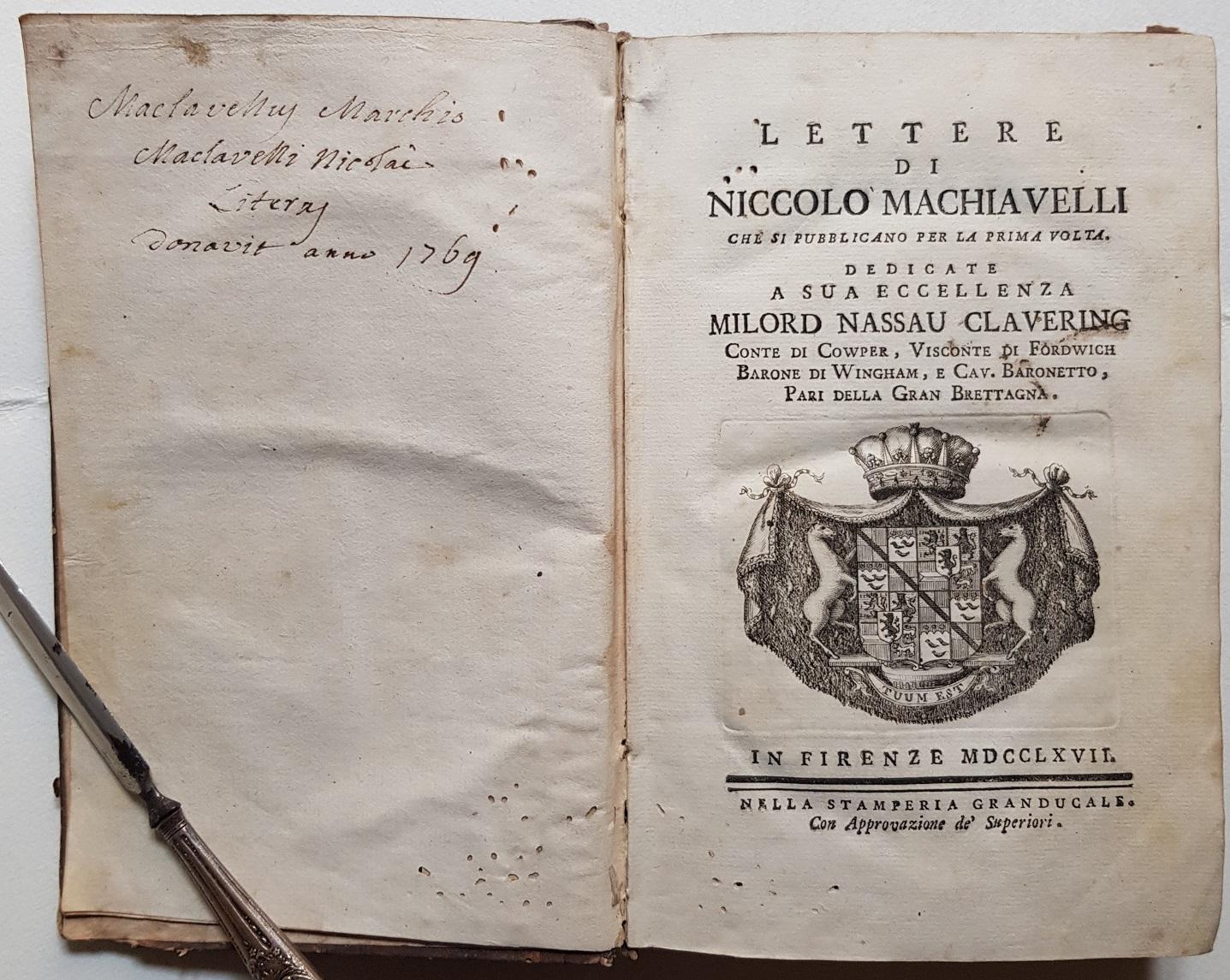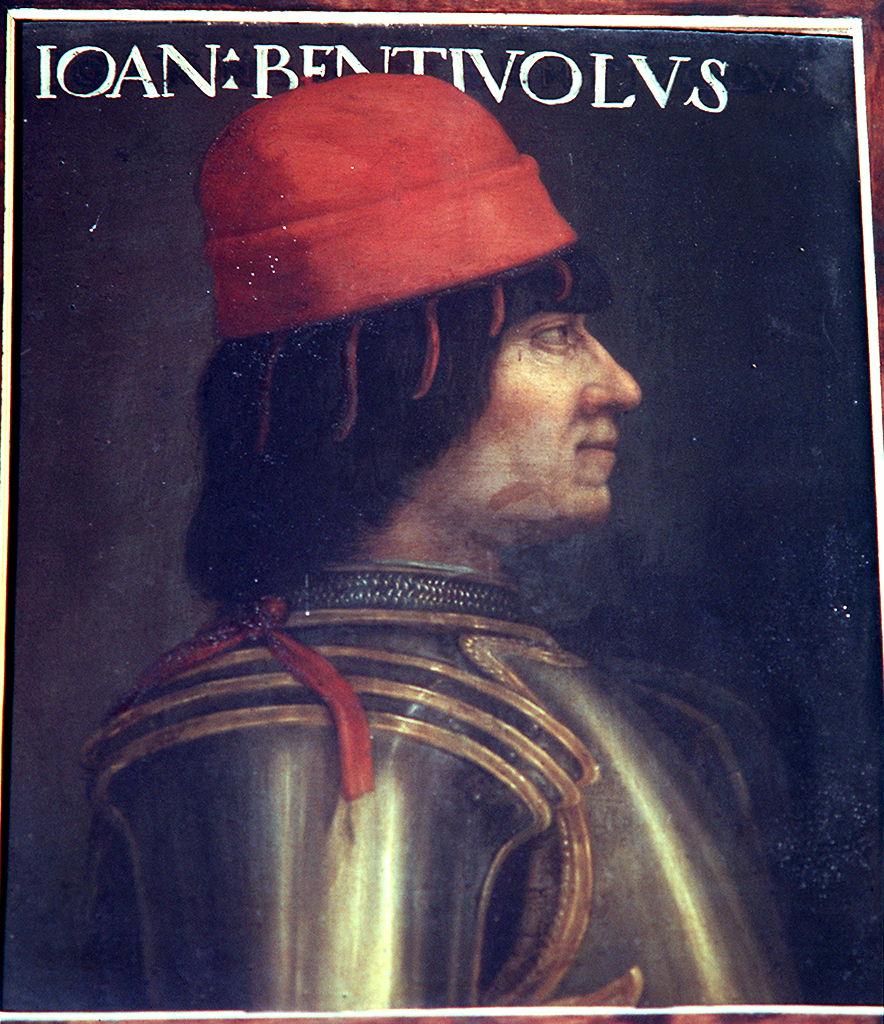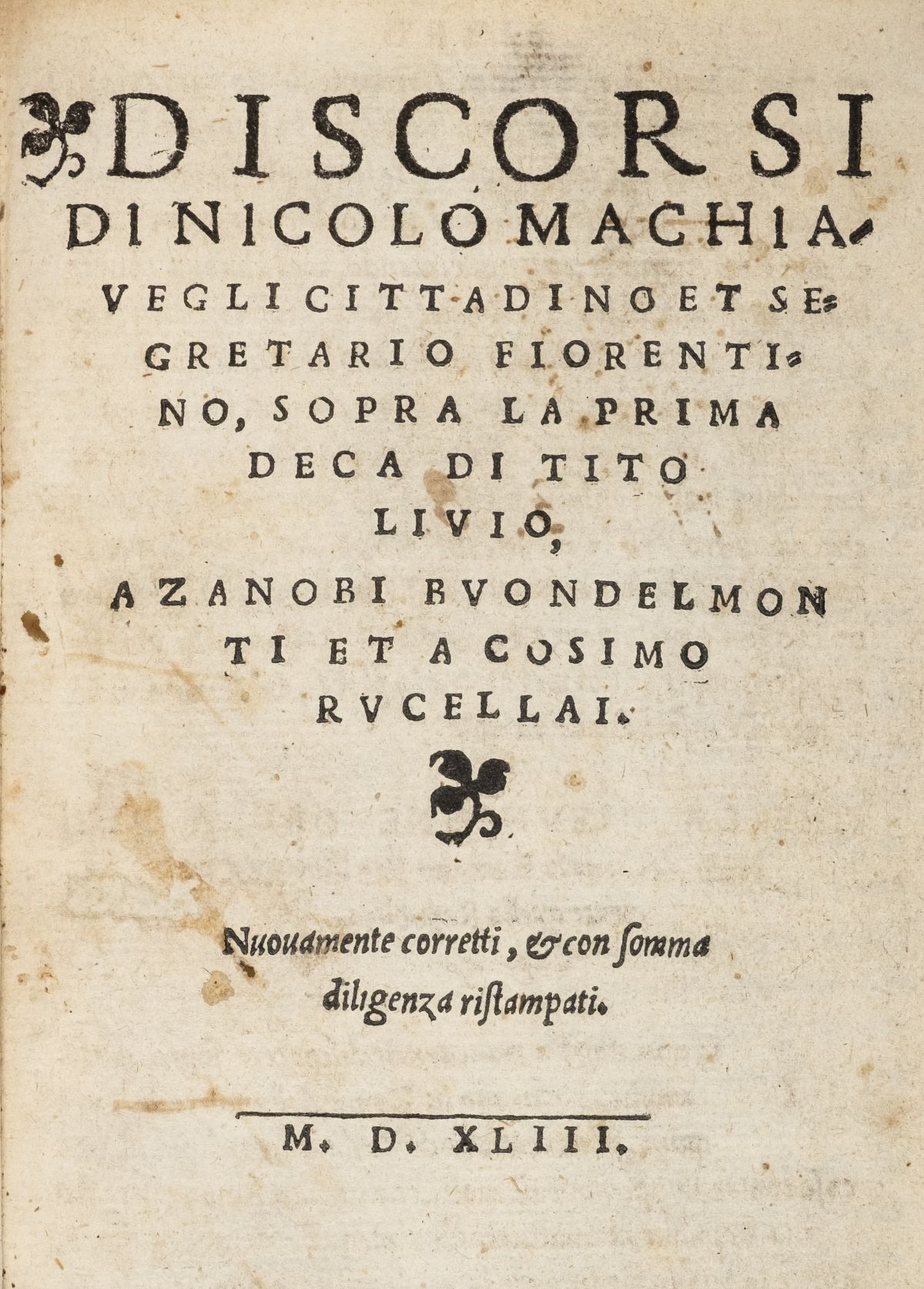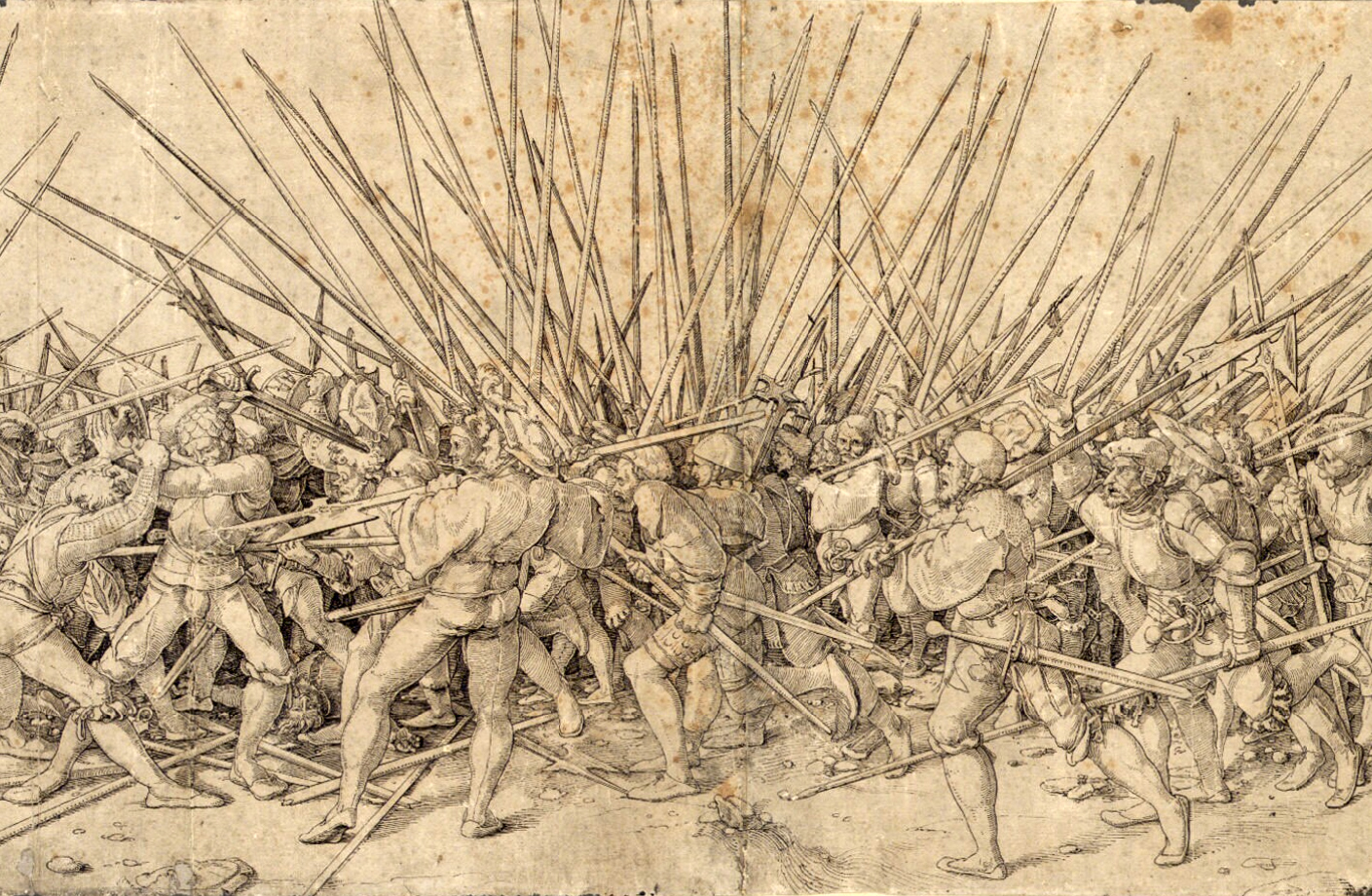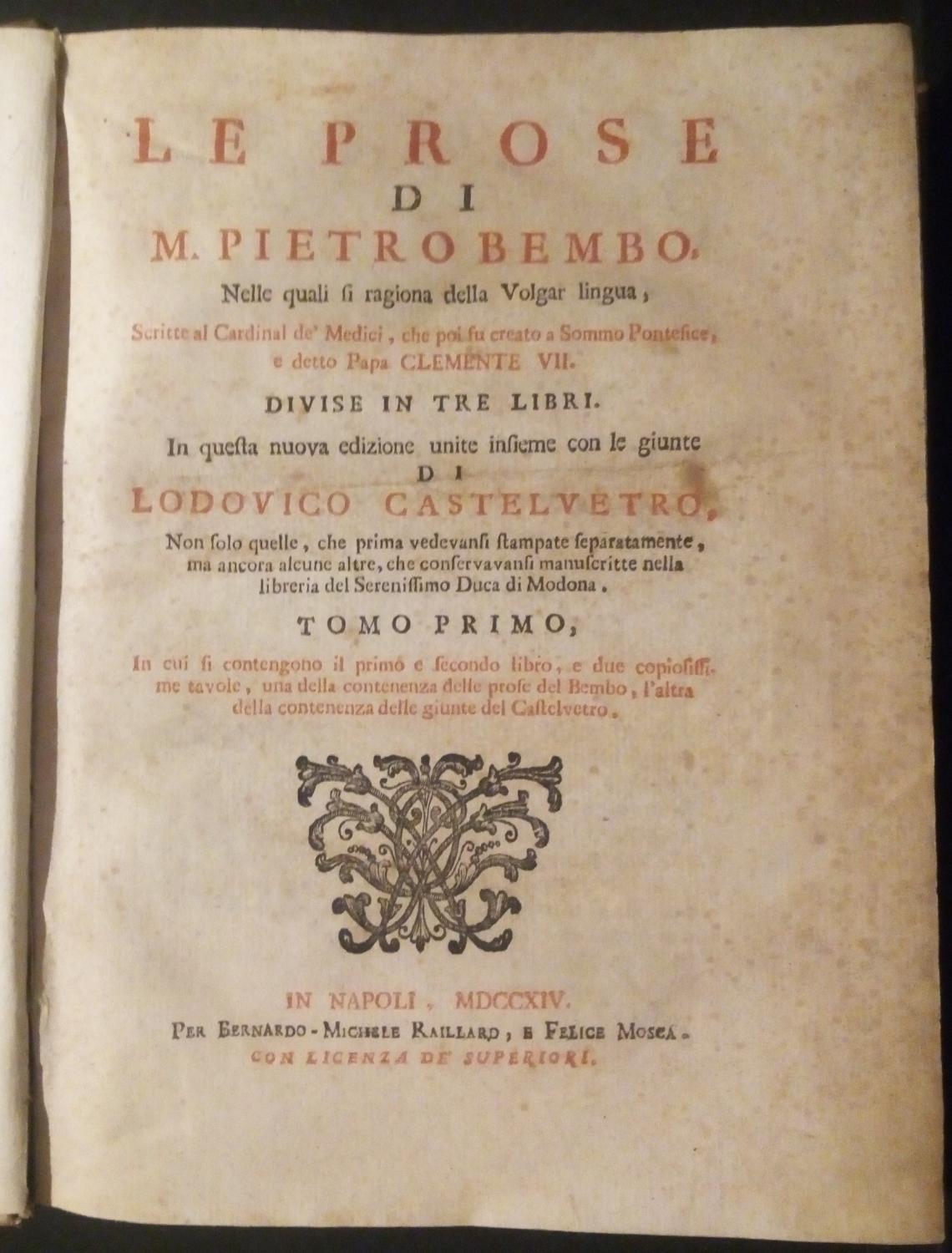Tiziano: Ritratto di Ludovico Ariosto (1510)
Ludovico Ariosto nasce a Reggio Emilia nel 1474 da Nicolò, capitano nella città appartenente ai domini estensi, e dalla nobildonna Daria Malaguzzi. Trascorre la prima giovinezza a Rovigo, al seguito paterno, lì recatosi per la guerra che gli Estensi conducevano contro Venezia. Al compimento dei dieci anni, fa rientro a Ferrara, dove riceve i primi rudimenti letterati da un precettore che lo fa innamorare della cultura latina, nonostante fosse spinto dal padre a seguire studi giuridici, verso i quali mostra scarso interesse.
Ferrara, nonostante la sua precarietà politica, vive in questo periodo un forte vitalismo culturale, dove Ariosto passerà quasi tutta la sua vita e dove verrà in contatto con un numero vario di artisti, tra cui ricordiamo Dosso Dossi e letterati che la città estense allora ospitava. Conosce, tra gli altri, Pietro Bembo, autore delle Prose della vulgar lingua: alla sua amicizia, molto probabilmente, sono collegati i Carmina in latino, ispirati soprattutto alla poesia oraziana e agli elegiaci Tibullo e Properzio.

Tiziano: Ritratto di Ippolito d’Este
Sono, per il nostro autore, anni molto felici, fra feste e spettacoli teatrali, cui offre una serie rappresentazioni riprese dall’autore latino Plauto; ma tale spensieratezza verrà interrotta nel 1500 dall’improvvisa morte paterna. Ludovico si trova a sobbarcarsi tutte le incombenze familiari: primo di dieci tra fratelli e sorelle e con a carico la madre, deve assumere la responsabilità del loro mantenimento: la dura realtà entra prepotentemente a cancellare un mondo perfetto dove corte e poesia sembravano non essere in contraddizione. Diventa anche lui, come il padre, capitano; prende inoltre gli ordini minori (per godere dei benefici ecclesiastici) e si mette al servizio del cardinale Ippolito d’Este, fratello del duca Alfonso I. Per conto del cardinale svolge vari incarichi, tra cui va ricordato quello presso il battagliero papa Giulio II, in urto con gli Estensi, che lo caccia in malo modo. Nel 1509 gli nasce il primo figlio, Virginio, che sarà accanto a lui per tutta la vita. In seguito si innamora di una nobildonna, Alessandra Benucci, moglie del mercante Tito Strozzi. Alla morte di quest’ultimo i rapporti fra i due si faranno più intensi, ma non giungeranno al matrimonio (che avverrà in segreto molto più tardi, nel 1527) per non perdere i benefici ecclesiastici e i diritti ereditari della vedova.
Nel 1517 il cardinale Ippolito prende possesso della sua diocesi a Budapest. Invitato a seguirlo, Ariosto rifiuta, adducendo motivi di salute (motivo di una celeberrima Satira). Entra pertanto alle dipendenze del duca Alfonso, il quale lo manda come governatore in Garfagnana, luogo da poco annesso ai territori estensi e infestato da briganti.
Dopo aver compiuto in modo egregio il suo lavoro, torna a Ferrara: ormai la sua vita scorre tranquillamente; compra un piccola casetta in contrada Mirasole, dove vi andrà a vivere con suo figlio Virginio. Corregge e revisiona le sue opere (Rime, Orlando furioso, Satire), ma già dal 1531 comincia a soffrire per una grave malattia intestinale, per la quale morirà nel 1533, a cinquantanove anni.

Il castello degli Estensi a Ferrara
L’uomo
Il tono bonario delle Rime e delle Satire, la grande conoscenza e saggezza umana che traspare nel Furioso, hanno fatto credere che l’uomo Ariosto e la sua vita, siano da iscriversi nella sfera dell’otium, cioè di quella predisposizione d’animo che sembra contraddire il “vitalismo” sia pur così diverso di Machiavelli e dello stesso Guicciardini. Dobbiamo tuttavia sottolineare alcune differenze sostanziali:

La casa in contrada Mirasole dove Alfieri passerà gli ultimi anni della sua vita
- Sia Machiavelli che Guicciardini vivono un momento di trapasso tra Repubblica e Signoria che fa sì che le loro opere e le loro riflessioni siano piene di voglia o di cambiare o di accettare, comunque di “vedere” la realtà circostante.
- Ariosto non sceglie: è costretto a muoversi, a partecipare per la morte del padre, all’interno di uno Stato che non vede né prospettive diverse dall’essere un ducato né sommovimenti tali da “prendere” una posizione. Non si tratta infatti di disegnare il futuro “politico” interno della città, com’era per Firenze. Bisognava invece misurare la capacità estense di barcamenarsi o cercare d’allargarsi tra le mire papali, l’influenza e concorrenza veneziana e/o milanese. Il tutto aggravato dalle guerre d’Italia tra Spagna e Francia.
- Machiavelli e Guicciardini, in una Firenze che si trasforma da Repubblica a Signoria possono essere, con gioia o meno, scegliendolo o meno, liberi; Ariosto non può: all’interno del sistema ducale deve imparare, senza disobbedire troppo, ad essere libero. Per questo darà, nella sua opera maggiore, sfogo alla fantasia.
OPERE DI LUDOVICO ARIOSTO
L’attività letteraria di Ludovico Ariosto può essere racchiusa nella ripresa di generi ed opere classiche, alla ricerca di una perfezione formale che le ponesse alla pari col modello; infatti riprende:
- la letteratura latina per i Carmina appunto in latino, dove ha come punto di riferimento la poesia elegiaca;
- la lezione di Petrarca e della tradizione lirica in lingua volgare con le Rime;
- Orazio con le Satire, ma “modernizza” il genere portato a perfezione dall’autore latino italianizzandolo, in quanto usa per esso la terzina dantesca;
- le Commedie scritte in versi, ad imitazione plautina;
- il poema cavalleresco, l’Orlando Furioso, che vuole apparire, generosamente come un atto d’amore verso un altissimo prodotto della cultura estense del ’400, l’Orlando Innamorato; ma sarà lui a portarlo alla perfezione, decretandone quindi la fine. La Gerusalemme liberata, del Tasso, non lo supererà (benché la lotta tra ariosteschi e tassiani sia ancora viva), perché sarà altro.
CARMINA E RIME
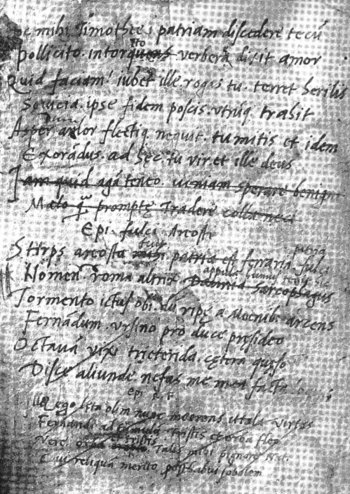
Pagina autografa di un carmen d’Ariosto
Possiamo dire che queste due opere appartengono alla giovinezza letteraria dell’Ariosto. Nei Carmina, in lingua latina, il nostro sembra apprendere gli strumenti per un’operazione di perfetta imitatio dei modelli. Sembra un’opera, appunto, in cui prevalga l’apprendistato formale.
Più difficile definire le Rime, perché ad esse Ariosto ci lavora quasi tutta la vita. In esse non prevale soltanto come modello Petrarca, come è abbastanza evidente in questo sonetto:
O SICURO, SECRETO E FIDEL PORTO
O sicuro, secreto e fidel porto,
dove, fuor di gran pelago, due stelle,
le più chiare del cielo e le più belle,
dopo una lunga e cieca via m’han scôrto:
or io perdono al vento e al mare il torto
che m’hanno con gravissime procelle
fatto sin qui, poi che se non per quelle,
io non potea fruir tanto conforto.
O caro albergo, o cameretta cara,
ch’in queste dolci tenebre mi servi
a goder d’ogni sol notte più chiara!
Scorda ora i torti e sdegni acri e protervi;
che tal mercé, cor mio, ti si prepara,
che appagherà quant’hai servito e servi.
O porto sicuro, riparato e fidato, dove due stelle (le più luminose e belle del cielo) mi hanno scortato dopo un lungo e tenebroso cammino, fuori da un mare in tempesta: ora io perdono al vento e al mare il torto che mi hanno fatto sinora con grandissime bufere, dal momento che se non era per quelle, non avrei potuto godere di un simile conforto. O caro rifugio, cara cameretta, che in queste dolci tenebre mi permetti di godere di una notte più luminosa di qualunque sole! O cuore mio, scordati ora i torti e le parole ingiuriose, aspre e arroganti; infatti si prepara per te un grande premio, che appagherà gli sforzi che hai fatto e che farai per servire.

Immagine d’Ariosto
Basti pensare al famoso O cameretta che già fosti un porto del poeta aretino in cui lo spazio privato è il luogo in cui versare lacrime e cercar rifugio per gli affanni perduti mentre qui, capovolgendo la situazione la cameretta sembra promettere una notte d’amore. Si pensi alle stelle, metafora di bei occhi che l’hanno “scorto” in tale luogo e come esso venga illuminato, dopo aver trascorso del tempo a cercare amore (le procelle), per portare luce ed amore. E’ evidente come prevalga una certa vena “sensuale” , che mostra l’importanza certo formale di Petrarca ma senza abbandonare un attento sguardo alla poesia erotica di Catullo e dei poeti elegiaci. Si può dire, insomma, che già mostra, in queste opere cosiddette “minori”, un’attenzione particolare verso il dato reale, fisico dell’amore, anche se, verso la fine, sembra prevalere la purezza formale del grande autore del ’300.
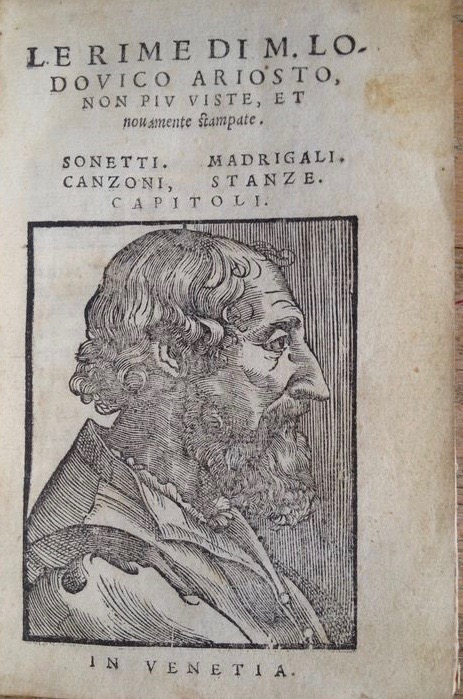
Copertina del libro delle Rime d’Ariosto del 1558
MADRIGALE
La bella donna mia d’un sì bel fôco
e di sì bella neve ha il viso adorno,
che Amor mirando intorno
qual di lor sia più bel, si prende giôco.
Tal’è proprio a veder quell’amorosa
fiamma che nel bel viso
si sparge, ond’ella con soave riso
si va di sue bellezze innamorando;
qual’è a veder qualor vermiglia rosa
scôpre il bel paradiso
delle sue foglie, allor che ’l sol diviso
dall’orïente sorge, il giorno alzando.
E bianca è sì, come n’appare, quando
nel bel seren più limpido la luna
sovra l’onda tranquilla
co’ bei tremanti suoi raggi scintilla.
Sì bella è la beltade che in quest’una
mia donna hai posto. Amor, e in sì bel lôco,
che l’altro bel di tutto il mondo è poco.

Sandro Botticelli: Simonetta Vespucci (1480) (modello di bellezza rinascimentale)
Anche questo madrigale rappresenta una ripresa di un modello petrarchesco, anche se bisogna ricordare che l’autore del Canzoniere su 366 componimenti ne inserisca soltanto quattro. Ma anche di essi l’Ariosto ne fa un uso non pedissequo, ma personale e ciò si nota dal cambio metrico che se vedeva in quelli del modello l’uso dell’endecasillabo, Ariosto l’alterna con il settenario, permettendo ad esso una maggiore musicalità quale sarà percepita successivamente da Tasso, ma soprattutto da Monteverdi che farà di questo genere poetico la base per la nascita del teatro musicale italiano.
COMMEDIE
L’attenzione che Ariosto dedica al teatro non è certo formale, in obbedienza alla volontà e all’estro di Ippolito e d’Alfonso, quanto una vera e propria esigenza di maturazione poetica, in cui egli può misurare sia l’aderenza al modello classico che il bisogno di realtà che ne caratterizza la personalità. Inoltre in esse il nostro può esercitare la sua capacità nell’intreccio: infatti qui organizza storie, trova battute esilaranti, sperimenta un linguaggio che sta tra l’aulico e il quotidiano: tutte cose fondamentali per la stesura del Furioso. Le commedie sono cinque e composte tra il 1508 e il 1528:
La Cassaria (1508): è la prima commedia volgare della letteratura italiana. S’ispira all’Aulularia di Plauto e narra la vicenda di una cassa d’oro intorno cui ruotano due giovani innamorati della stessa ragazza. Vediamo come “si giustifica” secondo il modello dei prologhi antichi:

Rappresentazione scenica de La Cassaria del 2016
PROLOGO
Nova comedia v’appresento, piena
di vari giochi, che né mai latine
né greche lingue recitarno in scena.
Parmi veder che la più parte incline
a riprenderla, subito c’ho detto
nova, senza ascoltarne mezo o fine:
ché tale impresa non li par suggetto
de li moderni ingegni, e solo estima
quel che li antiqui han detto esser perfetto.
E’ ver che né volgar prosa né rima
ha paragon con prose antique o versi,
né pari è l’eloquenzia a quella prima;
ma l’ingegni non son però diversi
da quel che fur, che ancor per quello Artista
fansi, per cui nel tempo indietro fersi.
La vulgar lingua, di latino mista,
è barbara e mal culta; ma con giochi
si può far una fabula men trista.
Non è chi ’l sappia far per tutti i lochi:
non crediate però che così audace
l’autor sia, che si metta in questi pochi.
Questo ho sol detto, a ciò con vostra pace
la sua comedia v’appresenti; e inanzi
il fin non dica alcun ch’ella mi spiace.
Per ch’ormai si cominci, e nulla avanzi
ch’io vi dovessi dir: sappiate come
la fabula che vol ponervi inanzi
detta Cassaria fia per proprio nome:
sappiate ancor che l’autor vol che questa
cittade Metellino oggi si nome.
De l’argumento, che anco udir vi resta,
ha dato cura a un servo, detto el Nebbia.
Or da parte di quel che fa la festa
priega chi sta a veder che tacer debbia.
Vi presento una nuova commedia piena di diversi accadimenti che nessuno mai mise in scena prima né in greco né il latino. Mi sembra di vedere la maggior parte di voi pronta a criticarla, appena ho pronunciato la parola “nuova”, senza averne ascoltato né un atto o la fine perché l’impresa di scriver commedie non le sembra compito da farsi dagli autori moderni e crede solo che le (commedie) perfette siano quelle scritte in lingua classica. E’ pur vero che il volgare, né in prosa né in versi, può essere paragonato con la prosa o con le rime antiche e neppure con la sua eloquenza; ma gli ingegni non sono diversi da quelli che un tempo ci furono, che ancora attraverso Dio si fanno allo stesso modo in cui li fece prima. La lingua volgare, mescolata con quella latina, è spiacevole e poco adatta alla cultura, ma con (valide) invenzioni si può narrare una storia un po’ piacevole. Non è che non ci sia qualcuno che sappia costruirla perfettamente in tutte le parti (come negli antichi): non pensate tuttavia che l’autore si sia mescolato fra questi incoscienti temerari. Ho detto soltanto questo, affinché con vostra pace la commedia si rappresenti e, prima che sia finita, nessuno dica che non gli è piaciuta. Dunque per cominciare, e affinché non rimanga nulla da aggiungere, sappiate come la commedia che vi voglio rappresentare si chiama Cassaria: sappiate anche che la città in cui l’autore vuole ambientarla oggi prenda il nome di Metellino (città dell’Egeo). Dell’argomento, che ancora deve esservi detto ho lasciato ad un servo il compito, detto il Nebbia. Ora da parte di chi ha organizzato la festa (in cui tale rappresentazione è inserita) / vi si prega che chi sta seduto per vederla, faccia silenzio.
E’ una vera e propria dichiarazione d’intenti quella che qui Ariosto porta avanti: non si tratta infatti di imitare pedissequamente il modello antico, ma d’inserire una “nuova favola” all’interno di una struttura classica. Anche questo prologo fa parte di questa struttura, che riprende il modo attraverso cui Terenzio “rispondeva” alle critiche che il pubblico poteva rivolgergli. Il nostro si tutela giustificandosi, sia pure con consapevolezza, essendo questa commedia la prima in assoluto che riprendeva il teatro classico in volgare. A ciò si aggiunga che l’utilizzo dell’endecasillabo sciolto che voleva riprendere e ripetere la metrica utilizzata dai commediografi latini.
I Suppositi (1509): il cui titolo vuol dire Gli scambiati, viene ripresa (attraverso l’idea della contaminatio, in pieno vigore nella commedia latina) dai Captivi di Plauto e dall’Eunuchus di Terenzio, dove si narra, appunto, la vicenda di uno scambio di persone.
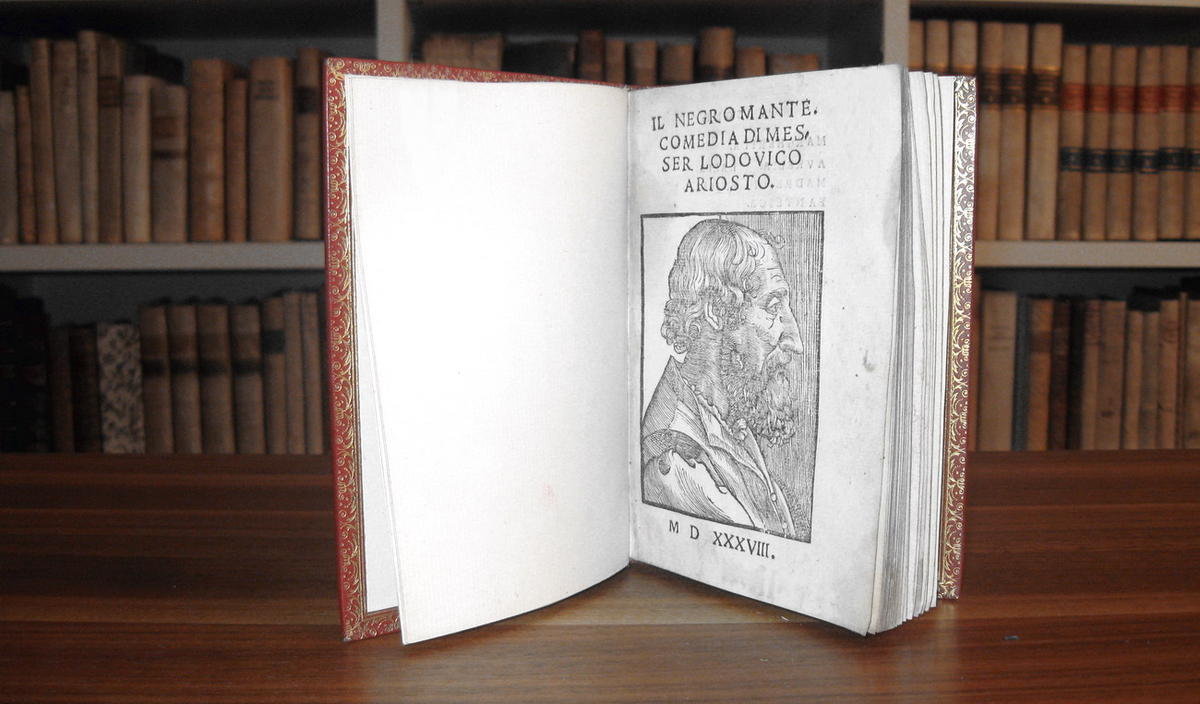
Antica edizione del Negromante
Il Negromante (1520, ma rappresentata per la prima volta nel 1530) : in parte ripresa da Terenzio, il cui protagonista è appunto un astrologo, finto mago, che approfitta dei creduloni, ma alla fine sarà scornato:
IL FALSO MAGO
(ATTO I, scena III)
CINTIO: Temolo, che ti par di questo astrologo / o negromante voglio dir?
TEMOLO: Lo giudico / una volpaccia vecchia.
CINTIO: Or ecco Fazio. / Io domandavo costui de l’astrologo / nostro che gli par.
TEMOLO: Dico ch’io el giudico / una volpaccia vecchia.
CINTIO: Et a voi, Fazio / che te ne par?
FAZIO: Io stimo uom di grande astuzia / e di molta dottrina.
TEMOLO: In che scienza / è egli dotto?
FAZIO: In l’arti che si chiamano / liberali.
CINTIO: Ma pur ne l’arte magica / credo che intenda ciò che si può intendere / e non ne sia per tutto il mondo un simile?
TEMOLO: Che ne sapete voi?
CINTIO: Cose mirabili / di lui mi narra il suo garzone.
TEMOLO: Fateci, / se Dio v’aiuti, udir questi miracoli.
CINTIO: Mi dice che a sua posta fa risplendere / la notte e il dì oscurarsi.
TEMOLO: Anch’io so simile- / mente cotesto far.
CINTIO: Come?
TEMOLO: Se accendere / di notte anderò un lume / e di dì chiudere / le finestre.
CINTIO: Deh, pecorone! Dicoti che estingue el sol per tutto il mondo, e splendida / fa la notte per tutto.
TEMOLO: Gli dovrebbono / dar gli speciali dunque un buon salario.
FAZIO: Perché?
TEMOLO: Perché calare il prezzo e crescere, / quando gli paia, può alla cera e all’olio. / Or sa fa altro?
CINTIO: Fa la terra muovere, / sempre che ’l vuol.
TEMOLO: Anch’io talvolta muovola, / s’io metto al fuoco o ne levo la pentola; / o quando cerco al buio se più gocciola / di vino è nel boccale, allor dimenola.
CINTIO: Te ne fai beffe, e ti par d’udir favole? / or che dirai di questo: che invisibile / va a suo piacer?
TEMOLO: Invisibile? Avetelo / voi mai, padron, veduto andarvi?
CINTIO: Oh, bestia! / Come si può veder, se va invisibile?
TEMOLO: Ch’altro sa far?
CINTIO: De le donne e de gli uomini / sa trasformar, sempre che vuole, in varii / animali e volatili e quadrupedi.
TEMOLO: Si vede far tutto il dì, / né miracolo è codesto.
FAZIO: U’ si vede far?
TEMOLO: Nel populo / nostro.
CINTIO: Non date udienza alle sue chiacchiere, / che ci dileggia.
FAZIO: Io vo’ saperlo: narraci / pur come.
TEMOLO: Non vedete voi, che subito / un divien podestate, commissario / proveditore, gabelliere, giudice, / notaio, pagator de li stipendii, / che li costumi umani lascia, e prendeli / o di lupo o di volpe o di alcun nibio?
FAZIO: Codesto è vero.
TEMOLO: E tosto ch’un ignobile / grado vien consigliere o segretario, / e che di commandar gli altri ha ufficio, / non è vero anco che diventa un asino?
FAZIO: Verissimo.
TEMOLO: Di molti che si mutano / in becco, vo’ tacer.
CINTIO: Cotesta, Temolo, è una cattiva lingua.
TEMOLO: Lingua pessima / la vostra è pur, che favole mi recita / per cose vere.
CINTIO: Temolo, voglio chiederti cosa ti sembra di questo astrologo o negromante?TEMOLO: Lo giudico un vecchio furbastro. CINTIO: Ecco Fazio. Io domandavo a costui cosa pensava del nostro astrologo. TEMOLO: Ripeto che sembra un vecchio furbastro. CINTIO: E a voi, Fazio, che ve ne pare? FAZIO: Lo credo un uomo di grande capacità e di molta cultura. TEMOLO: In quale disciplina egli è colto? FAZIO: Nelle arti che si chiamano liberali (cioè intellettuali). CINTIO: Ma soprattutto nell’arte magica credo che egli capisca tutto ciò che c’è da capire e che non ve ne sia in tutto il mondo uno esperto come lui. TEMOLO: Cosa ne sapete? CINTIO: Il suo servo mi racconta cose mirabolanti su di lui. CINTIO: Fateci, per piacere, ascoltare questi miracoli. CINTIO: Mi dice che a suo piacere illumina la notte ed oscura il giorno. TEMOLO: Anch’io lo so fare. CINTIO: Come? TEMOLO: Se andrò ad accendere una luce di notte e a chiudere una finestra di giorno. CINTIO: Ma va là, ignorante! Ti dico che spegne la luce in tutto il mondo e fa la notte splendente dappertutto. TEMOLO: I droghieri dovrebbero dargli un buon stipendio. FAZIO: Perché? TEMOLO: Perché potrebbero alzare o abbassare il prezzo della cera o dell’olio (che servono per l’illuminazione). Sa fare altro? CINTIO: Fa muovere il mondo quando vuole. TEMOLO: Anch’io qualche volta la muovo, se metto o levo dal fuoco una pentola; o quando cerco al buio se ancora vi è qualche goccia di vino nel bicchiere, allora lo scuoto. CINTIO: Lo prendi in giro oppure ti sembra d’ascoltare bugie? Ora che mi dirai di questo, che quando vuole diventa invisibile? TEMOLO: Invisibile? L’avete mai visto, padrone? CINTIO: Scemo che non sei altro! Come si può vedere, se è invisibile? TEMOLO: Cos’altro sa fare? CINTIO: Sa trasformare, quando vuole, gli uomini e le don-ne in animali, sia uccelli che mammiferi. TEMOLO: Questo succede tutti i giorni: non è un miracolo. FAZIO: E dove si fa? TEMOLO: Fra la nostra gente. CINZIO: Non dategli retta, che ci prende in giro. FAZIO: Io voglio saperlo: dicci come. TEMOLO: Non vedete che appena uno diventa podestà, commissario, provveditore, gabelliere, giudice, notaio, amministratore, abbandona le abitudini umane e prende quelle di lupo, di volpe, o di qualche rapace? FAZIO: E’ vero. TEMOLO: E non appena uno di bassa condizione diventa consigliere o segretario, che ha come potere quello di comandare sugli altri, non è anche vero che diventa un asino? FAZIO: Verissimo. TEMOLO: Dei molti che diventano cornuti, come un cervo, non voglio parlare. CINTIO: Questa, o Temolo, è una battuta infelice. TEMOLO: Battute infelici sono soltanto le vostre, che mi vende come cose serie, vere e proprie favole.
Questo piccolo esempio ci serve per capire in che modo Ariosto, nonostante l’uso dell’endecasillabo, cerchi di usare un ritmo brioso e colloquiale tra i personaggi; esso si nota anche nelle differenze tra la scelta terminologica dei signori Cintio e Fazio ed il servo Temolo. Quello che tuttavia qui interessa è la polemica che l’autore conduce contro una delle branche del sapere più in voga in epoca rinascimentale: la magia. Non è tale fatto in contraddizione con lo spirito razionale di cui Ariosto qui si fa portavoce. Per altri intellettuali la magia e la stregoneria (non dico a livello popolare) erano studiate come mezzi che, andando al di là della scienza, potevano spiegare la contraddittorietà della natura, per arrivare a capire l’essenza della creazione voluta da Dio.
La Lena (1529) è una commedia d’intreccio, che ha per protagonista una mezzana, la Lena appunto, sposata a Pacifico (di nome e di fatto) e due giovani, Licinia e Flavio, che alla fine coroneranno il loro amore con il matrimonio. E’ un’opera piuttosto tarda del ’29, ambientata a Ferrara, mentre Ariosto sta lavorando al Furioso. Per la caratterizzazione dei personaggi ed intreccio è considerata la sua commedia migliore.
Gli Studenti (postuma): è una commedia non completata da Ariosto, di cui conosciamo due versioni: una portata a termine dal fratello Gabriele, l’altra dal figlio Virginio, che ha per protagonisti due giovani studenti dell’università di Pavia.
SATIRE
Quando nel 1517 il cardinale Ippolito va a Budapest nella sua diocesi, Ariosto rifiuta. E’ tale episodio che dà vita all’inizio della stesura delle Satire. Nel periodo infatti tra il ’17 e il ’25 vengono infatti composte sette satire, genere poetico da lui composto in terzine dantesche, che diverrà in seguito “canone” per tale genere poetico. Esse si strutturano come epistole poetiche, con diversi destinatari, fra cui fratelli e cugini di Ludovico; solo una di esse è indirizzata a Pietro Bembo.
![Sette_libri_di_satire_di_[...]Arioste_L'_bpt6k314470k.JPEG](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2018/08/sette_libri_di_satire_di_-arioste_l_bpt6k314470k.jpeg) Edizione 1560
Edizione 1560
Nella I satira viene raccontato il rifiuto di Ludovico di seguire il Cardinale Ippolito in Ungheria. Dietro tale rifiuto non vi è comunque soltanto il motivo “salutare” che sconsiglia al nostro climi freddi, ma anche l’orgogliosa consapevolezza della superiorità morale della poesia rispetto alla ricchezza:
PIU’ TOSTO CHE ARRICCHIR, VOGLIO QUIETE
(I, 160-177)
Più tosto che arricchir, voglio quïete:
più tosto che occuparmi in altra cura,
sì che inondar lasci il mio studio a Lete.
Il qual, se al corpo non può dar pastura,
lo dà alla mente con sì nobil ésca,
che merta di non star senza cultura.
Fa che la povertà meno m’incresca,
e fa che la ricchezza sì non ami
che di mia libertà per suo amor esca;
quel ch’io non spero aver, fa ch’io non brami,
che né sdegno né invidia me consumi
perché Marone o Celio il signor chiami;
ch’io non aspetto a mezza estade i lumi
per esser col signor veduto a cena,
ch’io non lascio accecarmi in questi fumi;
ch’io vado solo e a piedi ove mi mena
il mio bisogno, e quando io vo a cavallo,
le bisaccie gli attacco su la schiena.
Piuttosto che diventare ricco, voglio la pace: / piuttosto da lasciarmi occupare in altre preoccupazioni / tanto da lasciare inondare il mio studio alle acque dell’oblio. / Il quale (studio) se non può nutrire il corpo / lo dà alla mente con un cibo così nobile / che merita essere coltivato. / (Lo studio) fa che la povertà mi dispiaccia meno e fa che non ami tanto la ricchezza / fino al punto di perdere la mia libertà; / ciò che non spero di avere, fa sì che io non lo desideri / che non mi consumi né rabbia né invidia / perché il cardinale Ippolito chiami Ippolito e Marone (poeti al seguito del Cardinale, dopo il rifiuto di Ariosto); / fa sì che io non aspetti le lampade a mezza estate / per esser visto a cena col Signore / perché non mi faccio acceccare dai lumi della vanità; / perché io vado solo e a piedi dove mi conduce / la mia necessità, e quando vado a cavallo / gli attacco le bisacce sul dorso.

Ritratto d’Ippolito da un disegno di Giovanni Maria Zappi (XVI sec.)
Pochi versi, tratti dalla prima Satira, già ci indicano il problema fondamentale dell’intellettualità non civile ma cortigiana dei primi anni del ’500: la perdita di libertà. Vi è qui l’orgoglio del poeta ferito, non capito, che tuttavia rivendica non solo la propria grandezza, ma anche la semplicità della vita fatta di piccoli piaceri. Pur infarcita pertanto di riflessioni personali, si nota in essa il riferimento oraziano della recusatio verso Augusto, di cui ripete anche il concetto della mediocritas.
Nella II Satira il poeta tratta il tema della corruzione papale (prendendo spunto da un suo viaggio a Roma.
Più importante la terza Satira, indirizzata al cugino, in essa il poeta spiega la sua condizione sotto il signore Alfonso:
UNA DICHIARAZIONE DI LIBERTA’
(III, 1-9)
Poi che, Annibale, intendere vuoi come
la fo col duca Alfonso, e s’io mi sento
più grave o men de le mutate some;
perché, s’anco di questo mi lamento,
tu mi dirai c’ho il guidalesco rotto,
o ch’io son di natura un rozzon lento:
senza molto pensar, dirò di botto
che un peso e l’altro ugualmente mi spiace,
e fòra meglio a nessuno esser sotto.
Dal momento che Annibale (Malaguzzi, cugino del poeta) desidera sapere come / me la passi col duca Alfonso / e se mi sento più libero o meno con il nuovo padrone; / perché, se mi lamento anche di lui / tu mi dirai che ho il guidalesco rotto (vescica del cavallo provocata dallo sfregamento delle finiture) / e che per natura sono un ronzino malandato: / senza starci molto a pensare ti dirò / che un padrone e l’altro mi spiacciono ugualmente / e sarebbe molto meglio non esser sotto a nessuno.
Pur nella piena consapevolezza dell’impossibilità della libertà per il mantenimento dei fratelli egli si rende conto come vi sia incompatibilità tra poesia e servitù: mancanza di studio, amore per la letteratura scevro da qualsiasi altra preoccupazione, impegno per le opere prodotte e da rivedere, non si conciliano con i compiti, pur se onorevoli, che deve compiere per il Duca. Quindi prosegue:

Battista Dossi: Ritratto di Alfonso d’Este in abiti militari (1530)
LIBERTA’ DI SCELTA
(III, 29-57)
So ben che dal parer dei più mi tolgo,
che ’l stare in corte stimano grandezza,
ch’io pel contrario a servitù rivolgo.
Stiaci volentier dunque chi la apprezza;
fuor n’uscirò ben io, s’un dì il figliuolo
di Maia vorrà usarmi gentilezza.
Non si adatta una sella o un basto solo
ad ogni dosso; ad un non par che l’abbia,
all’altro stringe e preme e gli dà duolo.
Mal può durar il rosignuolo in gabbia,
più vi sta il gardelino, e più il fanello;
la rondine in un dì vi mor di rabbia.
Chi brama onor di sprone o di capello,
serva re, duca, cardinale o papa;
io no, che poco curo questo e quello.
In casa mia mi sa meglio una rapa
ch’io cuoca, e cotta s’un stecco me inforco
e mondo, e spargo poi di acetto e sapa,
che all’altrui mensa tordo, starna o porco
selvaggio; e così sotto una vil coltre,
come di seta o d’oro, ben mi corco.
E più mi piace di posar le poltre
membra, che di vantarle che alli Sciti
sien state, agli Indi, alli Etiopi, et oltre.
Degli uomini son varii li appetiti:
a chi piace la chierca, a chi la spada,
a chi la patria, a chi li strani liti.
Chi vuole andare a torno, a torno vada:
vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna
a me piace abitar la mia contrada.
So bene che mi allontano dall’opinione comune, che considera un grande onore vivere a corte, e che io al contrario lo ritengo servitù. Ci rimanga volentieri chi lo apprezza, io ne uscirei con gioia se un giorno Mercurio (figlio di Maia, dio della ricchezza) si mostrerà propizio. Una sella o un basto non si adattano ad ogni schiena, ad un cavallo sembra di non avere niente addosso, ad un altro stringe e fa male. Male può vivere l’usignolo in gabbia, ci sta meglio il cardellino e il fanello, una rondine ci muore in un giorno per la rabbia. Chi desidera onori di cavalleria o di sacerdozio, serva re, duchi, cardinali o il papa, io no, che non mi interessano. In casa mia preferisco una rapa, cotta da me, infilzata su uno spiedo che poi sbuccio e la cospargo di aceto e di mostarda, che in tavola d’altri un tordo, una starna ed un cinghiale, e poi mi corico sotto una misera coperta, come se fosse di seta e d’oro. E preferisco riposare le pigre membra, che vantarmi di aver viaggiato in Russia, in India, in Africa e oltre. Gli uomini hanno diversi desideri a chi piace la vita ecclesiastica a chi la militare, a chi la sua patria, a chi i luoghi esotici. Chi vuole girare il mondo, lo giri: veda l’Inghilterra, l’Ungheria, la Francia, la Spagna, a me piace stare nel mio paese.
Vi è in questo brano una forte rivendicazione tra l’onore e il servilismo: con ironia, talvolta venata di sarcasmo, egli si distanzia da chi cerca onore e gloria e chiede poco, quasi nulla. Il quadretto domestico, costruito con similitudini tratte dalla quotidianità del vivere, ci rimandano al concetto di mediocritas. Anche ad esso deve a volte rinunciare, ma in modo meno deludente che col Cardinale: il duca sembra essere meno oppressivo. Tuttavia per spiegare al cugino la sua vera situazione ricorre ad una favola, anche qui, riprendendo il suo maestro latino, che in una Satura aveva inserito il famoso apologo del topo di campagna e del topo di città.
IL PASTORE E LA GAZZA
(III, 109-150)
Una stagion fu già, che sì il terreno
arse, che ’l Sol di nuovo a Faetonte
de’ suoi corsier parea aver dato il freno;
secco ogni pozzo, secca era ogni fonte;
li rivi e i stagni e i fiumi più famosi
tutti passar si potean senza ponte.
In quel tempo, d’armenti e de lanosi
greggi io non so s’i’ dico ricco o grave,
era un pastor fra gli altri bisognosi,
che poi che l’acqua per tutte le cave
cercò indarno, si volse a quel Signore
che mai non suol fraudar chi in lui fede have;
et ebbe lume e inspirazion di core,
ch’indi lontano troveria, nel fondo
di certa valle, il desiato umore.
Con moglie e figli e con ciò ch’avea al mondo
là si condusse, e con gli ordegni suoi
l’acqua trovò, né molto andò profondo.
E non avendo con che attinger poi,
se non un vase picciolo et angusto,
disse: «Che mio sia il primo non ve annoi;
di mógliema il secondo; e ’l terzo è giusto
che sia de’ figli, e il quarto, e fin che cessi
l’ardente sete onde è ciascuno adusto:
li altri vo’ ad un ad un che sien concessi,
secondo le fatiche, alli famigli
che meco in opra a far il pozzo messi.
Poi su ciascuna bestia si consigli,
che di quelle che a perderle è più danno
inanzi all’altre la cura si pigli».
Con questa legge un dopo l’altro vanno
a bere; e per non essere i sezzai,
tutti più grandi i lor meriti fanno.
Questo una gazza, che già amata assai
fu dal padrone et in delizie avuta,
vedendo et ascoltando, gridò: «Guai!
Io non gli son parente, né venuta
a fare il pozzo, né di più guadagno
gli son per esser mai ch’io gli sia suta;
veggio che dietro alli altri mi rimagno:
morò di sete, quando non procacci
di trovar per mio scampo altro rigagno».

Disegno di una gazza
Ci fu un tempo che il terreno era così riarso, che sembrava che il Sole avesse dato il permesso di guidare il suo carro a Faetonte che, passando troppo vicino alla terra la bruciò; ogni pozzo, ogni fonte era secca, i rivi, gli stagni, anche i più famosi fiumi si potevano attraversare senza bisogno di un ponte. In quel tempo, non so se ricco o povero di greggi, vi era un pastore, anche lui bisognoso d’acqua. Poi che l’aveva cercata inutilmente in ogni pozzo, si rivolse a quel Signore che non hai mai ingannato chi crede in Lui; ed ebbe l’illuminazione e l’ispirazione del cuore, che avrebbe trovato non molto lontano, nel fondo di una valle, la desiderata bevanda. Con la moglie ed i figli e tutto ciò che era in suo possesso, si portò lì, e con i suoi strumenti, trovò l’acqua, senza andare troppo in profondità. Non avendo, per raccoglierla, che un vasetto piccolo e stretto, disse: «Che io sia il primo, non vi dispiaccia; il secondo sarà di mia moglie, il terzo è giusto che sia dei figli, fino al quarto, finché non cessa l’ardente sete da cui ognuno è oppresso. Gli altri voglio che siano distribuiti secondo le fatiche sostenute, ai servi che misi all’opera insieme a me per lo scavo del pozzo. Poi si conceda ad ogni capo di bestiame e si prenda cura di quelli che possono essere più utili prima degli altri». Con questo patto uno dopo l’altro vanno a bere; e per non essere ultimi, tutti rendono più grandi i loro meriti. Una gazza, che fu molto amata e procurò molta gioia al padrone, vedendo e ascoltando tutto questo gridò: «Guai! Io non sono sua parente, né l’ho aiutato a fare il pozzo, né potrò essergli più utile di quanto sia stata sinora. Vedo che rimango indietro rispetto agli altri: morirò di sete, se non cerco di trovare un altro rigagnolo per la mia salvezza».
Vi è qui l’allegoria, un po’ amara di Leone X e del poeta. Infatti egli aveva tentato, inutilmente, quando era ancor giovane, d’entrare al suo servizio. Quest’ultimo infatti, figlio di Lorenzo il Magnifico, aveva mostrato un vivo apprezzamento per l’opera del poeta; ma è chiaro, qui, che non poteva aspettarsi troppo, dovendo Giovanni de’ Medici, ripagare con uffici e prebende tutti coloro che lo avevano aiutato. Si tratta di un’amara considerazione di un modus vivendi “amorale”, ma che egli osserva, attraverso la favola, con grande ironia, sapendo che “così va il mondo”.
Nella IV Satira racconta la sua esperienza come governatore in Garfagnana, mentre nella V disserta sulla fortuna o sfortuna di prender moglie; la VI è indirizzata a Pietro Bembo perché trovi un maestro di greco per il figlio Virginio, mentre la VII riafferma la volontà di non volersi spostare da Ferrara per diventare ambasciatore presso Clemente V.
Come si vede esse sono tutte basate su elementi autobiografici. Ma non per questo dobbiamo riferirci ad essi per scoprire la verità sull’esistenza del nostro: sono infatti frutto di una accurata rielaborazione letteraria. Non si tratta, cioè di scoprirsi presso il pubblico, quanto di mostrare ad esso la capacità di svolgere in una terzina modellata sul verso di Dante argomenti tratti dalla quotidianità, in cui la parola aulica si sposi con quella d’uso comune. Si osservi l’argomento e lo stile della III Satira: la riaffermazione della libertà, dove all’alto orgoglio si sposa l’esempio del ronzino; ho ancora lo sfarzo della vita di corte con il pasto di una rapa e, infine l’impossibilità di aver servito il papa con la favola della gru. E’ questo il processo dell’abbassamento ottenuto con la sua capacità ironica, che nel poema sarà utilizzata per abbracciare il mondo intero.
ORLANDO FURIOSO
L’Orlando Furioso, poema cavalleresco, viene definito dall’autore stesso una gionta (aggiunta) al non terminato Orlando Innamorato che il nobile Boiardo aveva composto, per il diletto della corte di Ercole I, nel 1495. Egli infatti riprende la vicenda interrotta dal predecessore e dedica la sua opera al figlio d’Ercole, il cardinale Ippolito. Dunque l’opera ariostesca si presenta subito come una continuazione. Eppure essa ha una vera e propria autonomia narrativa ed una qualità che il suo predecessore non possedeva, tanto da diventare, nella coscienza comune, come l’emblema di tutto il Rinascimento. Frutto di tutto il lavoro che l’autore ferrarese profuse nell’estensione del suo capolavoro sono le tre edizioni in cui essa si fece conoscere al pubblico:

Edizione del 1551
- 1516, in 40 canti, ritenuta sin da subito provvisoria dall’autore;
- 1521 in cui l’opera subisce un’importante revisione linguistica, grazie all’apporto amicale di Pietro Bembo, che di lì a poco avrebbe pubblicato le Prose della vulgar lingua (1525). Alcuni critici pensano che l’autore abbia avuto per questa edizione l’intenzione di aggiungere qualche canto (si tratterebbe dei Cinque canti, mai pubblicati, poi, perché sentiti poco coesi all’interno dell’opera dallo stesso poeta, ma resi postumi per opera del figlio);
- 1532, l’edizione definitiva in ben 46 canti, con un ulteriore e più perfetta revisione linguistica.

Riproduzione anastatica di cinque Canti pubblicati da Virginio
Se è quasi impossibile riassumere il poema, per la varietà e l’intrecciarsi delle vicende. È tuttavia possibile enuclearne tre temi principali:
- Il tema bellico, con la guerra tra i Franchi e i Mori;
- Il tema sentimentale con l’amore tra Orlando e Angelica, incluso la pazzia d’Orlando;
- Il tema encomiastico con l’amore tra Ruggiero e Bradamante.
Vediamone la struttura e i principali temi attraverso l’opera stessa:
PROEMIO E INCIPIT
(I, 1-16)
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.
Piacciavi, generosa Erculea prole,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir questo che vuole
e darvi sol può l’umil servo vostro.
Quel ch’io vi debbo, posso di parole
pagare in parte e d’opera d’inchiostro;
né che poco io vi dia da imputar sono,
che quanto io posso dar, tutto vi dono.
Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m’apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L’alto valore e’ chiari gesti suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensier cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.
Orlando, che gran tempo innamorato
fu de la bella Angelica, e per lei
in India, in Media, in Tartaria lasciato
avea infiniti ed immortal trofei,
in Ponente con essa era tornato,
dove sotto i gran monti Pirenei
con la gente di Francia e de Lamagna
re Carlo era attendato alla campagna,
per far al re Marsilio e al re Agramante
battersi ancor del folle ardir la guancia,
d’aver condotto, l’un, d’Africa quante
genti erano atte a portar spada e lancia;
l’altro, d’aver spinta la Spagna inante
a destruzion del bel regno di Francia.
E così Orlando arrivò quivi a punto:
ma tosto si pentì d’esservi giunto:
che vi fu tolta la sua donna poi:
ecco il giudicio uman come spesso erra!
Quella che dagli esperi ai liti eoi
avea difesa con sì lunga guerra,
or tolta gli è fra tanti amici suoi,
senza spada adoprar, ne la sua terra.
Il savio imperator, ch’estinguer volse
un grave incendio, fu che gli la tolse.
Nata pochi dì inanzi era una gara
tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo,
che ambi avean per la bellezza rara
d’amoroso disio l’animo caldo.
Carlo, che non avea tal lite cara,
che gli rendea l’aiuto lor men saldo,
questa donzella, che la causa n’era
tolse, e diè in mano al duca di Bavera;
in premio promettendola a quel d’essi,
ch’in quel conflitto, in quella gran giornata,
degl’infideli più copia uccidessi,
e di sua man prestasse opra più grata.
Contrari ai voti poi furo i successi;
ch’in fuga andò la gente battezzata,
e con molti altri fu ’l duca prigione,
e restò abbandonato il padiglione.
Dove, poi che rimase la donzella
ch’esser dovea del vincitor mercede,
inanzi al caso era salita in sella,
e quando bisognò le spalle diede,
presaga che quel giorno esser rubella
dovea Fortuna alla cristiana fede:
entrò in un bosco, e ne la stretta via
rincontrò un cavallier ch’a piè venìa.
Indosso la corazza, l’elmo in testa,
la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;
e più leggier correa per la foresta,
ch’al pallio rosso il villan mezzo ignudo.
Timida pastorella mai sì presta
non volse piede inanzi a serpe crudo,
come Angelica tosto il freno torse,
che del guerrier, ch’a piè venìa, s’accorse.
Era costui quel paladin gagliardo,
figliuol d’Amon, signor di Montalbano,
a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo
per strano caso uscito era di mano.
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,
riconobbe, quantunque di lontano,
l’angelico sembiante e quel bel volto
ch’all’amorose reti il tenea involto.
La donna il palafreno a dietro volta,
e per la selva a tutta briglia il caccia;
né per la rara più che per la folta,
la più sicura e miglior via procaccia:
ma pallida, tremando, e di sé tolta,
lascia cura al destrier che la via faccia.
Di sù di giù, ne l’alta selva fiera
tanto girò, che venne a una riviera.
Su la riviera Ferraù trovosse
di sudor pieno e tutto polveroso.
Da la battaglia dianzi lo rimosse
un gran disio di bere e di riposo;
e poi, mal grado suo, quivi fermosse,
perché, de l’acqua ingordo e frettoloso,
l’elmo nel fiume si lasciò cadere,
né l’avea potuto anco riavere.
Quanto potea più forte, ne veniva
gridando la donzella ispaventata.
A quella voce salta in su la riva
il Saracino, e nel viso la guata;
e la conosce subito ch’arriva,
ben che di timor pallida e turbata,
e sien più dì che non n’udì novella,
che senza dubbio ell’è Angelica bella.
E perché era cortese, e n’avea forse
non men de’ dui cugini il petto caldo,
l’aiuto che potea tutto le porse,
pur come avesse l’elmo, ardito e baldo:
trasse la spada, e minacciando corse
dove poco di lui temea Rinaldo.
Più volte s’eran già non pur veduti,
m’al paragon de l’arme conosciuti.

L’Orlando Furioso visto dai Pupari Siciliani
Le donne, i cavalieri, le battaglie, gli amori, gli atti di cortesia, le audaci imprese io canto, che ci furono nel tempo in cui gli Arabi attraversarono il mare d’Africa, e arrecarono tanto danno in Francia, seguendo le ire e i furori giovanili del loro re Agramante, il quale si vantò di poter vendicare la morte di Traiano contro il re Carlo, imperatore romano. // Nello stesso tempo, racconterò di Orlando cose mai dette né in prosa né in rima: che per amore, divenne furioso e matto, lui che prima era considerato uomo così saggio; dirò queste cose se da parte di colei che mi ha quasi reso tale e che a poco a poco consuma il mio piccolo ingegno, me ne sarà concesso a sufficienza (di ingegno) tanto che mi basti a finire l’opera che ho promesso. // Vi piaccia, o Ippolito, generosa e nobile figlio di Ercole I, ornamento e splendore del nostro tempo, di gradire questo poema che vuole e darvi solo può il vostro umile servitore. Il mio debito nei vostri confronti, lo posso solo pagare in parte con le mie parole ed opere scritte; non mi si potrà accusare di darvi poco, perché io vi dono tutto quanto posso donarvi. // Voi mi sentirete ricordare fra i più valorosi eroi, che mi appresto a citare lodandoli, di quel Ruggiero che fu il vostro e dei vostri nobili avi il capostipite. Il suo grande valore e le sue imprese vi farò udire se mi presterete ascolto; e le vostre profonde preoccupazioni cedano un poco, in modo che tra loro i miei versi possano trovare spazio. // Orlando, che per tanto tempo era stato innamorato della bella Angelica e per lei in India, in Oriente, aveva lasciato trofei immortali ed in numero infinito, era tornato infine con la donna amata in Occidente dove, sotto gli alti monti Pirenei, con i Francesi ed i Tedeschi, il re Carlo si era insediato in campo aperto, // perché il re Marsilio ed il re Agramante si pentissero ancora una volte delle loro folli azioni; Agramante per avere condotto dall’Africa tante persone quante erano in grado di portare spada e lancia, Marsilio per avere condotto la Spagna nella distruzione del bel regno di Francia. E così Orlando arrivò sul posto al momento giusto, ma subito si pentì di esservi giunto. // Perché gli anche fu tolta la donna che amava: ecco come il giudizio umano spesso sbaglia! La donna che dalle coste Orientali a quelle Occidentali aveva difeso con una tanto lunga guerra, ora gli viene tolta tra tanti suoi amici, senza che sia adoperata spada alcuna, sulla sua terra. Il saggio imperatore, con la volontà di estinguere un grave incendio (pericolosa contesa d’amore), fu a togliergliela. // Pochi giorni prima era infatti iniziato un conflitto tra il conte Orlando e suo cugino Rinaldo, poiché entrambi, per la rara bellezza di Angelica, avevano l’animo infiammato dal desiderio amoroso. Carlo non vedeva di buon occhio tale lite, che poteva mettere in dubbio il loro aiuto, questa fanciulla (Angelica), che ne era la causa, prese e consegnò nelle mani del duca Namo di Baviera; // promettendola in premio a chi dei due, nell’imminente conflitto, in quella battaglia campale, avesse ucciso il maggior numero di infedeli, e con la sua mano avesse quindi reso maggior servizio. Gli eventi fecero però venire meno le promesse; perché i cristiani dovettero ritirarsi, insieme a molti altri, il duca Namo fu fatto prigioniero e la sua tenda rimase vuota. // Rimasta sola nella tenda, la donzella, che avrebbe dovuto essere la ricompensa del vincitore, visto l’andamento degli eventi, salì in sella ad un cavallo e ad momento opportuno scappò, avuto presagio che, quel giorno, avversa alla fede cristiana sarebbe stata la fortuna. Entrò in un bosco e per lo stretto sentiero incontrò un cavaliere che avanzava a piedi. // Con addosso la corazza, in testa l’elmo, al fianco la spada ed al braccio lo scudo, correva per la foresta più rapidamente di un contadino poco vestito in una gara di corsa. Una timida pastorella mai così rapidamente sottrasse il piede dal morso di un serpente letale, quanto rapidamente Angelica tirò le redini per cambiare direzione non appena si accorse del guerriero che sopraggiungeva a piedi. // Era questo guerriero (Rinaldo) quel paladino, figlio di Amone, signore di Montalbano, al quale poco prima il proprio destriero per uno strano caso era fuggito di mano. Non appena posò lo sguardo sulla donna, riconobbe, nonostante fosse lontana, l’angelica figura ed il bel volto che lo avevano fatto prigioniero delle reti dell’amore. // La donna volta indietro il cavallo e per il bosco lo lancia in corsa a briglia sciolta; più per la sgombra che per la fitta boscaglia non va cercando la via migliore e più sicura, perché pallida, tremante, e fuori di sé, lascia che sia il cavallo a frasi strada da solo. L’animale da ogni parte, nell’inospitale foresta, tanto vagò che infine giunse alla riva di un fiume. // In riva al fiume trovò Ferraù tutto impolverato e sudato. Poco prima lo aveva tolto dalla battaglia un grande desiderio di bere e di riposarsi; e poi, contro la sua volontà, lì si dovette fermare, perché, nella fretta di bere, lasciò cadere nel fiume il proprio elmo ed ancora non era riuscito a ritrovarlo. // Sopraggiunse, gridando quanto più poteva la donzella spaventata. Udita la voce, il Saracino salta sulla riva la guarda attentamente in viso e subito riconosce che chi sta arrivando al fiume, nonostante fosse pallida e turbata dalla paura e fossero passati più giorni dall’ultima volta che ne ebbe notizia, era senza dubbio la bella Angelica. // Essendo di indole gentile e forse avendo anche l’animo infiammato non meno dei due cugini, porse a lei tutto l’aiuto che era in grado di dare, come se avesse riavuto l’elmo, temerario e spavaldo: sguainò la spada e corse minaccioso verso Rinaldo, che in realtà non era per niente intimorito da lui. Più volte si era già non solo visti, ma anche scontrati con le armi.
Abbiamo qui sia il proemio che l’incipit del poema stesso. Nel primo vi è la scansione classica: presentazione dell’argomento, invocazione e dedica. Ma Ariosto stravolge queste parti classiche di ogni poema. Vediamo come:
- l’argomento presenta il tema bellico ed il sentimentale che vengono strutturati attraverso un doppio chiasmo in cui è evidente che tale figura retorica vuole indicarci la varietà e l’intrecciarsi delle vicende:
le donne i cavalier
l’arme gli amori
le cortesie l’audaci imprese
- l’invocazione viene abbassata a tal punto che non si parla più né di figure celesti né di altissime figure pagane il cui compito è quello d’ispirare l’alto compito che il poeta deve elaborare, ma la semplice sua compagna che ama talmente tanto da poter finire “pazzo” come Orlando;
- La dedica è dedicata ad Ippolito d’Este, cardinale a cui egli presta servizio, ma non pare così interessato, tra le sue mille attività d’uomo di mondo e di chiesa, come ci ha fatto intendere già nelle Satire.
Quindi dopo avercelo presentato, il poeta, molto “umilmente” inizia il poema proprio dove Boiardo l’aveva cominciato e con un sunto estremamente veloce ci dice cosa nell’Orlando Innamorato si era raccontato: il paladino Orlando, tornato a Parigi dalla guerra vittoriosa in Oriente con la bella Angelica, figlia del re del Catai, si scontra con Rinaldo per la conquista della bella giovane. Re Carlo ne approfitta per prometterla in premio a chi si mostrerà più valoroso nella lotta contro i Saraceni e intanto l’affida in custodia al duca di Baviera Namo. Attraverso questo modo Ariosto non inizia il suo poema, ma continua il precedente; cioè, egli struttura un vero e proprio non inizio, in quanto vuole che il suo lavoro abbia una struttura “aperta”. Quindi parte in medias res, con la fuga d’Angelica, inseguita a piedi da Rinaldo, che aveva smarrito il cavallo, fino a che giunge ad un rivo dove vi è il soldato Ferraù, che cerca un elmo che gli era caduto. Alle grida della fanciulla si volge e riconosciutala, poiché anche a lui piaceva immensamente, la difende contro Rinaldo che intanto sopraggiungeva. Fra i due sorge un epico duello, di cui Angelica approfitta ridandosi alla fuga. Allora Rinaldo, accortosi dell’assenza della fanciulla, propone una tregua al rivale, affinché, solo dopo averla riacciuffata, si possa fra di loro stabilire chi la dovrà possedere. Tale proposta viene accettata da Ferraù di buon grado, che, essendo assai cortese, non lascia che il suo avversario rimanga a piedi, e caricatolo nel suo cavallo, insieme vanno all’inseguimento d’Angelica.

Ida Saitta: Orlando alla corte del re Carlo
RIFLESSIONI D’AUTORE 1
(I, 22-23)
Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!
Eran rivali, eran di fé diversi,
e si sentian degli aspri colpi iniqui
per tutta la persona anco dolersi;
e pur per selve oscure e calli obliqui
insieme van senza sospetto aversi.
Da quattro sproni il destrier punto arriva
ove una strada in due si dipartiva.
E come quei che non sapean se l’una
o l’altra via facesse la donzella
(però che senza differenza alcuna
apparia in amendue l’orma novella),
si messero ad arbitrio di fortuna,
Rinaldo a questa, il Saracino a quella.
Pel bosco Ferraù molto s’avvolse,
e ritrovossi al fine onde si tolse.
Oh gran bontà dei cavalieri antichi! Erano rivali, parlavano una diversa lingua, si sentivano dei duri colpi crudeli ancora dolere tutto il corpo; eppure per boschi oscuri e sentieri tortuosi vanno insieme senza temersi tra loro. Da quattro speroni punto, il destriero arriva ad un bivio. // E come quelli che non sapevano se l’una o l’altra via avesse imboccato la donzella (poiché senza alcuna differenza, su entrambi i sentieri l’impronta appariva fresca, recente) misero la propria sorte nelle mani della fortuna. Rinaldo per questo sentiero, il saracino per quello. Per il bosco Ferraù molto s’aggirò ad alla fine si ritrovò al punto di partenza.
Ci troviamo qui di fronte a dei procedimenti che ricorreranno moltissimo nel poema:
- Intervento dell’autore: con esso Ariosto pratica un abbassamento e “modernizzazione”: ciò avviene nello “svelamento” della favola, così come la presenta nel duello, descritto in modo “altisonante ed eroico”, ma anche una riflessione amara sull’odio che percorre l’intera penisola con le guerre del primo Cinquecento;
- Concetto di biforcazione: i due cavalieri si trovano di fronte ad un bivio; attraverso questa tecnica, Ariosto introduce il tema della simultaneità e quindi, narrativamente, il bisogno dell’intreccio presente nell’opera (racconto un episodio, che poi interrompo, perché voglio raccontarvi cosa nel frattempo succede in un altro episodio e via discorrendo);
- Concetto di circolarità: Ferraù si ritrova nel luogo in cui era partito: è un concetto collegato al precedente, quello dell’intreccio. Se quest’ultimo non mi può offrire una linea verticale della narrazione, basato sul prima e sul poi, mi darà viceversa un aspetto circolare in cui le cose tornano al punto stesso in cui erano.

Immagine che mostra Ferraù ed Argalia per un’edizione genovese dell’Orlando Furioso (XVI sec.)
Riprendendo la narrazione Ferraù si ritrova nel fiume a ricercare l’elmo. Ma mentre tenta il terreno sotto l’acqua esce il fantasma d’Argalia (fratello di Angelica) con l’elmo tra le braccia che rimprovera al cavaliere di non averglielo restituito come aveva promesso quando l’aveva ucciso. Ne cercasse un altro, come quelli di Rinaldo ed Orlando, altrimenti lui non ne avrà più. Vergognandosi molto, Ferraù così decide. Rinaldo intanto vede il suo cavallo. Angelica capisce che lui è vicino e ricomincia la fuga.
FUGA D’ANGELICA
(I, 33-45)
Fugge tra selve spaventose e scure,
per lochi inabitati, ermi e selvaggi.
Il mover de le frondi e di verzure,
che di cerri sentia, d’olmi e di faggi,
fatto le avea con subite paure
trovar di qua di là strani viaggi;
ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle,
temea Rinaldo aver sempre alle spalle.
Qual pargoletta o damma o capriuola,
che tra le fronde del natio boschetto
alla madre veduta abbia la gola
stringer dal pardo, o aprirle ’l fianco o ’l petto,
di selva in selva dal crudel s’invola,
e di paura trema e di sospetto:
ad ogni sterpo che passando tocca,
esser si crede all’empia fera in bocca.
Quel dì e la notte a mezzo l’altro giorno
s’andò aggirando, e non sapeva dove.
Trovossi al fin in un boschetto adorno,
che lievemente la fresca aura muove.
Duo chiari rivi, mormorando intorno,
sempre l’erbe vi fan tenere e nuove;
e rendea ad ascoltar dolce concento,
rotto tra picciol sassi, il correr lento.
Quivi parendo a lei d’esser sicura
e lontana a Rinaldo mille miglia,
da la via stanca e da l’estiva arsura,
di riposare alquanto si consiglia:
tra’ fiori smonta, e lascia alla pastura
andare il palafren senza la briglia;
che di fresca erba avean piene le sponde.
Ecco non lungi un bel cespuglio vede
di prun fioriti e di vermiglie rose,
che de le liquide onde al specchio siede,
chiuso dal sol fra l’alte querce ombrose;
così voto nel mezzo, che concede
fresca stanza fra l’ombre più nascose:
e la foglia coi rami in modo è mista,
che ’l sol non v’entra, non che minor vista.
Dentro letto vi fan tenere erbette,
ch’invitano a posar chi s’appresenta.
La bella donna in mezzo a quel si mette,
ivi si corca ed ivi s’addormenta.
Ma non per lungo spazio così stette,
che un calpestio le par che venir senta:
cheta si leva e appresso alla riviera
vede ch’armato un cavallier giunt’era.
Se gli è amico o nemico non comprende:
tema e speranza il dubbio cor le scuote;
e di quella aventura il fine attende,
né pur d’un sol sospir l’aria percuote.
Il cavalliero in riva al fiume scende
sopra l’un braccio a riposar le gote;
e in un suo gran pensier tanto penètra,
che par cangiato in insensibil pietra.
Pensoso più d’un’ora a capo basso
stette, Signore, il cavallier dolente;
poi cominciò con suono afflitto e lasso
a lamentarsi sì soavemente,
ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso,
una tigre crudel fatta clemente.
Sospirante piangea, tal ch’un ruscello
parean le guance, e ’l petto un Mongibello.
«Pensier (dicea) che ’l cor m’agghiacci ed ardi,
e causi il duol che sempre il rode e lima,
che debbo far, poi ch’io son giunto tardi,
e ch’altri a corre il frutto è andato prima?
a pena avuto io n’ho parole e sguardi,
ed altri n’ha tutta la spoglia opima.
Se non ne tocca a me frutto né fiore,
perché affligger per lei mi vuo’ più il core?
La verginella è simile alla rosa,
ch’in bel giardin su la nativa spina
mentre sola e sicura si riposa,
né gregge né pastor se le avvicina;
l’aura soave e l’alba rugiadosa,
l’acqua, la terra al suo favor s’inchina:
gioveni vaghi e donne inamorate
amano averne e seni e tempie ornate.
Ma non sì tosto dal materno stelo
rimossa viene e dal suo ceppo verde,
che quanto avea dagli uomini e dal cielo
favor, grazia e bellezza, tutto perde.
La vergine che ’l fior, di che più zelo
che de’ begli occhi e de la vita aver de’,
lascia altrui corre, il pregio ch’avea inanti
perde nel cor di tutti gli altri amanti.
Sia vile agli altri, e da quel solo amata
a cui di sé fece sì larga copia.
Ah, Fortuna crudel, Fortuna ingrata!
trionfan gli altri, e ne moro io d’inopia.
Dunque esser può che non mi sia più grata?
dunque io posso lasciar mia vita propia?
Ah più tosto oggi manchino i dì miei,
ch’io viva più, s’amar non debbo lei!»
Se mi domanda alcun chi costui sia,
che versa sopra il rio lacrime tante,
io dirò ch’egli è il re di Circassia,
quel d’amor travagliato Sacripante;
io dirò ancor, che di sua pena ria
sia prima e sola causa essere amante,
è pur un degli amanti di costei:
e ben riconosciuto fu da lei.

Carlo Jacono: La fuga di Angelica (1957)
Fugge tra spaventosi ed oscuri boschi, per luoghi inabitati, selvaggi e solitari. Il rumore provocato dal movimento dei rami e dalla vegetazione di querce, olmi e faggi, che Angelica sentiva, causa le improvvise paure, le avevano fatto intraprendere insoliti sentieri da ogni parte; perché ogni ombra che vedeva sui monti o nelle valli, le facevano temere di avere ancora alle spalle Rinaldo. // Come un cucciolo di daino o capriolo, che tra i rami del boschetto nel quale è nato abbia visto la gola della madre dal morso del leopardo stretta, o che le squarcia il petto od il fianco, scappa dall’animale crudele di bosco in bosco e trema per la paura e per il sospetto della sua presenza: per ogni cespuglio che tocca al proprio passaggio crede di essere già in bocca alla belva crudele. // Quel giorno, la stessa notte e per metà del giorno seguente vagò senza sapere dove stesse andando. Venne a trovarsi infine in un boschetto leggiadro, mosso delicatamente da un vento fresco. Due ruscelli trasparenti, riempiendo l’aria del loro gorgoglio, consentono la presenza sempre dell’erba e la sua crescita; e rendevano piacevole da ascoltare la dolce armonia, interrotta solo tra piccoli sassi, dal loro scorrere lento. // Qui, credendo di essere al sicuro e lontana mille miglia da Rinaldo, per lo stancante tragitto ed il caldo estivo decide di riposare per un po’ tempo: scende da cavallo tra i fiori e lascia andare a nutrirsi, senza briglia, libero, il proprio destriero; l’animale vaga quindi nei dintorni dei ruscelli, che avevano piene le rive di fresca erba. // Non lontano da sé Angelica scorge un bel cespuglio, fiorito di biancospini e di rose rosse, che si specchia nelle onde limpide dei ruscelli ed è riparato dal sole dalle alte querce ombrose; vuoto nel mezzo, così da concedere fresco giaciglio tra le ombre più nascoste: le sue foglie ed i suoi rami sono talmente intrecciati che non passa il sole, e nemmeno la vista dell’uomo, meno penetrante. // L’erbetta morbida crea un letto all’interno del cespuglio, invitando a stendersi sopra chi vi giunge. La bella donna si mette in mezzo al cespuglio, lì si corica e quindi si addormenta. Ma non rimane lì addormentata molto tempo, che le sembra di sentire avvicinarsi un rumore di calpestio: si solleva piano piano e presso la riva di un ruscello vede essere giunto un cavaliere armato. // Angelica non riesce a capire se gli è amico o nemico: il timore e la speranza le scuotono il suo cuore dubbioso; attende che quella avventura giunga ad un termine senza emettere neanche un solo sospiro. Il cavaliere si siede in riva al ruscello reggendosi la testa con un braccio; e viene tanto rapito dai propri pensieri, al punto che, immobile, sembra essersi mutato in insensibile pietra. // Assorto dai propri pensieri, con il capo basso, per più di un’ora stette, cardinale Ippolito, il cavaliere abbattuto; dopo di ché cominciò con un la-mento afflitto e dolente a lamentarsi in modo tanto struggente, che avrebbe infranto un sasso per pietà, una crudele tigre fatta misericordiosa. Piangeva tra i sospiri, tanto che un ruscello sembrava scorrergli sulle guance ed il petto un vulcano infuocato. // Diceva: «Pensiero che mi ghiaccia ed arde il cuore, e causa del dolore che sempre lo consuma, che ci posso fare se sono giunto tardi ed altri, arrivati prima, hanno già colto il frutto (Angelica)? Ho ricevuto a stento i suoi sguardi e parole, altri hanno invece ricevuto tutto il ricco bottino. Se a me non spettano né il frutto né il fiore, perché per lei voglio ancora tormentare il mio cuore? // La vergine è simile ad una rosa, che in un bel giardino, sul rovo che l’ha generata, si riposa finché è sola ed al sicuro, e né gregge né pastore le si avvicinano; la brezza delicata e la rugiada del mattino, l’acqua e la terra si inchinano davanti al suo fascino: giovani amanti e donne innamorate amano ornarsi il collo e la testa di lei, la rosa. // Ma non appena dallo stelo materno e dal ceppo verde del cespuglio viene staccata, quanto aveva per gli uomini e per il cielo fascino, grazia e bellezza, tutto perde. La vergine che il proprio fiore, del quale deve avere cura più che dei propri begli occhi e della propria vita, lascia cogliere ad altra persona, perde l’ammirazione che poco prima aveva nel cuore di tutti i propri amanti. // Diviene di scarso valore agli occhi degli altri, ed amata solo da colui al quale fece così grande dono di sé. Ah, fortuna crudele, fortuna ingiusta! Gli altri godono mentre io muoio di stenti. Non potrebbe allora essermi lei meno cara? Non potrei forse abbandonare la mia propria vita? Ah, che io muoia oggi stesso piuttosto che vivere più a lungo, se non dovessi amare lei!». // Se qualcuno mi domandasse chi sia questo cavaliere, che versa così tante lacrime sopra il torrente, io risponderò che lui è il re di Circassia, Sacripante, tormentato dall’amore; dirò ancora che della sua pena, grave da sopportare, la prima e sola causa è l’amare una donna, ed è proprio uno degli amanti di Angelica: è subito fu infatti da lei riconosciuto.
Qui Ariosto tocca due tecniche estremamente presenti nella cultura classica e quindi riprese nell’età rinascimentale: l’aspetto dell’elegia e del locus amoenus; infatti la selva in cui fugge Angelica, oltre a richiamare Dante, riflette lo stato ansioso della fanciulla; mentre il prato in cui ella trova riposo rimanda ad echi petrarcheschi, in cui egli idealizzava la sua amata Laura. Ma è proprio qui che egli crea il contrasto ironico: al piacevole e perfetto posto in cui trova riposo la fanciulla, fa da contrasto l’atteggiamento malinconico di Sacripante; alla bellezza e purezza d’Angelica, fa da contrasto la certezza che Orlando, nel portarla da Oriente a Parigi, l’abbia sverginata ed una donna, cui è stato colto il frutto, perde d’ogni qualità. Così pensa lui. Angelica che ha sentito il suo lamento e che, vistosi sola, una compagnia per tornare al suo paese l’avrebbe voluta volentieri, ma senza compromettersi, si svela al re e, per meglio convincerlo, afferma d’esser ora vergine così come Dio l’ha fatta.
RIFLESSIONI D’AUTORE 2
(I, 56)
Forse era ver, ma non però credibile
a chi del senso suo fosse signore;
ma parve facilmente a lui possibile,
ch’era perduto in via più grave errore.
Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibiIe,
e l’invisibil fa vedere Amore.
Questo creduto fu; che ’l miser suole
dar facile credenza a quel che vuole.
Forse era vero ciò che diceva, ma non era però credibile a chi fosse padrone della propria ragione; ma parve facilmente possibile a Sacripante, che aveva commesso un ben più grave errore, innamorandosi. Quel che l’uomo potrebbe vedere, l’amore gli nasconde, e ciò che non sarebbe visibile viene fatto vedere dall’amore. Il racconto fu creduto; poiché l’uomo misero è solito credere troppo facilmente a ciò che ha bisogno di credere.
E’ evidente qui l’ironia di Ariosto, che tuttavia nasconde riflessioni sulla realtà umana e sulla sua debolezza; in primo luogo il solito contrasto tra apparenza e realtà, tra forma idealizzata e forma concreta: la bella Angelica (tale anche nel nome) non è che una furba ragazza; dall’altra, più con saggezza che con ironia, la constatazione di un aspetto dell’amore che crea bugie nella nostra mente, ma alle quali non sappiamo opporci. Ma Sacripante, ben pensandoci, riflette che se Orlando è stato così stupido da non approfittare della presenza di una così splendida fanciulla, ci penserà ben lui a farle provare la dolcezza dell’amore. Mentre si prepara al dolce assalto vede giungere un cavaliere, completamente bianco: estremamente arrabbiato perché lo ha interrotto sul più bello, lo sfida subito a duello. Monta sul cavallo e, dopo l’assalto, rimane disarcionato:

Giuseppe Bergomi: Angelica che fugge (2014)
DA RE A UOMO
(I, 63-64)
Già non fero i cavalli un correr torto,
anzi cozzaro a guisa di montoni:
quel del guerrier pagan morì di corto,
ch’era vivendo in numero de’ buoni:
quell’altro cadde ancor, ma fu risorto
tosto ch’al fianco si sentì gli sproni.
Quel del re saracin restò disteso
adosso al suo signor con tutto il peso.
L’incognito campion che restò ritto,
e vide l’altro col cavallo in terra,
stimando avere assai di quel conflitto,
non si curò di rinovar la guerra;
ma dove per la selva è il camin dritto,
correndo a tutta briglia si disserra;
e prima che di briga esca il pagano,
un miglio o poco meno è già lontano.
I due cavalli, uno di fronte all’altro, non deviarono in corsa, anzi si scontrarono violentemente tra loro come fanno i montoni: il cavallo di Sacripante morì sul colpo, pur potendo essere annoverato, da vivo, tra i buoni destrieri: anche l’altro cadde a terra, ma si rialzò non appena sentì pungere al suo fianco gli speroni. Quello del re saracino restò disteso, tendendo schiacciato con il proprio peso il padrone. // Il misterioso campione che rimase dritto a cavallo, e vide l’altro cavaliere in terra con il cavallo, ritenendo di avere avuto sufficiente trionfo da quel conflitto, non ritenne necessario rinnovare il combattimento; là dove, attraverso la selva, il sentiero è dritto, si lancia invece al galoppo; e prima che il pagano riesca a liberarsi dall’impaccio, si è già allontanato di un miglio o poco meno.
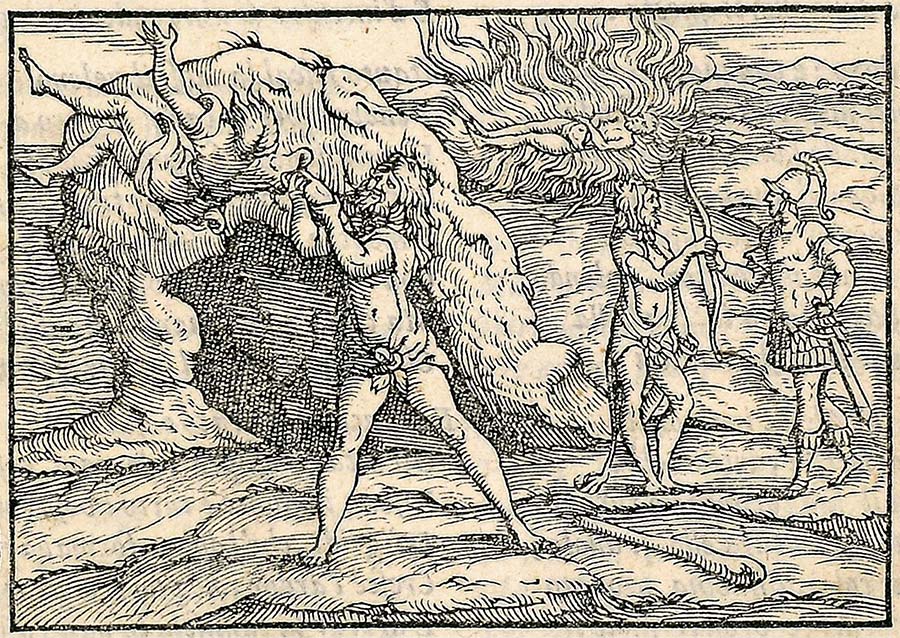
Immagine per il 1° canto del Furioso
E’ questo quello che si definisce l’“abbassamento” ariostesco: da re a uomo profondamente turbato per la vergogna d’esser stato disarcionato e gettato a terra di fronte alla donna che un attimo prima pensava di far sua. Ma ad acuire la vergogna di Sacripante è la notizia che a batterlo è stata una donna, Bradamante, anch’ella in cerca del suo Ruggero. Quindi Angelica prende il re sul proprio cavallo, e s’incammina. Di lontano riconosce Baiardo, cavallo di Rinaldo, ma a lei legato (Spiega Calvino: “Come mai Baiardo, così fedele, gli era scappato? Non tarderemo a comprendere che questa fuga – da cui a ben vedere, si scatenano tutte le vicissitudini dell’Orlando furioso – era una straordinaria prova di fedeltà e intelligenza. Per servire il suo padrone innamorato, Baiardo s’era messo di sua iniziativa sulle tracce di Angelica, di modo che Rinaldo, correndo dietro al destriero, avrebbe trovato la sua bella. Se si lasciava montare dal padrone, sarebbe stato il padrone a dirigerlo, come sempre avviene ad ogni cavallo; fuggendo è Baiardo a dirigere Rinaldo. Questo Baiardo, così corposamente cavallo, tende a sconfinare dalla natura equina, proprio perché vuole essere un cavallo ideale”). Il saraceno cerca di cavalcarlo, ma viene allontanato e si mostra solamente grato ad Angelica. Mentre i due lasciano il cavallo precedente e montano su questo, assai più forte, riappare Rinaldo. Sacripante si fa raggiungere, e si accinge a sostenere un duello, per vendicare l’offesa di ladro di cavallo e di donna lanciatagli da Rinaldo, ma mentre cominciano a combattere, Angelica stringe le briglia e fugge.
Quel che si seguì tra questi due superbi
vo’ che per l’altro canto si riservi.
Quello che seguì tra questi due superbi, voglio che sia riservato per il prossimo canto.
E’ questa la tecnica della dilazione: si è già mostrato come Ariosto tenda a non chiudere le vicende, per il concetto della contemporaneità, in cui tutto avviene in un tempo e tutto ad un tempo dev’essere seguito. Ma anche per esercitare la curiosità del lettore, facendo terminare il canto nel momento topico in cui si prepara un duello, per differire l’esito del duello stesso nel canto successivo. Un altro elemento caratterizzante il primo e quindi l’intero poema è il concetto della queste (ricerca): tutto l’episodio è costellato da Rinaldo che cerca Angelica, Ferraù l’elmo, Angelica un accompagnatore, Bradamante Ruggiero, senza ottenerlo. Ma vedremo spesso che chi cerca è a sua volta cercato e a quale destino porterà la ricerca esasperata.

Bradamante e Pinabello
Il canto II si apre con il duello tra Sacripante e Rinaldo, e Angelica, vista la forza del cavaliere francese, e temendo di divenire sua prigioniera, approfitta della situazione e fugge a cavallo nel bosco. Qui incontra un eremita, il quale, con un incantesimo, evoca uno spirito, che interrompe il duello tra i due contendenti comunicando loro che Angelica è intanto fuggita a Parigi con Orlando. Rinaldo monta subito Baiardo, lascia a piedi Sacripante, e si precipita a Parigi. Nel frattempo re Carlo, sconfitto in battaglia, si era ritirato a Parigi con i propri soldati e si apprestava ai preparativi necessari per sostenere l’imminente assedio e quindi dà ordine a Rinaldo di partire immediatamente per l’Inghilterra per chiedere soccorsi. Rinaldo, malvolentieri parte, ma deve affrontare una bufera. Bradamante, sua sorella, continua la ricerca di Ruggiero finché giunge ad un torrente dove incontra un cavaliere che, disperato ed in lacrime, le racconta che un uomo in groppa ad un cavallo alato, l’ippogrifo, era sceso dal cielo ed aveva rapito la sua amante. Inseguendolo era arrivato ai piedi di una roccia dove aveva visto un castello luminoso dimora del mago Atlante, irraggiungibile se non a piedi. Anche il re Gradasso e Ruggiero, andati a misurarsi con lui, vengono quindi subito fatti prigionieri. E’ questo cavaliere Pinabello, discendente dei Maganza, famiglia nemica di Bradamante, ma, per il momento, lei non lo sa e ancora all’oscuro della sua identità gli chiede di essere condotta al castello. Pinabello apprende, per un messaggero, che la sua compagna di viaggio discende dal casato dei Chiaromonte, suo acerrimo nemico, e progetta quindi o di tradire o di abbandonare la giovane alla prima possibilità. Così preso dal pensiero del tradimento, Pinabello smarrisce però la strada ed i due si trovano infine in un bosco, dove Pinabello, con uno stratagemma fa precipitare Bradamante sul fondo di una caverna, che non muore, ma rimane priva di sensi per molto tempo.

Melissa evoca gli spiriti e mostra a Bradamante la dinastia estense
Il canto III si apre con Pinabello che si allontana dalla caverna con il cavallo di Bradamante, convinto d’averla uccisa. Invece lei si riprende, ed entra attraverso la roccia in una caverna molto ampia, con al centro un altare. Entra nella stessa caverna anche una altra donna, chiama Bradamante per nome, e le dice di trovarsi nella tomba del mago Merlino e che le era stata annunciata la sua venuta dallo stesso mago, la cui voce può essere ancora ascoltata. La maga Melissa conduce la donna verso il sepolcro e subito la voce del mago si rivolge a lei profetizzando il suo matrimonio con Ruggiero, nonostante gli interventi del mago Atlante, e quindi la gloria a cui saranno destinati tutti i loro discendenti. Quindi le mostra le immagini dei suoi illustri discendenti della famiglia d’Este (momento encomiastico). Spariti gli spiriti Melissa promette a Bradamante di condurla fuori dal bosco e di indirizzarla poi verso il castello di Atlante, dove Ruggiero è tenuto prigioniero. Durante il viaggio la maga sollecita Bradamante a correre in soccorso del suo amato e, per vincere gli incantesimi d’Atlante le racconta che un certo Brunello ha con sé un anello magico in grado di annullare ogni incantesimo. Quindi la indirizza ad un ostello dove lo incontrerà per farsi accompagnare al castello dove dovrà ucciderlo senza pietà, prima che lui possa infilarsi in bocca l’anello e sparire. Quindi Bradamante si incammina, raggiunge l’albergo e conosce Brunello. I due stanno parlando insieme, quando sentono un forte rumore.
Il canto IV inizia così:
L’APPARIZIONE DI ATLANTE
(IV, 1-8)
Quantunque il simular sia le più volte
ripreso, e dia di mala mente indici,
si trova pur in molte cose e molte
aver fatti evidenti benefici,
e danni e biasmi e morti aver già tolte;
che non conversiam sempre con gli amici
in questa assai più oscura che serena
vita mortal, tutta d’invidia piena.
Se, dopo lunga prova, a gran fatica
trovar si può chi ti sia amico vero,
ed a chi senza alcun sospetto dica
e discoperto mostri il tuo pensiero;
che de’ far di Ruggier la bella amica
con quel Brunel non puro e non sincero,
ma tutto simulato e tutto finto,
come la maga le l’avea dipinto?
Simula anch’ella; e così far conviene
con esso lui di finzioni padre;
e, come io dissi, spesso ella gli tiene
gli occhi alle man, ch’eran rapaci e ladre.
Ecco all’orecchie un gran rumor lor viene.
Disse la donna: «O gloriosa Madre,
o Re del ciel, che cosa sarà questa?»
E dove era il rumor si trovò presta.
E vede l’oste e tutta la famiglia,
e chi a finestre e chi fuor ne la via,
tener levati al ciel gli occhi e le ciglia,
come l’ecclisse o la cometa sia.
Vede la donna un’alta maraviglia,
che di leggier creduta non saria:
vede passar un gran destriero alato,
che porta in aria un cavalliero armato.
Grandi eran l’ale e di color diverso,
e vi sedea nel mezzo un cavalliero,
di ferro armato luminoso e terso;
e ver ponente avea dritto il sentiero.
Calossi, e fu tra le montagne immerso:
e, come dicea l’oste (e dicea il vero),
quel era un negromante, e facea spesso
quel varco, or più da lungi, or più da presso.
Volando, talor s’alza ne le stelle,
e poi quasi talor la terra rade;
e ne porta con lui tutte le belle
donne che trova per quelle contrade:
talmente che le misere donzelle
ch’abbino o aver si credano beltade
(come affatto costui tutte le invole)
non escon fuor sì che le veggia il sole.
«Egli sul Pireneo tiene un castello
(narrava l’oste) fatto per incanto,
tutto d’acciaio, e sì lucente e bello,
ch’altro al mondo non è mirabil tanto.
Già molti cavallier sono iti a quello,
e nessun del ritorno si dà vanto:
sì ch’io penso, signore, e temo forte,
o che sian presi, o sian condotti a morte».
La donna il tutto ascolta, e le ne giova,
credendo far, come farà per certo,
con l’annello mirabile tal prova,
che ne fia il mago e il suo castel deserto;
e dice a l’oste: «Or un de’ tuoi mi trova,
che più di me sia del viaggio esperto;
ch’io non posso durar: tanto ho il cor vago
di far battaglia contro a questo mago».
Sebbene il fingere la maggior parte delle volte venga rimproverato, e fornisca anche indizio di mente malvagia, si può comunque vedere come in molte situazioni abbia anche portato evidenti benefici, evitando danni, critiche ed anche morti; perché non abbiamo a che fare sempre con amici in questa nostra vita mortale, molto più scura che serena, sempre piena di invidia. // Se, dopo lunghi tentativi, molta fatica, si riesce a trovare una persona che possa essere un vero amico, alla quale, senza avere sospetti, si possa dire e rendere quindi chiaro il nostro pensiero; che deve fare allora Bradamante, la bella amante di Ruggiero, con quel Brunello che non è né puro né sincero, ma è invece maestro di simulazione e di finzione, così come la maga glielo aveva descritto? // Anche lei finge; e conviene fare così trattando con lui, che è il padre della menzogna; e, come vi ho già raccontato, spesso lei getta lo sguardo sulle mani di lui, che erano avide e da ladro. All’improvviso giunge al loro orecchio un forte rumore. Chiede allora la donna: «Oh Madre gloriosa, oh Re del cielo, che cosa è questa cosa?» E rapidamente raggiunge il punto da cui proviene il rumore. // E vede così l’oste e tutta la servitù, chi dalle finestre e chi all’aperto, lungo la strada, tenere fissi gli occhi verso il cielo come se ci fosse l’eclisse o il passaggio di una cometa. Bradamante vede una cosa incredibile, che non sarebbe stato possibile credere facilmente: vede passare un grande cavallo alato, che porta in giro per il cielo un cavaliere armato. // Le sue ali sono grandi e multicolore, e si può vedere in mezzo a loro un cavaliere, con indosso una armatura luminosa e limpida; e si dirige verso ovest. Scende di quota e sparisce quindi tra le montagne: e, come dice l’oste (e dice una cosa vera), quel cavaliere è un mago, e passa spesso da là, a volte da più lontano altre da più vicino. // In volo, a volte va tanto in alto sino alle stelle, e poi scende quasi fino a toccare terra; e porta sempre con sé tutte le belle donne che riesce a trovare in quei paesini: a tal punto che le povere ragazze che sono o si credono belle (come se il mago le rapisse proprio tutte) non escono mai di casa, non escono alla luce del sole. // «Il mago possiede un castello sui Pirenei (racconta l’oste) costruito con un incantesimo, tutto in acciaio, ed è così bello e lucente, che non ne esiste al mondo uno tanto meraviglioso. Molti cavalieri sono già andati fino a questo castello, ma nessuno di loro può vantarsi di essere anche poi tornato: tanto che io credo, signore, e temo anche molto, o che siano stati fatti prigionieri, o che siano stati uccisi.» // La donna ascolta tutto il racconto, e se ne compiace, pensando già di affrontare, come è sicuro che farà, tale impresa con l’aiuto dell’anello magico, sino a sconfiggere il mago e distruggere il castello; e dice quindi all’oste: «Trovami ora uno dei tuoi servitori, che conosca quale strada occorre seguire; perché non posso rimanere più a lungo, essendo il mio cuore tanto desideroso di scontrarsi contro questo mago.»
In questo passo appare evidente come, su suggestione del ciclo bretone (quello relativo alla corte di re Artù) il nostro lasci libero sfogo all’elemento fantastico. Esso tuttavia non elude la capacità ariostesca di filosofeggiare sulla stregua certamente machiavelliana sulla necessità della finzione se essa porta ad un buon fine. Era certamente un tema assai dibattuto tra gli intellettuali del ‘500, che tuttavia fa già presagire un clima diverso, meno solare di quanto la critica abbia voluto inquadrare il Rinascimento. Ciò rende il poema dell’autore ferrarese ricco di questa incredibile oscillazione tra riflessione morale, contemporanea, come questa sull’opportunità di fingere, se si è circondati dalla falsità degli uomini, e la necessità puramente edonistica della narrazione com’è appunto l’apparizione dell’ippogrifo.

Brunello legato ad un albero da Bradamante che gli ruba l’anello magico
Il barone Brunello cade nella trappola, si offre subito come guida e il mattino dopo partono insieme. Giungono quindi ai piedi del dirupo, sui monti Pirenei, in cima al quale sorge la fortezza di Atlante. Bradamante capisce che è il momento di uccidere la propria guida per impossessarsi dell’anello, ma non vuole commettere un atto vile, e lo immobilizza legandolo ad un albero, riuscendo così ad impadronirsene senza spargere sangue. Giunta sotto la torre, suona il proprio corno e chiama alla battaglia il mago.
IL DUELLO TRA BRADAMANTE E ATLANTE
(IV 16-24)
Non stette molto a uscir fuor de la porta
l’incantator, ch’udì ’l suono e la voce.
L’alato corridor per l’aria il porta
contra costei, che sembra uomo feroce.
La donna da principio si conforta;
che vede che colui poco le nuoce:
non porta lancia né spada né mazza,
ch’a forar l’abbia o romper la corazza.
Da la sinistra sol lo scudo avea,
tutto coperto di seta vermiglia;
ne la man destra un libro, onde facea
nascer, leggendo, l’alta maraviglia:
che la lancia talor correr parea,
e fatto avea a più d’un batter le ciglia;
talor parea ferir con mazza o stocco,
e lontano era, e non avea alcun tocco.
Non è finto il destrier, ma naturale,
ch’una giumenta generò d’un Grifo:
simile al padre avea la piuma e l’ale,
li piedi anteriori, il capo e il grifo;
in tutte l’altre membra parea quale
era la madre, e chiamasi ippogrifo;
che nei monti Rifei vengon, ma rari,
molto di là dagli aghiacciati mari.
Quivi per forza lo tirò d’incanto;
e poi che l’ebbe, ad altro non attese,
e con studio e fatica operò tanto,
ch’a sella e briglia il cavalcò in un mese:
così ch’in terra e in aria e in ogni canto
lo facea volteggiar senza contese.
Non finzion d’incanto, come il resto,
ma vero e natural si vedea questo.
Del mago ogn’altra cosa era figmento,
che comparir facea pel rosso il giallo;
ma con la donna non fu di momento,
che per l’annel non può vedere in fallo.
Più colpi tuttavia diserra al vento,
e quinci e quindi spinge il suo cavallo;
e si dibatte e si travaglia tutta,
come era, inanzi che venisse, istrutta.
E poi che esercitata si fu alquanto
sopra il destrier, smontar volse anco a piede,
per poter meglio al fin venir di quanto
la cauta maga istruzion le diede.
Il mago vien per far l’estremo incanto;
che del fatto ripar né sa né crede:
scuopre lo scudo, e certo si prosume
farla cader con l’incantato lume.
Potea così scoprirlo al primo tratto,
senza tenere i cavallieri a bada;
ma gli piacea veder qualche bel tratto
di correr l’asta o di girar la spada:
come si vede ch’all’astuto gatto
scherzar col topo alcuna volta aggrada;
e poi che quel piacer gli viene a noia,
dargli di morso, e al fin voler che muoia.
Dico che ’l mago al gatto, e gli altri al topo
s’assimigliar ne le battaglie dianzi;
ma non s’assimigliar già così, dopo
che con l’annel si fe’ la donna inanzi.
Attenta e fissa stava a quel ch’era uopo,
acciò che nulla seco il mago avanzi;
e come vide che lo scudo aperse,
chiuse gli occhi, e lasciò quivi caderse.
Non che il fulgor del lucido metallo,
come soleva agli altri, a lei nocesse;
ma così fece acciò che dal cavallo
contra sé il vano incantator scendesse:
né parte andò del suo disegno in fallo;
che tosto ch’ella il capo in terra messe,
accelerando il volator le penne,
con larghe ruote in terra a por si venne.

Giovan Battista Sirani: Bradamante sconfigge Atlante (1655)
Non aspettò molto prima di uscire dalla porta del castello il mago, avendo ascoltato sia il suono del corno che le grida. Il destriero alato lo porta per aria a combattere contro di lei, che sembra ai suoi occhi un fiero cavaliere. La donna da subito si dà coraggio, vedendo che il suo avversario non può farle molto male: dal momento che non ha né la spada né un bastone ferrato, che le possa forare o rompere la corazza. // Alla sua sinistra aveva con sé solo lo scudo, completamente coperto da un telo di rossa seta; ne la mano destra teneva quindi un libro, dal quale faceva scaturire, leggendo, i suoi prodigiosi incantesimi: così che a volte sembrava combattere con la lancia, e a più di un cavaliere aveva fatto temere di essere colpito; a volte sembrava ferire con la mazza o con una arma corta, ma era in realtà lontano e non aveva colpito nessuno. // Non è invece un incantesimo il cavallo, ma è vero, è opera della Natura, perché nacque da una cavalla e da un grifone: aveva le piume e le ali simili a quelle del padre, e anche le zampe davanti, la testa ed il muso; in tutte le altre parti del corpo era invece tale e quale alla madre, ed il suo nome era Ippogrifo; come ne nascono sui monti Urali, anche che sono rari, molto al di là dei mari ghiacciati. // Il mago lo portò al suo castello grazie ad un incantesimo; e dopo che l’ebbe avuto, non si dedicò a null’altro, ma si impegnò con così grande cura e fatica, che nel giro di un mese riuscì a cavalcarlo con tanto di sella e briglia: così che adesso in terra, in aria, in ogni luogo, lo faceva volteggiare a proprio piacere. Non quindi come la finzione frutto di un incantesimo, come ogni altra cosa, ma vero ed al naturale era visto dalla donna. // Qualunque altra cosa del mago era finzione; che faceva vedere una cosa per un’altra, il rosso al posto del giallo: ma con Bradamante non gli servì però a nulla; poiché, grazie all’anello, non può essere ingannata. Nonostante ciò, lei sferra parecchi colpi a vuoto, finge di combattere, e spinge in giro il proprio cavallo; e si dibatte e si affatica tutta, come le era stato spiegato prima di giungere in quel posto. E dopo essersi esercita a lungo in questa finzione a cavallo, volle anche smontare e continuare a piedi, per poter meglio portare a compimento ciò su cui l’attenta maga Melissa l’aveva istruita. Il mago si avvicinò per fare il suo ultimo incantesimo; poiché né sa né crede possibile che sia stata fatta una difesa; scopre il proprio scudo, e ritiene cosa certa che lei cada a terra a causa del suo bagliore incantato. Avrebbe anche potuto scoprirlo subito, senza dover controllare le mosse dei cavalieri; ma gli piaceva stare a guardare qualche bel colpo dato con la lancia o dal roteare di una spada: così come si può vedere a volte che all’astuto gatto piace scherzare con il topo per piacere; e quando quel piacere gli va a noia, gli dà un morso ed alla fine lo vuole vedere morto. // Dico che il mago somigliava al gatto, e gli altri somigliavano al topo nelle precedenti battaglie; ma questa somiglianza non c’era stata quando, con l’anello, Bradamante si era fatta avanti per sfidarlo. Stava attenta e concentrata nel fare tutto ciò che era necessario affinché il mago non si potesse avvantaggiare nei suoi confronti; e non appena vide che il mago aveva scoperto lo scudo, chiuse subito gli occhi, e si lasciò cadere sul posto. // Non perché il forte bagliore generato dal lucido metallo le avesse fatto male, come era invece solito fare agli altri; ma si lasciò cadere così che da cavallo scendesse ed andasse verso di lei il mago, non efficace nell’occasione: nessuna parte del piano di lei andò storto; perché non appena Bradamante appoggiò a terra la propria testa, dopo aver aumentato il moto delle ali, il cavallo alato atterrò infine seguendo ampie spire.
Segue la narrazione dell’ippogrifo, di Atlante e dell’avversaria Bradamante (si ricordi, donna dalla cui discendenza nasceranno gli Estensi). Ciò che colpisce in questo brano è quasi il capovolgimento ludico a cui deve sottostare il lettore: gli si chiede infatti di porre l’attenzione su come sia vero ciò che è palesamente falso (l’ippogrifo) e come sia falso ciò che un comune uomo cinquecentesco ritiene vero (l’atteggiamento guerresco di sfida). Appare evidente quindi cosa s’intenda qui per edonismo: il puro gusto di un episodio avventuroso-fantastico; ma ciò non esime il nostro dall’esprimere “caratteristiche umane”: la voglia del mago d’andare a vedere, orgogliosamente, la sua ipotetica vittima, proprio come fa il gatto con il topo (abbassamento).

Il mago Atlante (tavola di LorCarmi – Fabrizio Carminati) (2018)
Una volta in terra Bradamante lo blocca, vorrebbe ucciderlo, ma vede che Atlante non è che un povero vecchio. Nonostante il mago le chieda di ucciderlo, lei non vi riesce, e gli domanda chi fosse e perché incantasse gli uomini. Così le viene risposto:
ATLANTE RIVELA LA VERITA’
(IV, 30-31)
Non vede il sol tra questo e il polo austrino
un giovene sì bello e sì prestante:
Ruggiero ha nome, il qual da piccolino
da me nutrito fu, ch’io sono Atlante.
Disio d’onore e suo fiero destino
l’han tratto in Francia dietro al re Agramante;
ed io, che l’amai sempre più che figlio,
lo cerco trar di Francia e di periglio.
La bella rocca solo edificai
per tenervi Ruggier sicuramente,
che preso fu da me, come sperai
che fossi oggi tu preso similmente;
e donne e cavallier, che tu vedrai,
poi ci ho ridotti, ed altra nobil gente,
acciò che quando a voglia sua non esca,
avendo compagnia, men gli rincresca.
In tutto il mondo, tra il nostro polo e quello australe, non esiste un altro giovane tanto bello e vigoroso: il suo nome è Ruggiero, e quando era ancora un bambino fu allevato da me, che mi chiamo Atlante. Il desidero di conquistare onore ed anche il suo crudele destino l’hanno convinto a seguire re Agramante sino in Francia; ed io, che l’ho sempre amato più di un figlio, faccio di tutto per allontanarlo dal pericolo e dalla Francia. // Ho costruito questa bella fortezza per mettervi al sicuro il cavaliere Ruggiero, che fu da me fatto prigioniero, allo stesso modo in cui sperai che tu fossi fatto oggi prigioniero; sia donne che cavalieri, come potrai vedere, vi ho rinchiuso, insieme a tanta altra nobile gente, così che anche se non può uscire quando vuole, avendo comunque compagnia, la prigionia non gli arrechi troppo dispiacere.
La capacità dell’Ariosto sta nel lasciare il lettore, insieme, in questo caso, alla protagonista, di fronte al dubbio: vi è in questo nemico che “ruba” uomini e donne, un profondo senso di bontà, il cui fine è quello di salvare Ruggiero da morte certa, o vi è un secondo fine, guidato da reconditi fini suggeriti dal re Saraceno? Fatto sta che Bradamante non gli crede e si dimostra ferma nel volere liberare il proprio amato, lega il mago e si avvia con lui verso il castello scalando la montagna. Giunti in cima Atlante spezza l’incantesimo, si libera da Bradamante e scompare insieme al castello. Tutti i suoi prigionieri, tra i quali re Gradasso, Sacripante e Ruggiero, vengono così a trovarsi liberi all’aria aperta. Bradamante e Ruggiero possono finalmente incontrarsi. Scendono poi tutti insieme a valle dove è l’ippogrifo di Atlante con al fianco lo scudo incantato. Cercano tutti di prendere il cavallo alato ma questo va incontro a Ruggiero. Il cavaliere gli sale in groppa credendo di poterlo condurre, ma il cavallo, per volontà del mago Atlante, prende il volo e scappa lontano con Ruggiero. Bradamante non può fare altro che vedere ancora una volta scomparire il proprio amante. La donna si allontana con Frontin, il cavallo di Ruggiero, intenzionata a restituirlo al legittimo proprietario.
Quindi si torna a Rinaldo, giunto in Scozia:
IL COMPITO D’UN CAVALIERE ERRANTE
(IV, 52-54)
Vanno per quella i cavallieri erranti,
incliti in arme, di tutta Bretagna,
e de’ prossimi luoghi e de’ distanti,
di Francia, di Norvegia e de Lamagna.
Chi non ha gran valor, non vada inanti;
che dove cerca onor, morte guadagna.
Gran cose in essa già fece Tristano,
Lancillotto, Galasso, Artù e Galvano,
ed altri cavallieri e de la nuova
e de la vecchia Tavola famosi:
restano ancor di più d’una lor pruova
li monumenti e li trofei pomposi.
L’arme Rinaldo e il suo Baiardo truova,
e tosto si fa por nei liti ombrosi,
ed al nochier comanda che si spicche
e lo vada aspettar a Beroicche.
Senza scudiero e senza compagnia
va il cavallier per quella selva immensa,
facendo or una ed or un’altra via,
dove più aver strane aventure pensa.
Capitò il primo giorno a una badia,
che buona parte del suo aver dispensa
in onorar nel suo cenobio adorno
le donne i cavallier che vanno attorno.
Vanno alla sua ricerca i cavalieri erranti, famosi nell’esercizio delle armi, di tutta la Bretagna, delle regioni vicine ed anche di quelle lontane, della Francia, della Norvegia e della Germania. Chi non ha un grande valore in questa arte, non proceda oltre; perché in quel luogo dove cerca l’onore, può trovare solo la morte. Lancillotto, Galasso, Artù e Galvano, // ed anche altri cavalieri famosi sia della nuova (di Artù) che della vecchia (del padre di Artù) Tavola Rotonda di più di una loro impresa sono ancora visibili monumenti ed i trofei sfarzosi. Rinaldo riprende le sue armi ed il suo cavallo Baiardo, e subito si fa lasciare sulle spiagge ombrose, ed al capitano della nave ordina di staccarsi dalla costa per andarlo ad aspettare a Berwick. // Senza scudiero al seguito e senza nessuna altra compagnia il cavaliere si avvia all’interno di quell’immenso bosco, seguendo ora uno ed ora un’altro sentiero, dove ritiene di poter avere maggiori probabilità di imbattersi in insolite avventure. Il primo giorno capitò presso una abbazia, che spende buona parte dei suoi averi per rendere onore, poi arriva nel suo bel monastero, alle donne ed ai cavalieri in viaggio per quei luoghi.

Evelyn: Ritratto di Rinaldo (per un pupo siciliano) (2017)
Passo di passaggio, ma al contempo fondamentale: viene qui mostrato il compito del cavaliere errante: cercare l’avventura. Ma se tale è il suo destino, esso costituirà un punto fermo per:
- essere il motore di una narrazione;
- riaffermare, laddove ce ne fosse bisogno, che il destino dell’uomo sta nella “quete”, nella ricerca.
Rinaldo chiede se ci siano imprese da compiere in quel territorio che possano dare fama ad un cavaliere. Gli viene risposto che la migliore impresa che può compiere consiste nell’andare in aiuto di Ginevra, figlia del re di Scozia, minacciata dal barone Lurcanio, che l’accusa di averla vista insieme ad un amante. Per questo motivo, la donna rischia la condanna al rogo se nessun cavaliere sarà disposto a combattere per lei, sostenendo la sua innocenza. Rinaldo decide quindi di combattere per la salvezza di Ginevra e, vinto il duello, il giorno dopo lascia il monastero insieme ad uno scudiero. Abbandonata la strada maestra per abbreviare il viaggio, i due sentono il pianto di una donna. Corrono in suo aiuto e vedono una donna, bellissima, nelle mani di due malviventi intenzionati a darle la morte. Alla vista di Rinaldo i due si mettono subito in fuga ed il cavaliere riesce così a salvarla.

Illustrazione della pagina che apre al V° canto in un’edizione della fine XV° secolo
Nel canto V si scopre che la donna è Dalinda, cameriera di Ginevra. Lei rivela di essersi innamorata del duca d’Albania, Polinesso, passando in sua compagnia notti di passione nella camera della sua padrona, quando lei non c’era.

Rinaldo e Dalinda
Ma il vero interesse del duca è per Ginevra e le aveva quindi chiesto di aiutarlo nei suoi intenti. Al fine di sposarla, goderne i ricchi frutti e mantenere la cameriera come amante. Tuttavia ciò non succede perché lei odia il duca ed è profondamente innamorata di un altro uomo, Ariodante, cavaliere tanto valoroso e già nelle grazie del re. Per lo scacco subito Polinesso ora vuole solo diffamare la donna. Fa vestire Dalinda come Ginevra e si mostra con lei per fare ingelosire Ariodante. Colui non crede che la figlia del re lo tradisca, ma il duca d’Albania gliene vuol dare la prova: quindi lo convince ad appostarsi fuori della stanza di Ginevra e quella sera, come richiesto a Dalinda, si fa accogliere dalla cameriera nelle sue vesti. Ariodante, accompagnato dal fratello Lucarnio, quindi vede la triste scena e per gelosia decide d’uccidersi. Il fratello cerca di dissuaderlo. Egli allora lascia la città, scrivendo il motivo a Ginevra, e, dopo pochi giorni si viene a sapere che si è ucciso gettandosi ad un dirupo. Ora è Lucarnio, che, spinto dall’ira e dal dolore, accusa apertamente Ginevra di essere stata la causa di quella morte e racconta quindi al re ciò che aveva visto quella notte: l’incontro amoroso di lei con un uomo a lui sconosciuto. Si dichiara quindi infine disposto a sostenere con le armi la propria accusa. La legge condanna al rogo una donna accusata di essersi unita con un uomo che non è suo marito, se entro un mese nessun cavaliere prende le sue difese contro l’accusatore. Ginevra è quindi in pericolo di morte.
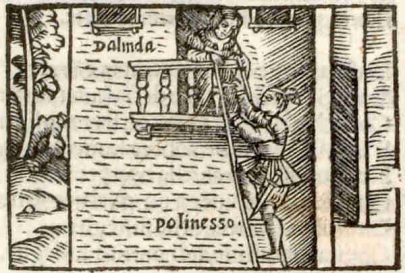
Dalinda e Polisseno
Dalinda, per paura che si venga a sapere la verità, scappa e corre ad informare Polinesso. Il duca d’Albania fingendo di volerla mettere al sicuro, decide però di farla uccidere, così da eliminare ogni testimone del suo inganno. L’arrivo di Rinaldo ha però messo in fuga i due assassini e l’ha salvata da morte certa. Rinaldo, che aveva già prima deciso di prendere le difese della donna, ora è ancora più convinto; corre verso la città e scopre che era da poco iniziato il combattimento tra Lucarnio ed un cavaliere sconosciuto, nascosto dal suo elmo, che aveva deciso di combattere per l’innocenza di Ginevra. Rinaldo giunge sul campo di battaglia, convince il re a fermare il combattimento in atto e rende quindi evidente a tutti ciò che era realmente accaduto. Per sostenere la propria accusa, sfida a duello Polinesso e lo sconfigge. Il duca d’Albania sul punto di morte confessa il proprio inganno. Il re chiede infine al cavaliere misterioso di mostrare la sua identità, per essere premiato per il proprio valore mostrato e per le proprie buone intenzioni.
Solo nel canto VI sapremo che il cavaliere misterioso è Ariodante, che sul punto di morte, si era pentito all’ultimo del proprio gesto e si era quindi messo in salvo a nuoto. Giunto in un ostello, aveva appreso della disperazione di Ginevra alla notizia della sua morte e delle pubbliche accuse del fratello. Spinto dal proprio amore per la donna e risentito per il gesto crudele del fratello, aveva così deciso di prendere lui le difese di Ginevra. Il re concede la mano della figlia al cavaliere, dando in regalo agli sposi il ducato di Albania, appena liberatosi. Dalinda ottiene la grazia e “per espiare” si farà monaca.
Ma il racconto torna a Ruggiero che con l’ippogrifo lascia l’Europa, passano le colonne d’Ercole per atterrare infine su un’isola meravigliosa.

Ruggiero sull’ippogrifo approda sull’isola di Alcina
ASTOLFO NELL’ISOLA DI ALCINA
(VI, 24-35)
E quivi appresso, ove surgea una fonte
cinta di cedri e di feconde palme,
pose lo scudo, e l’elmo da la fronte
si trasse, e disarmossi ambe le palme;
ed ora alla marina ed ora al monte
volgea la faccia all’aure fresche ed alme,
che l’alte cime con mormorii lieti
fan tremolar dei faggi e degli abeti.
Bagna talor ne la chiara onda e fresca
l’asciutte labra, e con le man diguazza,
acciò che de le vene il calor esca
che gli ha acceso il portar de la corazza.
Né maraviglia è già ch’ella gl’incresca;
che non è stato un far vedersi in piazza:
ma senza mai posar, d’arme guernito,
tremila miglia ognor correndo era ito.
Quivi stando, il destrier ch’avea lasciato
tra le più dense frasche alla fresca ombra,
per fuggir si rivolta, spaventato
di non so che, che dentro al bosco adombra:
e fa crollar sì il mirto ove è legato,
che de le frondi intorno il piè gli ingombra:
crollar fa il mirto, e fa cader la foglia;
né succede però che se ne scioglia.
Come ceppo talor, che le medolle
rare e vote abbia, e posto al fuoco sia,
poi che per gran calor quell’aria molle
resta consunta ch’in mezzo l’empìa,
dentro risuona e con strepito bolle
tanto che quel furor truovi la via;
così murmura e stride e si corruccia
quel mirto offeso, e al fine apre la buccia.
Onde con mesta e flebil voce uscìo
espedita e chiarissima favella,
e disse: «Se tu sei cortese e pio,
come dimostri alla presenza bella,
lieva questo animal da l’arbor mio:
basti che ’l mio mal proprio mi flagella,
senza altra pena, senza altro dolore
ch’a tormentarmi ancor venga di fuore».
Al primo suon di quella voce torse
Ruggiero il viso, e subito levosse;
e poi ch’uscir da l’arbore s’accorse,
stupefatto restò più che mai fosse.
A levarne il destrier subito corse;
e con le guance di vergogna rosse:
«Qual che tu sii, perdonami (dicea),
o spirto umano, o boschereccia dea.
Il non aver saputo che s’asconda
m’ha lasciato turbar la bella fronda
e far ingiuria al tuo vivace mirto:
ma non restar però, che non risponda
chi tu ti sia, ch’in corpo orrido ed irto,
con voce e razionale anima vivi;
se da grandine il ciel sempre ti schivi.
E s’ora o mai potrò questo dispetto
con alcun beneficio compensarte,
per quella bella donna ti prometto,
quella che di me tien la miglior parte,
ch’io farò con parole e con effetto,
ch’avrai giusta cagion di me lodarte».
Come Ruggiero al suo parlar fin diede,
tremò quel mirto da la cima al piede.
Poi si vide sudar su per la scorza,
come legno dal bosco allora tratto,
che del fuoco venir sente la forza,
poscia ch’invano ogni ripar gli ha fatto;
e cominciò: «Tua cortesia mi sforza
a discoprirti in un medesmo tratto
ch’io fossi prima, e chi converso m’aggia
in questo mirto in su l’amena spiaggia.
Il nome mio fu Astolfo; e paladino
era di Francia, assai temuto in guerra:
d’Orlando e di Rinaldo era cugino,
la cui fama alcun termine non serra;
e si spettava a me tutto il domìno,
dopo il mio padre Oton, de l’Inghilterra.
Leggiadro e bel fui sì, che di me accesi
più d’una donna: e al fin me solo offesi.
Ritornando io da quelle isole estreme
che da Levante il mar Indico lava,
dopo Rinaldo ed alcun’altri insieme
meco fur chiusi in parte oscura e cava,
ed onde liberati le supreme
forze n’avean del cavallier di Brava;
ver ponente io venìa lungo la sabbia
che del settentrion sente la rabbia.
E come la via nostra e il duro e fello
destin ci trasse, uscimmo una matina
sopra la bella spiaggia, ove un castello
siede sul mar, de la possente Alcina.
Trovammo lei ch’uscita era di quello,
e stava sola in ripa alla marina;
e senza rete e senza amo traea
tutti li pesci al lito, che volea.

Giuseppe Cades: Ruggiero e il mirto
E vicino a quel luogo, là dove sgorgava una fonte circondata da cedri e da palme ricche di frutti, depone il suo scudo, si toglie l’elmo dalla fronte, e disarma infine entrambe le mani (si toglie i guanti di ferro); e ora verso il mare ed ora verso il monte rivolge la faccia ai venticelli freschi e vivificatrici che, con dolci mormorii, fanno vibrare le alte cime dei faggi e degli abeti. // Si bagna a volte nell’acqua fresca e trasparente della fonte le sue labbra asciutte, ed agita in acqua le sue mani per fare in modo che dalle sue vene se ne vada quel calore che gli provoca il portare ancora la corazza. Non c’è da meravigliarsi che la corazza gli dia fastidio; dal momento che il viaggio non è stato certo una passeggiata in piazza: al contrario, completamente armato, senza mai fermarsi, ha percorso tremila miglia senza mai rallentare. // Mentre sta lì, alla fonte, il destriero che ha lasciato alla fresca ombra dove la boscaglia è più fitta, si ribella per riuscire a fuggire, spaventato da non so che cosa, che dentro al bosco lo atterrisce: e fa così crollare il mirto al quale era stato legato, che gli ostruisce le zampe con i rami caduti in terra: fa crollare il mirto e fa cadere anche le sue foglie; senza però riuscire a liberarsi dall’albero. // Come a volte fa il ceppo, che ha la parte più interna meno densa e vuota, quando viene messo sul fuoco, dopo che per il grande calore l’aria più umida che riempiva la sua parte centrale viene consumata, (il ceppo) emette suoni dal suo interno, e ribolle con strepitii fintanto che quell’aria ardente non trova la via per uscire; allo stesso modo emette mormorii e stride e si lamenta quella pianta di mirto lesionata, ed infine si lacera la sua corteccia. // Dalla lacerazione con una triste e lamentosa voce escono chiare e fluenti parole, e dice: «Se tu sei gentile e pietoso, come può dimostrare la tua bella presenza, togli questo animale dal mio albero: può ben bastare che mi faccia soffrire il mio proprio male, senza un’altra pena, senza un altro dolore che venga a tormentarmi dall’esterno». // Al sentire il primo suono di quella voce Ruggiero piega il viso verso l’albero e subito si alza in piedi; e dopo essersi accorto che viene proprio dall’albero, resta più sorpreso di quanto fosse mai stato in vita sua. Corre subito a togliere il destriero da in mezzo ai rami; e con le guance rosse di vergogna dice: «Qualunque cosa tu sia, perdonami sia tu uno spirito umano o una ninfa dei boschi. Il non aver saputo che si nascondeva uno spirito umano sotto una ruvida corteccia, mi ha lasciato danneggiare la bella chioma e arrecare danno al tuo vivo mirto: ma non fare però che tu non mi faccia sapere chi tu sia, che in un corpo ispido e pungente, vivi con una voce ed una anima razionale; possa sempre il cielo proteggerti dalla grandine. // E se adesso o se per caso in futuro potrò a questo mio torto porre rimedio con qualche atto benefico, ti prometto sul nome di quella bella donna (Bradamante), quella che possiede la mia parte migliore, la mia anima, che con le parole e con i fatti io farò sì che potrai poi avere una buona ragione per essere soddisfatto di me». Non appena Ruggiero pone fine al suo discorso, il mirto trema dalla sua cima fino alle radici. // Si può poi vedere che il mirto lacrima da tutta la sua corteccia, come fa un pezzo di legno appena tagliato dal bosco, quindi ancora verde, quando sente arrivare la forza del fuoco, dopo che invano ha cercato di porre resistenza; e comincia a dire: «La tua gentilezza mi costringe a rivelarti allo stesso tempo chi sono stato prima, quando ero uomo, e chi mi ha trasformato poi in questa pianta di mirto su questa piacevole spiaggia. // Il mio nome era Astolfo; ed ero un paladino della Francia molto temuto in guerra: ero cugino di Orlando e di Rinaldo, la fama dei quali non ha confini in tutto il mondo; e sarebbe spettato a me tutto il dominio dell’Inghilterra, dopo la morte di mio padre Oton. Ero talmente bello e grazioso, da fare innamorare di me più di una donna; ma alla fine la mia bellezza danneggiò solo me stesso. // Durante il viaggio di ritorno dalle Isole Lontane, situate a Levante e bagnate dall’Oceano Indiano, là dove Rinaldo ed alcuni altri insieme a me erano stati fatti prigionieri in una caverna buia, dalla quale fummo poi liberati dalla suprema forza del cavaliere Orlando; stavo navigando verso ponente, lungo le coste di mare che sentono la rabbia della tramontana, del vento freddo da Nord. // E come il nostro tragitto ed il duro ed avverso destino vollero condurci, ci ritrovammo così una mattina sopra la bella spiaggia dove un castello sorge a ridosso del mare, il castello della potente maga Alcina. Trovammo lei in persona che era uscita da quella sua dimora e stava tutta sola in riva al mare; e senza usare nessuna rete o amo, tirava a riva tutti i pesci del mare che voleva».

Giolito: Astolfo sull’ippogrifo tenta di fuggire dai mostri di Alcina (1554)
E’ evidente il duplice richiamo: dapprima al Palinuro virgiliano, quindi al Pier delle Vigne dantesco (che a Virgilio si rifà). Il classicismo rinascimentale ariostesco abbraccia tutta la letteratura precedente, da quella latina a quella italiana. Eppure vi è un elemento che fa di questa reminiscenza un qualcosa di completamente nuovo: la leggerezza dell’ottava. Il passo infatti non si carica di valenze sacrali, ma si svolge in un mondo favolistico, dove la cortesia fa da contorno ad un episodio dipinto con colori pastello.
Vista la bellezza di Astolfo, Alcina decide di farlo prigioniero. Con una scusa, lo fa salire con sé su una balena e lo rapisce. Rinaldo pur tuffandosi in mare non riesce a raggiungerlo, mentre i due, sul dorso della balena, finiscono infine sull’isola meravigliosa. Questa in realtà era stata lasciata in eredità a sua sorella Logistilla, ma le due sorellastre, Morgana ed Alcina, appunto, si sono alleate per sottrarle ogni avere; lei possiede ora solo una piccola parte dell’isola, e solo perché è un territorio irraggiungibile. Alcina arde d’amore per Astolfo ed il cavaliere ricambiava il sentimento, essendo lei molto bella e tanto premurosa nei suoi riguardi. Completamente si perdono nei piaceri dimenticando ogni altra cosa. Un giorno però lei rivolge improvvisamente il proprio cuore altrove, caccia Astolfo e lui scopre che nella sua stessa situazione ci sono altri mille amanti, trasformati in alberi, animali, fonti… per evitare che vadano in giro per il mondo a raccontare le abitudini della maga. Astolfo avverte quindi Ruggiero del pericolo che potrebbe correre. Ruggiero conosceva già Astolfo di nome, in quanto cugino di Bradamante e decide pertanto di aiutarlo. Astolfo gli indica la via per raggiungere il regno di Logistilla senza passare da quello di Alcina. Lo avverte però che la maga malvagia ha messo a guardia del sentiero un gruppo di suoi guerrieri dall’aspetto mostruoso. Ruggiero riprende il cavallo alato, senza salirgli in groppa per paura di dover ancora volare contro la propria volontà, e si mette in cammino. Raggiunge poco dopo la fortezza di Alcina e si dirige poi verso il monte in cima al quale si trovava il regno di Logistilla. Il suo cammino viene però interrotto dai guerrieri: esseri metà animali e metà uomini, metà uomini e metà donne, a cavallo di animali di ogni genere e con ogni tipo di arma in pugno. Ruggiero sguaina la spada e si lancia tra di loro, ma sono troppi, è accerchiato; escono allora dalla città di Alcina due bellissime donne in groppa a due unicorni. Costretto ad entrare nella fortezza, lui vi trova una bellissima festa amorosa, tanto che si può ritenere essere il posto dove sia nato Amore. Quindi gli viene dato un cavallo sul quale poter salire, mentre l’ippogrifo viene consegnato ad un giovane, che lo segue a piedi. Le due donne chiedono aiuto al cavaliere per sconfiggere la gigante Erifile, che sta a guardia di un ponte ed impedisce il suo attraversamento. Ruggiero dice loro di essere completamente al loro servizio, qualunque sia il loro desiderio.
Il VII canto si apre con la sconfitta che Ruggiero imprime ad Erifile. Quindi, liberato il sentiero, viene accolto da Alcina:
ALCINA
(VII, 9- 18)
La bella Alcina venne un pezzo inante,
verso Ruggier fuor de le prime porte,
e lo raccolse in signoril sembiante,
in mezzo bella ed onorata corte.
Da tutti gli altri tanto onore e tante
riverenze fur fatte al guerrier forte,
che non potrian far più, se tra loro
fosse Dio sceso dal superno coro.
Non tanto il bel palazzo era eccellente,
perché vincesse ogn’altro di ricchezza,
quanto ch’avea la più piacevol gente
che fosse al mondo e di più gentilezza.
Poco era l’un da l’altro differente
e di fiorita etade e di bellezza:
sola di tutti Alcina era più bella,
sì come è bello il sol più d’ogni stella.
Di persona era tanto ben formata,
quanto me’ finger san pittori industri;
con bionda chioma lunga ed annodata:
oro non è che più risplenda e lustri.
Spargeasi per la guancia delicata
misto color di rose e di ligustri;
di terso avorio era la fronte lieta,
che lo spazio finia con giusta meta.
Sotto duo negri e sottilissimi archi
son duo negri occhi, anzi duo chiari soli,
pietosi a riguardare, a mover parchi;
intorno cui par ch’Amor scherzi e voli,
e ch’indi tutta la faretra scarchi
e che visibilmente i cori involi:
quindi il naso per mezzo il viso scende,
che non truova l’invidia ove l’emende.
Sotto quel sta, quasi fra due vallette,
la bocca sparsa di natio cinabro;
quivi due filze son di perle elette,
che chiude ed apre un bello e dolce labro:
quindi escon le cortesi parolette
da render molle ogni cor rozzo e scabro;
quivi si forma quel suave riso,
ch’apre a sua posta in terra il paradiso.
Bianca nieve è il bel collo, e ’l petto latte;
il collo è tondo, il petto colmo e largo:
due pome acerbe, e pur d’avorio fatte,
vengono e van come onda al primo margo,
quando piacevole aura il mar combatte.
Non potria l’altre parti veder Argo:
ben si può giudicar che corrisponde
a quel ch’appar di fuor quel che s’asconde.
Mostran le braccia sua misura giusta;
e la candida man spesso si vede
lunghetta alquanto e di larghezza angusta,
dove né nodo appar, né vena eccede.
Si vede al fin de la persona augusta
il breve, asciutto e ritondetto piede.
Gli angelici sembianti nati in cielo
non si ponno celar sotto alcun velo.
Avea in ogni sua parte un laccio teso,
o parli o rida o canti o passo muova:
né maraviglia è se Ruggier n’è preso,
poi che tanto benigna se la truova.
Quel che di lei già avea dal mirto inteso,
com’è perfida e ria, poco gli giova;
ch’inganno o tradimento non gli è aviso
che possa star con sì soave riso.
Anzi pur creder vuol che da costei
fosse converso Astolfo in su l’arena
per li suoi portamenti ingrati e rei,
e sia degno di questa e di più pena:
e tutto quel ch’udito avea di lei,
stima esser falso; e che vendetta mena,
e mena astio ed invidia quel dolente
a lei biasmare, e che del tutto mente.
La bella donna che cotanto amava,
novellamente gli è dal cor partita;
che per incanto Alcina gli lo lava
d’ogni antica amorosa sua ferita;
e di sé sola e del suo amor lo grava,
e in quello essa riman sola sculpita:
sì che scusar il buon Ruggier si deve,
se si mostrò quivi incostante e lieve.
 Niccolò dell’Abate, Ruggiero e Alcina
Niccolò dell’Abate, Ruggiero e Alcina
La bella Alcina viene avanti, per un pezzo di strada, fuori dalle prime porte d’ingresso del palazzo, verso Ruggiero, e lo accoglie, con modi signorili, in mezzo ad una corte bella e stimabile. Da tutti gli altri, sono fatte al forte guerriero tanti onori e tante reverenze, che non si potrebbero fare di più se fosse disceso Dio direttamente dal Paradiso. // Il bel palazzo è tanto superiore agli altri non perché non ha pari per ricchezza, quanto perché è abitato dalle persone più piacevoli, e con i modi più gentili, che ci potessero essere al mondo. Ogni persona è poco differente dall’altra sia per la giovane età che per bellezza: solo Alcina supera gli altri per bellezza, così come il sole è più bello di ogni altra stella. // La sua persona è tanto bene formata, quanto meglio sanno fare i più abili pittori; con una bionda chioma lunga ed annodata: non c’è oro che risplenda di più e sia più lucente. Si diffonde lungo la sua delicata guancia un misto di colore di rose e di ligustri; simile a limpido avorio è la sua lieta fronte, che si estende entro giusti limiti. // Sotto due neri e sottilissimi archi si trovano due occhi neri, anzi due chiari soli, benevoli nel guardare, lenti nel muoversi; intorno ai quali sembra che voli e giochi il dio Amore, che da lì scagli tutte le sue frecce e che in modo chiaro i cuori rubi: da qui il naso scende attraverso il viso, sul quale nemmeno l’invidia potrebbe trovare un difetto. // Sotto al naso si trova, tra due piccole fossette, la bocca cosparsa di un rosso naturale; qui stanno due file di perle rare, che un bello e dolce labbro apre e chiude: da qui escono dolci e cortesi parole tali da rendere molle, ingentilire, ogni cuore rozzo e ruvido; qui si forma quel dolce sorriso, che apre a suo piacere il Paradiso in terra. // Neve bianca è il suo bel collo, il petto è latte; il collo è tondo, il petto largo e bene riempito: due seni piccoli e sodi, fatti come d’avorio, vengono e vanno con il suo respiro come onde sul margine estremo della spiaggia, quando un piacevole venticello percuote il mare. Neppure Argo, con i suoi cento occhi, potrebbe vedere le altri parti del suo corpo: si può a buon ragione ritenere che ciò che rimane nascosto corrisponda a quello che si può ammirare dal fuori. // Le braccia mostrano la loro giusta lunghezza; e la bianca mano spesso appare alquanto lunga ed affusolata, sulla quale non compare nessun nodo, né alcuna vena sporge. Si vede alla fine della maestosa persona il piccolo piede, asciutto ma ben rotondo. Coloro, nati in cielo, che hanno aspetto angelico non possono essere nascosti sotto nessun velo. // Ogni sua parte del corpo era una laccio teso per catturare gli amanti, sia che parli o rida o canti o muova passi: non c’è quindi da meravigliarsi se Ruggiero fu preso in trappola, trovandola così tanto buona nei propri confronti. Quello che riguardo a lei aveva appreso dal mirto (nel quale Astolfo è stato trasformato), di come fosse perfida e crudele, a poco gli serve; dal momento che non gli sembra possibile che l’inganno ed il tradimento possa convivere con un così gioioso sorriso. // Anzi vuole anche credere che da costei Astolfo fosse stato trasformato in mirto, in riva al mare, a causa del suo comportamento ingrato e malvagio, e che fosse stato degno di questa ed anche di più grave pena: e tutto ciò che riguardo a lei aveva udito, ritiene ora essere falso; e che sono il desiderio di vendetta, l’invidia e l’astio nei confronti di lei, a spingere quell’infelice Astolfo, a rimproverarla, e che quindi lui mente su ogni cosa. // La bella donna, Bradamante, che Ruggiero così tanto amava, all’improvviso non trova più posto nel suo cuore; poiché per incantesimo Alcina gli purifica il cuore da ogni antica ferita d’Amore; e lo occupa solo con il pensiero di se stessa e dell’Amore nei suoi confronti, e rimane in quel cuore impressa solo lei: tanto che Ruggiero si deve scusare per essere stato in quell’occasione incostante e leggero.
E’ questo uno dei passi più famosi del poema, che si figura, allegoricamente, come un processo iniziatico, da cui si uscirà fortificati e con maggior saggezza. Precedentemente abbiamo visto come, egli, con l’ippogrifo, sia giunto nell’isola. Possiamo anche dire che, in questo caso, il cavallo alato, metafora di un sogno, l’abbia condotto in un giardino di delizie (sessuali), anch’esse idealizzate in un mondo onirico. Infatti, non manca nessuna forma di piacere in quella corte e già dalla prima sera i due vengono travolti dalla passione amorosa. Bradamante, disperata per aver nuovamente perso il proprio amante, vaga alla ricerca di Ruggiero:
BRADAMANTE ALLA RICERCA
(VII, 33-41)
Con questa intenzion prese il camino
verso le selve prossime a Pontiero,
dove la vocal tomba di Merlino
era nascosa in loco alpestro e fiero.
Ma quella maga che sempre vicino
tenuto a Bradamante avea il pensiero,
quella, dico io, che ne la bella grotta
l’avea de la sua stirpe istrutta e dotta;
quella benigna e saggia incantatrice,
la quale ha sempre cura di costei,
sappiendo ch’esser de’ progenitrice
d’uomini invitti, anzi di semidei;
ciascun dì vuol sapere che fa, che dice,
e getta ciascun dì sorte per lei.
Di Ruggier liberato e poi perduto,
e dove in India andò, tutto ha saputo.
Ben veduto l’avea su quel cavallo
che regger non potea, ch’era sfrenato,
scostarsi di lunghissimo intervallo
per sentier periglioso e non usato;
e ben sapea che stava in giuoco e in ballo
e in cibo e in ozio molle e delicato,
né più memoria avea del suo signore,
né de la donna sua, né del suo onore.
E così il fior de li begli anni suoi
in lunga inerzia aver potria consunto
sì gentil cavallier, per dover poi
perdere il corpo e l’anima in un punto;
e quel odor che sol riman di noi,
poscia che ’l resto fragile è defunto,
che tra’ l’uom del sepulcro e in vita il serba,
gli saria stato o tronco o svelto in erba.
Con questa intenzione Bradamante intraprese il cammino verso le foreste vicine a Pontiero, feudo dei Maganza, là dove la tomba parlante di Merlino stava nascosta in un luogo montuoso e selvaggio. Ma quella maga, Melissa, che sempre vicino a Bradamante aveva tenuto il proprio pensiero, quella, mi riferisco a lei, che nella bella grotta l’aveva istruita e messa a conoscenza della sua stirpe; // quella buona e saggia incantatrice, la quale ha sempre avuto cura di costei, sapendo che sarebbe stata progenitrice di uomini vittoriosi, anzi, di semidei; (riprende l’elemento encomiastico) ogni giorno vuole sapere che cosa stia facendo, che cosa dica, ed ogni giorno fa incantesimi per sapere presente e futuro di lei, di Ruggiero liberato e poi smarrito, e del luogo in India dove si è recato, ha saputo tutto. // L’aveva visto molto bene su quel cavallo che non poteva guidare, non ubbidendo al freno, allontanarsi per una così grande distanza lungo un sentiero pericoloso e mai battuto, per la via dell’aria; e molto bene sapeva anche che si trovava ora preso da giochi, balli, dal cibo e dal morbido e delicato ozio, senza avere più memoria del proprio signore, né della sua donna amata, né del proprio onore. // Ed in questo modo, il fiore dei più bei anni della sua vita, il meglio della sua giovinezza, avrebbe potuto consumare nella lunga inerzia, nella lunga inattività, un così gentile cavaliere, per dover poi perdere il proprio corpo e la propria anima, trasformato in pianta, ad un certo punto; e quel buon nome, che solo rimane di noi dopo che tutto il resto, più fragile, è ormai defunto, che toglie l’uomo dal sepolcro e lo mantiene in vita, gli sarebbe stato o troncato o divelto come erba.
 «Coppa con Bradamante», maiolica di Castel Durante, 1525-1530, Sèvres, Cité de la Céramique
«Coppa con Bradamante», maiolica di Castel Durante, 1525-1530, Sèvres, Cité de la Céramique
Infatti Bradamante, nella continuazione allegorica, rappresenta la coscienza fatta tacere da Ruggiero, per lasciar libero il sogno, come appare nella prima stanza dei versi seguenti:
MELISSA E L’ANELLO MAGICO
(VII, 46-52)
La giovane riman presso che morta,
quando ode che ’l suo amante è così lunge;
e più, che nel suo amor periglio porta,
se gran rimedio e subito non giunge:
ma la benigna maga la conforta,
e presta pon l’impiastro ove il duol punge,
e le promette e giura, in pochi giorni
far che Ruggiero a riveder lei torni.
«Da che, donna – (dicea) – l’annello hai teco,
che val contra ogni magico fattura,
io non ho dubbio alcun, che s’io l’arreco
là dove Alcina ogni tuo ben ti fura,
ch’io non le rompa il suo disegno, e meco
non ti rimeni la tua dolce cura.
Me n’andrò questa sera alla prim’ora,
e sarò in India al nascer de l’aurora».
E seguitando, del modo narrolle
che disegnato avea d’adoperarlo,
per trar del regno effeminato e molle
il caro amante, e in Francia rimenarlo.
Bradamante l’annel del dito tolle;
né solamente avria voluto darlo,
ma dato il core e dato avria la vita,
pur che n’avesse il suo Ruggiero aita.
Le dà l’annello e se le raccomanda;
e più le raccomanda il suo Ruggiero,
a cui per lei mille saluti manda:
poi prese ver Provenza altro sentiero.
Andò l’incantatrice a un’altra banda;
e per porre in effetto il suo pensiero,
un palafren fece apparir la sera,
ch’avea un piè rosso, e ogn’altra parte nera.
Credo fosse un Alchino o un Farfarello,
che da l’Inferno in quella forma trasse;
e scinta e scalza montò sopra a quello,
a chiome sciolte e orribilmente passe:
ma ben di dito si levò l’annello,
perché gl’incanti suoi non le vietasse.
Poi con tal fretta andò, che la matina
si ritrovò ne l’isola d’Alcina.
Quivi mirabilmente transmutosse
s’accrebbe più d’un palmo di statura,
e fe’ le membra a proporzion più grosse;
e restò a punto di quella misura
che si pensò che ’l negromante fosse,
quel che nutrì Ruggier con sì gran cura.
Vestì di lunga barba le mascelle,
e fe’crespa la fronte e l’altra pelle.
Di faccia, di parole e di sembiante
sì lo seppe imitar, che totalmente
potea parer l’incantator Atlante.
Poi si nascose, e tanto pose mente,
che da Ruggiero allontanar l’amante
Alcina vide un giorno finalmente:
e fu gran sorte; che di stare o d’ire
senza esso un’ora potea mal patire.

Bradamante dà l’anello magico a Melissa
La giovane rimane quasi morta, le viene quasi un colpo, quando si sente dire che il suo amante è così lontano da lei; ed ancora di più ascoltando che il suo amore si trova in pericolo, se non dovesse arrivare un rimedio efficace e rapido: ma la benigna maga la conforta, e subito pone il medicamento là dove serve, dove il dolore è pungente, e le promette e le giura, in pochi giorni, di riuscire a fare in modo che Ruggiero possa tornare a guardarla. // Disse la maga: «Dal momento che, donna, hai con te l’anello magico, che si oppone ad ogni possibile incantesimo, rendendolo vano, io non ho nessun dubbio che se io lo portassi là, dove Alcina ti sottrae ogni tuo bene, potrei rendere vano ogni sua intenzione, e con me potrei riportare indietro l’uomo amato per cui tanto ti affanni. Partirò questa sera alla prima ora della notte, e sarò in India al sorgere del sole». // E proseguendo, le raccontò il modo in cui aveva pensato di adoperare quell’anello, per sottrarre al regno effeminato e molle di Alcina il caro amante, e ricondurlo in Francia. Bramante si sfilò quindi l’anello dal dito; avrebbe voluto dare non solo quello, ma avrebbe dato anche il proprio cuore e la propria vita se solo avessero potuto essere d’aiuto a Ruggiero. // Le dà l’anello magico e le si raccomanda; ma più le affida la protezione del suo Ruggiero, al quale tramite lei manda mille saluti: infine prese un sentiero verso la Provenza. La maga proseguì lungo un’altra direzione; e per poter mettere in pratica le proprie intenzioni, alla sera fece apparire un destriero che aveva un piede rosso ed ogni altra parte del corpo nera, simile ad un demonio. // Credo fosse un diavolo Alchino o Fanfarello, (nomi usati da Dante nell’Inferno) che dall’inferno fu evocato sulla terra sotto quelle sembianze; e poco vestita e scalza montò sopra a quel cavallo, con i capelli sciolti ed orribilmente sparsi: ma si levò a buon ragione l’anello dal dito, così che non potesse annullare i propri incantesimi. Dopo di che partì con una tale fretta, che la mattina seguente si trovò sull’isola di Alcina. // Giunta lì si trasformò in maniera incredibile: crebbe più di un palmo in altezza, e l’intero corpo si fece più grosso in proporzione alla nuova altezza e si portò giusta giusta in quella misura che si poteva credere fosse il mago Atlante, colui che aveva nutrito Ruggiero con così tanta cura. Vestì la mascella con una lunga barba e rese rugosa la fronte e tutte le altre parti del corpo. // In faccia, nel parlare e nelle sembianza lo seppe tanto imitare, riprodurre, che per ogni suo aspetto poteva sembrare l’incantatore Atlante. Quindi si nascose e rimase a studiare a lungo la situazione, fino a che da Ruggiero vide finalmente un giorno allontanarsi l’amante Alcina: e fu una grande fortuna; perché di stare o di andare in giro senza di lui, anche per una sola ora, era per lei difficile da sopportare.
Quindi, per chiudere la rappresentazione allegorica, non ci rimane che la ratio, nelle vesti di Melissa e del suo mezzo, che, proprio attraverso l’anello fatato gli mostra la realtà. Anche qui Ariosto non cessa di giocare con i lettori: che la magia sveli la realtà è uno splendido ossimoro, ma è anche una profonda convinzione umanistico-rinascimentale (si pensi alla fortuna che in questo tempo ebbe l’alchimia, sebbene un po’ ironizzata da Ariosto).
Continuando il racconto della vicenda, Melissa trova il paladino totalmente mutato in abitudini; ha abbandonato ogni arma ed è completamente vestito, acconciato ed adornato come fosse una donna. Melissa, nelle sembianze di Atlante, lo rimprovera aspramente per avere dimenticato tutti i suoi insegnamenti, che avrebbero dovuto portarlo a compiere gloriose imprese e non a trascorrere una vita molle nell’ozio. Gli consegna quindi l’anello magico, e lo invita ad andare da Alcina per vedere in quale inganno sia caduto. Il paladino si infila l’anello al dito, gli incantesimi di Alcina svaniscono: la donna appare finalmente a Ruggiero nel suo aspetto reale: una orribile vecchia. Come suggeritogli, il cavaliere dapprima non fa trasparire il proprio disgusto ed il proprio odio e mette in atto il piano di fuga consigliato dalla maga. Fingendo di voler solo vedere se con le proprie armi indosso può risultare ancora più bello agli occhi di Alcina, si rimette l’armatura, prende la propria spada Balisarda e lo scudo incantato di Atlante. Va quindi nella stalla, monta su Rabican, il velocissimo cavallo appartenuto ad Astolfo, e scappa dal castello e si lancia poi al galoppo in direzione del regno di Logistilla (quindi come un piccolo romanzo di formazione, dopo il sogno, più maturo e consapevole, affronta di nuovo la realtà).
Nell’VIII canto vediamo Alcina raccogliere tutta la sua gente intorno a sé e partire alla ricerca di Ruggiero sia per terra che per mare. Lei, presa dal desiderio di catturarlo, si unisce a questa gente e lascia così la propria città incustodita. Quindi vi giunge Melissa che riesce ad annullare con comodo tutti gli incantesimi della maga e tutti gli amanti trasformati in varie forme che così tornano ad essere come erano e, con Ruggiero, si mettono in salvo nel regno di Logistilla, per tornare quindi ai rispettivi paesi di origine. Melissa libera anche il paladino Astolfo, gli fa montare l’ippogrifo e lo fa volare in salvo. Infine si reca anch’essa da Logistilla.

Filippo Pistrucci: Melissa libera i soldati dall’incantesimo di Alcina
(illustrazione del XIX sec.)
Cambiando completamente scena, vediamo Rinaldo chiedere aiuto al re di Scozia e al principe di Galles per il re Carlo assediato a Parigi. Spostandoci di nuovo ci troviamo invece davanti all’eremita, che aveva aiutato Angelica ad allontanare Rinaldo e Sacripante (vedi canto II). Colpito dalla bellezza di lei, l’eremita cerca di trattenerla, ma la donna fugge; allora evoca un demone che prende possesso del cavallo di Angelica, mentre l’uomo la segue da lontano. Giunta sulle rive dell’Oceano Atlantico, il demone spinge il cavallo in mare aperto verso nord, senza che Angelica possa fare nulla per fermarlo. Quando è sera l’animale e la donna raggiungono una spiaggia deserta e spaventosa. L’eremita, che aveva già raggiunto questo luogo grazie ad un altro demonio, compare improvvisamente e, ingannando Angelica, la fa cadere addormentata. Tenterà di abusare di lei, ma a causa dell’età finirà solo per addormentarsi al suo fianco.

Paul e Gaetan Brizzi: Angelica e l’eremita
Nel mare del nord, oltre l’Irlanda, si trova l’isola di Ebuda. In un tempo passato, il re dell’isola aveva una figlia tanto bella da fare innamorare di sé il dio marino Proteo, che trovandola un giorno da sola, l’aveva quindi posseduta ed ingravidata. Il re, uomo crudele, non perdonò il gesto alla figlia e la decapitò subito, facendo quindi morire anche il nipote prima che potesse nascere. Proteo, colmo d’ira, infrange le regole della natura e manda sulla terra ferma tutte le creature marine, a seminare distruzione e a tenere d’assedio gli abitanti dell’isola. Per placarlo bisogna offrire al dio una donna che, quando verrà reputata di pari bellezza della donna uccisa, farà terminare l’ira del dio contro gli uomini. Da allora ogni giorno una bella donna viene portata sulla spiaggia e finisce mangiata da un’orca, tanto che gli abitanti di Ebuda hanno cominciato a rapire le donne delle vicine isole, per salvare le proprie mogli. Ed è per questo che Angelica viene fatta prigioniera e messa insieme alle altre donne destinate al sacrificio.

Gustave Doré: Proteo rapisce una fanciulla
Orlando (che appare qui per la prima volta) viene tormentato la notte dal pensiero di Angelica, della quale non aveva avuto più notizie. Si dispera tutto il tempo finché una voce misteriosa gli dice di non sperare di poterla ancora rivedere e lo fa svegliare tra le lacrime. Temendo che Angelica sia in pericolo, appena sveglio si mette l’armatura, monta su Brigliadoro ed a mezzanotte parte alla sua ricerca. Il re Carlo, accortosi della sua lontananza, è molto adirato. Un caro compagno di Orlando, senza dire nulla a nessuno, nemmeno alla sua donna Fiordiligi, parte all’inseguimento dell’amico: ma non tornerà subito, tanto che la stessa Fiordiligi partirà alla sua ricerca.
Il canto IX inizia con il paladino che cerca tracce della donna amata in ogni luogo possibile. Arrivato un giorno sulla riva del fiume Quesnon, per attraversarlo chiede aiuto ad una ragazza al comando di una imbarcazione. La donna in cambio del favore chiede però ad Orlando di unirsi all’esercito che sta allestendo il re d’Irlanda, per muovere guerra agli abitanti dell’isola di Ebuda, e porre quindi fine ai loro saccheggi ed al rapimento delle donne più belle, che vengono ogni giorno sacrificate da quel popolo ad una orca. Orlando accetta subito, sia perché è contrario ad ogni ingiustizia, sia perché crede che anche Angelica sia stata fatta da loro prigioniera, visto che non era riuscito a trovarla in nessuno luogo. Quindi già il giorno seguente si imbarca per l’isola, ma non la raggiunge perché un vento impetuoso lo riporta subito indietro fino ad Anversa. Qui, Orlando sbarca e viene accolto da un vecchio che lo invita a dare il proprio aiuto ad una donna in difficoltà. La donna, di nome Olimpia, vestita a lutto e piena di dolore, racconta al conte Orlando la propria storia. Figlia del conte d’Olanda, si era innamorata del duca Bireno, che era poi dovuto andare in Spagna per prendere parte alla guerra contro gli arabi. Il re di Frisia, Cimosco, aveva deciso di farla sposare con il proprio figlio Arbante, e ne chiede quindi la mano. La donna, per non venire meno all’amore ed alla parola data, risponde però di preferire la morte, ed il re di Frisia, in tutta risposta, invade l’Olanda ed uccide in guerra tutti i familiari di Olimpia. Cimosco possiede infatti un’arma avveniristica, un archibugio (un’arma da fuoco), e non esiste avversario che possa competere con lui.
 Ruprecht Heller: Particolare della battaglia di Pavia del 1525, combattenti con in mano gli archibugi
Ruprecht Heller: Particolare della battaglia di Pavia del 1525, combattenti con in mano gli archibugi
IL MALEDETTO ORDIGNO
(IX, 27-31)
Il mio buon padre, al qual sol piacea quanto
a me piacea, né mai turbar mi volse,
per consolarmi e far cessare il pianto
ch’io ne facea, la pratica disciolse:
di che il superbo re di Frisa tanto
isdegno prese e a tanto odio si volse,
ch’entrò in Olanda, e cominciò la guerra
che tutto il sangue mio cacciò sotterra.
Oltre che sia robusto, e sì possente,
che pochi pari a nostra età ritruova,
e sì astuto in mal far, ch’altrui niente
la possanza, l’ardir, l’ingegno giova;
porta alcun’arme che l’antica gente
non vide mai, né fuor ch’a lui, la nuova:
un ferro bugio, lungo da dua braccia,
dentro a cui polve ed una palla caccia.
Col fuoco dietro ove la canna è chiusa,
tocca un spiraglio che si vede a pena;
a guisa che toccare il medico usa
dove è bisogno d’allacciar la vena:
onde vien con tal suon la palla esclusa,
che si può dir che tuona e che balena;
né men che soglia il fulmine ove passa,
ciò che tocca, arde, abatte, apre e fracassa.
Pose due volte il nostro campo in rotta
con questo inganno, e i miei fratelli uccise:
nel primo assalto il primo; che la botta,
rotto l’usbergo, in mezzo il cor gli mise;
ne l’altra zuffa a l’altro, il quale in frotta
fuggìa, dal corpo l’anima divise;
e lo ferì lontan dietro la spalla,
e fuor del petto uscir fece la palla.
Difendendosi poi mio padre un giorno
dentro un castel che sol gli era rimaso,
che tutto il resto avea perduto intorno,
lo fe’ con simil colpo ire all’occaso;
che mentre andava e che facea ritorno,
provedendo or a questo or a quel caso,
dal traditor fu in mezzo gli occhi colto,
che l’avea di lontan di mira tolto.
Il mio buon padre, al quale piaceva solamente ciò che a me piaceva, non volendomi assolutamente turbare, per consolarmi e fare quindi cessare il pianto mio, ruppe la trattativa di nozze; il re di Frisia, peccatore di superbia, di tale azione tanto si sdegnò e tanto iniziò ad odiarci, che invase l’Olanda e iniziò una guerra che provocò la morte di tutti i miei familiari. // Oltre ad esser robusto e molto possente, tanto che se ne trovano pochi eguali nella nostra età, è così astuto, furbo, nel fare del male, che agli altri a niente giova la propria prestanza fisica, l’ingegno e l’audacia; porta con sé una certa arma che la gente antica non ha mai potuto vedere, e, ad eccezione di lui, neanche la nuova gente: un archibugio (un ferro bucato), lungo circa due braccia, dentro al quale infila della polvere ed una palla. // Con una miccia accesa, sul retro della canna, dove è chiusa, tocca un piccolo foro che a malapena si riesce a vedere; allo stesso modo in cui il medico è solito toccare nel punto in cui dovrà ricucire una vena: a quel punto la palla viene espulsa con un tale frastuono, che si può dire che tuona e balena, simile ad un temporale; e non meno di quanto è solito fare un fulmine dove colpisce, tutto quello che tocca brucia, abbatte, spezza e distrugge. // Mise due volte in fuga il nostro campo con questo archibugio, ed uccise i miei due fratelli: durante il primo assalto uccise il primo, al quale il colpo, rotta la corazza, gli indirizzò in mezzo al cuore; durante l’altro combattimento al secondo fratello, che insieme agli altri fuggiva, separò l’anima dal corpo, lo uccise. Da lontano, lo colpì sulla schiena e fuori dal petto fece uscire la palla. // Un giorno, difendendosi mio padre dentro al castello, unica cosa che gli era rimasta, poiché aveva perso tutto il resto che possedeva nei pressi del castello, lo ammazzò con un colpo simile; perché mentre andava e veniva per il castello, occupandosi ora di questa ed ora di altra faccenda, fu colpito in mezzo agli occhi dal traditore, che da lontano lo aveva preso di mira.
E’ chiaro come qui Ariosto “contemporaneizzi” il suo discorso: abbiamo già visto come egli riesca a rappresentarci l’eterna anima umana dietro gli atteggiamenti fantastici dei protagonisti attraverso l’abbassamento ironico che ci permette di guardare e nel contempo sorridere di noi e dell’umanità intera. Qui invece nessun processo di svelamento, ma la vera e propria denuncia di un’arma di fuoco, chiaramente sconosciuta nel tempo dei cavalieri, ma che una volta introdotta avrebbe sconvolto i canoni di cortesia e virtù ai quali egli malinconicamente si richiama.
Continuando nella narrazione troviamo Olimpia, imprigionata nel proprio castello. Cimosco fa sapere che avrebbe posto fine alla guerra se lei si fosse concessa in sposa ad Arbante. Olimpia rifiuta ed i suoi sudditi, per non rischiare anche la loro vita, consegnano lei ed il suo castello nelle mani di Cimosco. Olimpia decide ci uccidersi, ma prima, di vendicarsi. Sposa Arbante e durante la prima notte di nozze, lo ammazza e scappa poi per mare con quel poco che le era rimasto. Durante il matrimonio però Cimosco, saputo che Bireno stava giungendo per mare, si era assentato per muovergli guerra. Il re di Frisia aveva sconfitto l’avversario e l’aveva fatto prigioniero. Visto il figlio morto, Cimosco uccide ogni persona che fosse vicina ad Olimpia. A Bireno pone invece una condizione crudele: gli dà un anno di tempo per portargli la donna tanto odiata, pena la morte. Olimpia tenta ogni stratagemma per liberare l’uomo amato ma senza successo alcuno. L’anno sta ormai per scadere e lei è infine disposta a consegnarsi nelle mani di Cimosco. Per essere sicura che questo sia di parola, chiede ad Orlando di stare al suo fianco durante lo scambio e di intervenire quindi prontamente se qualcosa dovesse andare storto. Orlando promette subito di dare il proprio supporto ed anzi di fare di più di quanto lei gli chieda. Quindi partono insieme e giungono in Olanda. Scende solo il paladino, la donna dovrà aspettare di aver notizia della morte di Cimosco. Trova alla porta della città una folta schiera di cavalieri. Il paladino sfida il re di Frisia: in caso della sua sconfitta gli verrà consegnata l’assassina di suo figlio Arbante, in caso di sua vittoria dovrà essere invece liberato il prigioniero.
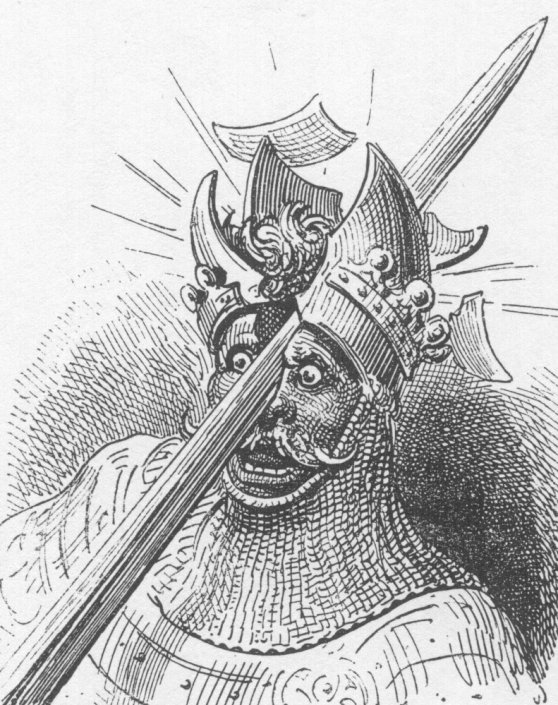
Orlando uccide il re di Fresia
Ma il re vuole catturare anche Orlando e con i suoi cavalieri lo circonda, convinto che l’impresa sia semplice che non prende neanche con sé l’archibugio. Orlando si butta sugli avversari e fa una strage. Inutilmente Cimosco chiede a gran voce che gli venga portata l’arma, tutti scappano; chi può tornare alla città non ha nessuna intenzione di uscirci ancora. Allora anche il re tenta di mettersi in salvo inseguito da Orlando e, quando finalmente entra in possesso dell’arma, spara, ma forse a causa della paura che gli fa tremare le mani, sbaglia mira e colpisce ed uccide solo il cavallo. Il cavaliere si lancia subito contro il re di Fresia e lo uccide. Quindi Bireno viene liberato e può nuovamente abbracciare Olimpia. Orlando si imbarca nuovamente per raggiungere Ebuda, porta con sé l’archibugio ed appena è in mare aperto lo getta nelle profondità dell’oceano.
Il canto X quindi inizia con la coppia appena ricostituita di Olimpia e Bireno: ma succede un fatto imprevisto; appena vede piangere la figlia del re di Frisia per la morte del proprio padre, Bireno subito se ne innamora e la ragazza, seppure quattordicenne, prende il posto di Olimpia nel suo cuore. Quest’ultima all’improvviso risulta insopportabile, ma lui non lo dà a vedere e nessuno si accorge del cambiamento. Partono per nave alla volta della sua patria, ma dopo tre giorni di tempesta raggiungono un’isola sconosciuta. Bireno ed Olimpia si accampano sulla spiaggia e lui, approfittando del sonno profondo di lei, torna di corsa sulla nave e riparte, abbandonandola. Olimpia si risveglia così sola; guarda la nave che si allontana e inveisce contro il crudele Bireno. Si accorge di non avere nessuna via di scampo; se anche si salvasse non sa dove poter andare, dal momento che aveva consegnato il suo regno, l’Olanda, nelle mani di Bireno.
 Giovani Martinelli: Olimpia abbandonata da Bireno (XVII sec.)
Giovani Martinelli: Olimpia abbandonata da Bireno (XVII sec.)
Nel frattempo Ruggiero, sotto il cocente sole di mezzogiorno, continua il suo viaggio verso il regno di Logistilla; è stanco, assetato e le armi che ha indosso sono infuocate. Dopo esser riuscito ad evitare l’insidia di tre donne, al soldo della maga, il cavaliere giunge infine allo stretto che separa le terre di Logistilla dal regno di Alcina. Trova ad aspettarlo un vecchio su una imbarcazione pronta a salpare e subito partono per raggiungere l’altra riva. All’inseguimento, giunge la flotta di Alcina con a bordo la stessa maga. Viene battuta dopo un’aspra battaglia ed infine è costretta a fuggire. Passerà i successivi giorni a piangere la perdita dell’amante ed a disperarsi perché, in quanto fata, non può morire. Ruggiero raggiunge la bellissima roccaforte di Logistilla; ritrova Astolfo nel castello e successivamente arriveranno anche tutti gli altri precedenti amanti della maga Alcina, liberati ora da Melissa. Logistilla insegna a Ruggiero a comandare l’ippogrifo ed appena il cavaliere è pronto, lo fa tornare dall’amata Bradamante, ma spinto dal desiderio di visitare il mondo, arriverà solo dopo mesi in Inghilterra ed atterrerà quindi una mattina a Londra. Qui il cavaliere vede riunito un immenso esercito di uomini pronti ad imbarcarsi per la Francia. Riprende il volo e si dirige poi verso Irlanda. e scorge su una isola, Ebuda, la bella Angelica incatenata nuda ad uno scoglio.
 Giorgio De Chirico: Ruggiero libera Angelica (inizi anni ’70)
Giorgio De Chirico: Ruggiero libera Angelica (inizi anni ’70)
Chiede chi sia stato ad incatenarla. Mentre Angelica sta per iniziare a raccontare le proprie vicende, emerge dal mare la mostruosa orca. Ruggiero pur colpendola non riesce a ucciderla ma con lo scudo incantato di Atlante fa svenire il mostro che rimane quindi rovesciato in mare. Il cavaliere libera Angelica, la fa salire sul cavallo alato e vola con lei in cielo. Atterranno su una vicina spiaggia della Bretagna e Ruggiero, preso dalla passione (era ormai anche lui vittima della bellezza di Angelica), inizia a togliersi l’armatura.

Il canto XI si apre con Ruggiero completamente preso dal desiderio per Angelica e si strappa l’armatura per poterla sfogare. La donna, imbarazzata per essere completamente nuda, guardandosi il corpo si accorge di avere al dito l’anello, che le permette di scomparire dalla vista del cavaliere.

Ruggiero cerca invano di ritrovarla, ma lei è ormai lontana, in una grotta dove trova cibo, vestiti, che seppur rozzi non riescono però a non farla comparire bella e nobile, ed una cavalla con cui poter proseguire il proprio viaggio verso casa. Il cavaliere intanto, perso anche l’ippogrifo che, liberatosi dal morso, vola ora libero in cielo, riprende le proprie armi e si incammina a piedi. Giunto in un bosco, sente un gran rumore d’armi ed assiste alla battaglia tra un gigante ed un valoroso cavaliere. Questo ultimo, tramortito da un colpo alla testa, è Bradamante, riconosciuta dal cavaliere, ma prima che possa intervenire in difesa della donna, il gigante se l’è messa in spalla ed è fuggito. Intanto, nonostante il debole vento, Orlando giunge all’isola di Ebuda prima del re Oberto d’Irlanda. Lasciata la nave al largo, la raggiunge con una scialuppa portando con sé solo la spada, la più grossa ancora della nave ed una robusta fune. Avvicinatosi alla riva, sente il pianto di una donna, che, nuda, è stata incatenata ad uno scoglio. Si avvicina a lei, quando improvvisamente compare il mostro marino che, vista l’imbarcazione del paladino, spalanca la bocca per inghiottirla. Allora Orlando le pianta in bocca l’enorme ancora, così da impedirle di richiederla. Si immerge quindi anche lui nel mostro e dal di dentro inizia a trafiggerla con la propria spada. Il cavaliere abbandona infine la gola dell’animale e impugna la robusta fune che aveva legato all’ancora, nuota fino alla riva ed inizia a tirare a sé l’orca con tutta la sua forza, fino a trascinarla a riva dove morirà.

Gli abitanti di Ebuda, temendo l’ira del dio marino, si arrabbiano e sono intenzionati a sacrificare Orlando al dio Proteo buttandolo in mare, ma il paladino, sguainata la spada si apre giusto la strada verso la donna. Nel frattempo arriva l’esercito mandato dall’Irlanda, fa strage del nemico, saccheggia e distrugge tutto ciò che incontra. La donna incatenata nuda è Olimpia. Orlando ascolta la sua storia e la libera. Arriva sulla spiaggia anche re Oberto, che conosce Orlando e quindi l’abbraccia contento. Il paladino racconta al re il tradimento subito da Olimpia per opera di Bireno. Le lacrime della donna, la sua storia e soprattutto il suo bellissimo corpo nudo, accendo all’istante d’amore il re d’Irlanda, che subito si propone di portarla in Olanda e di punire adeguatamente il crudele Bireno. Orlando, soddisfatto della situazione, può quindi continuare a ritrovare Angelica, mentre il re Oberto, insieme ai re d’Inghilterra e di Scozia, toglierà a Bireno tutti i possessi ed infine anche la vita. Sposa infine anche Olimpia che da contessa diventa regina. Orlando, ritornato al porto di partenza, riprende il proprio cavallo Brigliadoro e continua il viaggio alla ricerca dell’amata. La primavera seguente, mentre è in viaggio, sente le urla di una donna in pericolo, sguaina la propria spada e corre in suo aiuto.
Il canto XII si apre con il paladino che vede passare al galoppo un cavaliere misterioso con in braccio una donna, contro la sua volontà, che ad Orlando sembra Angelica. Il duca si lancia al suo inseguimento con Brigliadoro e raggiunge infine, uscito dal bosco, un vasto prato con al centro un bellissimo castello, all’interno delle cui mura è entrato il misterioso cavaliere.
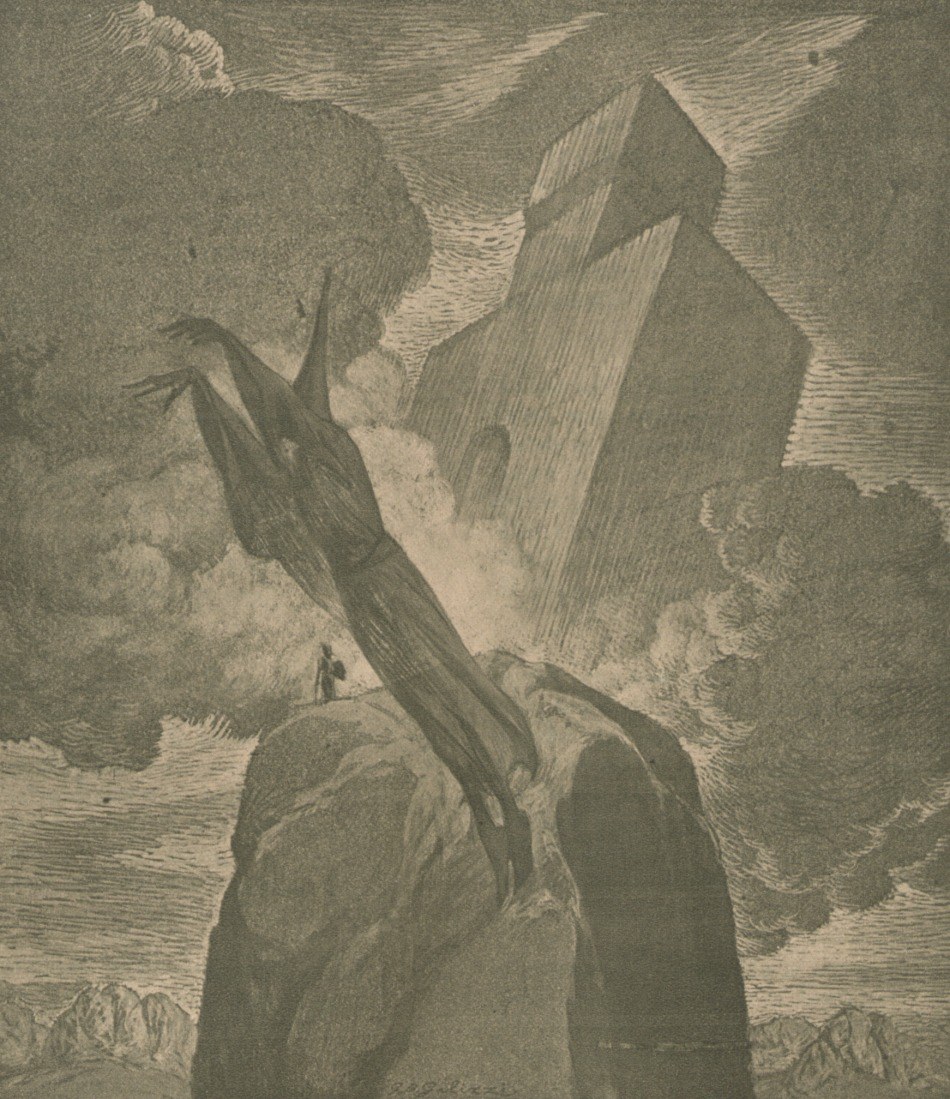
Giovan Battista Galizzi: Atlante ed il suo castello incantato (1945)
IL CASTELLO INCANTATO
(XII, 8-12)
Di vari marmi con suttil lavoro
edificato era il palazzo altiero.
Corse dentro alla porta messa d’oro
con la donzella in braccio il cavalliero.
Dopo non molto giunse Brigliadoro,
che porta Orlando disdegnoso e fiero.
Orlando, come è dentro, gli occhi gira;
né più il guerrier, né la donzella mira.
Subito smonta, e fulminando passa
dove più dentro il bel tetto s’alloggia:
corre di qua, corre di là, né lassa
che non vegga ogni camera, ogni loggia.
Poi che i segreti d’ogni stanza bassa
ha cerco invan, su per le scale poggia;
e non men perde anco a cercar di sopra,
che perdessi di sotto, il tempo e l’opra.
D’oro e di seta i letti ornati vede:
nulla de muri appar né de pareti;
che quelle, e il suolo ove si mette il piede,
son da cortine ascose e da tapeti.
Di su di giù va il conte Orlando e riede;
né per questo può far gli occhi mai lieti
che riveggiano Angelica, o quel ladro
che n’ha portato il bel viso leggiadro.
E mentre or quinci or quindi invano il passo
movea, pien di travaglio e di pensieri,
Ferraù, Brandimarte e il re Gradasso,
re Sacripante ed altri cavallieri
vi ritrovò, ch’andavano alto e basso,
né men facean di lui vani sentieri;
e si ramaricavan del malvagio
invisibil signor di quel palagio.
Tutti cercando il van, tutti gli dànno
colpa di furto alcun che lor fatt’abbia:
del destrier che gli ha tolto, altri è in affanno;
ch’abbia perduta altri la donna, arrabbia;
altri d’altro l’accusa: e così stanno,
che non si san partir di quella gabbia;
e vi son molti, a questo inganno presi,
stati le settimane intiere e i mesi.
Con perizia lavorato, il palazzo era stato edificato con diversi marmi. Il cavaliere con la fanciulla in braccio sorpassa la porta lavorata d’oro. Dopo non molto giunge Brigliadoro, cavalcato da Orlando sdegnato e furioso. Orlando, come giunge dentro il palazzo, gira lo sguardo, ma non vede più né il cavaliere né la fanciulla. // Subito smonta da cavallo, e come un fulmine si dirige verso le stanze; corre di qua, corre di là, non trascura alcuna camera né ogni loggiato. Dopo aver cercato nelle stanze del pian terreno, sale le scale e impiega lo stesso tempo a cercare in quelle di sopra. // Vede letti ornati d’oro e di seta, nelle pareti son nascosti i muri, che sono, come il pavimento, coperti da tendaggi e da tappeti. Il conte Orlando va su, giù, torna indietro, ma gli occhi tristi non riescono a vedere Angelica o il ladro che l’ha rapita. // E mentre inutilmente va ora da una parte ora dall’altra, pieno di pena e di pensieri, ritrovò lì dentro Ferraù, Brandimarte, il re Gradasso, Sacripante e altri cavalieri che vagavano come lui inutilmente e si rammaricavano del malvagio ed invisibile signore di quel luogo. // Tutti girano per il palazzo alla sua ricerca, tutti lo accusano di aver rubato loro qualcosa: uno è all’affannata ricerca del destriero che il signore gli ha sottratto; un altro si arrabbia per aver perduto la propria donna; altri lo accusa per altri misfatti: e stanno così senza sapere come poter abbandonare quella gabbia; e ci sono molti, catturati con l’inganno, in trappola da intere settimane e mesi.
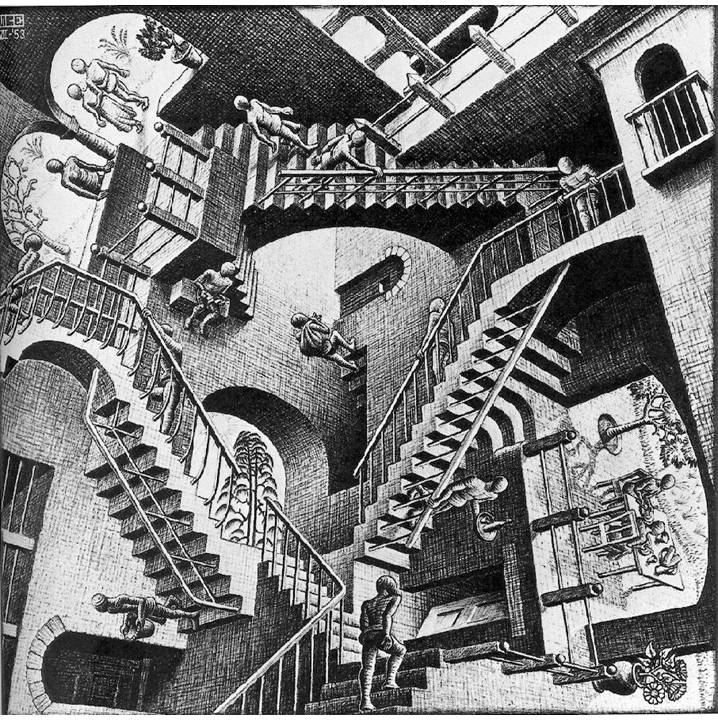
Immagine di Esher che ben rappresenta il castello incantato di Ariosto
E’ evidente che la descrizione di questo castello, nuova magia di Atlante, rappresenti l’intero poema: infatti esso è il palazzo del desiderio insoddisfatto, la cui rincorsa diviene affannosa, ripetitiva: non raggiunto, produce un rinnovato movimento, per la sua conquista, ma completamente invano. Infatti non riuscendo a trovare quello che cerca, Orlando esce nel prato circostante ma subito vede Angelica ad una finestra e sente le donna chiedergli aiuto. Torna nel castello e continua la ricerca; la voce di lei proviene sempre da un luogo diverso, sempre da tutt’altra parte rispetto a quella dove si trova lui.
Giunge nel palazzo d’Atlante anche Ruggiero:
RUGGIERO NEL PALAZZO D’ATLANTE
(XII, 17-20)
Ma tornando a Ruggier, ch’io lasciai quando
dissi che per sentiero ombroso e fosco
il gigante e la donna seguitando,
in un gran prato uscito era del bosco;
io dico ch’arrivò qui dove Orlando
dianzi arrivò, se ’l loco riconosco.
Dentro la porta il gran gigante passa:
Ruggier gli è appresso, e di seguir non lassa.
Tosto che pon dentro alla soglia il piede,
per la gran corte e per le logge mira;
né più il gigante né la donna vede,
e gli occhi indarno or quinci or quindi aggira.
Di su di giù va molte volte e riede;
né gli succede mai quel che desira:
né si sa imaginar dove sì tosto
con la donna il fellon si sia nascosto.
Poi che revisto ha quattro volte e cinque
di su di giù camere e logge e sale,
pur di nuovo ritorna, e non relinque
che non ne cerchi fin sotto le scale.
Con speme al fin che sian ne le propinque
selve, si parte: ma una voce, quale
richiamò Orlando, lui chiamò non manco;
e nel palazzo il fe’ ritornar anco.
Una voce medesma, una persona
che paruta era Angelica ad Orlando,
parve a Ruggier la donna di Dordona,
che lo tenea di sé medesmo in bando.
Se con Gradasso o con alcun ragiona
di quei ch’andavan nel palazzo errando,
a tutti par che quella cosa sia,
che più ciascun per sé brama e desia.
Ma tornando a raccontare di Ruggiero, che ho abbandonato quando dissi che, attraverso un sentiero ombroso e buio, seguendo il gigante e la donna, era finalmente giunto, uscito dal bosco, in un grande prato; potrei dire che arrivò nel luogo dove Orlando era arrivato poco prima, se ho riconosciuto il luogo. Il gigante passa attraverso la grande porta; Ruggiero gli è subito dietro e non smette di seguirlo (entra anche lui). // Appena mette il piede dentro alla porta, da un’occhiata alla grande corte ed alle stanze ma non vede più né il gigante né la donna. Invano gira gli occhi tutt’intorno. Più volte va su e giù e ci ritorna ma mai trova quel che va cercando e non riesce ad immaginare dove, così velocemente, il fellone si sia nascosto con al donna. // Dopo che ha controllato più e più volte le camere, le logge e le sale del primo e del secondo piano, torna comunque di nuovo a controllare, e non rinuncia a cercare fin sotto le scale. Infine, con la speranza che siano tornati nel vicino bosco, esce dal castello. Ma una voce, simile a quella che richiamò Orlando, richiamò anche lui non di meno e lo fece tornare nel palazzo. // La medesima voce, una persona che era sembrata Angelica ad Orlando, sembrò ora a Ruggiero esser Bradamante, della quale era lui innamorato (che lo faceva sentire fuori di sé). Se dovesse discutere con re Gradasso, o con altra persona di quelle che andavano vagando per il palazzo, a ciascuno sarebbe sembrata essere ciò che più ciascuno ambisce e desidera avere per sé.
E’ una vera e propria ripetizione questa che succede a Ruggiero: come Orlando, anche lui segue la sua irraggiungibile “quete”. Si noti, tuttavia, un elemento estremamente interessante quando Ariosto afferma se ’l loco riconosco: infatti sembra quasi, dall’alto, possedere la mappa dei luoghi e delle azioni dei suoi personaggi, che lui “manovra” ed esegue con estrema attenzione. Quindi i personaggi sono tutti vittima del nuovo incantesimo di Atlante, che dopo il castello d’acciaio e dopo l’isola della maga Alcina, cerca ora di tenere impegnato il proprio protetto in questo nuovo castello per salvarlo dalla morte predetta dagli astri. Il mago aveva deciso di condurre in quel posto anche tutti i valorosi cavalieri che avrebbero potuto uccidere Ruggiero. Vi giunge anche Angelica:
ANGELICA, IL CASTELLO E L’ANELLO FATATO
(XII, 23-34)
Ma torniamo ad Angelica, che seco
avendo quell’annel mirabil tanto,
ch’in bocca a veder lei fa l’occhio cieco,
nel dito, l’assicura da l’incanto;
e ritrovato nel montano speco
cibo avendo e cavalla e veste e quanto
le fu bisogno, avea fatto disegno
di ritornare in India al suo bel regno.
Orlando volentieri o Sacripante
voluto avrebbe in compania: non c’ella
più caro avesse l’un che l’altro amante;
anzi di par fu a’ lor disii ribella:
ma dovendo, per girsene in Levante,
passar tante città, tante castella,
di compagnia bisogno avea e di guida,
né potea aver con altri la più fida.
Or l’uno or l’altro andò molto cercando,
prima ch’indizio ne trovasse o spia,
quando in cittade, e quando in ville, e quando
in alti boschi, e quando in altra via.
Fortuna al fin là dove il conte Orlando,
Ferraù e Sacripante era, la invia,
con Ruggier, con Gradasso ed altri molti
che v’avea Atlante in strano intrico avolti.
Quivi entra, che veder non la può il mago,
e cerca il tutto, ascosa dal suo annello;
e trova Orlando e Sacripante vago
di lei cercare invan per quello ostello.
Vede come, fingendo la sua immago,
Atlante usa gran fraude a questo e a quello.
Chi tor debba di lor, molto rivolve
nel suo pensier, né ben se ne risolve.
Non sa stimar chi sia per lei migliore,
il conte Orlando o il re dei fier Circassi.
Orlando la potrà con più valore
meglio salvar nei perigliosi passi:
ma se sua guida il fa, sel fa signore;
ch’ella non vede come poi l’abbassi,
qualunque volta, di lui sazia, farlo
voglia minore, o in Francia rimandarlo.
Ma il Circasso depor, quando le piaccia,
potrà, se ben l’avesse posto in cielo.
Questa sola cagion vuol ch’ella il faccia
sua scorta, e mostri avergli fede e zelo.
L’annel trasse di bocca, e di sua faccia
levò dagli occhi a Sacripante il velo.
Credette a lui sol dimostrarsi, e avenne
ch’Orlando e Ferraù le sopravenne.
Le sopravenne Ferraù ed Orlando;
che l’uno e l’altro parimente giva
di su di giù, dentro e di fuor cercando
del gran palazzo lei, ch’era lor diva.
Corser di par tutti alla donna, quando
nessuno incantamento gli impediva:
perché l’annel ch’ella si pose in mano,
fece d’Atlante ogni disegno vano.
L’usbergo indosso aveano e l’elmo in testa
dui di questi guerrier, dei quali io canto;
né notte o dì, dopo ch’entraro in questa
stanza, l’aveano mai messi da canto;
che facile a portar, come la vesta,
era lor, perché in uso l’avean tanto.
Ferraù il terzo era anco armato, eccetto
che non avea né volea avere elmetto,
fin che quel non avea, che ’l paladino
tolse Orlando al fratel del re Troiano;
ch’allora lo giurò, che l’elmo fino
cercò de l’Argalia nel fiume invano:
e se ben quivi Orlando ebbe vicino,
né però Ferraù pose in lui mano;
avenne, che conoscersi tra loro
non si poter, mentre là dentro foro.
Era così incantato quello albergo,
ch’insieme riconoscer non poteansi.
Né notte mai né dì, spada né usbergo
né scudo pur dal braccio rimoveansi.
I lor cavalli con la sella al tergo,
pendendo i morsi da l’arcion, pasceansi
in una stanza, che presso all’uscita,
d’orzo e di paglia sempre era fornita.
Atlante riparar non sa né puote,
ch’in sella non rimontino i guerrieri
per correr dietro alle vermiglie gote,
all’auree chiome ed a’ begli occhi neri
de la donzella, ch’in fuga percuote
la sua iumenta, perché volentieri
non vede li tre amanti in compagnia,
che forse tolti un dopo l’altro avria.
E poi che dilungati dal palagio
gli ebbe sì, che temer più non dovea
che contra lor l’incantator malvagio
potesse oprar la sua fallacia rea;
l’annel che le schivò più d’un disagio,
tra le rosate labra si chiudea:
donde lor sparve subito dagli occhi,
e gli lasciò come insensati e sciocchi

Salvator Dalì: Orlando alla ricerca di Angelica
Ma torniamo da Angelica, che con sé avendo portato quell’anello molto speciale, che la rende invisibile quanto viene tenuto in bocca, ed al dito la protegge da ogni incantesimo; ed avendo trovato, nella conca della montagna, cibo, un cavallo, vestiti e quanto altro di cui aveva bisogno, aveva ora deciso di ritornare in India al suo bel regno. // Volentieri Orlando o Sacripante avrebbe voluto al suo fianco: lei non aveva voluto più bene a l’uno o all’altro dei due suoi amanti, allo stesso modo, anzi, si era opposta ai loro desideri. Ma dovendo, per tornare in Oriente, attraversare tante città, tanti castelli, aveva bisogno di compagnia e di una guida, e solo con Orlando e Sacripante poteva avere la più fidata compagnia. // Continuò a cercare ora l’uno ed ora l’altro prima di riuscire a trovare un indizio o una loro traccia, a volte in città, a volte in ville, altre volte in alti boschi ed a volte ancora in tutt’altri luoghi. La fortuna infine la inviò là dove il conte Orlando, Ferraù e Sacripante si trovavano insieme a Ruggiero, re Gradasso e molti altri ancora che il mago Atlante aveva imprigionato in uno strano incantesimo. // Entra nel castello, invisibile agli occhi del mago, e gira dappertutto, nascosta dall’anello. Incontra Orlando e Sacripante che vagano nel tentativo invano di cercarla in quel palazzo. Vede come, simulando con l’incantesimo la sua immagine, Atlante inganni l’uno e l’altro. Chi di loro due debba prendere come guida valuta molto nei suoi pensieri senza riuscire a decidersi. // Non riesce a valutare chi dei sia il meglio per lei, il conte Orlando o Sacripante. Orlando la potrà con più valore proteggere nei punti più pericolosi del cammino: ma se lo farà sua guida, lo farà anche suo signore; non riesce quindi a vedere come potrà poi togliergli la signoria, non appena, non più utile, vorrà poi sminuirne l’importanza o rimandarlo in Francia. // Al contrario, quando più le piaccia, valuta di potersi liberare facilmente da Sacripante, agendo nel giusto modo. Questa sola ragione fa sì che lei decida di scegliere Sacripante come sua scorta e di mostrare a lui la sua fiducia ed il suo affetto. Angelica si toglie l’anello dalla bocca, e dalla sua faccia levò quindi quel velo che la rendeva invisibile a Sacripante. Pensò di potersi mostrare a lui solo, accadde invece che sia Orlando che Ferraù sopraggiunsero in quel momento. // Giunsero Ferraù ed Orlando, che allo stesso modo avevano girato, sopra e sotto, fuori e dentro, alla ricerca di lei dentro tutto il palazzo, che era la donna da loro amata ed adorata. Corsero tutti insieme verso Angelica, dal momento che nessun incantesimo poteva ora impedirglielo, perché l’anello che la donna si mise alla mano, rese vano ogni tentativo di incantesimo da parte di Atlante. // Avevano addosso la corazza e in testa l’elmo, due (Sacripante ed Orlando) di questi guerrieri le cui gesta io vi canto; non di notte e neanche di giorno, dopo che furono entrati in questo palazzo, se li erano mai levati di dosso. Facili da portare, come fossero un vestito, erano per loro, tanto erano abituati a portarli. Ferraù, il terzo guerriero, era anche lui armato, ma non aveva, e non voleva avere, nessun elmo, // fino a ché non fosse entrato in possesso di quello che il paladino Orlando tolse ad Almonte, fratello del re troiano. Perché ciò aveva giurato allora, quando l’elmo, di buona fattura, di Argalia aveva cercato senza successo nel fiume. Sebbene avesse a portata di mano Orlando, Ferraù non lo assalì. Incrociare fra loro le armi non fu possibile fintanto che furono nel castello. // Era così incantato quel palazzo, che non poterono riconoscersi l’un l’altro. Né di notte né di giorno, né la spada né la corazza e nemmeno solo lo scudo dal braccio si toglievano. I loro cavalli, con la sella sul dorso, con il morso a penzoloni dall’arcione, si rilassavano in una stanza, che in prossimità dell’uscita del castello, era sempre fornita di orzo e di paglia. // Il mago non sa e non può nemmeno evitare che i tre guerrieri rimontino in sella dei loro destrieri per correre dietro alle rosee guancie, alla chioma dorata ed ai begli occhi neri di Angelica, che spinge la sua cavalla alla fuga, perché non gradisce vedere insieme i tre amanti, che forse avrebbe preso come guida, se fossero arrivati separatamente. // E dopo che li ebbe allontanati dal palazzo a sufficienza, da poter non più temere che contro loro l’incantatore malvagio potesse usare le proprie ingannevoli arti magiche; l’anello, che più di una brutta situazione le aveva evitato, chiuse tra le sue rosse labbra, di conseguenza scomparve alla loro vista, e li lasciò istupiditi ed increduli.
Se dovessimo pensare in modo non contenutistico a questo passo, ma “narratologico”, ci troveremo al primo episodio in cui tutti i protagonisti, racchiusi nel labirinto di Atlante, si ritrovano insieme. Cosa fa agire l’autore in questo modo? Il bisogno di raccogliere le fila che egli aveva tessuto ma che, se non le avesse raccolte, avrebbe corso il pericolo di perderle e quindi di farle perdere al lettore; ciò fa sì che egli trovi quest’escamotage per “raccoglierle” e ritrovarle. Ma, a questo punto, l’autore si trova di fronte ad un altro pericolo: quello di “aggrovigliarsi” e creare il caos nella sua storia; affinché ciò non sia possibile è necessario che la narrazione ritrovi il suo “motore”, e tale “motore” sta, come abbiamo visto, nel movimento centripeto, in altre parole, nella fuga di Angelica.

Sacripante, Orlando e Ferraù all’inseguimento di Angelica
Riprendendo la narrazione ritroviamo i tre cavalieri, stupiti per aver visto scomparire Angelica, che iniziano a litigare. Ferraù dichiara apertamente di ricercare l’elmo del paladino Orlando senza averlo riconosciuto nel cavaliere che ha di fronte. Il cavaliere spagnolo, spavaldo, sostiene anche di avere già incontrato molte volte il conte e di averlo ogni volta messo alle strette, ma non di aver voluto allora prendergli le armi. Acceso d’ira, Orlando rivela la propria identità, si toglie l’elmo e si lancia nel combattimento con lo spagnolo. Il duello è crudele, ma entrambi sono stati resi invulnerabili da un incantesimo. Ferraù può essere ferito solo all’ombelico ed Orlando solo sotto le piante dei piedi, tutto il resto dei loro corpi è più duro del diamante e portavano quindi l’armatura solo per ornamento. Angelica è l’unica testimone del combattimento perché Sacripante, approfittando della situazione, è ripartito a cavallo alla ricerca di lei e quindi per far loro dispetto, ruba l’elmo di Orlando con l’intenzione di tenerlo per poco e restituirlo appena possibile. Orlando e Ferraù si rendono conto della sua sparizione, accusano Sacripante di quel gesto e subito corrono al suo inseguimento. Seguendo tracce diverse, Orlando rifà il percorso di Sacripante e Ferraù invece quello di Angelica. Angelica nel frattempo si era fermata ad una fonte per riposarsi, lasciando incustodito l’elmo. Quando vede giungere Ferraù, riprende subito la fuga e rimette l’anello in bocca per scomparire alla vista del cavaliere. Il pagano vede la donna sparire, la cerca inutilmente ed infine torna alla fonte, dove trova l’elmo tanto desiderato. Torna quindi all’accampamento spagnolo presso Parigi. Angelica è pentita per aver sottratto l’elmo al conte, consegnandolo infine involontariamente allo spagnolo Ferraù. Non è questo ciò che Orlando meritava per quanto aveva fatto per lei, e si lamenta quindi con sé stessa. Precedendo il suo viaggio verso l’oriente, incontrerà infine un giovane ferito mortalmente al petto. Nel frattempo, recuperato un altro elmo senza cimiera, Orlando procede nella propria ricerca di Angelica. Giunge nei pressi di Parigi nel periodo in cui re Agramante è impegnato a cingere d’assedio la città. A tale scopo lo stesso re aveva riunito un enorme gruppo di soldati e si apprestava a organizzarlo. Alzirdo, capitano di una delle schiere di soldati, vede passare un cavaliere dall’aspetto fiero e valoroso, vuole metterlo alla prova e si lancia a cavallo contro il conte; finisce morto con il cuore trafitto. Gli altri soldati, avendo assistito alla scena, circondano l’avversario misterioso ed iniziano a colpirlo in ogni modo. Orlando estrae la propria spada, Durindana, e fa una strage di saraceni, fino a che non vede che sul campo di battaglia non è rimasta nessuna persona viva. Quindi il conte Orlando prosegue il proprio viaggio, incontra una grotta con l’ingresso bloccato ma dalla quale vede uscire una luce intensa. Pensando che al suo interno si trovi prigioniera Angelica, vi entra e trova così al suo interno una giovane e bellissima ragazza, con gli occhi bagnati di lacrime, in compagnia di una vecchia. Orlando le domanda chi sia la persona tanto crudele che le tiene imprigionate in quella caverna.

Orlando e Isabella
Nel XIII canto sappiamo che si tratta di Isabella, saracena e figlia del re di Galizia (Maricoldo, ucciso da Orlando, ma lei non lo sa). Il padre aveva organizzato una giostra ed erano giunti cavalieri da ogni parte del mondo per sfidarsi, tra i quali Zerbino, figlio del re di Scozia, del quale lei si innamorò subito. Zerbino ricambiando il sentimento e sapendo di non poterla avere in moglie, a causa della loro diversa fede, organizza il suo rapimento. Non potendo compiere l’opera di persona, poiché impegnato nella guerra in Frisia, la fa accompagnare per mare dal suo fedele amico Odorico. Ma una tempesta, costringe loro ad abbandonare la nave e a salire su una scialuppa, insieme a Almonio e Corebo. Raggiungono una spiaggia deserta, e Odorico, acceso d’amore per la ragazza, ha intenzione di possederla; a tal fine, manda Almonio a compiere una missione e confessa tutto a Corebo, ma quest’ultimo, volendo fermare l’amico, rimarrà da lui ucciso. Rimasti ormai soli, Odorico tenta di usare la forza per possedere la donna, ma arriva all’improvviso un gruppo di persone e lui è costretto a fuggire. Isabella non ottiene però aiuto da loro, viene anzi imprigionata in una caverna con l’intenzione di riuscire poi a venderla.

Orlando esce dalla grotta
Proprio mentre lei termina il racconto, entrano in quel momento nella caverna alcune persone armate, Orlando lancia loro contro una immensa tavola e ne mette fuori gioco buona parte. Lega poi con una fune i rimasti e li appende come cibo per i corvi ad un albero fuori dalla grotta. La vecchia fugge di corsa ed incontra infine un guerriero sulla riva di un fiume. Quindi Orlando si allontana con Isabella ed i due proseguono insieme il viaggio finché non incontrano un cavaliere che stava per essere portato in prigione. Nel frattempo Bradamante, tornata a Marsiglia per difendere la città, non aveva più avuto notizie del suo amato Ruggiero; quando Melissa le fa finalmente visita e la maga le racconta della trappola che il mago Atlante ha ancora una volta teso al cavaliere, le chiede di partire subito per andare a salvarlo. Una volta giunta nel castello vedrà il mago nelle sembianze di Ruggiero per ingannarla, ma lei dovrà ucciderlo senza esitazione per porre fine ad ogni suo incantesimo. Le due donne intanto parlano ancora del valore della stirpe d’Este, attraverso le donne che la rappresentano, che da lei e da Ruggiero avrà origine. Giunte infine nei pressi del castello incantato, Bradamante si separa dalla maga, ma appena vide Ruggiero combattere contro due giganti, si dimentica degli avvertimenti della maga ed anzi pensa che Melissa abbia in odio il cavaliere e lo voglia morto. Il mago Atlante, con le sembianze di Ruggiero, le chiede aiuto e subito parte al galoppo inseguito dai due aggressori. Bradamante insegue l’amato e non esita ad entrare nel castello, cadendo anche lei in trappola.
 Orlando lascia i corpi accesi come cibo per i corvi
Orlando lascia i corpi accesi come cibo per i corvi
Il canto XIV si apre con i due re che, di fronte alle forti perdite subite da entrambi le parti, stanno assegnando nuovi comandanti alle truppe. Tra i comandanti di reparto c’è anche Brunello, che già aveva tentato di uccidere Brandimarte, da cui si era fatto rubare l’anello incantato.

Un’altra schiera dell’esercito è guidata invece da Rodomonte, il più forte e coraggioso cavaliere saraceno ed anche il più acerrimo nemico della fede cristiana. Mancano ancora comandanti, e Agramante viene così a sapere che molti cavalieri sono morti per mano di un oscuro cavaliere (Orlando). Mandricardo, valorosissimo e crudele cavaliere saraceno, proprietario dell’armatura che mille anni prima era appartenuta ad Ettore, sentita la storia, si propone subito, senza farne parola, di inseguire le tracce di quel cavaliere per confrontarsi con lui. Cavalcando incontra un giorno sulla riva di un fiume un gruppo di soldati; proteggono Doralice, figlia del re di Granata e sposa di Rodomonte. Il crudele cavaliere vuole mettere alla prova quel gruppo di soldati, chiede di poter vedere la ragazza e li assale.

Grazia Nidasio: Mandricardo rapisce Doralice (1970)
Mandricardo combatte con una lancia. Aveva infatti trovato solo l’armatura di Ettore, la spada Durindana era stata già presa da Orlando, e non potrà usare nessuna spada finché non riuscirà ad impossessarsi di quella del paladino. Anche con la sola lancia spezzata, il saraceno fa una strage. Alcuni soldati cercano di scappare ma Mandricardo non vuole lasciare superstiti: li insegue e completa la sua opera. Vista la bellezza di Doralice in lacrime, Mandircardo se ne innamora e come premio per la propria vittoria diviene quindi prigioniero d’amore. Prende sul proprio cavallo la donna, saluta benevolmente i servitori di Doralice, dicendo di prendersi ora lui cura di lei, e continua il suo viaggio. Ma non è più interessato a ritrovare il cavaliere misterioso. Infatti il saraceno mente alla donna dicendo di averla sempre amata e di essere arrivato in Europa solo per poterla rivedere. Confortata da tanto amore la sera stessa Mandricardo e Doralice si fermano ad un villaggio e sfogano la passione. Ripartiti il giorno dopo, incontrano poi due cavalieri ed una donna che riposano all’ombra sulla riva di un fiume. Si torna quindi a Parigi, dove re Agramante, prima dell’arrivo dei rinforzi di re Carlo, tenta di espugnare la città e prepara tutto il necessario per l’assalto. I parigini cristiani chiedono aiuto a Dio che domanda all’arcangelo Michele di far giungere Silenzio all’esercito arrivato dall’Inghilterra così da creare nell’esercito saraceno liti accese e ridurne quindi la forza. L’arcangelo, dopo lungo cercare, infine troverà Silenzio e lo porterà a Rinaldo che, grazie a quell’aiuto, raggiunge in un solo giorno Parigi senza essere visto o sentito dagli avversari pagani.

Inizia l’assalto dei Saraceni, e Rodomonte riesce a passare però lo sbarramento; quindi fa strage di cristiani e libera una delle torri di difesa della città, creando quindi una via facile di accesso per i propri compagni che conquistano così la prima cerchia di mura. Ma i cristiani intanto danno fuoco al letto di rami secchi che avevano posto tra mura e mura, facendo morire bruciati tutti i pagani che si erano avventurati oltre la prima cerchia.
Nel canto XV continua l’aspra battaglia all’interno della città di Parigi. Il duca Astolfo, salvato da Melissa e giunto nel regno di Logistilla, riesce infine a partire per mare per fare ritorno in patria e per proteggerlo durante il viaggio, la maga lo fa accompagnare da una forte scorta armata dal libro contro gli incantesimi ed il corno magico, il cui orrendo suono è in grado di mettere in fuga qualunque avversario.
Prendendo spunto dal viaggio di Astolfo, Ariosto fa una riflessione sulle recenti scoperte geografiche:
LE SCOPERTE GEOGRAFICHE
(XV, 21-24)
Ma volgendosi gli anni, io veggio uscire
da l’estreme contrade di ponente
nuovi Argonauti e nuovi Tifi, e aprire
la strada ignota infin al dì presente:
altri volteggiar l’Africa, e seguire
tanto la costa de la negra gente,
che passino quel segno onde ritorno
fa il sole a noi, lasciando il Capricorno;
e ritrovar del lungo tratto il fine,
che questo fa parer dui mar diversi;
e scorrer tutti i liti e le vicine
isole d’Indi, d’Arabi e di Persi:
altri lasciar le destre e le mancine
rive che due per opra Erculea fersi;
e del sole imitando il camin tondo,
ritrovar nuove terre e nuovo mondo.
Veggio la santa croce, e veggio i segni
imperial nel verde lito eretti:
veggio altri a guardia dei battuti legni,
altri all’acquisto del paese eletti:
veggio da dieci cacciar mille, e i regni
di là da l’India ad Aragon suggetti;
e veggio i capitan di Carlo quinto,
dovunque vanno, aver per tutto vinto.
Dio vuol ch’ascosa antiquamente questa
strada sia stata, e ancor gran tempo stia;
né che prima si sappia, che la sesta
e la settima età passata sia:
e serba a farla al tempo manifesta,
che vorrà porre il mondo a monarchia,
sotto il più saggio imperatore e giusto,
che sia stato o sarà mai dopo Augusto.
Ma passando gli anni, io vedo uscire dall’estreme coste occidentali, nuovi navigatori (coraggiosi come gli Argonauti, guidati da Tifi) e mostrarci strade sconosciute fino ai giorni d’oggi: (vedo) alcuni circumnavigare l’Africa seguendo le coste degli uomini neri, fino a passare il tropico del Capricorno, dove torna indietro il sole durante il solstizio d’inverno // e scoprire il termine lungo tutto il tratto (africano), che fa apparire i due mari così diversi, e quindi costeggiare le isole indiane, arabe, persiane: (vedo) altri lasciare le colonne d’Ercole e seguendo il corso del sole, trovare nuove terre e un nuovo mondo. Vedo la santa croce e i santi segnali dell’Impero eretti nel verde suolo; altri ne vedo di guardia alle stanche navi, altri ancora intenti alla conquista del nuovo paese; vedo dieci (cavalieri) cacciare mille uomini, ed i regni al di là dell’India diventare soggetti a quello d’Aragona, e vedo i capitani di Carlo V, dovunque essi vadano, diventare vincitori. // Dio vuol tenere nascosta questa strada e vuole che lo sia ancora per molto tempo lo sia, né che si sappia prima di sei o sette secoli, e si riserva di renderla palese, quando vorrà porre il mondo in una monarchia, sotto il più saggio e giusto imperatore che ci sia stato o che mai ci sarà dopo Augusto.
E’ evidente che qui Ariosto adotti la tecnica già messa bene in evidenza in Dante della profezia post eventum. Ma non deve sembrare strano che tale profezia non sia “direttamente” rivolta verso la casa d’Este: sembra infatti un passo “encomiastico” indiretto, visti gli ottimi rapporti che, nel momento in cui l’autore ferrarese li scriveva, esistevano fra i duchi di Ferrara e Carlo V rapporti eccellenti.
Giunti allo stretto di Bahrein, Astolfo approda e prosegue il proprio viaggio sulla terra. Cavalcando lungo il Nilo sul suo cavallo incontra un vecchio eremita su di una imbarcazione, che gli consiglia, se ha cara la vita, di continuare il viaggio sull’altra riva del fiume, così da non incontrare il gigante Caligorante che è solito catturare le persone con una rete che egli tiene nascosta, divorarle ed adornare con le loro pelli la propria dimora. Astolfo, con estremo onore e coraggio, prosegue invece oltre alla ricerca del gigante. Quest’ultimo, visto arrivare Astolfo, pensa di prendere il cavaliere alle spalle, ma il duca però ferma subito il cavallo e suona il corno magico, facendo cadere il gigante nella rete. Catturato Caligorante, dapprima lo lega, poi lo libera dalla rete divina e se lo porta dietro come trofeo.

Gustave Doré: Astolfo porta in trofeo il gigante Caligorante
Ancora un’altra avventura per Astolfo, infatti viene a sapere che alla foce del Nilo vive un ladrone, di nome Orrilo, che il cavaliere vuole andare a vedere. Arrivato sul posto, il duca assiste al combattimento tra quella persona incantata ed due nipoti di Orlando, Grifone e Aquilante. Qualunque ferita o mutilazione venga inflitta al ladrone, lui si ricompone e riprende normalmente il combattimento. Assistono alla scena anche due donne, le due fate che avevano nutrito i due, quando erano giovani, che dopo averli sottratti alla loro madre, li avevano spinti a confrontarsi in duello con Orrilo. Astolfo viene a sapere che l’unico modo per rendere Orrilo vulnerabile è di strappargli di testa un capello fatato. Quindi, il giorno dopo, durante il combattimento, il duca decapita l’avversario e rade completamente la testa di Orrilo. Subito la testa perde vita, così come ogni altra parte del corpo del ladrone. I due giovani ora si possono unire ad Astolfo per combattere contro i saraceni. Uno dei due giovani, Grifone, viene a sapere che Orrilige, la donna da lui amata (tanto bella quanto crudele), ha abbandonato Constantinopoli, dove lui l’aveva lasciata, per seguire un suo nuovo amante. Il ragazzo pensa quindi di raggiungere l’amata per riprendersela.
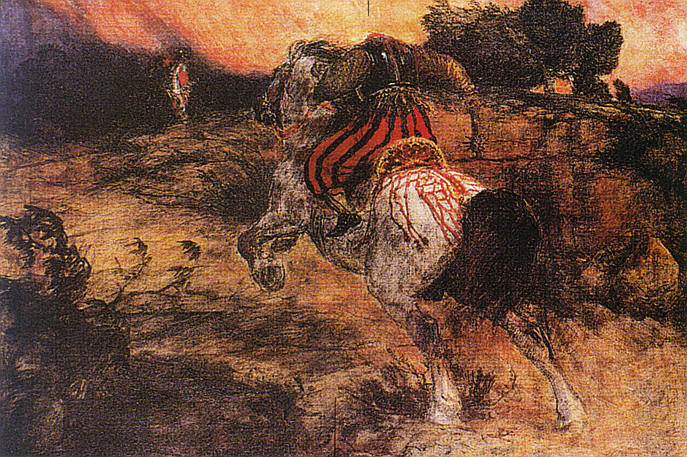 Arnold Böcklin, Astolfo che fugge con la testa di Orrillo, 1874
Arnold Böcklin, Astolfo che fugge con la testa di Orrillo, 1874
Nel canto XVI Grifone incontra Orrilige, donna crudele ed infedele, a Damasco in compagnia di un cavaliere, altrettanto ingiusto; i due si stanno dirigendo in città per partecipare ad una giostra. Orrilige finge che il cavaliere sia suo fratello, e così Grifone entra in città in compagnia della donna e del nuovo amante di lei.

Il canto XVI in una miniatura
Nel frattempo, a Parigi, infuria la guerra: Rodomonte giunge nella cerchia interna di mura della città di Parigi, fa strage del popolo inerme; uccide senza alcuna pietà vecchi e bambini e infine dà fuoco a tutte le abitazioni e le percuote così da farle crollare. Rinaldo, giunto infine a Parigi con i rinforzi inglesi, li incita a difendere la città; suona la carica e assale le schiere saracene all’improvviso. Il rumore della guerra è assordante. Il cielo viene oscurato dalla polvere sollevata dagli eserciti, dall’alito dei soldati e dal vapore rilasciato dal loro sudore. La terra si tinge di rosso ed è coperta di cadaveri. L’esercito pagano subisce grosse perdite, molti scappano, ed inizia a perdere terreno. Re Agramante abbandona l’assedio e manda parte dell’esercito a difendere l’accampamento contro gli Irlandesi. Questi cavalieri, visto il numero immenso di soldati che li assale, scappano lasciando indietro il cavaliere Zerbino, senza più cavallo. Rinaldo blocca la fuga degli scozzesi, giunge in soccorso di Zerbino e conquista con le armi spazio sufficiente per consentirgli di salire su un nuovo destriero. Zerbino si lancia subito al combattimento contro la schiera di re Agramante. Rinaldo lancia al galoppo Baiardo contro re Agramante stesso, lo colpisce e lo butta a terra insieme al cavallo. Intanto, re Carlo viene informato della distruzione e della strage che sta compiendo un solo uomo nell’altra parte della città; infatti si accorge delle fiamme che avvolgono parte della città e dei pianti e delle grida che da lì giungono; raccoglie intorno a sé i più valorosi cavalieri e si dirige contro il nemico saraceno.

Miniatura per il XVII canto
Nel XVII re Carlo vede che la maggior parte del popolo si è barricata nel palazzo reale e dalle sue mura esterne butta pezzi di tetto e di colonne su Rodomonte, che a colpi di spada sta per aprirsi un passaggio nel portone principale. Re Carlo, insieme ai paladini ed ai cavalieri al suo seguito si lancia contro il saraceno. Tornando a parlare di Grifone, il cavaliere entra nella bellissima e ricchissima città di Damasco in compagnia della donna e del nuovo amante di lei. Un cavaliere li ferma lungo la via e li accoglie nel proprio palazzo, invitandoli alla giostra organizzata dal re Norandino. Quest’ultimo era stato per lungo tempo innamorato di Lucina, figlia del re di Cipro. Dopo averla finalmente sposata, al ritorno in patria la loro nave era stata colta da una tempesta, e dopo tre giorni in mare erano infine giunti su una spiaggia. Mentre il re è intento nella caccia per procurare del cibo, il resto dell’equipaggio viene assalito da un orco. Il mostro è cieco ma compensa la mancanza con un infallibile fiuto e così riesce a catturarne molti; poi porta i rimanenti nella propria tana e li rinchiude in una caverna, dove prima si trovava il suo gregge. L’orco va quindi a fare pascolare gli animali. Tornato dalla caccia, il re si accorge di quanto successo. Quelli che si sono salvati sulla nave gli raccontano l’accaduto e lui decide subito di andare a caccia dell’orco per riprendersi Lucina. Raggiunta la tana del mostro, la moglie dell’orco gli dice che non deve temere per la vita di Lucina, perché il mostro è solito mangiare solo uomini, le donne vengono invece rinchiuse in quella grotta in cui si trova lei stessa insieme a tante altre. Consiglia a Norandino di andarsene, ma il desiderio del re di ritrovare l’amata è tanto grande da non farlo muovere da lì, e quindi la donna lo aiuta, ungendogli il corpo con del grasso animale, in modo da coprire completamente il suo odore. Mettendosi inoltre la pelle di un caprone si mescola al gregge riportato alla tana dal mostro e riesce quindi a rivedere Lucina. Norandino spiega agli altri come travestirsi e scappare.

Giovanni Lanfranco: Oroco, Norandino e Lucina, 1621
Il mattino dopo l’orco apre la grotta ed insieme al gregge escono anche Norandino e tutti gli altri. Eccetto Lucina perché il mostro riconosce che non si tratta di un vero caprone e la ricaccia nella grotta. La sera l’orco, ritornato alla grotta, si accorge della fuga di tutti i sui prigionieri e punisce Lucina incatenandola nuda sulla cima dello scoglio. Arriveranno i re Mandricardo e Gradasso che la libereranno; la giostra è quindi in memoria della salvezza ottenuta dopo quattro mesi passati nella grotta dell’orco. Quindi Grifone, Orrilige e Martano (nome dell’amante della donna) si recano al torneo. Sarà vincitore chi riuscirà a sconfiggere tutti e otto i cavalieri scelti dal Norandino tra i più valorosi e più fedeli suoi servitori. Entra dapprima Martano, ma per viltà fugge deriso da tutti gli spettatori. Quindi tocca a Grifone che si lancia al combattimento e sconfigge tutti e otto i cavalieri. Norandino elegge Grifone vincitore. Irato con Martano, ma convinto da Orrilige i tre lasciano la città, ma a Grifone, addormentato, gli viene rubata l’armatura. Martano, con l’armatura del vincitore, si presenta dal re, ma Grifone si rende conto dell’inganno. Prende le armi, l’armatura ed il cavallo lasciati dal vile cavaliere e si mette subito in viaggio per abbandonare la città. Dall’alto di un castello il re riconosce però il cavaliere tanto deriso il giorno prima e Grifone, nascosto dall’armatura di Martano viene fatto prigioniero. Lasciato finalmente libero all’ingresso della città, Grifone si mostra pronto a vendicarsi dell’umiliazione e combattere nuovamente per il proprio onore.

Miniatura che introduce il canto XVIII
Quindi il XVIII libro si apre con Grifone, acceso d’ira per il disonore subito, che fa strage degli abitanti di Damasco. Si torna immediatamente a Parigi, dove re Carlo si lancia contro Rodomonte insieme al suo seguito di paladini e cavalieri. Ma la corazza del pagano, costruita con scaglie di drago, resiste a qualsiasi colpo e Rodomonte non subisce alcuna fatica. Accortosi però che, pur uccidendone molti, nuovi avversari si accalcano intorno a lui, Rodomonte si apre una via a colpi di spada e lascia infine la città buttandosi nel fiume. Ma quando esce dall’acqua, dispiaciuto per non aver distrutto la città, sta per tornare indietro, quando Discordia lo informa che la propria donna è stata rapita da Mandricardo. Allora il feroce saraceno decide subito di partire alla ricerca della donna. Intanto a Parigi, allontanato Rodomonte dalla città, re Carlo esce dalle mura e assale la retroguardia dell’esercito saraceno, che si trova tra due fuochi, essendo l’altro fronte battuto dai cavalieri cristiani Lucarnio, Zerbino e soprattutto Rinaldo. Ma Ferraù e Dardinello incitano i compagni saraceni alla battaglia; Dardinello uccide Lucarnio, ma sarà Rinaldo a vendicarlo. Si torna a Damasco dove re Norandino, visto il valore di quel cavaliere che su consiglio di Orrilige e Martano aveva esposto alla pubblica umiliazione, si accorge dell’errore commesso e chiede quindi scusa a Grifone e placa così l’ira del cristiano (sfinito dal combattimento ed anche ferito in più punti). Il cavaliere viene quindi accolto nel palazzo reale. Astolfo e Aquilante, che sono alla ricerca di Grifone, vengono infine anche loro a sapere che Orrilige, la donna da lui amata, ha abbandonato Constantinopoli, dove lui l’aveva lasciata, per seguire il suo nuovo amante Martano. Aquilante parte subito per l’Antiochia, quindi per Damasco e sulla sua via incontra infine Martano con le armi, l’armatura ed il cavallo dal fratello Grifone. Aquilante temendo per la vita del fratello, minaccia i due di morte se non gli raccontano subito l’accaduto. Martano credendo di ridurre le proprie colpe, dice di essere il fratello della donna e di aver sottratto con l’astuzia armi. Il cavaliere cristiano sa però che i due sono amanti e non fratelli, li lega entrambi e li trascina quindi con sé fino a Damasco. Nella città tutti hanno saputo da Grifone il vero corso degli avvenimenti e quindi i due malvagi vengono rinchiusi in prigione. Re Norandino per ripagare ulteriormente Grifone del torto subito fa bandire un’altra giostra in suo onore; la notizia del torneo si sparge ovunque, fino in Palestina. Sansonetto e Zerbino, saputo del torneo, partono a cavallo per raggiungere Damasco. Incontrano durante il viaggio Marfisa, una donna tanto valorosa in combattimento da aver fatto faticare gli stessi Orlando e Rinaldo; si unisce a loro per mostrare il proprio valore partecipando alla giostra organizzata da re Norandino. Il premio è costituito da un destriero e da altre armi (convinto della vittoria di Grifone, Norandino voleva donargli il completo da cavaliere) che vengono messe in bella mostra insieme all’armatura già vinta da Grifone. Marfisa riconosce nell’armatura esposta quella che, per poter inseguire Brunello, le era stata rubata. La donna si impossessa subito di ciò che era stato suo ed inizia una feroce battaglia. Marfisa si apre con la spada un via di fuga tra l’ira dei cittadini, ma dopo essersi riconosciuti, Marfisa spiega loro, e poi anche al re Norandino, la ragione del suo gesto. Tornata quindi la pace e terminata la giostra tutti e cinque i cavalieri partono infine via mare per la Francia. La loro nave verrà però sorpresa da una tempesta poco dopo aver lasciato l’isola di Cipro. Nella battaglia tra saraceni e cristiani Rinaldo lancia il proprio cavallo Baiardo contro Dardinello. Tutti i soldati saraceni rimangono impietriti dalla paura vedendo con quanta ferocia il paladino, la cui spada era molto temuta, si scagli contro Dardinello, che rimane ucciso poco dopo. Quel giorno, infatti, viene fatta strage dell’esercito saraceno e solo la ritirata lo salva dal suo completo annientamento. L’esercito cristiano, guidato da Re Carlo, si accampa all’esterno dell’insediamento avversario. Tra i molti arabi che piangono amici o parenti morti quel giorno, ci sono Cloridano e Medoro, senza pari per bellezza in tutto l’esercito pagano, che piangono la morte dell’amato Dardinello.
CLORIDANO E MEDORO
(XVIII, 165-192)
Duo Mori ivi fra gli altri si trovaro,
d’oscura stirpe nati in Tolomitta;
de’ quai l’istoria, per esempio raro
di vero amore, è degna esser descritta.
Cloridano e Medor si nominaro,
ch’alla fortuna prospera e alla afflitta
aveano sempre amato Dardinello,
ed or passato in Francia il mar con quello.
Cloridan, cacciator tutta sua vita,
di robusta persona era ed isnella:
Medoro avea la guancia colorita
e bianca e grata ne la età novella;
e fra la gente a quella impresa uscita
non era faccia più gioconda e bella:
occhi avea neri, e chioma crespa d’oro:
angel parea di quei del sommo coro.
Erano questi duo sopra i ripari
con molti altri a guardar gli alloggiamenti,
quando la Notte fra distanze pari
mirava il ciel con gli occhi sonnolenti.
Medoro quivi in tutti i suoi parlari
non può far che ’l signor suo non rammenti,
Dardinello d’Almonte, e che non piagna
che resti senza onor ne la campagna.

Medoro con il corpo del suo re
Volto al cornpagno, disse: «O Cloridano,
io non ti posso dir quanto m’incresca
del mio signor, che sia rimaso al piano,
per lupi e corbi, ohimé! troppo degna esca.
Pensando come sempre mi fu umano,
mi par che quando ancor questa anima esca
in onor di sua fama, io non compensi
né sciolga verso lui gli oblighi immensi.
Io voglio andar, perché non stia insepulto
in mezzo alla campagna, a ritrovarlo:
e forse Dio vorrà ch’io vada occulto
là dove tace il campo del re Carlo.
Tu rimarrai; che quando in ciel sia sculto
ch’io vi debba morir, potrai narrarlo:
che se Fortuna vieta sì bell’opra,
per fama almeno il mio buon cor si scuopra.»
Stupisce Cloridan, che tanto core,
tanto amor, tanta fede abbia un fanciullo:
e cerca assai, perché gli porta amore,
di fargli quel pensiero irrito e nullo;
ma non gli val, perch’un sì gran dolore
non riceve conforto né trastullo.
Medoro era disposto o di morire,
o ne la tomba il suo signor coprire.
Veduto che nol piega e che nol muove,
Cloridan gli risponde: «E verrò anch’io,
anch’io vuo’ pormi a sì lodevol pruove,
anch’io famosa morte amo e disio.
Qual cosa sarà mai che più mi giove,
s’io resto senza te, Medoro mio?
Morir teco con l’arme è meglio molto,
che poi di duol, s’avvien che mi sii tolto.»
Così disposti, messero in quel loco
le successive guardie, e se ne vanno.
Lascian fosse e steccati, e dopo poco
tra’ nostri son, che senza cura stanno.
Il campo dorme, e tutto è spento il fuoco,
perché dei Saracin poca tema hanno.
Tra l’arme e’ carriaggi stan roversi,
nel vin, nel sonno insino agli occhi immersi.
Fermossi alquanto Cloridano, e disse:
«Non son mai da lasciar l’occasioni.
Di questo stuol che ’l mio signor trafisse,
non debbo far, Medoro, occisioni?
Tu, perché sopra alcun non ci venisse,
gli occhi e l’orecchi in ogni parte poni;
ch’io m’offerisco farti con la spada
tra gli nimici spaziosa strada.»

Gustave Doré: Medoro che trascina il corpo di Dardanello
Cloridano e Medoro s’inoltrano dunque nell’accampamento cristiano, immerso nel silenzio e nel sonno, e fanno strage dei nemici, fino a giungere a ridosso del padiglione di Carlo, circondato e protetto dai paladini.
Gl’insidiosi ferri eran vicini
ai padiglioni che tiraro in volta
al padiglion di Carlo i paladini,
facendo ognun la guardia la sua volta;
quando da l’empia strage i Saracini
trasson le spade, e diero a tempo volta;
ch’impossibil lor par, tra sì gran torma,
che non s’abbia a trovar un che non dorma.
E ben che possan gir di preda carchi,
salvin pur sé, che fanno assai guadagno.
Ove più creda aver sicuri i varchi
va Cloridano, e dietro ha il suo compagno.
Vengon nel campo, ove fra spade ed archi
e scudi e lance in un vermiglio stagno
giaccion poveri e ricchi, e re e vassalli,
e sozzopra con gli uomini i cavalli.
Quivi dei corpi l’orrida mistura,
che piena avea la gran campagna intorno,
potea far vaneggiar la fedel cura
dei duo compagni insino al far del giorno,
se non traea fuor d’una nube oscura,
a’ prieghi di Medor, la Luna il corno.
Medoro in ciel divotamente fisse
verso la Luna gli occhi, e così disse:
«O santa dea, che dagli antiqui nostri
debitamente sei detta triforme;
ch’in cielo, in terra e ne l’inferno mostri
l’alta bellezza tua sotto più forme,
e ne le selve, di fere e di mostri
vai cacciatrice seguitando l’orme;
mostrami ove ’l mio re giaccia fra tanti,
che vivendo imitò tuoi studi santi.»
La luna a quel pregar la nube aperse
(o fosse caso o pur la tanta fede),
bella come fu allor ch’ella s’offerse,
e nuda in braccio a Endimion si diede.
Con Parigi a quel lume si scoperse
l’un campo e l’altro; e ’l monte e ’l pian si vede:
si videro i duo colli di lontano,
Martire a destra, e Lerì all’altra mano,
Rifulse lo splendor molto più chiaro
ove d’Almonte giacea morto il figlio.
Medoro andò, piangendo, al signor caro;
che conobbe il quartier bianco e vermiglio:
e tutto ’l viso gli bagnò d’amaro
pianto, che n’avea un rio sotto ogni ciglio,
in sì dolci atti, in sì dolci lamenti,
che potea ad ascoltar fermare i venti.
Ma con sommessa voce e a pena udita;
non che riguardi a non si far sentire,
perch’abbia alcun pensier de la sua vita,
più tosto l’odia, e ne vorrebbe uscire:
ma per timor che non gli sia impedita
l’opera pia che quivi il fe’ venire.
Fu il morto re sugli omeri sospeso
di tramendui, tra lor partendo il peso.
Vanno affrettando i passi quanto ponno,
sotto l’amata soma che gl’ingombra.
E già venìa chi de la luce è donno
le stelle a tor del ciel, di terra l’ombra;
quando Zerbino, a cui del petto il sonno
l’alta virtude, ove è bisogno, sgombra,
cacciato avendo tutta notte i Mori,
al campo si traea nei primi albori.
E seco alquanti cavallieri avea,
che videro da lunge i dui compagni.
Ciascuno a quella parte si traea,
sperandovi trovar prede e guadagni.
«Frate, bisogna (Cloridan dicea)
gittar la soma, e dare opra ai calcagni;
che sarebbe pensier non troppo accorto,
perder duo vivi per salvar un morto.»
E gittò il carco, perché si pensava
che ’l suo Medoro il simil far dovesse:
ma quel meschin, che ’l suo signor più amava,
sopra le spalle sue tutto lo resse.
L’altro con molta fretta se n’andava,
come l’amico a paro o dietro avesse:
se sapea di lasciarlo a quella sorte,
mille aspettate avria, non ch’una morte.
Quei cavallier, con animo disposto
che questi a render s’abbino o a morire,
chi qua chi là si spargono, ed han tosto
preso ogni passo onde si possa uscire.
Da loro il capitan poco discosto,
più degli altri è sollicito a seguire;
ch’in tal guisa vedendoli temere,
certo è che sian de le nimiche schiere.
Era a quel tempo ivi una selva antica,
d’ombrose piante spessa e di virgulti,
che, come labirinto, entro s’intrica
di stretti calli e sol da bestie culti.
Speran d’averla i duo pagan sì amica,
ch’abbi a tenerli entro a’ suoi rami occulti.
Ma chi del canto mio piglia diletto,
un’altra volta ad ascoltarlo aspetto.
Lì insieme agli altri si trovarono anche due arabi, nati nella Tolometta, di sconosciuta stirpe, la storia dei quali, come raro esempio di vero amore, è degna di essere raccontata. Cloridano e Medoro erano i loro nomi, sia nella buona che nella cattiva sorte avevano sempre avuto a cuore Dardinello, ed avevano quindi poi attraverso con lui il mare per giungere in Francia. // Cloridano, cacciatore da quando era nato, era una persona forte e snella: Medoro aveva le guancie colorite, bianche e leggiadre della prima giovinezza; e tra le persone accorse dall’Africa per partecipare a quella impresa non vi era viso più bello ed allegro: aveva occhi neri, e capelli riccioli color oro: sembra un angelo, Serafino, appartenente alla gerarchia più elevata. // Si trovavano entrambi sopra le fortificazioni, insieme a molti altri, a difesa degli alloggiamenti, quando la notte, a metà del suo corso, guardava ormai il cielo con occhi sonnolenti. Medoro, tra tutti gli argomenti di discussione non può fare a meno di ricordare il proprio signore, Dardinello figlio di Almonte, e non riesce a non piangere per il fatto che resti senza degna sepoltura sul campo di battaglia. // Rivolto al compagno disse quindi: «Oh Cloridano, io non riesco ad esprimere quanto mi dispiaccia della sorte capitata al mio signore, rimasto abbandonato sul terreno, per i lupi ed i corvi, ahimè, cibo troppo nobile. Pensando a quanto è stato sempre buono nei miei confronti, mi sembra che se anche dovessi morire per salvare l’onore della sua buona reputazione, non potrei compensare né sciogliere gli immensi obblighi che ho nei suoi confronti. // Io voglio andare a cercarlo, affinché non rimanga insepolto in mezzo alla campagna: e forse Dio vorrà aiutarmi, tenendomi nascosto mentre procedo attraverso l’accampamento, immerso nel sonno, di re Carlo. Tu invece rimarrai qui: perché se in cielo è scritto che io debba morire durante tale impresa, potrai tu comunque raccontarla: così che, se la Fortuna non permetterà una così bella opera, il mio buon cuore possa essere reso noto almeno a voce». Cloridano si stupisce che così tanto cuore, tanto amore, tanta fedeltà, possa avere un ragazzo: cerca quindi in ogni modo, intenerito da lui, di rendere quel suo pensiero vano, incompiuto; ma non ci riesce, perché un così grande dolore non può ricevere conforto né subire distrazione. Medoro aveva deciso o di morire o di seppellire in una degna tomba il suo signore. // Visto che non riesce né a piegare né a smuovere la sua volontà, Cloridano gli risponde: «Verrò allora anche io con te, anche io voglio intraprendere una tanto lodevole prova, anche io desidero ed amo una morte tanto gloriosa. Quale cosa potrà mai giovarmi di più, se io dovessi restare senza di te, mio caro Medoro? Morire con le armi insieme a te è molto meglio che farlo per il dolore, se dovesse accadere che tu mi sia tolto, tu muoia». Così decisi, misero al loro posto su quel bastione le guardie del turno successivo, e se ne andarono. Superano fossati e trincee, e dopo poco sono tra i soldati cristiani, che non mostrano nessuna preoccupazione. Tutto l’accampamento dorme, tutti i fuochi sono spenti, perché hanno poca paura dei saraceni. Stanno rovesciati tra le armi ed i carri, ubriachi, immersi in un sonno profondo. Cloridano si fermò un poco e disse: «Le occasioni, quando si presentano, non sono mai da lasciare. Di questo esercito, che ha trafitto ed ucciso il mio signore, non devo fare, Medoro, strage? Tu, affinché nessuno ci giunga addosso, poni orecchie ed occhi da ogni parte; che io mi offro di farti con la mia spada una spaziosa via di passaggio tra i nemici».
(…)
Le minacciose spade di Cloridano e Medoro erano ormai vicine ai padiglioni che i paladini avevano allestito tutt’intorno al padiglione principale di re Carlo, così da poter fare ognuno, a turno, la guardia; a quel punto i saraceni ritirarono le loro spade dal compiere la crudele strage, e tornarono quindi indietro in tempo; perché a loro sembra impossibile, in mezzo a così tanta gente, non tro-vare infine uno che in realtà non dorma. // E sebbene possano anche andarsene carichi di bottino, pensino piuttosto salvare se stessi, perché sarebbe un grande guadagno. Cloridano procede dove crede di avere il più sicuro passaggio, dietro sé ha il proprio compagno. Giungono sul campo di battaglia, dove tra spade ed archi e scudi e lance, in una pozza rossa sangue, giacciono morti poveri e ricchi, re e semplici vassalli, ed i cavalli sottosopra con i loro cavalieri. // Quell’orribile ammasso intricato di corpi, che riempiva in ogni luogo tutta la vasta campagna, avrebbe potuto vanificare il fedele proposito di ritrovare Dardinello, dei due compagni, fino alla mattina del giorno seguente, se la Luna non avesse tratto fuori da una scura nube, come da preghiere di Medoro, la sua falce luminosa. Medoro con devozione fissò in cielo, verso la luna, i propri occhi, e così si pronunciò: // «Oh santa Dea, che dai nostri antenati sei stata giustamente detta triforme (Dea di cielo, terra ed inferno); che nel cielo, sulla terra e nel profondo inferno mostri la tua suprema bellezza sotto più forme, e nelle selve, animali selvaggi e mostri vai cacciando, nelle vesti di Diana, seguendone le orme; indicami il punto dove giace in mezzo a tanti altri il mio re, che da vivo si dedicò all’attività sacra a te consacrata, la caccia. // A quelle preghiere la Luna aprì la scura nube che la nascondeva (fosse stato un puro caso o altrimenti la tanta fede mostrata da Medoro), e si mostrò bella come lo fu quando offrì sé stessa, e si abbandonò nuda tra le braccia di Endimione. A quella luce Parigì venne scoperta, resa visibile, insieme ad entrambi gli accampamenti; furono visibili il monte e la pianura: si videro i due colli lontani, Montmartre sulla destra e Montlhery sulla sinistra. // Lo splendore della Luna fu più vivo laddove giaceva morto il corpo di Dardinello, figlio di Almonte. Medoro andò, piangendo, nei pressi del suo caro signore: del quale riconobbe l’insegna a riquadri bianchi e rossi: e gli bagnò tutto il viso con le lacrime del suo doloroso pianto, che gli rigava il viso, come un fiume, sotto entrambi gli occhi, con così dolci gesta, con così dolci lamenti, che ad ascoltarlo avrebbe potuto fermare i venti per la compassione. // Ma si lamenta con una voce bassa ed a malapena udibile; non perché si guardi bene dall’essere udito, avendo preoccupazione per la salvezza della sua propria vita, al contrario, infatti, la odia e vorrebbe abbandonarla: lo fa per la paura che gli possa essere impedito il compimento di quella opera pia che la ha fatto andare fino a quel luogo. Il corpo morto del loro re fu sollevato sulle spalle di entrambi, così da dividere il peso tra di loro. // Procedono quindi affrettando quanto possono i loro passi, sotto il caro peso che li ostruisce. Già sopraggiungeva il sole, signore della luce, a togliere le stelle dal cielo, e l’ombra dalla terra; quando Zerbino, al quale libera il petto dal sonno, nel momento del bisogno, la suprema virtù che possiede, avendo dato la caccia tutta la notte ai nemici, ritorna, con le prime luci del giorno, all’accampamento. // E con sé aveva al seguito un buon numero di cavalieri, che da lontano videro subito i due compagni, Medoro e Cloridano. Ognuno dei cavalieri si dirigeva da quella parte, verso di loro, sperando di poter trovare un bottino ed un guadagno. Disse Cloridano: «Fratello, bisogna gettare il peso che portiamo e darsi alla fuga; sarebbe al contrario un’idea non troppo astuta perdere due persone vive per salvarne una morta». // E gettò quindi il carico, pensando che il suo caro Medoro dovesse fare altrettanto: ma quel meschino, che amava il suo signore più di sé stesso, tenne invece tutto il peso sopra le proprie spalle. Cloridano di tutta fretta si mise in fuga, come se avesse avuto l’amico o al fianco od almeno dietro di sé: se si fosse reso conto di averlo abbandonato a quella sorta, avrebbe atteso senza alcuna cura non una morte, ma mille. // Quei cavalieri, con l’animo risoluto che i due si debbano arrendere o altrimenti morire, chi da una parte e chi dall’altra, si sparpagliano, e subito bloccano ogni possibile via di fuga. Poco lontano da loro, il loro capitano si lancia all’inseguimento anche più velocemente degli altri; poiché vedendoli così agire spinti dalla paura, è certo che entrambi appartengano all’esercito nemico. // C’era a quel tempo lì vicino una antica selva, fitta di piante ombrose e di giovani arbusti, che, alla pari di un labirinto, al suo interno si avvolge su stretti sentieri frequentati solo da bestie. I due pagani sperano possa essere tanto loro amica da riuscire a tenerli nascosti tra i suoi rami intricati. Ma chi trova piacere dal mio raccontare, e vuole saperne di più, dovrà aspettare ancora prima di poterlo nuovamente ascoltare.
Il canto seguente, il XIX, dopo una piccola introduzione sulla fedeltà (su cui Ariosto, con un sorriso, sembra alludere a se stesso riguardo al suo “padrone”), riprende la storia di Cloridano e Medoro:
LA MORTE DI CLORIDANO
(XIX, 3-16)
Cercando già nel più intricato calle
il giovine infelice di salvarsi;
ma il grave peso ch’avea su le spalle,
gli facea uscir tutti i partiti scarsi.
Non conosce il paese, e la via falle,
e torna fra le spine a invilupparsi.
Lungi da lui tratto al sicuro s’era
l’altro, ch’avea la spalla più leggiera.
Cloridan s’è ridutto ove non sente
di chi segue lo strepito e il rumore:
ma quando da Medor si vede absente,
gli pare aver lasciato a dietro il core.
«Deh, come fui – dicea – sì negligente,
deh, come fui sì di me stesso fuore,
che senza te, Medor, qui mi ritrassi,
né sappia quando o dove io ti lasciassi!»
Così dicendo, ne la torta via
de l’intricata selva si ricaccia;
ed onde era venuto si ravvia,
e torna di sua morte in su la traccia.
Ode i cavalli e i gridi tuttavia,
e la nimica voce che minaccia:
all’ultimo ode il suo Medoro, e vede
che tra molti a cavallo è solo a piede.

Medoro in mezzo ai soldati irlandesi
Cento a cavallo, e gli son tutti intorno:
Zerbin commanda e grida che sia preso.
L’infelice s’aggira com’un torno,
e quanto può si tien da lor difeso,
or dietro quercia, or olmo, or faggio, or orno,
né si discosta mai dal caro peso.
L’ha riposato al fin su l’erba, quando
regger nol puote, e gli va intorno errando:
come orsa, che l’alpestre cacciatore
ne la pietrosa tana assalita abbia,
sta sopra i figli con incerto core,
e freme in suono di pietà e di rabbia:
ira la ’nvita e natural furore
a spiegar l’ugne e a insanguinar le labbia;
amor la ’ntenerisce, e la ritira
a riguardare ai figli in mezzo l’ira.
Cloridan, che non sa come l’aiuti,
e ch’esser vuole a morir seco ancora,
ma non ch’in morte prima il viver muti,
che via non truovi ove più d’un ne mora;
mette su l’arco un de’ suoi strali acuti,
e nascoso con quel sì ben lavora,
che fora ad uno Scotto le cervella,
e senza vita il fa cader di sella.
Volgonsi tutti gli altri a quella banda
ond’era uscito il calamo omicida.
Intanto un altro il Saracin ne manda,
perché ’l secondo a lato al primo uccida;
che mentre in fretta a questo e a quel domanda
chi tirato abbia l’arco, e forte grida,
lo strale arriva e gli passa la gola,
e gli taglia pel mezzo la parola.
Or Zerbin, ch’era il capitano loro,
non poté a questo aver più pazienza.
Con ira e con furor venne a Medoro,
dicendo: «Ne farai tu penitenza».
Stese la mano in quella chioma d’oro,
e strascinollo a sé con violenza:
ma come gli occhi a quel bel volto mise,
gli ne venne pietade, e non l’uccise.
Il giovinetto si rivolse a’ prieghi,
e disse: «Cavallier, per lo tuo Dio,
non esser sì crudel, che tu mi nieghi
ch’io sepelisca il corpo del re mio.
Non vo’ ch’altra pietà per me ti pieghi,
né pensi che di vita abbi disio:
ho tanta di mia vita, e non più, cura,
quanta ch’al mio signor dia sepultura.
E se pur pascer vòi fiere ed augelli,
che ’n te il furor sia del teban Creonte,
fa lor convito di miei membri, e quelli
sepelir lascia del figliuol d’Almonte».
Così dicea Medor con modi belli,
e con parole atte a voltare un monte;
e sì commosso già Zerbino avea,
che d’amor tutto e di pietade ardea.
In questo mezzo un cavallier villano,
avendo al suo signor poco rispetto,
ferì con una lancia sopra mano
al supplicante il delicato petto.
Spiacque a Zerbin l’atto crudele e strano;
tanto più, che del colpo il giovinetto
vide cader sì sbigottito e smorto,
che ’n tutto giudicò che fosse morto.
E se ne sdegnò in guisa e se ne dolse,
che disse: «Invendicato già non fia!»
e pien di mal talento si rivolse
al cavallier che fe’ l’impresa ria:
ma quel prese vantaggio, e se gli tolse
dinanzi in un momento, e fuggì via.
Cloridan, che Medor vede per terra,
salta del bosco a discoperta guerra.

Immagine di un’edizione illustrata dell’Orlando Furioso
E getta l’arco, e tutto pien di rabbia
tra gli nimici il ferro intorno gira,
più per morir, che per pensier ch’egli abbia
di far vendetta che pareggi l’ira.
Del proprio sangue rosseggiar la sabbia
fra tante spade, e al fin venir si mira;
e tolto che si sente ogni potere,
si lascia a canto al suo Medor cadere.
Seguon gli Scotti ove la guida loro
per l’alta selva alto disdegno mena,
poi che lasciato ha l’uno e l’altro Moro,
l’un morto in tutto, e l’altro vivo a pena.
Giacque gran pezzo il giovine Medoro,
spicciando il sangue da sì larga vena,
che di sua vita al fin saria venuto,
se non sopravenia chi gli diè aiuto.
Il giovane infelice andava allora cercando nei sentieri più intricati di salvarsi; ma il pesante carico che aveva sulle spalle, rendeva vani tutti i suoi tentativi. Non conosce quei luoghi, e sbaglia la via, tornando ad avvolgersi nei rovi. Lontano da lui si era invece messo al sicuro Cloridano, avendo la spalla più leggera, senza pesi da sostenere. // Cloridano si è rifugiato in un luogo dal quale non può sentire il rumore egli schiamazzi di chi è al suo inseguimento: ma quando si accorge che Medoro non è più con lui, gli sembra di avere lasciato indietro il proprio cuore. Diceva a sé stesso: «Come sono stato tanto negligente, come ho perso il controllo di me stesso, che mi sono trovato ad essere senza di te, Medoro, qui, senza neppure sapere quando e dove ti ho lasciato!» // Così dicendo, si ributta nell’attorcigliato sentiero di quell’intricata selva; riavviandosi verso il punto da dove era venuto, e torna sulle tracce che condurranno alla sua morte. Sente continuamente il rumore dei cavalli, le urla dei cavalieri, ed i nemici che pronunciano minacce: infine sente il suo Medoro, e lo vede, tra molti altri a cavallo, unico a piedi. // Ce ne sono cento a cavallo e sono tutti intorno a lui: Zerbino comanda i cavalieri e grida loro l’ordine di catturarlo. L’infelice Medoro si aggira come un tornio, e quanto può cerca di difendersi da loro, ora dietro una quercia, ora un olmo, ora un faggio ed ora un ornello, senza mai separarsi dal caro peso che porta sulle spalle. Alla fine lo posa nuovamente sull’erba, quando non può più reggerne il peso, e gli gira intorno, vagando senza meta: // come un orsa, che il cacciatore di montagna abbia sorpreso nella sua tana di pietra, si pone con animo combattuto sopra i propri figli, e si agita con frastuono tra l’amore per i cuccioli e la ferocia per il cacciatore: spinta dall’ira e dal suo furore innato a tirar fuori le unghie ed a voler insanguinare le labbra; l’amore la intenerisce e la fa indietreggiare, nel mezzo dell’ira, per guardare con attenzione ai propri figli. // Cloridano, che non sa come poter essere d’aiuto a Medoro, e che vuole essere al suo fianco anche nella morte, ma non vuole che il suo vivere sia trasformato in morte prima di aver trovato il modo di uccidere più di un nemico: pone nell’arco una delle sue frecce acuminate, e, rimanendo nascosto, fa con quell’arma un lavoro tanto buono, che trapassa le cervella ad un nemico Scozzese, e lo fa quindi cadere morto da cavallo. // Tutti gli altri volgono lo sguardo da quella parte dalla quale era arrivato il dardo omicida. Il saraceno intanto ne lancia un altro, per uccidere un secondo nemico, quello a lato del primo caduto morto; e mentre costui in tutta fretta domanda in giro chi abbia tirato con l’arco, gridando forte, arriva la freccia e gli trapassa la gola, e la parola gli interrompe a metà. // Ora Zerbino, che era il loro capitano, non poté a quel punto avere più pazienza. Con ira e con furore si avvicinò a Medoro, dicendo: «Ne pagherai tu le conseguenze». Allungò la mano afferrando la sua bionda chioma e lo trascinò a sé con violenza: ma non appena pose i propri occhi su quel bel volto, non poté fare a meno di provare pietà per lui, e non lo uccise. // Il giovane ragazzo ricorse alle preghiere, e disse: «Cavaliere, in nome del tuo Dio, non essere tanto crudele da impedire che io possa dare degna sepoltura al corpo del mio re. Non voglio che nessun altra pietà nei miei confronti pieghi la tua volontà, né voglio che tu possa pensare che abbia solo il desiderio di poter vivere: ho tanta cura della mia vita, niente di più, quanta ne basta per poter dare sepoltura al mio signore. // E se vuoi invece nutrire fiere ed uccelli, lasciando il corpo insepolto, perché vi è in te la collera del tebano Creonte, che impedì la sepoltura dei nemici morti, fa banchettare loro con le mie membra, e quelle del figliolo di Almonte lascia invece che vengano seppellite». Così pronunciò Medoro con belle maniere, e con parole adatte a smuovere anche una montagna; ed aveva talmente commosso Zerbino, che costui ormai ardeva tutto d’amore e di pietà. // Ma nel frattempo, un cavaliere maleducato, dimostrando poco rispetto nei confronti del suo signore, con una lancia impugnata al di sopra della spalla, ferì il petto delicato del supplicante Medoro. L’atto crudele e barbaro non piacque a Zerbino; tanto più che, per il colpo ricevuto, vide cadere il giovane ragazzo tanto smorto e con espressione tanto impaurita, che credette fosse morto. // E si indignò per l’atto e se ne addolorò in tale misura, che disse: «Non rimarrà ora senza vendetta!» e pieno di sdegno si rivolse al cavaliere che aveva compiuto quell’atto malvagio: ma costui agì d’anticipo, gli si tolse da davanti in un attimo e fuggì via. Cloridano, che vede ora Medoro giacere in terra, salta fuori dal bosco per combattere allo scoperto. // Getta l’arco, e tutto pieno di rabbia agita la propria spada in mezzo ai nemici, più per trovare anch’esso la morte, che con l’intenzione di ottenere una qualche vendetta che possa compensare la sua ira. Vede la sabbia divenire rossa del proprio sangue, tra tante spade nemiche, e si vede ormai in fin di vita; vedendosi tolta ogni forza, si lascia quindi cadere accanto al suo Medoro. // Gli scozzesi proseguono dove il loro comandante Zerbino per la profonda selva, viene condotto dal suo nobile sdegno, dopo che ha lasciato sul campo l’uno e l’altro moro, uno completamente morto e l’altro con molta poca vita. Giaceva in terra già da molto tempo il giovane Medoro, perdendo sangue dalla tanto profonda ferita, che la sua vita, alla fine, avrebbe perduto, se non fosse sopraggiunto chi poi gli diede aiuto.

I corpi distesi di Cloridano, Medoro e Dardanello mentre i soldati vanno via
E’ un passo fondamentale, quello di Cloridano e Medoro, perché troviamo in esso, per la prima volta nel poema, l’unitarietà “contenutistica” se non proprio tonale (infatti in esso troviamo più stili: tragico, ironico, idillico). Tale scelta sembra dipendere da una maggiore attenzione che il nostro sembra assumere nei confronti dei modelli: Eurialo e Niso dall’Eneide virgiliano e il meno famoso episodio di Opleo e Dimante dalla Tebaide di Stazio (anch’esso ispirato al noto passo dell’autore modenese): tuttavia vi sono alcune differenze: i primi appartenevano all’esercito di Enea, invece questi due sono saraceni, appartenenti all’esercito nemico; se nel poema virgiliano i giovani sono mossi da un medesimo intento (avvisare Enea che Turno ha cominciato ad assediare il loro campo), pur mostrando un’identico andamento, in Ariosto Medoro è spinto dall’amore verso il loro re, Cloridano dall’affetto che nutre verso il giovane ragazzo, ma in ambedue i poemi i due compagni addurranno la stessa motivazione, non lasciare da soli i loro amici). Simile ancora al modello latino il desiderio per una morte gloriosa: pulchram properet per volnera mortem (affrettare la bella morte nel sangue). Ariosto, quindi, proprio grazie al modello innalza il linguaggio e i riferimenti alle opere greche e latine (si veda il “matrimonio della luna con Endimione”, “Creonte che lascia insepolti i nemici”) ma non per questo abbandona completamente l’ironia si veda nell’episodio omesso della strage l’immagine di un uomo ubriaco, ironico già dal nome Grillo, che ucciso emette sangue con il vino come fosse una botte oppure dalla sottile osservazione secondo cui è difficilmente credibile che Cloridano non si accorga della mancanza di Medoro, quando quest’ultimo, per il peso del corpo del re, rimane indietro; ma l’utilizzo anche di uno stile elegiaco quando, rivolto alla luna, essa risponde splendendo sul piano al illuminare il corpo dell’amato re ed il pianto silenzioso affinché possa compiere il suo “cortese” gesto. Interessante è inoltre il mescolamento dei piani: l’attribuzione della cavalleria ai saraceni e della villania ai cristiani che si esemplifica nella sepoltura del re Dardinello e nella villania del cavaliere scozzese verso Medoro. Un’ultima cosa, infine: abbiamo sempre detto che dietro la fantasia ariostesca si nasconda sempre la verità: l’episodio di Cloridano e Medoro vuole “additare” il concetto di fedeltà ai cortigiani “apparentemente” legati al Signore, ma solo spinti dalla loro arroganza e vanità.

Giovan Battista Tiepolo: Angelica, Medoro e il pastore
Riprendendo la narrazione vediamo che a salvare Medoro sarà Angelica, vestita di panni umili ma con il solito aspetto regale, che giunge per caso là dove si trova il corpo del saraceno ferito. L’orgoglio della ragazza che le fa ritenere che nessuno sia all’altezza della sua compagnia fa sì che Amore, non potendo più tollerare questo suo comportamento, aspetti Angelica vicino al giovane, colpendola con una freccia e facendola sua prigioniera. Angelica cura la ferita di Medoro e convince un pastore, in-contrato lì vicino, ad aiutarli, dando loro ospitalità, ma prima bisogna dar sepoltura a Dardinello ed a Cloridano. Quanto più il giovane guarisce, tanto più Angelica, ferita da Amore, s’innamora di lui. I due sfogano infine la loro passione e Medoro ottiene così da Angelica ciò che nessun altro cavaliere era mai riuscito ad ottenere. Nella casa del pastore, per rendere legittima la loro unione, i due amanti si sposano. Passano più di un mese ad amoreggiare in ogni luogo e in ogni luogo lasciano la loro traccia. Angelica decide infine di ripartire con Medoro per fare ritorno in India e paga l’ospitalità del pastore donandogli il bracciale prezioso che aveva ricevuto da Orlando come pegno del suo amore. Mentre sono in viaggio, per poco non subiranno danni da un uomo completamente folle (Orlando) incontrato su una spiaggia.
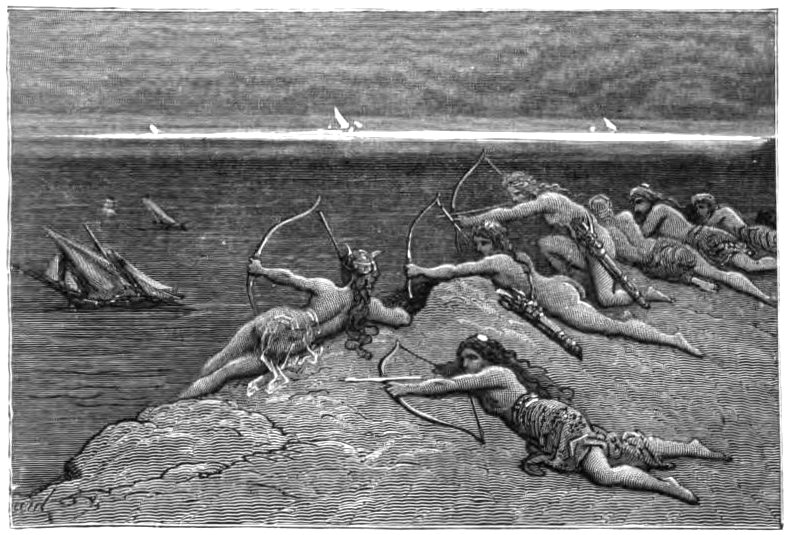 Le femmine omicide
Le femmine omicide
Nel frattempo i compagni, allontanatisi da Damasco, giungono sulle coste della città di Alessandretta, dove vivono femmine crudeli ed omicide, che uccidono o fanno prigioniero ogni uomo che giunga presso la loro terra e non riesca a superare una prova di valore: sconfiggere in combattimento dieci uomini e soddisfare a letto altrettante donne. Se vi riesce, allora avrà salva la vita ma dovrà comunque sposare dieci donne. Mentre decidono cosa fare, vengono fatti prigionieri: ad attenderli c’è Orontea, che espone le loro condizioni. I cavalieri accettano la sfida e vengono quindi condotti a terra. I cinque cavalieri estraggono a sorte la persona che dovrà sostenere entrambe le prove. Viene estratta Marfisa che viene quindi condotta nell’arena dove troverà i dieci cavalieri suoi avversari. Nove cavalieri si avventano subito su Marfisa, il decimo invece rimane in disparte, per non mancare di rispetto alle regole cavalleresche.
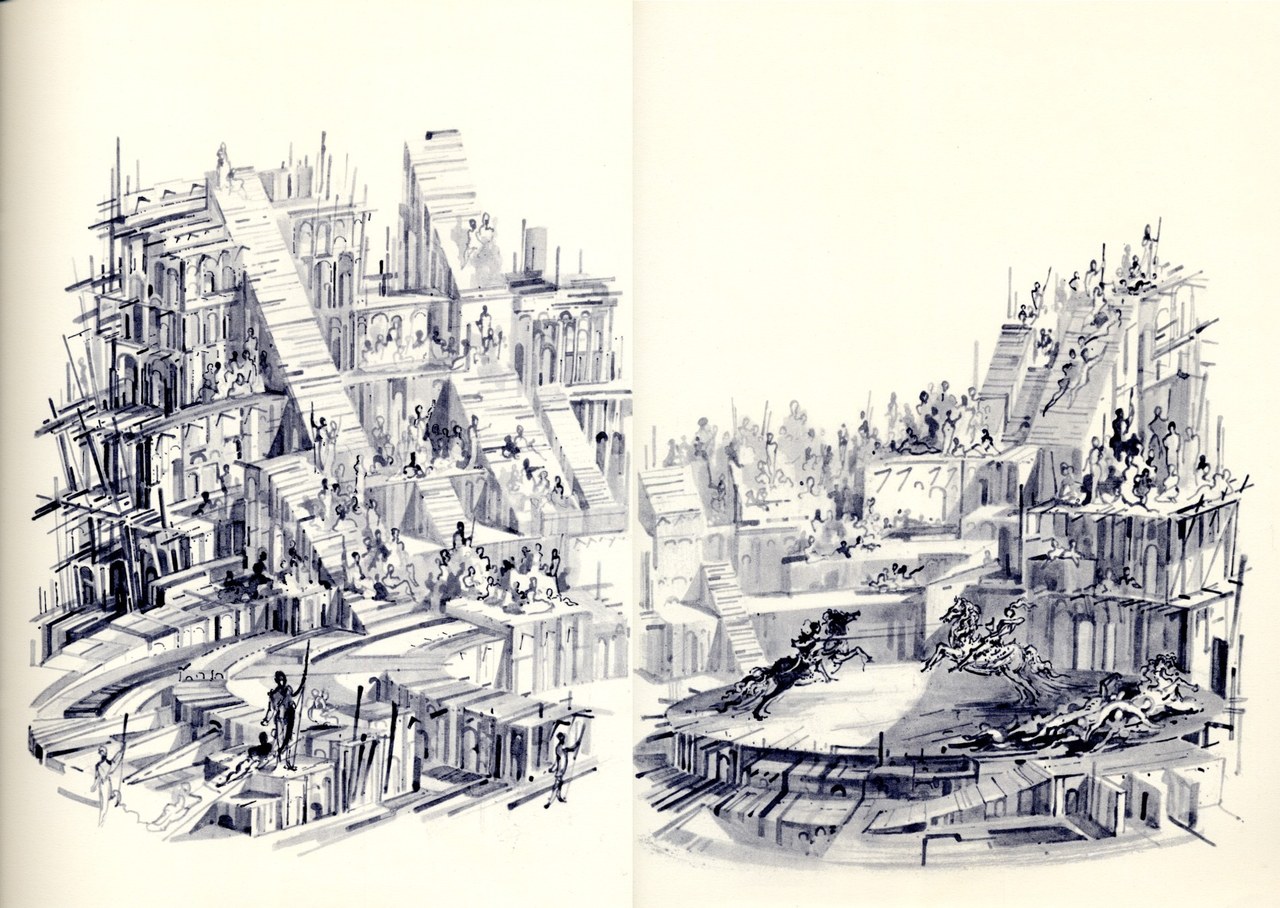 Fabrizio Clerici, Giostra sull’isola delle femmine omicide (1967)
Fabrizio Clerici, Giostra sull’isola delle femmine omicide (1967)
Marfisa infila tre avversari in un solo colpo servendosi della sua grossa lancia e, utilizzando la spada, fa poi strage degli altri sei. L’ultimo cavaliere giunge nel momento in cui il combattimento si può svolgere alla pari. Giunge però infine la notte ed il confronto viene sospeso. Il cavaliere misterioso si rivelerà un ragazzo di appena diciotto anni, che a sua volta si stupirà nel sapere che Marfisa è una donna.
Nel XX canto veniamo a sapere che il ragazzo è Guidon Selvaggio, di cui si scopre essere fratello di Rinaldo e cugino del duca Astolfo. Egli racconta la storia di Alessandretta: quando dopo dieci anni di assedio ed altrettanti anni di mare, i Greci lasciarono Troia per tornare in patria, trovarono le loro case piene di figli avuti dalle loro donne con nuovi giovani amanti. Non volendo mantenere figli non loro, i mariti mandarono i giovani a cercarsi fortuna altrove. Uno di questi venne assoldato dai Cretesi, insieme agli altri giovani del suo seguito per stare a guardia di Dictea. Le donne della città subito si innamorarono dei giovani greci, che diventarono loro amanti. Quindi, terminato l’incarico, i giovani ripartirono e le donne decisero di seguirli. Giungono così sulla spiaggia dove sorge ora Alessandretta. Ma i giovani greci abbandonarono in seguito le donne e ripartono per la Puglia, dove fondarono Taranto. Le donne, per vendicarsi del torto subito, decidisero quindi di assaltare ogni nave costretta a raggiungere il loro porto e di uccidere tutto l’equipaggio. Ma ciò le avrebbe portate all’estinzione: selezionarono perciò un piccolo gruppo ristretto di uomini come loro sposi. In seguito le crudeli regole di quella società iniziarono man mano ad essere meno dure fino ad arrivare a quella legge che anche i cinque cavalieri sono ora costretti a rispettare. Il giovane e tutti i cavalieri vorrebbero por fine alla crudele legge di Alessandretta: Marfisa propone al giovane di combattere fianco a fianco per fare un strage e distruggere la città. Il giovane propone invece di inviare la sua più fedele moglie, Aleria, a fare allestire una nave per la loro fuga e di fuggire quindi tutti insieme di nascosto. Tale decisione viene accettata da tutti. La nave viene allestita, ma i sei cavalieri, per raggiungere il porto, devono passare dalla piazza principale dove le donne della città si erano già riunite intorno all’arena per vedere la fine del combattimento. Capita la loro l’intenzione si muovono tutte per fermare la fuga, ma Astolfo, con il suo corno magico, le mette in fuga.

Immagine da un’edizione spagnola dell’Orlando Furioso in cui si illustra
Astolfo con il corno (1872)
Raggiungono fortunatamente il porto e salgono in fretta sulla nave, che subito prende il largo. Purtroppo Astolfo arriva sulla spiaggia quando la nave è già partita; non potrà pertanto fare altro che proseguire il viaggio per terra. Quattro cavalieri, tutti uniti, troveranno dimora nel castello di Pinabello di Maganza, che li farà suoi prigionieri approfittando del loro sonno. Marfisa, invece, proseguirà da sola il proprio viaggio ed incontrerà sul suo cammino una donna anziana, Gabrina, quella scappata dalla caverna dove Orlando aveva liberato Isabella. Marfisa prende la vecchia con sé ed incontra poi Pinabello insieme alla sua amata, crudele come il conte. Quest’ultima, vedendo Gabrina, la deride e Marfisa, per punirla, sfida Pinabello, lo sconfigge, e fa indossare alla vecchia tutti i vestiti e gli ornamenti della donna. Procedendo oltre, le due donne incontrano anche Zerbino. Anche il paladino non si può trattenere dal deridere Gabrina, la cui bruttezza veniva ulteriormente esaltata da tutti gli ornamenti che ora portava. I due cavalieri si sfidano: chi perde dovrà per sempre tenere la vecchia con sé. Zerbino viene disarcionato e quindi riparte in compagnia della vecchia. Gabrina, sebbene Zerbino non abbia detto nulla né di sé ne dell’amore per Isabella, capisce subito che il paladino è quel cavaliere del quale aveva tanto sentito parlare dalla ragazza. Zerbino dopo aver pregato ed anche minacciato invano la vecchia per sapere il luogo dove Isabella si trova, non può fare altro che ripartire in sua compagnia e condurla, come promesso a Marfisa, ovunque lei voglia. Incontreranno alla fine un cavaliere.
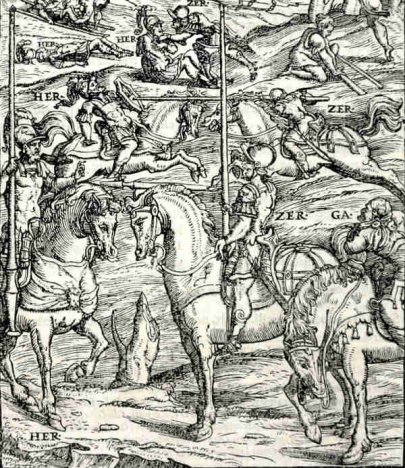
Zerbino incontra Ermione
Nel XXI sapremo che il cavaliere è Ermonide d’Olanda, al quale la vecchia aveva ucciso il padre ed anche l’unico fratello. Subito sfida Zerbino per vendicarsi di Gabrina, ma nello scontro il cavaliere olandese viene trafitto ad una spalla e cade a terra. Ermonide racconta quindi la propria storia, spiegando perché avesse tanto in odio quella vecchia. Il fratello, di nome Filandro, era stato accolto nel palazzo di un barone di nome Argeo, la cui moglie era appunto Gabrina. La donna iniziò a desiderare il fratello di Ermonide, ottenendone in risposta solo rifiuti. Rimasti soli nel palazzo, i continui tentativi della donna spinsero il giovane ad abbandonarsi. Gabrina racconta al marito di essere stata posseduta con la forza da Filandro che è poi scappato per paura. Argeo le crede, corre a vendicarsi, lo ferisce e lo fa prigioniero. Nonostante sia in prigione la donna continua a provocarlo. Filandro le risponde sempre con un rifiuto, ma un giorno, dopo che per sette mesi Gabrina non gli aveva più fatto visita, Argeo, d’accordo con la moglie, fa finta di partire per Gerusalemme così da poter sorprendere intorno al proprio castello il barone Morando, tanto odiato da Argeo ed amante di Gabrina.

Zerbino colpisce ad una spalla Ermonide d’Olanda
L’astuta donna corre da Filandro chiedendogli di intervenire per salvare il suo onore e quello del marito, proteggendola dal barone, così agendo potrà realmente dimostrare la propria fedeltà verso Argeo. Filandro quindi aspetta, nascosto nella camera di lei, che giunga Morando, ma la donna lo porta invece nella stanza del marito che trova così la morte. Gabrina, svelato l’inganno a Filandro, è alla fine costretto a sottomettersi al volere di lei, per fare poi ritorno in Olanda insieme alla donna. Tornato in patria, si ammala gravemente per tutta l’ira che aveva indosso. Gabrina, trasformato l’amore in odio, si mette d’accordo con un medico per avvelenare il giovane. Nel momento di somministrare il veleno, viene però meno all’accordo per non avere testimoni, e lo fa bere anche al medico. L’uomo prima di morire riesce però a raccontare ai presenti l’inganno organizzato da Garbina e la donna viene subito incarcerata. Ermonide d’Olanda non riesce purtroppo a proseguire il suo racconto; perché gli mancano le forze. Zerbino si scusa per il danno arrecato, ed infine i due, ripartono a cavallo e verso sera sentiranno i rumori di una battaglia.

Dopo una breve carrellata sulla guerra, il canto XXII si apre con Astolfo, a cui gli viene rubato il cavallo Rabicano. Corre all’inseguimento del ladro, raggiunge infine il castello di Atlante e vi entra seguendo il furfante. Accortosi di essere prigioniero di un luogo incantato, Astolfo fa ricorso al libro contro gli incantesimi e viene a sapere che per rendere vana la magia è necessario liberare un spirito rinchiuso sotto la soglia del castello. Atlante, si accorge del tentativo del cavaliere di rimuovere la pietra e liberare lo spirito, e quindi, con un incantesimo, lo fa apparire agli occhi degli altri suoi prigionieri nella forma di un mostro. Tutti i cavalieri prigionieri del castello di Atlante si avvicinano minacciosi al duca, che però si difende prontamente soffiando nel corno magico. Tutti fuggono terrorizzati dalla prigione incantata, compresi i cavalli e compreso anche lo stesso mago. Astolfo riesce a fermare la fuga di Rabicano, rientrandone in possesso, ma ritrova anche l’ippogrifo e, intenzionato ad impossessarsi del cavallo alato, decide di trovare qualcuno che sia disposto a seguirlo portando con sé Rabicano, così da condurlo in una città e poterlo dare in dono ad un suo amico. Rimane sul posto aspettando che passi qualcuno e vede infine arrivare un cavaliere. Nel frattempo, finalmente liberi, Bradamante e Ruggiero possono ora abbracciarsi e baciarsi. Lei invita il cavaliere a battezzarsi e a chiederla in sposa al padre; Ruggiero risponde di essere disposto a qualunque cosa per lei, e così i due amanti si dirigono dove poter fare battezzare il pagano.

Bradamante e Ruggiero incontrano una donna
Incontrano però sulla loro via una donna dal volto triste che dice loro che un ragazzo sarebbe stato ucciso quel giorno, perché, innamorato della figlia del re spagnolo Marsilio, incontrandola ogni notte, era stato scoperto. Bradamante, colpita da quella notizia, chiede di essere condotta all’interno delle mura, ma la donna dice loro su quella via si trova il castello di Pinabello che ha da poco istituito una legge, per vendicarsi dell’offesa recatagli quando la sua amante aveva deriso la vecchia Gabrina. Aquilante, Grifone, Sansonetto e Guidon Selvaggio, fatti prigionieri, riavranno la libertà facendo rispettare quella ingiusta legge per un anno ed un mese. Giunti alle porte del castello di Pinabello, avviene la sfida tra Ruggiero e Sansonetto, vinto dal primo grazie anche allo scudo magico; Pinabello si avvicina in quel momento a Bradamante per chiedere chi fosse il valoroso cavaliere suo compagno, ma la donna lo riconosce e sguaina così la spada. Lui fugge nella foresta ma è subito inseguito da lei. Intanto, sconfitto Sansonetto, dal castello escono gli altri tre cavalieri, che, secondo le regole e con vergogna, combatteranno ora tutti insieme contro Ruggiero. Durante uno scontro, il cristiano viene disarcionato e con la propria lancia strappa il velo che ricopre lo scudo magico; viene così liberato il grande splendore in grado di fare cadere tutti svenuti, e così succede anche in quel caso. Accortosi dell’accaduto, Ruggiero ricopre lo scudo con un altro velo, prende con sé la donna, ora tramortita, che li aveva guidati lì e riparte lungo la via. Bradamante nel frattempo ha raggiunto ed ucciso il conte Pinabello.
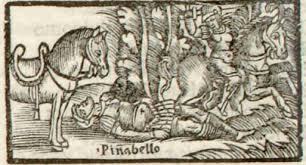
La morte di Pinabello
La donna non è riuscita però a ritrovare la strada per ritornare là dove aveva lasciato l’amante; vagherà pertanto a lungo nel bosco.

Con il canto XXIII ci troviamo nel centro del poema (e non casualmente). Bradamante, dopo aver ucciso Pinabello si accorge di non sapere più tornare dove ha lasciato Ruggiero. Alla sua ricerca, vaga in un bosco, fin quando il giorno dopo raggiunge il palazzo nel quale era stata tenuta prigioniera, per incantesimo, insieme ad altri cavalieri, ed incontra suo cugino Astolfo. Il paladino è ben contento di incontrare Bradamante, la miglior persona alla quale affidare Rabicano. Quindi le consegna il proprio destriero, l’armatura, e la lancia incantata, chiedendole il piacere di portarle a Montalbano affinché lui possa muoversi leggero nell’aria a cavallo dell’ippogrifo. Aiutata da un campagnolo, la donna riprende quindi il proprio viaggio con l’intenzione di ritrovare prima Ruggiero, e solo dopo fare ritorno a Montalbano, dove aveva la madre ed alcuni suoi fratelli ad aspettarla. Vagando per il bosco, si ritrova però subito nella sua città. Cerca di allontanarsi ma incontra suo fratello Alardo, che la conduce dalla madre e gli altri suoi fratelli. Bradamante allora invia Ippalca, alla ricerca di Ruggiero e per informarlo degli avvenimenti e chiedergli quindi di procedere nel battesimo per poi raggiungerla a Montalbano, affidandole anche Frontino, il cavallo di Ruggiero. Ma Ippalca incontra sulla propria via Rodomonte, il quale, non esita a rapire il destriero di Ruggero, vi sale in groppa e si rimette in viaggio.

Ippalca si imbatte in Rodomonte
Rodomonte chiede ad Ippalca di fare il suo nome a Ruggiero e di dirgli che se lo rivuole indietro potrà trovarlo facilmente seguendo le chiare tracce del suo passaggio. Nel frattempo Zerbino, seguito da Gabrina, trova il cadavere di Pinabello e mentre il cavaliere cerca invano di trovare il colpevole dell’omicidio, la vecchia sottrae al morto tutto ciò che di valore riesce a nascondersi addosso, tra cui un cintura. I due, ripartiti, giungono presso al palazzo del padre di Pinabello che aveva promesso un ricco premio a chi riuscisse a indicargli l’assassino del figlio, e la vecchia Gabrina subito approfitta dell’occasione per indicare in Zerbino l’omicida e, per essere meglio creduta, mostra anche al conte la cintura sottratta al cadavere. Zerbino viene subito fatto prigioniero e condannato ad essere squartato là dove Pinabello era stato ucciso. Giunge per fortuna sul posto il paladino Orlando in compagnia della bella Isabella. Il cavaliere, lasciata la compagna su di un monte, si avvicina al condannato a morte chiedendo spiegazioni. Zerbino gli racconta la sua storia e convince così bene Orlando della propria innocenza che subito il paladino decide di aiutarlo. Orlando si lancia in combattimento e fa una strage uccidendo senza pietà tutti quelli che riesce a raggiungere. Zerbino, riavuta la libertà ed indossate nuovamente le proprie armi, si accorge della presenza dell’amata Isabella e arde pertanto d’amore, ma teme di non essere più ricambiato. Giunti presso una fonte, Zerbino si toglie infine l’elmo e viene riconosciuto da Isabella, che corre ad abbracciarlo. Un rumore giunto dal bosco pone fine ai ringraziamenti dei due amanti verso Orlando ed i tre vedono arrivare a cavallo Mandricardo e Doralice. Il crudele pagano era alla ricerca di quel cristiano che aveva fatto una strage di guerrieri saraceni presso Parigi, per potersi confrontare con lui; riconosciutolo quindi nel cavaliere che si trova in quel momento di fronte, Orlando appunto, lo sfida subito a duello. Le lance vengono subito ridotte in pezzi nei primi scontri e gli sfidanti, non avendo altre armi, non possono fare altro che cercare di avere la meglio con i pugni e nel combattimento corpo a corpo. Il cavallo di Mandricardo rimasto senza le briglie, tolte da Orlando, parte subito al galoppo, portandosi dietro il proprio padrone. Terminerà la propria corsa cadendo in un fosso. Doralice, corsa dietro alla propria guida, offre al guerriero le briglie del proprio cavallo. Mandricardo si impossessa invece di quelle del cavallo guidato da Gabrina, giunta lì per caso. Orlando, non vedendo ricomparire l’avversario, decide di andare alla ricerca di Mandricardo e si separa così dai due amanti, chiedendo però prima loro, dovessero mai incontrare il guerriero pagano, di dirgli che potrà trovare il paladino in quei boschi per altri tre giorni, prima che faccia poi ritorno a Parigi. Dopo aver girato invano per due giorni, il conte Orlando giunge infine nei luoghi dove Angelica e Medoro sfogarono la loro passione amorosa.

Gustave Doré: La pazzia d’Orlando
LA PAZZIA D’ORLANDO
(XXIII, 100-136)
Lo strano corso che tenne il cavallo
del Saracin pel bosco senza via,
fece ch’Orlando andò duo giorni in fallo,
né lo trovò, né poté averne spia.
Giunse ad un rivo che parea cristallo,
ne le cui sponde un bel pratel fioria,
di nativo color vago e dipinto,
e di molti e belli arbori distinto.
Il merigge facea grato l’orezzo
al duro armento ed al pastore ignudo;
sì che né Orlando sentia alcun ribrezzo,
che la corazza avea, l’elmo e lo scudo.
Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo;
e v’ebbe travaglioso albergo e crudo,
e più che dir si possa empio soggiorno,
quell’infelice e sfortunato giorno.
Volgendosi ivi intorno, vide scritti
molti arbuscelli in su l’ombrosa riva.
Tosto che fermi v’ebbe gli occhi e fitti,
fu certo esser di man de la sua diva.
Questo era un di quei lochi già descritti,
ove sovente con Medor veniva
da casa del pastore indi vicina
la bella donna del Catai regina.
Angelica e Medor con cento nodi
legati insieme, e in cento lochi vede.
Quante lettere son, tanti son chiodi
coi quali Amore il cor gli punge e fiede.
Va col pensier cercando in mille modi
non creder quel ch’al suo dispetto crede:
ch’altra Angelica sia, creder si sforza,
ch’abbia scritto il suo nome in quella scorza.
Poi dice: «Conosco io pur queste note:
di tal’io n’ho tante vedute e lette.
Finger questo Medoro ella si puote:
forse ch’a me questo cognome mette».
Con tali opinion dal ver remote
usando fraude a sé medesmo, stette
ne la speranza il malcontento Orlando,
che si seppe a se stesso ir procacciando.
Ma sempre più raccende e più rinuova,
quanto spenger più cerca, il rio sospetto:
come l’incauto augel che si ritrova
in ragna o in visco aver dato di petto,
quanto più batte l’ale e più si prova
di disbrigar, più vi si lega stretto.
Orlando viene ove s’incurva il monte
a guisa d’arco in su la chiara fonte.
Aveano in su l’entrata il luogo adorno
coi piedi storti edere e viti erranti.
Quivi soleano al più cocente giorno
stare abbracciati i duo felici amanti.
V’aveano i nomi lor dentro e d’intorno,
più che in altro dei luoghi circostanti,
scritti, qual con carbone e qual con gesso,
e qual con punte di coltelli impresso.
Il mesto conte a piè quivi discese;
e vide in su l’entrata de la grotta
parole assai, che di sua man distese
Medoro avea, che parean scritte allotta.
Del gran piacer che ne la grotta prese,
questa sentenza in versi avea ridotta.
Che fosse culta in suo linguaggio io penso;
ed era ne la nostra tale il senso:
“Liete piante, verdi erbe, limpide acque,
spelunca opaca e di fredde ombre grata,
dove la bella Angelica che nacque
di Galafron, da molti invano amata,
spesso ne le mie braccia nuda giacque;
de la commodità che qui m’è data,
io povero Medor ricompensarvi
d’altro non posso, che d’ognor lodarvi:
e di pregare ogni signore amante,
e cavallieri e damigelle, e ognuna
persona, o paesana o viandante,
che qui sua volontà meni o Fortuna;
ch’all’erbe, all’ombre, all’antro, al rio, alle piante
dica: benigno abbiate e sole e luna,
e de le ninfe il coro, che proveggia
che non conduca a voi pastor mai greggia”.
Era scritto in arabico, che ’l conte
intendea così ben come latino:
fra molte lingue e molte ch’avea pronte,
prontissima avea quella il paladino;
e gli schivò più volte e danni ed onte,
che si trovò tra il popul saracino:
ma non si vanti, se già n’ebbe frutto;
ch’un danno or n’ha, che può scontargli il tutto.
Tre volte e quattro e sei lesse lo scritto
quello infelice, e pur cercando invano
che non vi fosse quel che v’era scritto;
e sempre lo vedea più chiaro e piano:
ed ogni volta in mezzo il petto afflitto
stringersi il cor sentia con fredda mano.
Rimase al fin con gli occhi e con la mente
fissi nel sasso, al sasso indifferente.
Fu allora per uscir del sentimento
sì tutto in preda del dolor si lassa.
Credete a chi n’ha fatto esperimento,
che questo è ’l duol che tutti gli altri passa.
Caduto gli era sopra il petto il mento,
la fronte priva di baldanza e bassa;
né poté aver (che ’l duol l’occupò tanto)
alle querele voce, o umore al pianto.
L’impetuosa doglia entro rimase,
che volea tutta uscir con troppa fretta.
Così veggiàn restar l’acqua nel vase,
che largo il ventre e la bocca abbia stretta;
che nel voltar che si fa in su la base,
l’umor che vorria uscir, tanto s’affretta,
e ne l’angusta via tanto s’intrica,
ch’a goccia a goccia fuore esce a fatica.
Poi ritorna in sé alquanto, e pensa come
possa esser che non sia la cosa vera:
che voglia alcun così infamare il nome
de la sua donna e crede e brama e spera,
o gravar lui d’insopportabil some
tanto di gelosia, che se ne pera;
ed abbia quel, sia chi si voglia stato,
molto la man di lei bene imitato.
In così poca, in così debol speme
sveglia gli spiriti e gli rifranca un poco;
indi al suo Brigliadoro il dosso preme,
dando già il sole alla sorella loco.
Non molto va, che da le vie supreme
dei tetti uscir vede il vapor del fuoco,
sente cani abbaiar, muggiare armento:
viene alla villa, e piglia alloggiamento.
Languido smonta, e lascia Brigliadoro
a un discreto garzon che n’abbia cura;
altri il disarma, altri gli sproni d’oro
gli leva, altri a forbir va l’armatura.
Era questa la casa ove Medoro
giacque ferito, e v’ebbe alta avventura.
Corcarsi Orlando e non cenar domanda,
di dolor sazio e non d’altra vivanda.
Quanto più cerca ritrovar quiete,
tanto ritrova più travaglio e pena;
che de l’odiato scritto ogni parete,
ogni uscio, ogni finestra vede piena.
Chieder ne vuol: poi tien le labra chete;
che teme non si far troppo serena,
troppo chiara la cosa che di nebbia
cerca offuscar, perché men nuocer debbia.
Poco gli giova usar fraude a se stesso;
che senza domandarne, è chi ne parla.
Il pastor che lo vede così oppresso
da sua tristizia, e che voria levarla,
l’istoria nota a sé, che dicea spesso
di quei duo amanti a chi volea ascoltarla,
ch’a molti dilettevole fu a udire,
gl’incominciò senza rispetto a dire:
come esso a prieghi d’Angelica bella
portato avea Medoro alla sua villa,
ch’era ferito gravemente; e ch’ella
curò la piaga, e in pochi dì guarilla:
ma che nel cor d’una maggior di quella
lei ferì Amor; e di poca scintilla
l’accese tanto e sì cocente fuoco,
che n’ardea tutta, e non trovava loco:
e sanza aver rispetto ch’ella fusse
figlia del maggior re ch’abbia il Levante,
da troppo amor costretta si condusse
a farsi moglie d’un povero fante.
All’ultimo l’istoria si ridusse,
che ’l pastor fe’ portar la gemma inante,
ch’alla sua dipartenza, per mercede
del buono albergo, Angelica gli diede.
Questa conclusion fu la secure
che ’l capo a un colpo gli levò dal collo,
poi che d’innumerabil battiture
si vide il manigoldo Amor satollo.
Celar si studia Orlando il duolo; e pure
quel gli fa forza, e male asconder pòllo:
per lacrime e suspir da bocca e d’occhi
convien, voglia o non voglia, al fin che scocchi.
Poi ch’allargare il freno al dolor puote
(che resta solo e senza altrui rispetto),
giù dagli occhi rigando per le gote
sparge un fiume di lacrime sul petto:
sospira e geme, e va con spesse ruote
di qua di là tutto cercando il letto;
e più duro ch’un sasso, e più pungente
che se fosse d’urtica, se lo sente.
In tanto aspro travaglio gli soccorre
che nel medesmo letto in che giaceva,
l’ingrata donna venutasi a porre
col suo drudo più volte esser doveva.
Non altrimenti or quella piuma abborre,
né con minor prestezza se ne leva,
che de l’erba il villan che s’era messo
per chiuder gli occhi, e vegga il serpe appresso.
Quel letto, quella casa, quel pastore
immantinente in tant’odio gli casca,
che senza aspettar luna, o che l’albore
che va dinanzi al nuovo giorno nasca,
piglia l’arme e il destriero, ed esce fuore
per mezzo il bosco alla più oscura frasca;
e quando poi gli è aviso d’esser solo,
con gridi ed urli apre le porte al duolo.
Di pianger mai, mai di gridar non resta;
né la notte né ’l dì si dà mai pace.
Fugge cittadi e borghi, e alla foresta
sul terren duro al discoperto giace.
Di sé si meraviglia ch’abbia in testa
una fontana d’acqua sì vivace,
e come sospirar possa mai tanto;
e spesso dice a sé così nel pianto:
«Queste non son più lacrime, che fuore
stillo dagli occhi con sì larga vena.
Non suppliron le lacrime al dolore:
finir, ch’a mezzo era il dolore a pena.
Dal fuoco spinto ora il vitale umore
fugge per quella via ch’agli occhi mena;
ed è quel che si versa, e trarrà insieme
e ’l dolore e la vita all’ore estreme.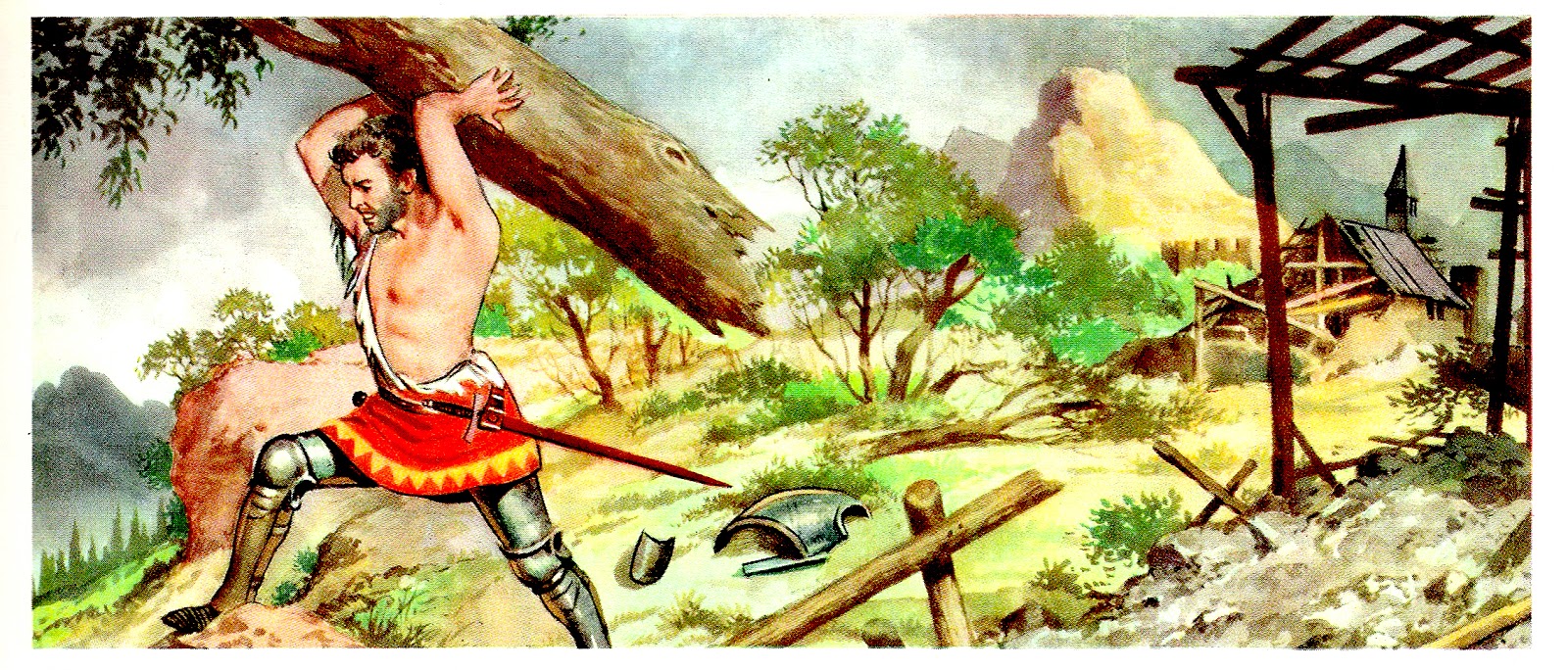 Carlo Jacopo: Orlando pazzo
Carlo Jacopo: Orlando pazzo
Questi ch’indizio fan del mio tormento,
sospir non sono, né i sospir sono tali.
Quelli han triegua talora; io mai non sento
che ’l petto mio men la sua pena esali.
Amor che m’arde il cor, fa questo vento,
mentre dibatte intorno al fuoco l’ali.
Amor, con che miracolo lo fai,
che ’n fuoco il tenghi, e nol consumi mai?
Non son, non sono io quel che paio in viso:
quel ch’era Orlando è morto ed è sotterra;
la sua donna ingratissima l’ha ucciso:
sì, mancando di fé, gli ha fatto guerra.
Io son lo spirto suo da lui diviso,
ch’in questo inferno tormentandosi erra,
acciò con l’ombra sia, che sola avanza,
esempio a chi in Amor pone speranza».
Pel bosco errò tutta la notte il conte;
e allo spuntar de la diurna fiamma
lo tornò il suo destin sopra la fonte
dove Medoro isculse l’epigramma.
Veder l’ingiuria sua scritta nel monte
l’accese sì, ch’in lui non restò dramma
che non fosse odio, rabbia, ira e furore;
né più indugiò, che trasse il brando fuore.
Tagliò lo scritto e ’l sasso, e sin al cielo
a volo alzar fe’ le minute schegge.
Infelice quell’antro, ed ogni stelo
in cui Medoro e Angelica si legge!
Così restar quel dì, ch’ombra né gielo
a pastor mai non daran più, né a gregge:
e quella fonte, già si chiara e pura,
da cotanta ira fu poco sicura;
che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle
non cessò di gittar ne le bell’onde,
fin che da sommo ad imo sì turbolle
che non furo mai più chiare né monde.
E stanco al fin, e al fin di sudor molle,
poi che la lena vinta non risponde
allo sdegno, al grave odio, all’ardente ira,
cade sul prato, e verso il ciel sospira.
Afflitto e stanco al fin cade ne l’erba,
e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto.
Senza cibo e dormir così si serba,
che ’l sole esce tre volte e torna sotto.
Di crescer non cessò la pena acerba,
che fuor del senno al fin l’ebbe condotto.
Il quarto dì, da gran furor commosso,
e maglie e piastre si stracciò di dosso.
Qui riman l’elmo, e là riman lo scudo,
lontan gli arnesi, e più lontan l’usbergo:
l’arme sue tutte, in somma vi concludo,
avean pel bosco differente albergo.
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo
l’ispido ventre e tutto ’l petto e ’l tergo;
e cominciò la gran follia, sì orrenda,
che de la più non sarà mai ch’intenda.
In tanta rabbia, in tanto furor venne,
che rimase offuscato in ogni senso.
Di tor la spada in man non gli sovenne;
che fatte avria mirabil cose, penso.
Ma né quella, né scure, né bipenne
era bisogno al suo vigore immenso.
Quivi fe’ ben de le sue prove eccelse,
ch’un alto pino al primo crollo svelse:
e svelse dopo il primo altri parecchi,
come fosser finocchi, ebuli o aneti;
e fe’ il simil di querce e d’olmi vecchi,
di faggi e d’orni e d’illici e d’abeti.
Quel ch’un ucellator che s’apparecchi
il campo mondo, fa, per por le reti,
dei giunchi e de le stoppie e de l’urtiche,
facea de cerri e d’altre piante antiche.
I pastor che sentito hanno il fracasso,
lasciando il gregge sparso alla foresta,
chi di qua, chi di là, tutti a gran passo
vi vengono a veder che cosa è questa.
Ma son giunto a quel segno il qual s’io passo
vi potria la mia istoria esser molesta;
ed io la vo’ più tosto diferire,
che v’abbia per lunghezza a fastidire.

Arnold Böcklin, Orlando furioso (1885)
L’imprevedibile percorso che prese il cavallo di Mandricardo per il bosco privo di sentieri fa sì che Orlando vaghi per due giorni a vuoto, né lo trova, né ne ha traccia. Arriva a un ruscello che sembra cristallo, sulle cui sponde fiorisce un bel prato dipinto dei colori della natura, e variamente ornato da molti bei cespugli. // La calda ora del mezzogiorno rende gradita l’ombra agli animali e al pastore nudo; così che neppure Orlando ha alcuna esitazione, pur avendo la corazza, l’elmo e lo scudo. Qui Orlando entra per riposare in mezzo ai cespugli e vi trova una dimora angosciosa, funesta più di quanto si possa dire, in quell’infelice e sfortunato giorno. // Girando intorno vede incisi con scritte molti alberelli sulla riva dell’ombroso fiume. Non appena ha gli occhi fermi e fissi con maggior attenzione fu sicuro che sono stati scritti dalla dea del suo cuore. Questo era uno di quei luoghi già descritti, dove spesso Medoro veniva dalla vicina casa del pastore con la bella Angelica. // Vede Angelica e Medoro in diversi modi, intrecciarti insieme ed in diversi luoghi. Tante sono le lettere, tanti sono i chiodi con i quali Cupido gli ferisce e punge il cuore. Va a cercare in mille modi con il pensiero di non credere quello a cui, suo malgrado, crede: si sforza di credere che sia un’altra Angelica ad aver scritto il suo nome sul quella corteccia. // Poi dice: «Io conosco la grafia di queste lettere: ne ho viste e ne ho lette tante. Potrebbe essersi inventata questo Medoro: forse mi ha dato questo soprannome». Con tali vane opinioni, continuò ad assillare se stesso, ponendo il suo malcontento nella speranza che seppe procurare a se stesso. // Ma più si riaccende e si rinnova il crudele sospetto più cerca di dimenticarlo: come il disattento uccello che finisce in una ragnatela o sui rami invischiati, quanto più batte le ali e più prova a liberarsi, più si lega stretto. Orlando giunge dove si incurva la montagna come un arco (formando una grotta) sulla fonte cristallina. // Avevano ornato l’ingresso (di quella grotta) edere e viti rampicanti con i loro fusti contorti. Nei giorni più caldi, qui erano soliti stare abbracciati i due felici amanti. C’erano i loro nomi dentro ed intorno (alla grotta) più che nei luoghi circostanti, scritti alcuni con il carbone ed altri con gesso e altri erano impressi con punte di coltelli. // Qui scese il triste cavaliere; e vide sull’entrata della grotta tante parole, che erano state scritte dalla mano di Medoro, e sembravano esser state scritte proprio in quel momento. Per esprimere il grande piacere che provò (con Angelica) nella grotta, aveva composto questa iscrizione in versi. Io penso che fosse poeticamente elaborata in arabo (lingua di Medoro), ed era tale il senso nella nostra lingua: “Liete piante, verdi erbe, limpide acque, grotta gradevole per la fresca ombra, dove la bella Angelica nacque di Galafron, è stata amata vanamente da molti, spesso nelle mie braccia giacque nuda; dei piaceri che qui mi sono stati dati, io povero Medoro non posso ricompensarvi in altro modo, se non lodandovi in ogni momento: // e di pregare ogni signore che vi ha amato, e cavalieri e damigelle ed ogni persona, del posto o forestiere, che capiti qui intenzionalmente o per caso; che all’erba, all’ombra, all’ingresso (delle grotta), al fiume e alle piante dica: che sole e luna vi siano favorevoli, e vi protegga il coro delle ninfe dai danni che potrebbero recare le greggi condotte lì da qualche pastore”. // Era scritto in arabo, che il cavaliere capisce bene come il latino: tra molte lingue che sa, il paladino sapeva benissimo quella; e gli ha fatto evitare più volte danni e scontri, quando si è trovato tra il popolo saraceno: si rallegri, se altre volte tale conoscenza gli è stata propizia; perché ora gli arreca un danno tale da cancellare tutti i vantaggi ottenuti. // Legge tre, quattro, sei volte la triste poesia l’infelice, ed anche cercando invano (d’immaginare) che non ci sia ciò che vi è scritto; ma gli risulta sempre più chiaro e facile da comprendere: ed ogni volta (che legge) si sente in mezzo al petto afflitto stringere il cuore con mano gelida. Rimane lì con gli occhi e con il pensiero rivolti al sasso, impietrito. // E’ allora che inizia ad impazzire, così che in preda si abbandona completamente al dolore. Credete a chi lo ha provato su se stesso, che questa, d’amore, è la sofferenza che fa passare tutte le altre. Gli cade il mento sopra il petto, la fronte, priva di rughe, era bassa; non può avere (che il dolore l’occupa tanto) voce per lamentarsi o lacrime per piangere. // Rimane dentro l’impetuoso dolore, che voleva uscire con troppa fretta. Così vediamo restare l’acqua nel vaso, che abbia il ventre largo e la bocca stretta; cosicché, capovolgendo il vaso, il liquido che vorrebbe uscire, tanto velocemente si riversa, e si ingorga nella stretta apertura, uscendo così goccia a goccia, a fatica. // Poi ritorna abbastanza in sé, e pensa se la cosa potrebbe essere non vera: che qualcuno voglia così infamare il nome della sua donna, e crede e spera e brama, oppure (che qualcuno voglia) gravarlo di un così insopportabile peso di gelosia, da farlo morire; e abbia, chiunque sia stato, imitato molto bene la sua calligrafia (di Angelica). // Con una così debole speranza, gli si rianimarono gli spiriti vitali; quindi salì in groppa al suo Brigliadoro quando il sole stava già lasciando il posto a sua sorella luna (tramonto). Non va molto avanti, che dagli alti comignoli dei tetti vede uscire del fumo, sente cani abbaiare e una mandria muggire: va fino alla villa e prende posto. // Languido smonta (da cavallo), e lascia Brigliadoro a un abile garzone perché ne abbia cura: si fa disarmare da uno, gli speroni d’oro un altro gli leva, e si fa lucidare l’armatura da un altro ancora. E’ questa la casa dove Medoro visse quando è stato ferito, e dove ha avuto grande fortuna. Orlando chiede solo da dormire e niente per cena, è sazio di dolore e non di altro cibo. // Quanto più cerca di trovare tranquillità, tanto più prova travaglio e dolore; vede piena della odiata poesia (quella scritta da Medoro) ogni parete ogni finestra, ogni porta. Vorrebbe chiedere a riguardo ma poi tiene le labbra ferme, perché teme di rendere troppo evidente, troppo chiara la cosa che cerca di dimenticare, per provare meno dolore. // Ingannare se stesso non gli giova; perché senza domandare c’è chi ne parla. Il pastore, che lo vede così oppresso dalla sua tristezza, e vorrebbe alleviarla, inizia a raccontargli la storia che conosceva bene; raccontava spesso dei due amanti a chi voleva ascoltare una storia molto dilettevole, e così, senza rispetto, comincia a raccontare // come egli, pregato dalla bella Angelica, aveva portato in casa sua Medoro, ferito gravemente; e che lei curò la ferita ed in pochi giorni la guarì: ma lei, con una piaga ancora maggiore di quella, è stata colpita nel cuore da Amore; e da una piccola scintilla si è accesa tanto di un fuoco così cocente, che la faceva ardere tutta, e non trovava pace: // e senza aver riguardo che Angelica fosse figlia del più grande re che abbia mai avuto l’oriente, sospinta da un grandissimo amore fu portata a sposare Medoro, umile soldato. La conclusione della storia è che il pastore mostra ad Orlando il gioiello, che al momento della partenza, come ricompensa della buona ospitalità, gli ha dato Angelica. // Questa conclusione è stata la scure che gli ha tolto la testa dal collo in un colpo solo, una volta che delle innumerevoli bastonate si è saziato il carnefice Amore. Orlando si sforza di nascondere il dolore; e tuttavia quello è talmente violento che difficilmente lo può tenere nascosto: attraverso le lacrime degli occhi ed i sospiri della bocca è inevitabile che esploda. // Dopo che poté dar libero sfogo al dolore (perché resta solo senza doversi preoccupare di nessun altro), dagli occhi, rigando le guance sparge un fiume di lacrime sul petto: sospira e piange, e cammina, girandosi spesso, di qua e di là esplorando il letto: e più duro che un sasso, e più pungente dell’ortica se lo sente. Intanto gli viene in mente l’atroce dubbio che nello stesso letto in cui egli giace, doveva essersi più volte venuta a coricare insieme al suo amante l’ingrata donna. Inevitabilmente ha in odio quel letto, né si alza dal letto meno velocemente del contadino che si leva dall’erba su cui si era steso per riposarsi, per aver visto vicino a sé un serpente. // Quel letto, quella casa, quel pastore immediatamente gli viene in tanto odio, che senza aspettare che sorga la luna o che l’alba, che precede il nuovo giorno, nasca, prende le armi e il destriero, ed esce fuori in mezzo al bosco, dove è più fitto e scuro l’intrico di rami; e poi quando si accorge di essere solo (che nessuno lo segue), con grida e urla apre le porte al dolore. // Non smette mai di gridare e di urlare; non si dà mai pace né la notte né il giorno seguente. Fugge da città e da borghi, e nei luoghi inabitati sul terreno duro, all’aperto, giace. Si meraviglia che nella propria testa ci possa essere una sorgente così inesauribile di pianto, e come i sospiri possano essere mai così tanti; e spesso si dice nel pianto: // “Queste non sono più lacrime, che fuoriescono dagli occhi con flusso così abbondante. Non bastano le lacrime al dolore: finiscono quando il dolore si è manifestato solo per metà. Dal dolore della gelosia ora lo spirito fugge attraverso quella via a cui gli occhi conducono; ed e’ quello che ne esce ora, quello che porterà via con sé insieme il dolore e la vita sul punto di morte. // Questi, che manifestano il mio tormento, non sono sospiri, né i sospiri sono così. I sospiri ogni tanto si interrompono; io non sento mai il mio petto ridurre il sospirare per la pena. L’amore che mi arde il cuore crea questi sospiri mentre agita attorno al fuoco le proprie ali. Amore, con quale miracolo riesci a tenere il cuore nel fuoco senza mai consumarlo? // Non sono io, non sono io quello che sembro in volto: quello che era Orlando è morto e sotterrato; la sua ingrata donna l’ha ucciso: si, mancandogli di fedeltà gli ha fatto la guerra. Io sono il suo spirito dal suo corpo diviso, che vaga tormentandosi in questo inferno, in modo che con il proprio fantasma, che è tutto quello che gli resta, ammonisca con l’esempio colui che affida la sua speranza nell’Amore”. // Tutta la notte il conte vaga per il bosco; ed al sorgere del sole il suo destino lo riporta vicino al fiume dove Medoro ha inciso l’iscrizione. Vedere le parole che testimoniavano il suo disonore incise nel monte, che lo ha acceso, così che in lui non è restato nulla che non sia odio, rabbia, ira o furia; non resiste più e sguaina la spada. // Taglia l’incisione e il sasso, e fino al cielo fa volare le piccole schegge. Infelice sia ogni grotta e ogni tronco in cui si leggono i nomi di Medoro ed Angelica! Sono state così ridotte (le piante) quel giorno, che né ombra né refrigerio daranno più al pastore né al suo gregge: e il fiume, così chiaro e puro, non è stato al riparo da un ira così grande; // poiché Orlando non ha smesso di gettare nelle belle onde i rami, i tronchi, i sassi e le zolle di terra, fino a che dalla superficie fino al fondo, le ha rese torbide così tanto che non saranno mai più così limpide e pure. E alla fine, stanco e sudato, dal momento che la forza fisica, esaurita, non è più in grado di servire allo sdegno, al pesante odio e all’ardente ira, si abbandona sul prato e sospira al cielo. // Afflitto e stanco cade infine nell’erba e fissa gli occhi al cielo senza dire parola alcuna. Rimane così, senza mangiare e senza dormire per tre giorni. Il suo dolore non smette di crescere, finché non l’ha fatto impazzire. Il quarto giorno, sconvolto dalla pazzia violenta, si toglie di dosso tutta l’armatura. // Qui resta l’elmo e là resta lo scudo, lontano gli arnesi (corredo dell’armatura), e più lontano ancora la corazza: tutte le sue armi, concludendo, ognuna ha una diversa collocazione per il bosco. E poi si squarcia i vestiti, e rimangono nudi il peloso addome e la schiena; e inizia la grande pazzia, così orrenda, che nessuno sentirà mai parlare di una (follia) più orrenda di questa. // Gli scaturisce così tanta rabbia e così tanto furore che tutte le sue facoltà sensitive furono alterate. Non gli è passato per la testa di prendere la spada, che tante incredibili avventure aveva passato, credo. Ma tanto né quella, né una scure, né una scure sono necessarie alla sua immensa forza. Qui fa davvero alcune tra le sue imprese più straordinarie, sradica un grande pino con un solo scrollone: // e ne abbatte, dopo il primo, molti altri ancora come se siano state piante dal fusto tenero; e sia la stessa cosa con querce, vecchi olmi, faggi e abeti. Come un uccellatore che per ripulire il campo, dove mette le reti, estirpa le erbacce, i ramoscelli e le ortiche, Orlando fa con le querce e con le altre piante secolari del bosco. // I pastori che hanno sentito il gran chiasso, lasciando il gregge sparso per la foresta, da ogni luogo, di corsa vanno a vedere che cosa sia quel rumore. Ma sono giunto a quel punto che se lo oltrepasso, la mia storia vi potrebbe essere dannosa; e io la voglio rinviare ad un altro canto prima che vi possa infastidire per la sua lunghezza.
 Giovanni Boulanger, Orlando impazzito per amore (1652)
Giovanni Boulanger, Orlando impazzito per amore (1652)
E’ questo il passo più importante dell’intero poema se si pensa che esso è posto esattamente al centro, come punto focale, e dà il titolo all’intera opera. Il motivo per cui esso è fondamentale nella visione ariostesca del mondo è che Orlando trascende dall’essere personaggio e, attraverso l’estremo dolore, concepisce la realtà umana del limite raggiungibile per una modesta, ma veritiera felicità. Osservandolo più da vicino, infatti, possiamo dividerlo in più sequenze secondo un vero e proprio percorso che conduce Orlando e con lui l’uomo alla pazzia.
- Il destino incontra Orlando: smarrimento del cavaliere e della scoperta delle scritte tra Angelica e Medoro;
- Negazione dell’evidenza: (non è Angelica, Medoro è il soprannome con cui lei lo indica). Spiegamento dei meccanismi difensivi;
- Dolore represso e ultima illusione: di fronte alla grotta il dolore è troppo vasto per essere contenuto; un’ultima illusione s’impone per salvarsi (qualcuno imita la grafia di Angelica);
- Secondo incontro di Orlando col destino: casa del pastore, laddove cerca requie trova soltanto tormento. A concludere l’episodio chiave, lo svelamento della verità attraverso il bracciale;
- Disperazione: piange come un fiume, non può dormire;
- Furia distruttrice uno: vaga tutta la notte, finché incontrerà i luoghi rivelatori dell’amore di Angelica e Medoro, distruggendoli;
- Furia distruttrice due: abdicherà al suo ruolo di cavaliere dismettendo l’armatura e vivendo come un animale (Angelica sulla spiaggia non lo riconoscerà).
Il percorso di Orlando racchiude, come già detto, l’intera ideologia del poema, trasformando l’eroe cavalleresco in uomo rinascimentale (da ciò l’incredibile successo dell’opera sin dal suo primo apparire). Infatti si racchiude in lui l’idea della vanità della ricerca, che, se posta al di là dei limiti umani, non potrà che essere vana, illusoria appunto, e condurre di conseguenza l’uomo alla follia. Riconoscere pertanto la peculiarità dell’uomo e dei possibili suoi raggiungimenti diventa un obbiettivo, proprio perché guidato da una ratio che sa riconoscersi e riconoscere, di conseguenza, la realtà che sta attorno. Il percorso è infatti strutturato secondo uno scivolamento verso l’abiezione in cui la “bugia”, qualunque sia il suo mascheramento, porta all’insania, all’animalità. Tuttavia soltanto attraverso essa si può raggiungere la piena consapevolezza di sé e quindi vivere in quell’aurea mediocritas, già da lui descritta nelle Satire.

Riprendiamo la narrazione dal XXIV canto in cui il pazzo Orlando fa strage di uomini e di animali. Tutti fuggono, essendo lui invulnerabile per incantesimo e l’Orlando furioso vagherà per tutta la Francia, saccheggiando paesi e annientando ogni essere vivente, fino a giungere un giorno presso un ponte. Nel frattempo Zerbino e di Isabella, i due amanti, dopo essersi separati da Orlando, incontrano sulla loro via Odorico, che aveva tentato (come abbiamo letto nel canto XIII) di possedere con la forza Isabella. Egli è condotto a cavallo come prigioniero da Almonio, il cavaliere che gli si era opposto ed era stato da lui ferito, e Corebo, che era stato allontanato con una scusa. Almonio racconta al suo signore gli avvenimenti successivi al rapimento di Isabella. Tornato alla spiaggia con i cavalli richiesti, Almonio aveva ritrovato solo il compagno ferito ed era stato informato su quanto successo. Una volta guarito Corebo, i due si erano messi alla ricerca del cavaliere infedele e l’avevano trovato presso il re Alfonso d’Aragona. Almone sfida in duello Odorico, lo sconfigge e su concessione del re lo incatena con l’intenzione di consegnarlo appunto a Zerbino. Odorico conferma le parole di accusa, ma il suo avversario era stato tanto superiore che alla fine era stato costretto a cedere. Zerbino decide quindi di graziarlo, sapendo che è stato vittima d’amore. Giunge in quel momento tra loro anche il cavallo con in groppa Gabrina, che viene subito riconosciuta. Per punizione Zerbino fa promettere a Odorico di tenersi per compagna la donna per un anno intero, di condurla ovunque lei voglia andare; ma lui non manterrà la promessa, impiccherà la vecchia ad un albero quello stesso giorno, ma subirà lo stesso trattamento per mano di Almonio.

Massimo d’Azeglio: La morte di Zerbino (1839)
Zerbino allontana infine Almonio e Corebo verso la schiera scozzese e prosegue insieme ad Isabella per conoscere la sorte del loro salvatore. Arrivano sul luogo dove Orlando è impazzito; ritrovano la sua armatura, il cavallo Brigliadoro e la sua spada Durindana. Raccolgono ogni pezzo e lasciano il tutto su di un pino. Giunge in quel posto anche Fiordiligi mentre è alla ricerca dell’amato Brandimarte, partito esso stesso alla ricerca di Orlando e poi ritornato a Parigi. La donna riconosce le armi del paladino e viene a conoscenza della sua sorte. Giunge poi anche Mandricardo e senza esitare si impossessa della spada d’Orlando. Zerbino non accetta quel comportamento e subito si lancia contro il guerriero pagano. Il duello è impari: Zerbino non può nulla contro l’armatura che in precedenza era appartenuta ad Ettore; i pochi colpi piazzati da Mandricardo vanno sempre a segno e Zerbino si ritrova in breve ferito, privo dello scudo e con l’armatura lacerata. Devono intervenire le donne, Isabella e Doralice, per calmare l’ira degli uomini e separarli. Fiordiligi si dispera vedendo allontanarsi in cattive mani la spada dell’amico Orlando. Vuole ora ancora di più ritrovare Brandimarte: per amore ma anche perché sa che lui sarebbe in grado di riprendere Durindana. Prosegue oltre il suo viaggio ed un giorno, mentre sta per oltrepassare un ponte, incontra il povero paladino. Invece Zerbino sente che la propria vita si spegne Isabella si dispera per non essere in grado di salvarlo e vuole morire con lui, ma lui stesso la convince a non compiere quel gesto e muore subito dopo tra le sue braccia.

Jacopo Vignali: Zerbino, Isabella e l’eremita (1630)
Giunge sul luogo un eremita che condurrà la donna in un monastero di monache in Provenza. Incontreranno però sulla loro via un cavaliere che li offenderà ingiustamente. Nel frattempo Mandricardo, terminata la battaglia, raggiunge un fonte e subito vede arrivare, Rodomonte, pronto a sfidarlo per vendicarsi della perdita della sua promessa sposa. Inizia un feroce combattimento tra i due cavalieri pagani, ma il re Agramante fa richiamare nelle file dell’esercito tutti i comandanti ed i cavalieri lontani da Parigi, i due guerrieri, allora, sospendono il combattimento, rimandando in seguito la decisione di chi fra loro due potrà avere Doralice. Mandricardo è però rimasto senza cavallo, senonché alla stessa fonte arriva anche Brigliadoro.

Siamo nel XXV in cui anche Ruggiero, poco dopo aver gettato nel pozzo lo scudo incantato, viene raggiunto dal messaggero inviato da re Agramante per ricevere la richiesta di soccorso. Decide però di proseguire oltre, per salvare il giovane innamorato della figlia del re Marsilio, e condannato ad essere arso vivo, ma soprattutto per poter ritrovare l’amata Bradamante. Giunto all’interno della piazza dove si sta svolgendo la condanna a morte e visto in faccia il giovane, Ruggiero crede si tratti di Bradamante, tanta è la somiglianza tra il condannato e la sua donna, caduta prigioniera nel tentativo di compiere l’impresa da sola. Il pagano sguaina la propria spada e libera il giovane ed escono al galoppo dal castello. Ruggiero è ancora dubbioso circa l’identità della persona che ha salvato, solo la voce grave del giovane ed il fatto che dice di non conoscerlo lo fanno dubitare che si tratti effettivamente della sua amata.

Bradamante e Fiordispina
Alla fine il ragazzo si presenta: è Ricciardetto, fratello di Rinaldo e di Bradamante e totalmente identico alla sorella. Ricciardetto racconta che un giorno la sorella, ferita alla testa durante un combattimento contro soldati saraceni, si era dovuta tagliare i capelli per curarsi la ferita. Giunta ad una fonte si era poi sdraiata sull’erba ed era stata così vista da Fiordispina, figlia del re Marsilio, che subito, credendo fosse un cavaliere, si era innamorata di lei. Bradamante, imbarazzata, chiarì allora subito la propria identità; ma nonostante la confessione, Fiordispina continuò ad ardere d’amore per Bradamante. La mattina la sorella di Ricciardetto ricevette in dono dall’altra donna un cavallo ed una sopraveste e ritornò infine a Montalbano.

Bradamante e Fiordispina
Bradamante aveva raccontato subito tutta la storia ai fratelli ed alla madre. In Ricciardetto, già in precedenza innamorato della ragazza, si riaccese subito il fuoco della passione ed il giovane decise così di vestirsi come la sorella per fare visita a Fiordispina. Nel castello di lei gli venne tolta l’armatura, venne vestito da donna, pettinato, invitato al banchetto ed infine a dormire nello stesso letto della giovane. Qui Ricciardetto per giustificare il proprio essere uomo, disse che durante il viaggio di ritorno aveva salvato dalle grinfie di un fauno una ninfa, che gli aveva detto di poter esaudire un suo qualunque desiderio. Il giovane aveva allora chiesto di poter sanare la ferita d’amore di Firodispina ed era stato infine trasformato da donna in un uomo. Quindi i due sfogarono la loro passione amorosa e continuarono a farlo, fino a quando il re non venne a sapere la verità e lo condannò così a morte. Ruggiero e Ricciardetto vengono a sapere che i fratelli del ragazzo, fatti prigionieri da Ferraù, stavano ora per essere venduti al nemico. Ruggiero si prende carico dell’impresa. Tuttavia il cavaliere pagano è tormentato da un dubbio: andare a soccorrere il proprio re o andare a Vallombrosa, dove crede di poter ritrovare Bradamente? Per non perdere il proprio onore decide infine di informare la donna degli avvenimenti e di ripartire per Parigi. Il giorno dopo comunque si reca al luogo dove avrebbe dovuto avvenire lo scambio ed incontra un cavaliere che ha come insegna una fenice.

Sapremo nel canto XXVI che si tratta di Marfisa, che decide di unirsi per liberare i prigionieri. Arriva la schiera saracena con i due prigionieri al seguito e subito dopo la schiera dei Maganza carichi d’oro e di oggetti preziosi necessari al pagamento. Ma appena Ruggiero e Marfisa intervengono sia i Maganza che i saraceni gridano al tradimento ed iniziano a combattere tra loro. Alla fine riescono a rimanere in vita solo quelli che si sono allontanati velocemente a cavallo. Terminata la battaglia, i due prigionieri vengono liberati e Marfisa si toglie l’elmo così che tutti possono ora vedere che si tratta di una donna. Inizia quindi una parte chiaramente allegorica dove l’avari-zia, che dopo aver fatto strage in ogni luogo della terra, viene ferita da un cavaliere con la corona d’alloro (Francesco I di Francia), tre giovani (Massimiliano d’Austria, Carlo V ed Enrico VII d’Inghilterra) ed un leone (Leone X), ed infine uccisa con l’aiuto delle nobili genti, giunte per combatterla. I cavalieri vengono approfonditamente ragguagliati su tali episodi da Malagigi quando giunge presso loro Ippalca, che era stata incaricata da Bradamante di raggiungere Ruggiero, ma a cui Rodomonte aveva sottratto Frontino, il cavallo dello stesso cavaliere. La donna riconosce Ricciardetto e subito gli racconta gli avvenimenti, così Ruggiero salta in piedi e chiede di essere condotto presso il saraceno che le aveva rubato il cavallo.

Ippalca
Una volta soli, Ippalca gli racconta di Bradamante e di Rodomonte. Quest’ultimo sta però andando a Parigi e Ruggiero non riesce ad incontrarlo. Presso Marfisa giungono infine anche Mandricardo, Rodomonte, Doralice ed il loro seguito. Mandricardo, vista la bellezza di Marfisa, decide di offrirla a Rodomonte in cambio di Doralice. Marfisa in risposta si mette l’armatura, monta a cavallo e lo sfida a duello. Le loro armature sono però invulnerabili per incantesimo e nessun colpo riesce a scalfirle. Rodomonte interviene infine per sospendere la contesa e per avviarsi verso re Agramante. Invece Ruggiero consegna ad Ippalca la lettera scritta per Bradamante, quindi ritrovato Rodomonte, in sella al suo cavallo, lo sfida subito a duello, ma il pagano si rifiuta di combattere sempre a causa dell’impegno preso verso re Agramante. Ruggiero si mostra disposto a rimandare il combattimento ma solo a patto di riavere subito il proprio destriero. Mentre i due cavalieri sono impegnati a litigare, arriva Mandricardo, subito si infuria vedendo che Ruggiero porta sullo scudo la stessa sua insegna, e sfida quindi a duello il cavaliere. Entrambi impugnano la spada e sono pronti a combattere, Rodomonte e Marfisa si intromettono però subito e cercano di calmare gli animi. Mandricardo è però ormai acceso d’ira e minaccia contemporaneamente Rodomonte e Ruggiero. Anche Rodomonte inizia a rispondere alle provocazioni ed alla fine rimane solo Marfisa a tentare di calmare la situazione, che tuttavia, alla fine dovrà giocoforza rispondere anche lei. Inizia un feroce combattimento tra Rodomonte e Ruggiero ed anche tra Marfisa e Mandricardo. A questo punto Superbia e Discordia tornano al monastero dal quale erano partite. Ma un demone prende possesso del cavallo di Doralice, facendolo scappare con in sella la donna urlante. Rodomonte corre subito in soccorso della donna amata; Mandricardo fa altrettanto e subito abbandona il combattimento. Marfisa e Ruggiero, non possono fare altro che recarsi all’accampamento pagano presso Parigi con l’intenzione di incontrare nuovamente là i loro avversari.

Julius Schnorr von Caroesfeld: Marfisa (1822)
Il XXVII è un canto dove tutti i cavalieri valorosissimi vanno a dare forza all’esercito saraceno mentre re Carlo è privo dei suoi più valorosi paladini: Orlando e Rinaldo. Il primo è divenuto folle e vaga nudo per la Francia, l’altro, subito dopo aver liberato Parigi dall’assedio, ha ripreso la ricerca di Orlando ed Angelica, e continua a spostarsi dove pensa potessero trovarsi. Nel frattempo re Gradasso, Sacripante, Rodomonte e Mandricardo assaltano la retroguardia cristiana all’improvviso, mettendone in fuga una buona parte ma uccidendone e ferendone la maggioranza. Anche Marfisa e Ruggiero fanno uguale strage. Tutti i soldati saraceni trovano nuovo vigore alla vista dei loro più valorosi compagni ed inizia così una nuova sanguinosa battaglia. Re Carlo non può fare altro che rifugiarsi nuovamente tra le mura di Parigi. L’arcangelo Michele, allora ordina alla Discordia di riaccendere subito d’ira i cuori di Marfisa, Rodomonte, Mandricardo e Ruggiero. I quattro cavalieri abbandonano l’assedio e si recano da re Agramante che suggerisce infine di estrarre a sorte la priorità dei duelli e fa infine allestire un campo di battaglia. Il primo duello dovrebbe avvenire tra Rodomonte e Mandricardo, ma tra quest’ultimo e re Gradasso scoppia una lite furibonda, in quanto Gradasso, vedendo che Mandricardo porta con sé la spada di Orlando rinfaccia all’altro di avere usurpato Durindana ingiustamente, in quanto è lui il legittimo proprietario. Ruggiero si intromette per fare rispettare le priorità già assegnate ai duelli. La situazione viene ricondotta alla calma solo grazie all’intervento di re Agramante e re Marsilio.

Jean Honore Fragonard: Rodomonte e Mandricardo di fronte al re Agramante (1780)
Scoppia però contemporaneamente una violenta lite anche tra Rodomonte e Sacripante. Questo ultimo riconosce in Frontino il proprio cavallo Frontalatte, sottrattogli da un furfante (per poi essere consegnato a Ruggiero, ma lui questo non lo sa). Il combattimento tra i due viene interrotto da Ferraù e poi anche da re Agramante, accorso dopo aver avuto notizia della nuova contesa ed aver quindi lasciato re Marsilio a tenere a bada Ruggiero, Mandricardo e re Gradasso. Giunge sul posto anche Marfisa e, sentita la storia di Sacripante su come gli era stato tolto il cavallo e che molti indicano in Brunello l’autore di quel furto, capisce che è stato lo stesso Brunello a rubarle la spada quello stesso giorno in cui era stato rubato Frontalatte. La donna decide così di vendicarsi all’istante; fa prigioniero il ladrone, lo conduce da re Agramante e chiede di poterlo impiccare con le proprie mani. Marfisa porta infine con sé il prigioniero presso un piccola torre, dove ha intenzione di trattenerlo per tre giorni prima di procedere all’impiccagione. Re Agramante si indigna per quel gesto di Marfisa, e vorrebbe sfidarla ma viene fermato e decide quindi infine di lasciar fare alla donna, per potersi dedicare alle altre più gravi liti. Per porre fine alla lite tra Rodomonte e Mandricardo, causata dalla bella Doralice, decide che sia infine la donna a scegliere il proprio amante, la quale decide per Mandricardo. Rodomonte si rifiuta di dover sottostare alla decisione di una donna, impugna nuovamente la spada e sfida Mandricardo. Viene però fatto tacere da re Agramante ed infine non gli resta altro da fare che abbandonare le schiere dell’esercito insieme ad un piccolo seguito. Quindi il cavaliere saraceno si allontana dall’accampamento maledicendo Doralice, tutte le donne in genere ed anche il re Agramante. Decide di alloggiare in un ostello e la sera l’oste, rispondendo ad una domanda del cavaliere riguardo alla fedeltà delle donne, si propone di raccontargli una storia, che gli era stata riferita da un viaggiatore per convincerlo di quanto siano rare le donne fedeli.

Rodomonte con l’oste
La storia viene raccontata nel canto XXVIII: Astolfo, re dei Longobardi, era in gioventù molto bello, fino a credere di non poter avere eguali. Un giorno il cavaliere romano Fausto dice al re che l’unico che può competere con lui in bellezza, è suo fratello Giocondo. Astolfo, incredulo, convince il cavaliere a condurre Giocondo presso la sua corte, così da poterlo conoscere. La più grande difficoltà che Fausto dice al re di dover superare, era lo smisurato amore tra il fratello e la sua moglie, che li faceva stare sempre insieme.

Giocondo con la moglie prima della partenza
Il cavaliere riesce a convincere la moglie di Giocondo, ma le notti ed i giorni prima della partenza la donna si mostra disperata, dicendo di non riuscire a vivere senza di lui. Il giorno prima di partire la donna gli regala anche una collanina, pregandolo di portarla sempre con sé come suo ricordo. Iniziato da poco il viaggio verso Pavia, Giocondo si rende conto di aver dimenticato il dono della moglie e decide di ritornare a Roma a riprenderlo. Trova così la moglie a letto addormentata tra le braccia di un loro garzone. Inizialmente il giovane pensa di ucciderli entrambi, ma poi, riprende la collanina in silenzio, senza svegliarli, e riparte. Da quel momento Giocondo non riesce più a dormire, né a mangiare ed inizia anche ad ammalarsi, tanto che la sua bellezza, quando giunge finalmente a Pavia, è ormai svanita. Il re Astolfo fa di tutto per fare riprendere il giovane, ma senza successo. Un giorno però, guardando attraverso un fessura nel muro della sua stanza, Giocondo vede la moglie del re sottomessa ai piaceri di un orribile nano, e assiste allo spettacolo per tutti i giorni successivi. Inizia a vedere sotto un altro punto di vista il proprio male (l’infedeltà è propria delle donne); ricomincia a mangiare, a dormire e si riprende indietro tutta la propria bellezza. Il re vuole sapere le ragioni della sua guarigione e Giocondo, dietro promessa che non si sarebbe vendicato, gliele mostra attraverso la fessura presente nella sua stanza.

La moglie di Astolfo con il nano
Dopo un primo momento d’ira, Astolfo chiede consiglio al giovane su come comportarsi ora. Giocondo propone di andare in giro per il mondo a fare alle mogli di altri ciò che il nano ed il garzone avevano fatto alle loro. Si mettono in viaggio e dopo un po’ di tempo passato da una donna all’altra, decidono di trovarne una sola, fissa, che possa piacere ad entrambi, pensando di soddisfare così anche la natura infedele della donna. La ragazza scelta si chiama Fiammetta, figlia di un albergatore di Valenza, che nell’albergo in cui i due si sono fermati, incontra un ragazzo, Greco, da sempre innamorato di lei e che la prega di soddisfare la sua passione amorosa. Lei accetta e lo invita la notte nella sua camera, dove dormiva in un unico letto insieme ad Astolfo e Giocondo. Il giorno dopo, avendo capito che qualcuno si è divertito tutta la notte con Fiammetta, Astolfo e Giocondo, hanno pensato uno che fosse stato l’altro, e hanno iniziato a prendersi in giro, ma Fiammetta fa il nome di Greco. I due uomini, passato il primo momento di incredulità, cominciano poi a ridere fino a sentire male al petto e capiscono quindi di aver avuto l’ultima e la più convincente prova dell’infedeltà femminile. Terminata la storia, l’oste riceve l’approvazione di Rodomonte, che il giorno dopo parte fino a giungere presso un villaggio. Passano un giorno da quello stesso villaggio Isabella ed il monaco che l’aveva salvata dal suicidio, diretti al monastero di Provenza. Rodomonte vista l’avvenenza della donna, decide di concentrare tutto il suo amore su di lei. Saputa la sua storia e la decisione di chiudersi nel monastero Rodomonte cerca di persuaderla. Il monaco cerca di venire in aiuto alla donna, ma finisce con l’accendere d’ira il guerriero e viene subito aggredito.
Sarà nel XXIX canto che Rodomonte prima uccide violentemente il vecchio, poi si rivolge con voce languida alla donna. Isabella, capito che ogni tentativo di resistere alla violenza del saraceno sarebbe inutile, promette a Rodomonte di preparargli un liquore in grado di renderlo invulnerabile in cambio del rispetto del suo voto di castità. Terminata la preparazione, la donna propone al saraceno di essere lei in prima persona a provare al liquore. Isabella ci si bagna tutto il corpo ed espone il proprio collo alla spada di Rodomonte: muore decapitata, pronunciando in ultimo il nome di Zerbino. Rodomonte rimane sconvolto per aver ucciso la donna amata e decide di trasformare la chiesetta del villaggio in un monumento funebre in onore di Isabella e Zerbino. Fa costruire anche un ponte senza protezioni e promette di adornare il sepolcro con le armi di tutti i cavalieri che oseranno attraversarlo. Il sepolcro non era ancora stato terminato quando giunge sul posto l’Orlando furioso e, completamente nudo e disarmato, si mette a correre sul ponte. Rodomonte minaccia il paladino prima da lontano, poi parte all’attacco con l’intenzione di buttarlo giù. Il combattimento corpo a corpo tra i due valorosi cavalieri termina quando entrambi finiscono nel fiume. Orlando, completamente nudo, raggiunge subito la riva a nuoto e riprende la propria folle corsa; Rodomonte è invece rallentato nei movimenti dalle proprie armi e tocca quindi terra molto dopo il cristiano. Durante il suo vagare senza meta, saranno molte le pazzie compiute dal conte Orlando. Giunge infine in riva al mare di Spagna.

Dosso Dossi: Angelica e Orlando furioso
L’ULTIMO INCONTRO TRA ANGELICA ED ORLANDO
(XXIX, 57-71)
E queste ed altre assai cose stupende
fece nel traversar de la montagna.
Dopo molto cercare, al fin discende
verso meriggie alla terra di Spagna;
e lungo la marina il camin prende,
ch’intorno a Taracona il lito bagna:
e come vuol la furia che lo mena,
pensa farsi uno albergo in quella arena,
dove dal sole alquanto si ricuopra;
e nel sabbion si caccia arrido e trito.
Stando così, gli venne a caso sopra
Angelica la bella e il suo marito,
ch’eran (sì come io vi narrai di sopra)
scesi dai monti in su l’ispano lito.
A men d’un braccio ella gli giunse appresso,
perché non s’era accorta ancora d’esso.
Che fosse Orlando, nulla le soviene:
troppo è diverso da quel ch’esser suole.
Da indi in qua che quel furor lo tiene,
è sempre andato nudo all’ombra e al sole:
se fosse nato all’aprica Siene,
o dove Ammone il Garamante cole,
o presso ai monti onde il gran Nilo spiccia,
non dovrebbe la carne aver più arsiccia.
Quasi ascosi avea gli occhi ne la testa,
la faccia macra, e come un osso asciutta,
la chioma rabuffata, orrida e mesta,
la barba folta, spaventosa e brutta.
Non più a vederlo Angelica fu presta,
che fosse a ritornar, tremando tutta:
tutta tremando, e empiendo il ciel di grida,
si volse per aiuto alla sua guida.
Come di lei s’accorse Orlando stolto,
per ritenerla si levò di botto:
così gli piacque il delicato volto,
così ne venne immantinente giotto.
D’averla amata e riverita molto
ogni ricordo era in lui guasto e rotto.
Gli corre dietro, e tien quella maniera
che terria il cane a seguitar la fera.
Il giovine che ’l pazzo seguir vede
la donna sua, gli urta il cavallo adosso,
e tutto a un tempo lo percuote e fiede,
come lo trova che gli volta il dosso.
Spiccar dal busto il capo se gli crede:
ma la pelle trovò dura come osso,
anzi via più ch’acciar; ch’Orlando nato
impenetrabile era ed affatato.
Come Orlando sentì battersi dietro,
girossi, e nel girare il pugno strinse,
e con la forza che passa ogni metro,
ferì il destrier che ’l Saracino spinse.
Feril sul capo, e come fosse vetro,
lo spezzò sì, che quel cavallo estinse:
e rivoltosse in un medesmo istante
dietro a colei che gli fuggiva inante.
Caccia Angelica in fretta la giumenta,
e con sferza e con spron tocca e ritocca;
che le parrebbe a quel bisogno lenta,
se ben volasse più che stral da cocca.
De l’annel c’ha nel dito si ramenta,
che può salvarla, e se lo getta in bocca:
e l’annel, che non perde il suo costume,
la fa sparir come ad un soffio il lume.
O fosse la paura, o che pigliasse
tanto disconcio nel mutar l’annello,
o pur, che la giumenta traboccasse,
che non posso affermar questo né quello;
nel medesmo momento che si trasse
l’annello in bocca e celò il viso bello,
levò le gambe ed uscì de l’arcione,
e si trovò riversa in sul sabbione.
Più corto che quel salto era dua dita,
aviluppata rimanea col matto,
che con l’urto le avria tolta la vita;
ma gran ventura l’aiutò a quel tratto.
Cerchi pur, ch’altro furto le dia aita
d’un’altra bestia, come prima ha fatto;
che più non è per riaver mai questa
ch’inanzi al paladin l’arena pesta.
Non dubitate già ch’ella non s’abbia
a provedere; e seguitiamo Orlando,
in cui non cessa l’impeto e la rabbia
perché si vada Angelica celando.
Segue la bestia per la nuda sabbia,
e se le vien più sempre approssimando:
già già la tocca, ed ecco l’ha nel crine,
indi nel freno, e la ritiene al fine.
Con quella festa il paladin la piglia,
ch’un altro avrebbe fatto una donzella:
le rassetta le redine e la briglia,
e spicca un salto ed entra ne la sella;
e correndo la caccia molte miglia,
senza riposo, in questa parte e in quella:
mai non le leva né sella né freno,
né le lascia gustare erba né fieno.
Volendosi cacciare oltre una fossa,
sozzopra se ne va con la cavalla.
Non nocque a lui, né sentì la percossa;
ma nel fondo la misera si spalla.
Non vede Orlando come trar la possa;
e finalmente se l’arreca in spalla,
e su ritorna, e va con tutto il carco,
quanto in tre volte non trarrebbe un arco.
Sentendo poi che gli gravava troppo,
la pose in terra, e volea trarla a mano.
Ella il seguia con passo lento e zoppo;
dicea Orlando: «Camina!» e dicea invano
Se l’avesse seguito di galoppo,
assai non era al desiderio insano.
Al fin dal capo le levò il capestro,
e dietro la legò sopra il piè destro;
e così la strascina, e la conforta
che lo potrà seguir con maggior agio.
Qual leva il pelo, e quale il cuoio porta,
dei sassi ch’eran nel camin malvagio.
La mal condotta bestia restò morta
finalmente di strazio e di disagio.
Orlando non le pensa e non la guarda,
e via correndo il suo camin non tarda.
Queste cose, ed altre tanto incredibili, fece attraversando la montagna. Dopo molto girovagare, alla fine discende, verso mezzogiorno, nella terra di Spagna; ed intraprende il cammino lungo il mare che bagna la spiaggia intorno a Terragona: e come vuole la follia che lo governa, pensa di costruirsi un rifugio in quella sabbia, // nel quale potersi riparare un poco dal sole; quindi si caccia sotto il sabbione, misto a terra, fine ed arido. Stando così, sopraggiunse per caso lì dove lui si trovava, la bella Angelica insieme a suo marito Medoro, che erano (così come vi ho in precedenza raccontato) scesi dai monti Pirenei fino al litorale della Spagna. Ella si avvicinò a meno di un braccio di distanza, non essendosi ancora accorta di lui. // Che quella persona fosse Orlando, non le passa nemmeno per la testa: è troppo diverso da colui che era solito essere. Da quando la follia si è impadronita di lui, è sempre andato in giro nudo, sia all’ombra che al sole: se fosse nato nell’assolata Assuan, o là dove i Garamanti venerano il dio Ammone, o presso ai monti, della luna, dai quali il grande Nilo sgorga, la sua carne non sarebbe stata più bruciacchiata di quanto lo era adesso. // Aveva gli occhi quasi nascosti nella testa, tanto erano rientrati, la faccia smagrita ed asciutta quasi quanto un osso, la chioma arruffata, squallida ed irta, la barba folta, spaventosa e spiacevole. Angelica non fu più veloce a vederlo, di quanto lo fu a tornare indietro, tremando tutta: tremando tutta, e riempiendo il cielo di grida, si volse chiedendo aiuto verso la sua guida, Medoro. // Non appena lo stolto Orlando si accorse di lei, per trattenerla si alzò di botto: tanto gli piacque il volto delicato di Angelica, tanto ne divenne immediatamente ghiotto. Di averla lungamente amata e riverita, ogni ricordo era in lui guasto e ridotto in pezzi. Le corre dietro, e si comporta come si comporterebbe il cane per rincorrere la preda. // Il giovane Medoro, vedendo quel pazzo inseguire la sua donna, gli getta il proprio cavallo addosso, e contemporaneamente lo percuote e lo colpisce, non appena vede che costui gli volta le spalle. Crede di potergli staccare la testa dal busto: ma trova invece una pelle dura come osso, anzi, molto più dell’acciaio; poiché Orlando era nato invulnerabile per incantesimo. // Come Orlando si sentì colpire alle spalle, si girò, nel girarsi strinse il pugno e con una forza che supera ogni possibile misura, colpì il destriero che il saraceno aveva spinto innanzi. Lo colpì al capo, e come se fosse stato di vetro, lo spezzò, così che quel cavallo uccise: e si voltò nuovamente, nel medesimo istante, verso colei che gli fuggiva dinnanzi. // Angelica spinge in tutta fretta la propria cavalla, e con frusta e con speroni la colpisce ripetutamente; poiché le sembrerebbe lenta, per il proprio bisogno di fuggire, anche se volasse più veloce della freccia scagliata dall’arco. Si ricorda poi che l’anello che porta al dito può salvarla, e se lo getta quindi in bocca: e l’anello, che non perde i suoi poteri magici, la fa sparire così come con un soffio fa sparire il lume. // Fosse stata la paura, o l’aver assunto una posizione tanto scomposta nel maneggiare l’anello, oppure il fatto che la cavalla fosse caduta a terra, io non posso affermare né l’una né l’altra ipotesi; nello stesso momento in cui si gettò l’anello in bocca e nascose alla vista il proprio bel viso, sollevò le gambe in aria, cadde dall’arcione e si trovò riversa sulla sabbia. // Fosse stato quella caduta anche più corta di due dita, sarebbe rimasta avviluppata con il matto, che nell’urto le avrebbe tolto la vita; ma una grande fortuna l’aiutò in quella circostanza. Cerchi ora pure, Angelica, con un’altro furto di ottenere l’aiuto di una altra bestia, come già aveva prima fatto; perché non sarà per riavere questa cavalla che si metterà ancora a correre sulla sabbia dinanzi al paladino. // Non dubitate ora che lei riesca a provvedere a sé stessa; seguiamo quindi le vicende di Orlando, nel quale non cessa la rabbia e l’impeto per il fatto che Angelica si tenga a lui nascosta. Insegue la cavalla di lei lungo la nuda spiaggia, e le si avvicina sempre di più: riesce a toccarla, ed ecco che l’afferra per la criniera, quindi per il freno, ed alla fine riesce a trattenerla. // Il paladino la afferra esultando tanto quanto un’altro avrebbe fatto prendendo invece una ragazza: le sistema le redini e la briglia, spicca un salto e si va a mettere in sella; la spinge al galoppo per molte miglia, senza concederle riposo, ora da questa ed ora da un’altra parte: non le toglie mai né la sella né il freno, mai le lascia assaporare né l’erba e né il fieno. // Volendosi cacciare dall’altra parte di un fossato, finisce a gambe all’aria con la cavalla. L’incidente non nuoce a lui, né lui sente il colpo; ma la povera cavalla, urtando il fondo del fossato, si sloga una spalla. Orlando non riesce a trovare un modo per tirarla fuori dal fossato, alla fine se la mette in spalla e ritorna su, e procede con tutto quel carico sulle spalle per una distanza superiore a tre tiri d’arco. // Sentendo poi che quel peso gli grava troppo, pone in terra la cavalla con l’intenzione di condurla per la briglia. La bestia lo segue zoppicando e con passo lento; dice Orlando: «Cammina!» ma lo dice inutilmente. Fosse stata anche in grado di seguirlo al galoppo, non sarebbe stato comunque abbastanza per il destriero di un pazzo. Alla fine le leva dal capo la cavezza, e la lega, dietro di sé, sopra al piede destro; // e così prosegue il proprio cammino trascinandola, e per confortarla le dice che così potrà seguirlo con un maggiore agio. Le levano il pelo e le asportano la pelle i sassi che incontra lungo quel difficile cammino. La bestia, così malamente trascinata, muore finalmente per lo strazio ed il disagio. Orlando non pensa a lei e non la guarda nemmeno, procede di fretta senza rallentare il cammino.
Il passo ci descrive il massimo capovolgimento della struttura epico-cavalleresca in un paradossale, ma non per questo meno tragico episodio. Si ricreano le strutture iniziali, quelle dell’inseguimento, ma vediamo come:
1. Orlando, l’integerrimo cavaliere si è trasformato in una lurida bestia, irriconoscibile per gli altri, il cui valore non è altro che forza bruta;
2. Angelica, bellissima e valorosa ragazza, non sa muoversi senza una guida e chiama vanamente Medoro che la salvi; fortunatamente (e narrativamente) si ricorda dell’anello fatato, che tuttavia la farà cadere impudicamente a gambe levate in uno stagno;
3. La cavalla rappresenta l’oggetto sostitutivo di un impossibile amore; Orlando la tratta, appunto, come una ragazza: le carezza la criniera e la “monta” fino a sfinirla. Non si rende conto neppure della sua morte.
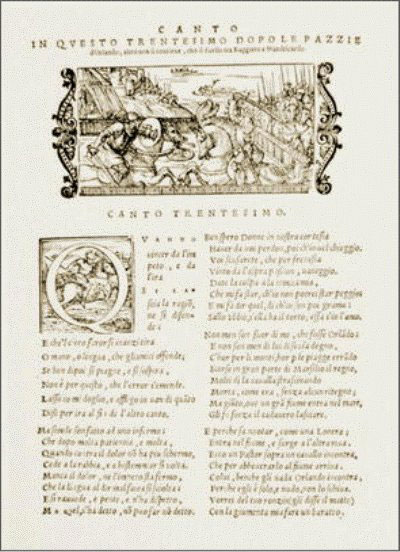
Edizione del 1548 pubblicata a Venezia
Le avventure di Orlando continueranno anche all’inizio del canto XXX portando ovunque distruzione. Giunge infine nei pressi di un immenso accampamento di guerrieri saraceni. Nell’accampamento saraceno, invece, nei pressi di Parigi, nonostante l’intervento del re Agramante e del re Marsilio si dà vita al duello tra Ruggiero e Mandricardo per la sorte della spada Durindana, voluta da re Gradasso ma posseduta da Mandricardo, e per lo stemma con l’aquila bianca, posseduta e contesa da Ruggiero e Mandricardo. Lo scontro, durissimo, vede alla fine vincitore Ruggiero che tuttavia rimane ferito e quindi curato nella tenda del re. Bradamante, grazie a Ippalca, riceve notizie di Ruggiero, ma lei teme di non riuscire più ad incontrarlo e si dispiace che lui abbia preferito andare in aiuto di suoi nemici piuttosto che raggiungerla. Infatti il cavaliere non riuscirà a tornare da lei entro venti giorni. Bradamante, saputo da Ricciardetto, che Ruggiero si era diretto con Marfisa a Parigi, inizia a temere anche per l’amore di lui. Parte per Parigi anche Rinaldo insieme a Ricciardetto. Rimane sua sorella, Bradamante, ancora in attesa dell’amante e finge pertanto una malattia.

Continua il racconto nel XXXI canto quando Rinaldo e Ricciardetto incontrano un cavaliere misterioso, accompagnato da una donna, che subito sfida e sconfigge il fratello di Bradamante. Quindi Rinaldo si candida subito come prossimo avversario del cavaliere, ma il duello non avrà subito esito. Giunge la notte e viene deciso di rimandare la contesa al giorno successivo. Rinaldo conduce con sé il rivale al suo padiglione, e scopre che il cavaliere misterioso è Guidon Selvaggio e che quindi sono fratelli, e finiscono per abbracciarsi amorevolmente. Il valoroso ragazzo si unisce agli altri e tutti insieme riprendono il giorno dopo il viaggio verso Parigi. Il gruppo di cavalieri incontra a poca distanza da Parigi anche altri paladini, impegnati in una discussione con una donna, Fiordiligi, triste e molto bella. Anche loro si uniscono al gruppo di cavalieri. La donna, riconosciuto Rinaldo, gli racconta della pazzia del cugino Orlando, del fatto che gli era stata rubata la spada Durindana ed il destriero Brigliadoro, e che correva nudo per il mondo, dello scontro che aveva avuto con Rodomonte ed infine che ora il re Gradasso è in possesso della sua terribile spada. Rinaldo rimane scosso dal racconto della donna e decide di fare tutto il possibile per fare rinsavire il cugino, non prima però di avere liberato re Carlo dall’assedio. Viene deciso di muovere battaglia nella notte ed il gruppo di cavalieri si ripara in un bosco. Giunto il momento dell’assalto, i cristiani fanno strage nell’accampamento dell’esercito pagano. Fra gli eroi cristiani troviamo anche Brandimarte, che veduta Fiordiligi, corre subito ad abbracciarla. La donna le racconta subito quanto aveva visto e saputo riguardo ad Orlando, e Brandimarte, che ama il conte come fosse suo fratello si mette in viaggio alla ricerca del cavaliere furioso. Giungono al ponte di Rodomonte ed il pagano chiede subito al cavaliere cristiano di togliersi le armi.
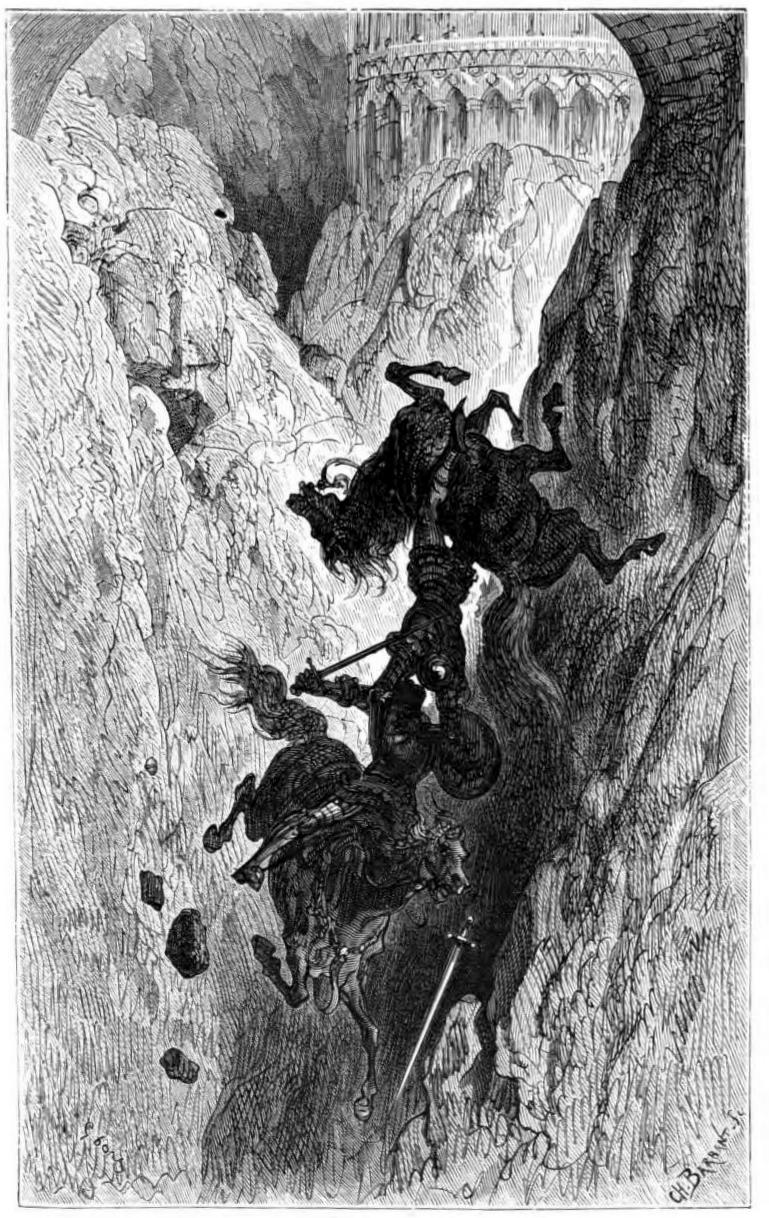
Brandimarte cade sul fiume nel ponte di Rodomonte
Brandimarte non risponde alla provocazione e lancia subito il suo cavallo contro l’avversario. Lo scontro tra i due sfidanti avviene sul ponte ed è talmente duro che entrambi finiscono nel fiume sottostante. Rodomonte, abituato a quella situazione, sa che via prendere ed esce subito sulla riva, Brandimarte finisce invece sottosopra con il proprio cavallo ed è trasportato dalla corrente. Fiordiligi si allontana alla ricerca di un valoroso cavaliere al quale chiedere aiuto per liberare il suo amato. Incontrerà infine un cavaliere riccamente adornato. Nel frattempo, a Parigi, re Agramante scappa dall’accampamento insieme ai suoi soldati e a Ruggiero, trasportato ancora malfermo su di un cavallo e poi su una nave. Il numero di pagani uccisi da Rinaldo e dagli altri cristiani è immenso. Solo re Gradasso rimane sul campo di battaglia, tanto è il suo desiderio di conquistare anche Baiardo, il cavallo di Rinaldo, avendo già Durindana, la spada di Orlando. Il pagano ed il cristiano si erano già dati appuntamento in passato per sostenere quel duello, ma un incantesimo di Malagigi aveva però allontanato Rinaldo. Il saraceno raggiunge ora il paladino e subito gli rinfaccia la sua codardia. Rinaldo spiega la sua storia, poi entrambi i guerrieri fissano un nuovo appuntamento per il giorno successivo presso una fontana. La mattina dopo entrambi si presentano per sostenere il combattimento.
Re Agramante, nel canto XXXII, giunge nella città di Arles e subito riorganizza l’esercito. Ad esso si aggiunge Marfisa, che non aveva voluto sporcarsi le mani con il vile sangue di Brunello e lo porta con sé per venire impiccato da re Agramante stesso.

Marfisa si reca da re Agramante
Nel frattempo Bradamante, aspetta invano l’arrivo di Ruggiero. I venti giorni passano lentissimi e la donna, per gelosia nei confronti di Marfisa, si tormenta al pensiero che Ruggiero non la ami più. Nonostante ciò, Bradamante ha ancora speranza che le promesse di Ruggiero siano vere. Giunge però presso il suo castello un cavaliere scappato dall’accampamento saraceno e le racconta le dicerie che avevano iniziato a circolare per l’esercito pagano: Marfisa e Ruggiero si amavano, erano ormai inseparabili e si sarebbero sposati. Bradamante, che ritiene ormai Ruggiero un infedele, decide però infine di partire e di unirsi nuovamente all’esercito cristiano, per vendicarsi di Marfisa e trovare la morte per mano dello stesso Ruggiero. Incontra durante il suo viaggio un donna con tre cavalieri al suo fianco ed al seguito una lunga schiera di persone. Bradamante viene a sapere che si tratta di una messaggera della bellissima regina d’Islanda, mandata da re Carlo per fargli dono di quello scudo, da destinare al più valoroso dei cavalieri cristiani. I tre cavalieri al suo fianco, tutti re, avevano già fatto prova del loro valore con il desiderio di avere in sposa la regina, ma lei, volendo come marito solo l’uomo più valoroso al mondo, aveva deciso di metterli un’ultima volta alla prova. Bradamante è presa dal suo tormento per Ruggiero, si lascia guidare dal cavallo finché giunge al castello di Tristano, dove chi viene ospitato deve necessariamente proteggere la propria stanza contro ogni altro cavaliere che si presenti dopo di lui; per le donne, è invece la loro bellezza a decidere a chi spetti la stanza. Bradamante giunge al castello, dice di voler una stanza e sfida i tre cavalieri che la occupano, che sono i tre re al seguito della messaggera della regina di Islanda. Bradamante si lancia al combattimento e li disarciona uno dopo l’altro, poi si toglie l’elmo è mostra a tutti la sua femminilità. L’oste quindi spiega quale sia l’origine di quella regola. Al tempo in cui il re di Francia era stato Fieramonte, quel castello era stato abitato dal figlio del re, Clodione, dalla sua bellissima amata e da dieci valorosi cavalieri. Giunse un giorno in quel posto Tristano, in compagnia di una donna, e chiese di poter essere ospitato. Clodione, geloso per la sua bellissima amante, rispose però con un rifiuto. Il valoroso cavaliere, indispettito, decise quindi di sfidare il figlio del re ed i suoi dieci cavalieri per ottenere con la forza ciò che non aveva potuto ottenere con le preghiere, e mise anche come condizione che in caso di vittoria avrebbe potuto lui solo stare in quella dimora. Tristano sconfisse tutti i rivali e prese possesso del castello. Clodione pregò il cavaliere di ridargli la sua bellissima compagna, ma Tristano rispose che una donna tanto bella meritava di stare con il cavaliere più valoroso e gli offrì invece in cambio la sua compagna di minore bellezza. Il giorno dopo Tristano, consapevole che era stato l’amore la causa di tutto, lasciò subito il castello e riconsegnò anche la bellissima donna al suo amato. Anche Clodiano lasciò quel castello e ci mise a guardia un cavaliere con il compito di fare rispettare quella regola a chiunque chiedesse ospitalità. Viene servita la cena, ma il padrone del castello comunica alla messaggera della regina d’Islanda che deve lasciare la dimora, in quanto meno bella di Bradamante, ma Bradamante stessa interviene dicendo di essersi meritata la stanza come cavaliere e non come donna.

Nel XXXIII, terminata la cena, Bradamante rimane nel grande salone ad ammirare i dipinti che ne rivestono le mura. Le pitture era state fatte realizzare con un incantesimo da Merlino per rappresentare scene future, ed in particolare le guerre che in futuro verranno sostenute dai francesi. Va infine a coricarsi e, addormentata, riceve in sogno la visita di Ruggiero che le rinnova la propria promessa d’amore.

Bradamante osserva le pitture
La donna si risveglia in lacrime, crede che sia vero solo ciò che la tormenta da sveglia. Riprende il proprio viaggio verso Parigi e, giunta alla città, ritrova Rinaldo e re Carlo, e viene a sapere da loro della sconfitta subita da re Agramante. Tornando a parlare della sfida tra re Gradasso e Rinaldo, per il possesso della spada Durindana e di Baiardo, i due cavalieri, giunti presso la fonte, impugnano subito la spada e danno inizio ad un feroce combattimento. Ma lo devono abbandonare quando vedono che il cavallo Baiardo è stato assalito da un mostro alato (probabilmente un incantesimo per cercare di interrompere il duello).

Il cavallo rapito da un mostro alato
Il cavallo riesce a mettersi in salvo in un bosco. Gradasso sale in groppa al proprio destriero e lo insegue, Rinaldo prosegue invece a piedi e, non riuscendo a trovare la giusta via, torna poi presso la fonte ed infine, non vedendo tornare neanche il rivale, all’accampamento cristiano. Re Gradasso alla fine ritrova il cavallo ma non rispetta il patto con lo sfidante cristiano, raggiunge re Agramante ad Arles e s’ imbarca per l’India. Astolfo, il cavaliere, in sella all’ippogrifo, dopo aver esplorato in lungo ed in largo la Francia a la Spagna, ed essere poi passato in Africa, raggiunge l’Etiopia, dove fa visita al re Senapo e lo trova tormentato dalle arpie. Queste erano state mandate da Dio per punirlo per aver voluto, quando era giovane, muovere il proprio esercito verso la sorgente del Nilo e verso i monti della Luna, sede del paradiso terrestre, per assoggettare i suoi abitanti. Il termine della punizione venne predetta a Senapo con la venuta dal cielo di un cavaliere in sella ad una cavallo alato. Astolfo quindi riesce a liberarlo dalla Arpie che inseguite dallo stesso, raggiungono il monte della Luna e si infilano subito nella grotta che porta fino agli abissi dell’Inferno.

Nel XXXIV Astolfo decide di avventurarsi per i gironi infernali. Il fumo nero e sgradevole che ne riempie l’aria, diviene però via via più denso man mano che si procede verso il basso, finché il cavaliere è costretto a fermarsi. Astolfo incontra l’anima di Lidia, che gli racconta la propria storia. In vita è stata tanto bella quanto altezzosa e ha fatto innamorare di sé il cavaliere Alceste. Il ragazzo si mette per amore al servizio del re di Lidia, padre della ragazza e con le proprie imprese gli consente innumerevoli conquiste. Alceste chiede un giorno la mano di Lidia, ma il re gli risponde con un rifiuto. Allora lascia la corte per offrire le proprie armi al re di Armenia, acerrimo nemico del padre della ragazza. Nel giro di un anno al re di Lidia rimane il possesso del suo solo castello e decise così di mandare la figlia a trattare la resa con Alceste. La ragazza, accortasi del potere che ha nei confronti del cavaliere lo fa subito sentire in colpa per i danni causati al padre e che, dopo quello che era successo, non vuole ora più amarlo, preferisce piuttosto la morte. Alceste si lancia ai piedi della ragazza chiedendo perdono, lei glielo promette a patto di fare riconquistare al padre tutto ciò che gli è stato sottratto in quella guerra. Il giovane quindi uccide il re di Armenia ed in meno di un mese ridà il regno al padre della amata. La ragazza ed il re decidono poi di fare morire Alceste e lo allontanano infine dalla corte. La sofferenza per quel trattamento fa ammalare e quindi morire Alceste. Gli occhi di Lidia vengono ora fatti lacrimare da quel fumo denso, per punirla dell’ingratitudine mostrata verso chi l’amava. Astolfo poi chiude con massi e tronchi l’apertura della caverna, così da impedire alle arpie di uscire nuovamente, e sale con l’ippogrifo verso il monte. Infine raggiunge la cima della montagna:

Astolfo e l’evangelista Giovanni
ASTOLFO NELLA LUNA
(XXXIV, 60-67; 70,75; 81-86)
Con accoglienza grata il cavalliero
fu dai santi alloggiato in una stanza;
fu provisto in un’altra al suo destriero
di buona biada, che gli fu a bastanza.
De’ frutti a lui del paradiso diero,
di tal sapor, ch’a suo giudicio, sanza
scusa non sono i duo primi parenti,
se per quei fur sì poco ubbidienti.
Poi ch’a natura il duca aventuroso
satisfece di quel che se le debbe,
come col cibo, così col riposo,
che tutti e tutti i commodi quivi ebbe;
lasciando già l’Aurora il vecchio sposo,
ch’ancor per lunga età mai non l’increbbe,
si vide incontra ne l’uscir del letto
il discipul da Dio tanto diletto;
che lo prese per mano, e seco scorse
di molte cose di silenzio degne:
e poi disse: «Figliuol, tu non sai forse
che in Francia accada, ancor che tu ne vegne.
Sappi che ’l vostro Orlando, perché torse
dal camin dritto le commesse insegne,
è punito da Dio, che più s’accende
contra chi egli ama più, quando s’offende.
Il vostro Orlando, a cui nascendo diede
somma possanza Dio con sommo ardire,
e fuor de l’uman uso gli concede
che ferro alcun non lo può mai ferire;
perché a difesa di sua santa fede
così voluto l’ha costituire,
come Sansone incontra a’ Filistei
costituì a difesa degli Ebrei:
renduto ha il vostro Orlando al suo Signore
di tanti benefici iniquo merto;
che quanto aver più lo dovea in favore,
n’è stato il fedel popul più deserto.
Sì accecato l’avea l’incesto amore
d’una pagana, ch’avea già sofferto
due volte e più venire empio e crudele,
per dar la morte al suo cugin fedele.
E Dio per questo fa ch’egli va folle,
e mostra nudo il ventre, il petto e il fianco;
e l’intelletto sì gli offusca e tolle,
che non può altrui conoscere, e sé manco.
A questa guisa si legge che volle
Nabuccodonosor Dio punir anco,
che sette anni il mandò il furor pieno,
sì che, qual bue, pasceva l’erba e il fieno.
Ma perch’assai minor del paladino,
che di Nabucco, è stato pur l’eccesso,
sol di tre mesi dal voler divino
a purgar questo error termine è messo.
Né ad altro effetto per tanto camino
salir qua su t’ha il Redentor concesso,
se non perché da noi modo tu apprenda,
come ad Orlando il suo senno si renda.
Gli è ver che ti bisogna altro viaggio
far meco, e tutta abbandonar la terra.
Nel cerchio de la luna a menar t’aggio,
che dei pianeti a noi più prossima erra,
perché la medicina che può saggio
rendere Orlando, là dentro si serra.
Come la luna questa notte sia
sopra noi giunta, ci porremo in via.»
Non appena la luna compare in cielo, il cavaliere e l’evangelista si sistemano su di un carro trainato da quattro cavalli rosso fuoco ed iniziano così il loro viaggio per la Luna
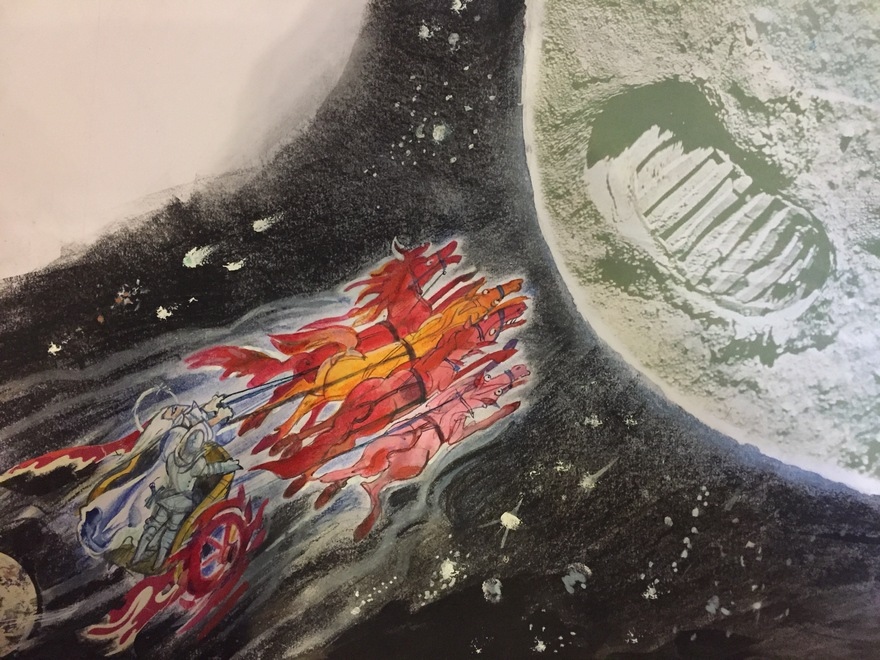
Grazia Nidasio: Astolfo e San Giovanni sul carro verso la luna
Tutta la sfera varcano del fuoco,
ed indi vanno al regno de la luna.
Veggon per la più parte esser quel loco
come un acciar che non ha macchia alcuna;
e lo trovano uguale, o minor poco
di ciò ch’in questo globo si raguna,
in questo ultimo globo de la terra,
mettendo il mar che la circonda e serra.
Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia:
che quel paese appresso era sì grande,
il quale a un picciol tondo rassimiglia
a noi che lo miriam da queste bande;
e ch’aguzzar conviengli ambe le ciglia,
s’indi la terra e ’l mar ch’intorno spande,
discerner vuol; che non avendo luce,
l’imagin lor poco alta si conduce.
Altri fiumi, altri laghi, altre campagne
sono là su, che non son qui tra noi;
altri piani, altre valli, altre montagne,
c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,
con case de le quai mai le più magne
non vide il paladin prima né poi:
e vi sono ample e solitarie selve,
ove le ninfe ognor cacciano belve.
Non stette il duca a ricercar il tutto;
che là non era asceso a quello effetto.
Da l’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro diffetto,
o per colpa di tempo o di Fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.
Non pur di regni o di ricchezze parlo,
in che la ruota instabile lavora;
ma di quel ch’in poter di tor, di darlo
non ha Fortuna, intender voglio ancora.
Molta fama è là su, che, come tarlo,
il tempo al lungo andar qua giù divora:
là su infiniti prieghi e voti stanno,
che da noi peccatori a Dio si fanno.
Le lacrime e i sospiri degli amanti,
l’inutil tempo che si perde a giuoco,
e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,
vani disegni che non han mai loco,
i vani desideri sono tanti,
che la più parte ingombran di quel loco:
ciò che in somma qua giù perdesti mai,
là su salendo ritrovar potrai.
Astolfo arriva in una valle dove viene raccolto tutto ciò che sulla terra è stato smarrito:
Vide gran copia di panie con visco,
ch’erano, o donne, le bellezze vostre.
Lungo sarà, se tutte in verso ordisco
le cose che gli fur quivi dimostre;
che dopo mille e mille io non finisco,
e vi son tutte l’occurrenze nostre:
sol la pazzia non v’è poca né assai;
che sta qua giù, né se ne parte mai.
Quivi ad alcuni giorni e fatti sui,
ch’egli già avea perduti, si converse;
che se non era interprete con lui,
non discernea le forme lor diverse.
Poi giunse a quel che par sì averlo a nui,
che mai per esso a Dio voti non ferse;
io dico il senno: e n’era quivi un monte,
solo assai più che l’altre cose conte.
Era come un liquor suttile e molle,
atto a esalar, se non si tien ben chiuso;
e si vedea raccolto in varie ampolle,
qual più, qual men capace, atte a quell’uso.
Quella è maggior di tutte, in che del folle
signor d’Anglante era il gran senno infuso;
e fu da l’altre conosciuta, quando
avea scritto di fuor: Senno d’Orlando.
E così tutte l’altre avean scritto anco
il nome di color di chi fu il senno.
Del suo gran parte vide il duca franco;
ma molto più maravigliar lo fenno
molti ch’egli credea che dramma manco
non dovessero averne, e quivi dénno
chiara notizia che ne tenean poco;
che molta quantità n’era in quel loco.
Altri in amar lo perde, altri in onori,
altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze;
altri ne le speranze de’ signori,
altri dietro alle magiche sciocchezze;
altri in gemme, altri in opre di pittori,
ed altri in altro che più d’altro aprezze.
Di sofisti e d’astrologhi raccolto,
e di poeti ancor ve n’era molto.
Astolfo tolse il suo; che gliel concesse
lo scrittor de l’oscura Apocalisse.
L’ampolla in ch’era al naso sol si messe,
e par che quello al luogo suo ne gisse:
e che Turpin da indi in qua confesse
ch’Astolfo lungo tempo saggio visse;
ma ch’uno error che fece poi, fu quello
ch’un’altra volta gli levò il cervello.

Giovan Battista Galizzi: Astolfo e il senno di Orlando
Con gentile accoglienza, il cavaliere fu fatto alloggiare dai santi in una stanza; in una altra si provvide affinché al suo destriero fosse data a sufficienza della buona biada. Diedero a lui da mangiare alcuni frutti del paradiso, di tale sapore, che a suo giudizio, senza scuse non sono stati i due primissimi antenati, Adamo ed Eva, se a causa di quei frutti furono così poco obbedienti alle regole divine. // Dopo che l’avventuroso duca ebbe soddisfatto i bisogni della propria natura umana, tanto con il cibo, quanto con il riposo, avendo ricevuto proprio tutte le comodità; al sorgere del nuovo giorno, nell’ora in cui Aurora lascia il vecchio sposo Titone, che, nonostante l’età avanzata, non smise mai di piacerle, si vide venire incontro, mentre si alzava dal letto, il discepolo, Giovanni, tanto amato teneramente da Dio, // il quale lo prese per mano, e con lui discorse di molte cose meritevoli del silenzio, e poi disse: «Figliolo, tu forse non sai che cosa stia accadendo in Francia, sebbene tu venga proprio da lì. Sappi quindi che il vostro cavaliere Orlando, avendo deviato dal giusto cammino le insegne di difensore della Chiesa a lui affidate, è ora punito da Dio, che, quando viene offeso, si infiamma d’ira di più contro chi più ama. // Il vostro Orlando, al quale, alla nascita, diede Dio, con immenso rischio, un’immensa forza, e gli concesse, fuori dalle usanze umane, che nessun ferro avrebbe mai potuto ferirlo; poiché a difesa della sua santa fede l’ha voluto porre con questi poteri, così come Sansone contro i Filistei pose a difesa degli Ebrei; // al suo Signore il vostro Orlando ha dato in cambio un’ingiusta ricompensa per i tanti benefici ricevuti; poiché quanto lo doveva avere in suo aiuto il popolo fedele, il popolo cristiano, tanto ne è rimasto privo, è stato abbandonato a se stesso. Tanto l’aveva reso cieco l’amore peccaminoso nei confronti di una donna pagana, da avere ormai tollerato di divenire, in due e più occasioni, crudele e malvagio, e sul punto di dare la morte al suo fedele cugino Rinaldo. // E per questo Dio fa sì che egli vaghi preso dalla follia, e mostri nudi il ventre, il petto ed il proprio fianco; e gli offusca e toglie tanto l’intelletto, da non essere in grado di riconoscere gli altri, e nemmeno se stesso. Allo stesso modo si legge che Dio volle punire anche Nabuccodonosor, e che per sette anni lo mandò in giro completamente folle al punto che, come fosse stato un bue, si nutriva di erba e di fieno. // Ma poiché molto minore è tuttavia stato il peccato del paladino, rispetto a quello di Nabucco, dal volere divino soli tre mesi sono stati imposti come periodo per purificare questa colpa. Non per un altro scopo, dopo un così lungo viaggiare, ti ha concesso il Redentore di salire fino al Paradiso terrestre, se non perché tu possa da noi apprendere il modo per rendere ad Orlando il suo senno. // Dovrai in verità intraprendere un altro viaggio in mia compagnia, ed abbandonare quindi completamente la terra. Ti devo condurre sulla Luna, che, tra tutti i pianeti, si muove in cielo più vicina alla terra, perché la medicina che può rendere saggio Orlando viene tenuta lassù. Non appena la Luna questa notte sarà giunta sopra di noi, ci metteremo sulla via per raggiungerla».
(…)
Attraversano tutta la sfera di fuoco e quindi proseguono verso il regno della Luna. Vedono quel luogo essere per la maggior parte come un acciaio privo di qualunque macchia; e lo trovano uguale, o poco meno, per dimensioni, alla superficie complessiva del globo terrestre, della terra di questo ultimo globo, il globo terrestre, comprendendo anche il mare che la terra circonda e stringe. // Lì Astolfo rimase meravigliato due volte: che visto da vicino quel luogo era tanto grande, mentre assomiglia invece ad un piccolo tondo a noi che lo osserviamo da queste parti; e che gli conveniva aguzzare lo sguardo, se dalla Luna la terra ed il mare, che intorno ad essa si spande, vuole distinguere; poiché, non avendo luce propria, la loro immagine arriva poco lontana. // Ben altri fiumi, altri laghi, altre campagne ci sono là sulla Luna, rispetto a quelli che ci sono qui tra noi; ben altre pianure, altre valli, altre montagne hanno a disposizione le città ed i castelli della Luna, con case in confronto alle quali mai più grandi poté vederne il paladino né prima di allora né dopo: e ci sono anche vaste e solitarie selve, dove le ninfe cacciano ad ogni ora le belve che vi abitano. // Il duca Astolfo non rimase ad esplorare tutto quel luogo; poiché non era salito là per quello scopo. Dal santo apostolo Giovanni fu condotto in un valle stretta tra due montagne, dove veniva miracolosamente raccolto ciò che viene da noi perso, o per nostra colpa, o a causa del tempo o della Fortuna: ciò che si perde qua sulla terra, là sulla Luna si raduna. // Non parlo solo di regni o di ricchezze, su cui ha potere la mutevole ruota della Fortuna; ma voglio anche dire di ciò che la Fortuna non ha alcun potere di togliere o di dare. Là si trova molta di quella fama che, come fosse un tarlo, il tempo, con il suo lungo passare, qua sulla terra divora: là sulla Luna stanno le infinite preghiere e promesse, che vengono fatte a Dio da noi peccatori. // Le lacrime ed i sospiri degli amanti, l’inutile tempo che si perde giocando, ed il lungo ozio di uomini ignoranti, i vani propositi che non hanno mai attuazione, i desideri infruttuosi sono tanti da ingombrare la maggior parte di quel luogo: in conclusione, ciò che qua sulla terra tu potresti perdere, salendo là sù potrai ritrovarlo.
(…)
Vide una grande abbondanza di trappole appiccicose fatte con il vischio, che furono un tempo, oh donne, la vostra bellezza. Sarebbe lungo se raccontassi in versi tutte le cose che sulla Luna si mostrarono agli occhi di Astolfo; poiché anche dopo mille e mille versi non riuscirei a terminare, essendoci tutto ciò che ci può capitare in vita: soltanto la pazzia sulla Luna è presente nella giusta misura, né poca né troppa; in quanto sta qua giù sulla terra senza mai allontanarsi. // Lì, su alcuni suoi giorni e su alcuni fatti che riguardavano lui, e che egli aveva già dimenticato, rivolse la propria attenzione: che se non ci fosse stato Giovanni a spiegargli le cose, non avrebbe potuto Astolfo distinguerne le diverse forme. Poi giunse dove stava ciò che a noi sembra sempre di avere a sufficienza, tanto che mai si fecero voti a Dio per poterne avere di più; sto parlando del senno: ve n’era lì tanto da formare un monte, da solo in quantità molto superiore a tutte le altre cose finora raccontate. // Era come un liquido diluito e fluido, destinato ad evaporare, se non tenuto opportunamente chiuso in un recipiente; e si poteva vedere in quella valle raccolto in varie ampolle, quale più, quale meno capiente, adatte a quell’impiego. La più grande di tutte era quella nella quale era stato versato dentro il senno del folle cavaliere Orlando; e venne riconosciuta in mezzo alle altre, in quanto riportava al suo esterno la scritta: Senno d’Orlando. // Ed allo stesso modo anche le altre riportavano scritto il nome di coloro ai quali il senno, in esse contenuto, era appartenuto. Il duca Astolfo vide un ampolla contenente gran parte del proprio senno; ma lo fecero meravigliare molto di più le ampolle di molti che credeva non dovessero essere privi nemmeno di un briciolo del proprio senno, dettero invece lì evidenza del fatto di averne in realtà ancora poco; essendone presente una grande quantità in quel luogo. // Alcuni lo perdono a causa dell’amore, altri a causa dell’onore, altri nella ricerca di ricchezze, muovendosi per mare; altri a causa delle speranze riposte nei propri signori, altri stando dietro alle vane arti della magia; altri per le gemme, altri per le opere di pittori, ed altri per qualcosa d’altro che apprezzano più di ogni altra cosa. Di filosofi e di astrologi ed anche di poeti era stato raccolto molto senno in quel luogo. // Astolfo prese il proprio senno; glielo concesse l’apostolo Giovanni, scrittore dell’ultimo libro del Nuovo Testamento relativo all’Apocalisse. Si portò semplicemente al naso l’ampolla nella quale era esso contenuto, e sembra quindi che il senno fece ritorno al proprio posto: e che Turpino ammetta, da quel momento in avanti, che Astolfo visse per un lungo periodo come un uomo saggio; ma fu un errore che fece successivamente quello che una altra volta gli tolse ancora il senno.
E’ questo un altro passo considerato tra i più importanti dell’intero poema: esso riprende alcuni passi della letteratura classica, soprattutto dell’autore satirico greco Luciano che aveva narrato un viaggio sulla Luna, ma il riferimento più diretto è con Dante, in quanto anche qui vi è un’ascesa verso il Paradiso. La differenza è che il Paradiso ariostesco è specchio, in positivo, del nostro Mondo: a livello speculare ciò che in questo mondo non vi è più è raccolto tutto in cielo. Ma, come dice Calvino, se la Luna è piena del senno degli uomini, tanto che anche il sano Astolfo trova una significativa quantità del suo, è naturale che la terra ne sia quasi priva. E’ la riprova di ciò che l’autore ferrarese ci ha sinora detto: i vani desideri scappano, fuggono via e ci portano alla follia, se non riusciamo a porre dei limiti ad essi e a vivere con giusta e “sana” moderazione.
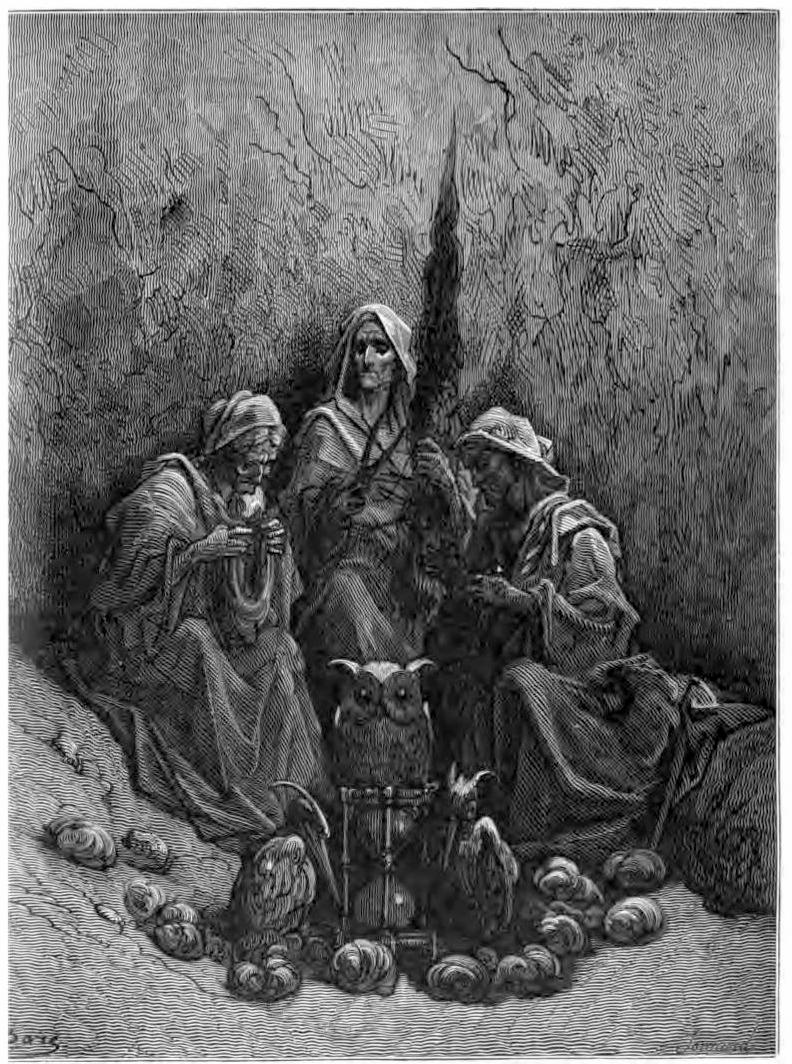
Le Parche
Dopo che il cavaliere ha prelevato l’ampolla del conte Orlando, l’evangelista Giovanni lo conduce in un palazzo pieno di batuffoli in cui una donna è intenta ad ottenere da ogni batuffolo un filo che poi avvolge su di un aspo per formare una matassa. Un’altra donna separa le matasse brutte da quelle belle. Sono le Parche (sembra qui strano che Ariosto ne citi soltanto due) ed hanno il compito di tessere la vita di ogni mortale. Un vecchio, il tempo, porta via senza riposo le piastrine che accompagnano le matasse con incisi i nomi delle persone loro proprietarie.

Nel XXXV canto Astolfo, vede un batuffolo che luccica più dell’oro e spicca per bellezza tra tutti gli altri presenti, è quello del cardinale Ippolito d’Este. Nel frattempo il vecchio, il tempo, scarica le piastrine nel fiume Lete, il fiume dell’oblio, che scorre vicino al palazzo. Molte piastrine vanno a fondo: alcune vengono prese nel becco da degli uccellacci per poi finire inevitabilmente ancora nel fiume; pochissime vengono invece salvate da due bianchi cigni, (gli scrittori) che le portano a riva, dove una ninfa le preleva per poi affiggerle ad una colonna del tempio dell’Immortalità. L’evangelista Giovanni sottolinea quindi quanto sia importante sostenere i poeti e gli scrittori perché il loro nome e di chi li benefica rimarrà nella storia.

Il Tempo
Nel frattempo Bradamante viene a sapere che re Agramante si trova ad Arles e si dirige in quella città, pensando di ritrovarvi anche Ruggiero. Incontra per strada Fiordiligi, afflitta per la sorte capitata all’amato Brandimarte, caduto prigioniero di Rodomonte. Fiordiligi chiede a Bradamante di liberare il suo fedele amante. Non appena la guerriera giunge al fiume, Rodomonte, si arma subito e si avvia per togliere le armi al nuovo venuto. Bradamante lo sfida a duello e chiede, come patto, che in caso di sua vittoria siano le armi del saraceno le uniche offerte al mausoleo, tutte le altre dovranno essere tolte e tutti i prigionieri dovranno essere liberati. Rodomonte accetta il patto, e chiede in cambio non le armi della donna, come era abitudine, ma il suo amore. La lancia d’oro di Bradamante (capace, per incantesimo, di disarcionare chiunque toccasse) manda a terra l’avversario pagano.
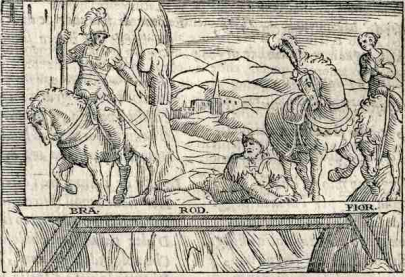
Rodomonte, tanta era la sorpresa per essere stato sconfitto da una donna, si toglie armi ed armatura, e si allontana, trovando rifugio in una caverna. Fiordiligi dice a Bradamante di voler andare alla città di Arles, dove spera di ritrovare Brandimarte. Bradamante si offre di accompagnarla per parte del viaggio e le chiede in cambio di portare a Ruggiero il cavallo che ha sottratto a Rodomonte (Frontino), e di dire al cavaliere pagano di armarsi e prepararsi a sfidare il cavaliere che glielo ha mandato, e che ha intenzione di dimostrare con le armi la sua infedeltà. Giunte ad Arles, Fiordiligi riporta il discorso della compagna e poi se ne va. Ruggiero è confuso da quel gesto di cortesia ma anche di sfida; non riesce a capire chi possa ritenerlo un infedele, crede si tratti di Rodomonte, non certo di Bradamante. Escono tre cavalieri, fra cui Ferraù, tutti disarcionati dal cavaliere misterioso. Ruggiero, saputo da Ferraù che il cavaliere chiede di lui, subito si prepara al combattimento.

Nel XXXVI Ruggiero si prepara al combattimento, ma Ferraù gli svela che probabilmente si tratta di Bradamante. Ruggiero non sa cosa fare e ritarda la propria uscita.

Marfisa, dipinto su maiolica
Marfisa approfitta dell’incertezza dell’uomo per uscire dalle mure e sfidare a duello il cavaliere. Bradamante capisce che non si tratta di Ruggiero, chiede il nome all’avversario, e saputo che si tratta di Marfisa, che le ha rubato l’amante, si accende subito d’ira ed è intenzionata ad ucciderla. Marfisa viene subito buttata a terra, appena Bradamante la tocca con la propria lancia incantata. Subito dopo esce Ruggiero, Bradamante lo riconosce e gli dice di volerlo uccidere. Ruggiero capisce che la causa di tutto è il suo non avere mantenuto i patti. Vorrebbe parlarle per spiegare le proprie ragioni ma Bradamante ha ormai già lanciato al galoppo il suo destriero contro di lui. Il pagano si stringe nell’armatura e tiene la lancia di lato per non ferirla. Lei all’ultimo non riesce a colpirlo e decide quindi di sfogare la propria ira contro gli altri avversari saraceni. Ruggiero riesce infine ad avvicinarsi all’amata ed a convincerla a lasciarlo parlare. Si allontanano quindi entrambi dal campo di battaglia. Marfisa, riuscita nel frattempo a risalire a cavallo e visto Ruggiero partire al galoppo all’inseguimento di Bradamante, li raggiunge.

Bradamante e Marfisa si sfidano
Bradamante si lancia contro la donna, e danno vita a una cruenta sfida. Ruggiero tenta con le preghiere di separare le due guerriere senza ottenere ascolto, passa infine alle maniere forti e fa così indirizzare contro di sé l’ira di Marfisa. Bradamante rimane da parte a godersi la scena, tale da rimuovere ogni suo precedente dubbio riguardo alla loro relazione. Il duello tra i due è interrotto dalla voce del mago Atlante. Il mago comunica a Ruggiero e Marfisa che sono fratelli gemelli. Almonte e Troiano, padre di re Agramante, avevano ucciso il loro padre Ruggiero II ed abbandonato in mare la loro madre Galaciella. La fortuna aveva però messo in salvo la donna, che li aveva così dati alla luce ed era morta subito dopo.

Ruggiero vs Marfisa, Bradamante e il mago Atlante
Atlante aveva dato sepoltura a Galaciella ed aveva allevato i due bambini, facendoli allattare da una leonessa. Un giorno un gruppo di arabi aveva rapido la bambina, ed a lui era rimasto solo Ruggiero. Detto questo, lo spirito del mago svanisce per raggiungere il regno degli inferi. Ruggiero e Marfisa si scoprono fratelli, abbandonano il combattimento e si abbracciano fraternamente. Ruggiero confessa quindi alla sorella l’amore che prova per Bradamante, le due donne si abbracciano affettuosamente ed abbandonano così anche loro ogni ostilità. Marfisa vuole sapere qualcosa di più riguardo alla loro madre ed al loro padre, Ruggiero le racconta la loro storia, di come Ruggiero II dovette combattere contro il re Agolante giunto in Italia con tre figli, tra cui Galaciella. Costei si convertì e appunto divenne la loro madre, mentre il padre trovò la morte dal re saraceno. Marfisa dichiara quindi la sua cristianità e dice infine di non voler più vedere il fratello in mezzo a cavalieri saraceni se non con l’intenzione di ucciderli. Il cavaliere non può però fare altro che promettere che aspetterà la prima buona occasione per lasciare l’esercito saraceno, senza compromettere il proprio onore.
Il canto XXXVII inizia con i tre (Bradamante, Marfisa e Ruggiero) che sentono un lamento e si dirigono nel luogo da dove proviene ed incontrano così tre donne, alle quali era stata tagliata la gonna fino all’ombelico. Sono le ambasciatrici mandate a portare lo scudo d’oro a Carlo.
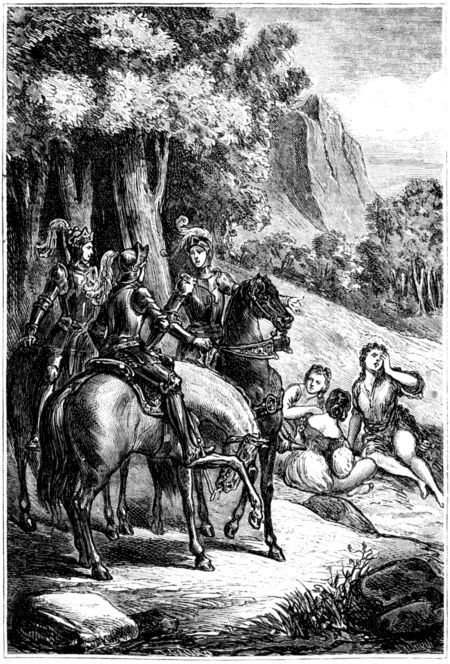 Bradamante, Marfisa e Ruggiero incontrano le donne con gli abiti tagliati
Bradamante, Marfisa e Ruggiero incontrano le donne con gli abiti tagliati
La donna le racconta che era stata così umiliata dagli abitanti di un castello vicino. La sera, i tre, con le donne al seguito alloggiano in un villaggio posto presso una collina e completamante abitato da donne. Ruggiero domanda ad una di loro il perché di quella situazione e gli viene quindi data la spiegazione. Il loro signore, Marganorre, aveva in odio il sesso femminile e le aveva perciò esiliate da ormai due anni al confine dei suoi possedimenti. Viene anche raccontato cos’è che ha portato all’istituzione di quella crudele usanza. Marganorre aveva due figli, Cilandro e Tanacro, molto cortesi ed ospitali verso chiunque passasse per quella terra. Un giorno capitò nel loro castello un cavaliere accompagnato da una bellissima dama. Cilandro si innamorò a tal punto della donna da scordare ogni regola di cortesia, che il cavaliere lo uccise. Anche Tanarco cadde nello stesso amore verso Drusilla, moglie del barone Olindro: se ne innamorò e cercò di impossessarsene con la forza. Ma per non cadere come suo fratello le uccide il marito. Drusilla capì di poter riuscire a vendicare la morte del marito solo con l’inganno: il giorno del matrimonio l’avvelena, fingendo di rispettare l’usanza di bere del liquore da uno stesso calice. Marganorre, rimasto privo di figli maturò odio contro le donne presenti e con la propria spada ne fece una strage. Quindi fece approvare una legge crudele, per cui le donne che capitavano in quella valle, dovevano essere fustigate e quindi umiliate con il taglio della gonna. Il mattino seguente Bradamante, Marfisa e Ruggiero si preparano per raggiungere il castello e mettere fine a quella legge crudele. Giunti nel borgo dove regna il crudele Marganorre, i tre cavalieri vengono subito circondati.

Drusilla, Ullania e le altre donne si vendicano di Marganorre
Marfisa si lancia contro il tiranno, lo lascia tramortito dopo averlo colpito alla testa con un pugno, lo lega e lo lascia quindi in custodia di una vecchia serva. Il tiranno viene quasi linciato dalla folla, il suo castello saccheggiato di ogni avere. Alle ambasciatrici viene restituito lo scudo d’oro e Marganorre viene buttato da una torre. Nel borgo sarà ora rispettata la legge dettata da Marfisa: saranno le donne a comandare nel villaggio, ogni terra e lo stesso castello sarà di loro proprietà. Inoltre, a nessuno straniero dovrà essere data ospitalità se non giura prima di essere per sempre amico delle donne e nemico dei loro nemici.

Quindi, siamo nel canto XXXVIII, Ruggiero prende la via per la città di Arles, mentre Bradamante e Marfisa raggiungono insieme l’accampamento cristiano e ricevono un’accoglienza festosa. Re Carlo le accoglie personalmente e, per la prima volta in tutta la sua vita, Marfisa si inginocchia, e gli dice che l’aver conosciuto le proprie origini le aveva ora spento il furore verso i cristiani, ed acceso un profondo odio verso re Agramante.

Re Carlo accoglie Marfisa tra i cavalieri
Marfisa dice anche di voler essere parente e serva di re Carlo, così come in passato lo era stato suo padre. Dice infine di volersi convertire al cristianesimo e di voler combattere contro i pagani. Re Carlo accetta di avere Marfisa non solo come parente ma anche come figlia. Il giorno dopo viene allestita una ricca cerimonia e la donna viene battezzata, con il re che le fa da padrino. Astolfo, intanto, presa con sé l’ampolla contenente il senno di Orlando, riceve dall’evangelista Giovanni le indicazioni per riuscire ad attraversare senza danni il deserto ed assalire Biserta, capitale del regno di Agramante. Il paladino raggiunge quindi in sella all’ippogrifo l’Etiopia, e fa organizzare l’esercito per muovere guerra contro i pagani. Giunto presso un colle, Astolfo mette i guerrieri più fidati alla sua base e ne raggiunge in volo la cima. Seguendo le indicazioni ricevute in paradiso, invoca l’evangelista Giovanni ed inizia a buttare dalla cima del colle dei sassi che, per miracolo, si trasformano in cavalli durante la caduta. Ogni fante diviene un cavaliere e l’esercito inizia a fare scorrerie per tutta l’Africa. I re messi da Agramante a guardia del suo regno, si muovono contro i cristiani, e mandano una nave in Francia per informare il loro signore degli avvenimenti. In Francia, ricevuto il messaggio dall’Africa, Agramante chiama a consiglio i re ed i principi pagani. Chiede consiglio a re Marsilio su come comportarsi ed il re di Spagna gli suggerisce di mandare in Africa solo poche sue navi, basterà la vista della sua bandiera per mettere in fuga gli oppressori e di non abbandonare quindi l’impresa in Francia. Il re Sobrino invece esorta Agramante a tornare in Africa. Non basta l’assenza di Orlando a fare sperare in una loro vittoria, dal momento che molti di loro sono comunque stati uccisi anche in assenza del paladino, ed ora quella guerra rischia di portarli all’estinzione. Per non perdere l’onore proponga a re Carlo di decidere la sorte di tutta la guerra con il combattimento di soli due cavalieri. Consiglia quindi di mettere il destino di tutti i pagani nelle mani di Ruggiero. Vengono mandati dei messaggeri da re Carlo, che subito accetta il patto sapendo di poter confidare nel valore di Rinaldo. Il paladino è onorato di essere stato scelto per l’impresa. Anche Ruggiero è onorato ma allo stesso tempo si duole profondamente sapendo che lo sfidante è il fratello della sua amata. Bradamante è disperata, capisce che qualunque possa essere l’esito di quel duello, lei non potrà che averne un danno. La maga Melissa ascolta le sue lacrime e le promette di darle tutto il suo aiuto per fare interrompere quel duello. Il giorno fissato per il combattimento entrambi gli eserciti escono dai loro accampamenti e si schierano l’uno di fronte all’altro.

Re Carlo e re Agramante
Vengono eretti due altari e su di essi prima re Carlo e poi Agramante promettono sulle proprie scritture sacre di rispettare il patto: chi perde dovrà pagare un tributo in oro ogni anno al vincitore e non dovrà mai più muovergli guerra. Entrambi i cavalieri giurano quindi di abbandonare la loro schiera e di servire l’esercito avversario, se qualcuno dei loro dovesse intervenire nel combattimento. Inizia quindi il combattimento. Ruggiero, indeciso sul da farsi, è più impegnato a difendersi che ad attaccare.

Ci troviamo ora nel canto XXXIX dove Ruggiero sa che se uccide Rinaldo perderà per sempre la sua amata Bradamante; ha l’animo tormentato e combatte più in difesa che in attacco. L’incontro inizia a sembrare impari ai pagani, anche perché Rinaldo combatte coraggiosamente, e temono il peggio.

Rinaldo contro Ruggiero
Interviene dunque la maga Melissa che assunte le sembianze di Rodomonte, si avvicina ad Agramante e chiede al re rompere il patto e passare quindi all’azione con tutto l’esercito. Agramante, credendo di avere al fianco il feroce guerriero, presa fiducia, si spinge subito in avanti. Entrambi gli eserciti si lanciano subito al combattimento ed i due sfidanti abbandonano il duello, si mettono da parte in attesa di sapere chi abbia violato il patto, e giurano infine di essere nemici di quella fazione. Bradamante e Marfisa non resistono oltre e si lanciano in mezzo ai nemici facendo una strage. L’esercito pagano viene messo subito in fuga. Agramante cerca invano Rodomonte, re Marsilio e re Sobrino, ma il primo non era reale e gli altri due si sono prontamente ritirati nella città di Arles, timorosi per l’imminente castigo divino (Agramante era venuto meno ad un giuramento sul testo sacro). Tornando in Africa da Astolfo, contro il paladino e l’esercito di Etiopia si muove un esercito di africani guidato da re Branzardo, messo da Agramante a guardia del suo regno. Ma tutti i migliori cavalieri erano stati infatti inviati precedentemente in Francia e quindi lo scontro è impari. Re Branzardo, rifiugiatosi nella città di Biserta, capisce di non poter organizzare da solo le difese della città. Allora Astolfo getta in mare dei rami e, grazie ad un altro miracolo, vengono generate delle navi. L’esercito cristiano libera tutti i prigionieri senza alcuna difficoltà e viene poi allestito un sontuoso banchetto. I festeggiamenti vengono interrotti da un gran frastuono. Tutti i paladini si armano, corrono sul posto e vedono che i loro soldati sono stati aggrediti e uccisi da un uomo feroce, completamente nudo ed armato di un semplice bastone. Giunge in quel momento anche Fiordiligi, che subito getta le braccia al collo del suo amato Brandimarte, per ritrovare il quale era giunta fino in Africa. Fiordiligi riconosce il furioso guerriero nudo, è il conte Orlando:

L’esercito di Agramante attacca
ORLANDO RINSAVITO
(XXXIX, 43-61)
Il gentil cavallier, non men giocondo
di veder la diletta e fida moglie
ch’amava più che cosa altra del mondo,
l’abraccia e stringe e dolcemente accoglie:
né per saziare al primo né al secondo
né al terzo bacio era l’accese voglie;
se non ch’alzando gli occhi ebbe veduto
Bardin che con la donna era venuto.
Stese le mani, ed abbracciar lo volle,
e insieme domandar perché venìa;
ma di poterlo far tempo gli tolle
il campo ch’in disordine fuggia
dinanzi a quel baston che ’l nudo folle
menava intorno, e gli facea dar via.
Fiordiligi mirò quel nudo in fronte,
e gridò a Brandimarte: «Eccovi il conte!»
Astolfo tutto a un tempo, ch’era quivi,
che questo Orlando fosse, ebbe palese
per alcun segno che dai vecchi divi
su nel terrestre paradiso intese.
Altrimente restavan tutti privi
di cognizion di quel signor cortese;
che per lungo sprezzarsi, come stolto,
avea di fera, più che d’uomo, il volto.
Astolfo per pietà che gli traffisse
il petto e il cor, si volse lacrimando;
ed a Dudon (che gli era appresso) disse,
ed indi ad Oliviero: «Eccovi Orlando!»
Quei gli occhi alquanto e le palpèbre fisse
tenendo in lui, l’andar raffigurando;
e ’l ritrovarlo in tal calamitade,
gli empì di meraviglie e di pietade.
Piangeano quei signor per la più parte:
sì lor ne dolse, e lor ne ’ncrebbe tanto.
«Tempo è (lor disse Astolfo) trovar arte
di risanarlo, e non di fargli il pianto.»
E saltò a piedi, e così Brandimarte,
Sansonetto, Oliviero e Dudon santo;
e s’aventaro al nipote di Carlo
tutti in un tempo; che volean pigliarlo.
Orlando che si vide fare il cerchio,
menò il baston da disperato e folle;
ed a Dudon che si facea coperchio
al capo de lo scudo ed entrar volle,
fe’ sentir ch’era grave di soperchio:
e se non che Olivier col brando tolle
parte del colpo, avria il bastone ingiusto
rotto lo scudo, l’elmo, il capo e il busto.
Lo scudo roppe solo, e su l’elmetto
tempestò sì, che Dudon cadde in terra.
Menò la spada a un tempo Sansonetto;
e del baston più di duo braccia afferra
con valor tal, che tutto il taglia netto.
Brandimarte ch’addosso se gli serra,
gli cinge i fianchi, quanto può, con ambe
le braccia, e Astolfo il piglia ne le gambe.
Scuotesi Orlando, e lungi dieci passi
da sé l’Inglese fe’ cader riverso:
non fa però che Brandimarte il lassi,
che con più forza l’ha preso a traverso.
Ad Olivier che troppo inanzi fassi,
menò un pugno sì duro e sì perverso,
che lo fe’ cader pallido ed esangue,
e dal naso e dagli occhi uscirgli il sangue.
E se non era l’elmo più che buono,
ch’avea Olivier, l’avria quel pugno ucciso:
cadde però, come se fatto dono
avesse de lo spirto al paradiso.
Dudone e Astolfo che levati sono,
ben che Dudone abbia gonfiato il viso,
e Sansonetto che ’l bel colpo ha fatto,
adosso a Orlando son tutti in un tratto.
Dudon con gran vigor dietro l’abbraccia,
pur tentando col piè farlo cadere:
Astolfo e gli altri gli han prese le braccia,
né lo puon tutti insieme anco tenere.
C’ha visto toro a cui si dia la caccia,
e ch’alle orecchie abbia le zanne fiere,
correr mugliando, e trarre ovunque corre
i cani seco, e non potersi sciorre;
imagini ch’Orlando fosse tale,
che tutti quei guerrier seco traea.
In quel tempo Olivier di terra sale,
là dove steso il gran pugno l’avea;
e visto che così si potea male
far di lui quel ch’Astolfo far volea,
si pensò un modo, ed ad effetto il messe,
di far cader Orlando, e gli successe.
Si fe’ quivi arrecar più d’una fune,
e con nodi correnti adattò presto;
ed alle gambe ed alle braccia alcune
fe’ porre al conte, ed a traverso il resto.
Di quelle i capi poi partì in commune,
e li diede a tenere a quello e a questo.
Per quella via che maniscalco atterra
cavallo o bue, fu tratto Orlando in terra.
Come egli è in terra, gli son tutti adosso,
e gli legan più forte e piedi e mani.
Assai di qua di là s’è Orlando scosso,
ma sono i suoi risforzi tutti vani.
Commanda Astolfo che sia quindi mosso,
che dice voler far che si risani.
Dudon ch’è grande, il leva in su le schene,
e porta al mar sopra l’estreme arene.
Lo fa lavar Astolfo sette volte;
e sette volte sotto acqua l’attuffa;
sì che dal viso e da le membra stolte
leva la brutta rugine e la muffa:
poi con certe erbe, a questo effetto colte,
la bocca chiuder fa, che soffia e buffa;
che non volea ch’avesse altro meato
onde spirar, che per lo naso, il fiato.
Aveasi Astolfo apparecchiato il vaso
in che il senno d’Orlando era rinchiuso;
e quello in modo appropinquogli al naso,
che nel tirar che fece il fiato in suso,
tutto il votò: maraviglioso caso!
che ritornò la mente al primier uso;
e ne’ suoi bei discorsi l’intelletto
rivenne, più che mai lucido e netto.
Come chi da noioso e grave sonno,
ove o vedere abominevol forme
di mostri che non son, né ch’esser ponno,
o gli par cosa far strana ed enorme,
ancor si maraviglia, poi che donno
è fatto de’ suoi sensi, e che non dorme;
così, poi che fu Orlando d’error tratto,
restò maraviglioso e stupefatto.
E Brandimarte, e il fratel d’Aldabella,
e quel che ’l senno in capo gli ridusse,
pur pensando riguarda, e non favella,
come egli quivi e quando si condusse.
Girava gli occhi in questa parte e in quella,
né sapea imaginar dove si fusse.
Si maraviglia che nudo si vede,
e tante funi ha da le spalle al piede.
Poi disse, come già disse Sileno
a quei che lo legar nel cavo speco:
«Solvite me», con viso sì sereno,
con guardo sì men de l’usato bieco,
che fu slegato; e de’ panni ch’avieno
fatti arrecar participaron seco,
consolandolo tutti del dolore,
che lo premea, di quel passato errore.
Poi che fu all’esser primo ritornato
Orlando più che mai saggio e virile,
d’amor si trovò insieme liberato;
sì che colei, che sì bella e gentile
gli parve dianzi, e ch’avea tanto amato,
non stima più se non per cosa vile.
Ogni suo studio, ogni disio rivolse
a racquistar quanto già amor gli tolse.

Orlando legato
Il gentile cavaliere, non meno felice nel vedere la sua cara e fedele moglie, che amava più di qualunque altra cosa al mondo, l’abbraccia, la stringe a sé e la accoglie teneramente: non si lasciava saziare né con il primo, né con il secondo e neanche con il terzo bacio il suo acceso desiderio; se non che, alzando gli occhi, vide Bardino, che era arrivato insieme alla donna. // Stese le mani, e volle abbracciarlo ed allo stesso tempo domandare il perché della sua venuta; ma gli impedì di riuscire nel suo intento l’accampamento che fuggiva in modo disordinato di fronte a que bastone che l’uomo folle e completamente nudo agitava tutt’intorno, e gli faceva lasciare via libera. Fiordiligi guardò in viso quell’uomo nudo, e gridò a Brandimarte: «Ecco a voi il conte Orlando!» // Nello stesso istante anche Astolfo, che si trovava lì, vide chiaramente che si trattava di Orlando grazie ad alcuni segni che dai vecchi Santi aveva appreso quando si trovava lassù in Paradiso. Non fosse stato grazie a loro due, tutti gli altri sarebbero rimasti all’oscuro dell’identità di quel gentile signore; che per il lungo trascurarsi, per la sua follia, aveva il volto più simile a quello di un animale che di un uomo. // Astolfo a causa della commozione che gli trafisse il petto ed anche il cuore, si volse piangendo; e disse a Dudone (che era vicino a lui), ed anche ad Oliviero: «Ecco a voi Orlando!» Quei due, gli occhi e le palpebre tenendo a lungo fisse su di lui, iniziarono a riconoscerlo; ed il ritrovarlo in una tale disgraziata condizione, li riempì di meraviglie a di pietà. // Piangeva la maggior parte di quei signori: tanto a loro faceva provare dolore, tanto si dispiacevano per ciò che vedevano. «E’ il momento (disse loro Astolfo) di trovare il modo per farlo rinsavire, e non di dovergli fare un lamento funebre.» E saltò da cavallo, si mise in piedi, lo stesso fecero Brandimarte, Sansonetto, Oliviero ed il santo Dudone; e si avventarono, si lanciarono sul nipote di Carlo, Orlando, tutti nello stesso istante; con l’intenzione di immobilizzarlo. // Orlando che si vide circondato, agitò il suo bastone da disperato e da pazzo; e a Dudone, che si faceva protezione alla testa con lo scudo e voleva farsi avanti, fece sentire che era anche molto pesante: e non fosse stato grazie ad Oliviero che con la spada tolse parte della potenza al colpo, quel bastone ingiusto avrebbe rotto non solo lo scudo, ma anche l’elmo, la testa ed il busto. // Ruppe solamente lo scudo, e su l’elmo si abbatté con tale forza che Dudone cadde a terra. Sansonetto menò la sua spada nello stesso istante; e colpì il bastone a più di due braccia dall’estremità con una tale forza, da tagliarlo completamente di netto. Brandimarte che gli si gettò addosso, gli strinse i fianchi, tanto forte quanto poté, con entrambe le braccia, mentre Asfolfo gli afferrò le gambe. // Si scosse Orlando, e dieci passi lontano da sé lanciò e fece cadere riverso sulla schiena l’inglese: ciò non fece però lasciare la presa a Brandimarte, che con più forza l’aveva afferrato di traverso. Ad Oliviero che si era fatto troppo avanti, tirò un pugno tanto forte e violento, che lo fece cadere pallido ed esangue, con il sangue che gli usciva dal naso e dagli occhi. // E non fosse stato per l’elmo, più che di buona fattura, che indossa Oliviero, quel pugno l’avrebbe anche ucciso: cadde però come morto, come se avesse fatto dono della sua anima al Paradiso. Dudone ed Astolfo che si sono rialzati, sebbene Dudone abbia il viso tutto gonfio, e Sansonetto che ha inferto il bel colpo di spada, sono improvvisamente ancora tutti addosso ad Orlando. // Dudone lo abbracciò da dietro con grande forza, tentando più volte di fargli lo sgambetto: Astolfo e gli altri gli presero le braccia, ma tutti insieme non riiuscirono a tenerlo fermo. Chi ha visto un toro a cui viene data la caccia, e che sia stato azzannato alle orecchie dai cani, correre muggendo, e portare con sé ovunque correi cani, e non potersi liberare da loro; // immagini ora come Orlando si trovasse in una identica situazione, portandosi dietro attaccati tutti quei guerrieri. In quel momento Oliviero si rialzò da terra, da dove era stato steso da quel gran pugno ricevuto; e visto che in quel modo si poteva soltanto fare male ciò che Astolfo aveva intenzione di fare con lui, pensò ad un modo per agire, e lo mise anche in pratica, di fare cadere Orlando, e riuscì nel suo intento. // Si fece portare sul posto più di una fune, e subito le preparò con nodi scorsoi; ed alcune le fece porre intorno alle gambe ed alle braccia del conte, il resto invece di traverso al suo corpo. Ripartì poi i capi di tutte le funi fra tutti i presenti, ed li diede da tenere a questo ed a quel soldato. Allo stesso modo in cui il maniscalco atterra un cavallo o un bue, Orlando fu fatto cadere, fu messo a terra. // Non appena il conte è a terra, gli saltano tutti addosso, e gli legano più forte sia le mani che i piedi. Orlando si agita molto da una parte e dall’altra, ma i suoi sforzi furono tutti inutili. Astolfo comandò quindi che fosse spostato da lì, perché disse che voleva fare in modo che riavesse il senno. Dudone che era grande e grosso, se lo mise sulla schiena, e lo portò al mare fino all’estremità della spiaggia. // Astolfo lo fece lavare sette volte, e sette volte lo immerse nell’acqua; così che dal viso e dal suo corpo folle venga tolta tutta la sporcizia incrostata: poi con certe erbe, raccolte a questo scopo, gli fece tenere chiusa la bocca, che soffia e sbuffa; non volendo che avesse nessuna altra apertura da cui rilasciare il proprio fiato, se non il naso. // Astolfo si era preparato il vaso nel quale si trovava rinchiuso il senno di Orlando; e glielo avvicinò al naso in modo tale che quando il conte fece per tirare dentro il fiato, lo vuotò completamente: fatto meraviglioso! che la mente di Orlando ritornò alle sue vecchie abitudini; e nei suoi bei discorsi ricomparì l’intelletto, più che mai lucido e chiaro. // Come chi si riprende da un sonno pesante e tormentoso, nel quale o ha visto forme abominevoli di mostri che non esistono, e che non possono neanche esistere, o gli è sembrato di compiere un gesto strano o fuori dall’ordinario, ancora si meraviglia, dopo che è tornato padrone dei suoi sensi e non dorme più; allo stesso modo, Orlando, dopo che fu tolto dalla sua condizione di errore, restò meravigliato e stupefatto. // E Brandimarte, ed Oliviero, fratello di Aldabella, ed Astolfo, colui che nella testa gli aveva fatto tornare la ragione, guarda, ripensando, senza dire nulla, come e quando aveva potuto raggiungere quel posto. Girava gli occhi da questa e da quella parte, e non sapeva neanche immaginare dove si trovava. Si meravigliò di vedersi nudo, e con tante funi addosso, dalle spalle ai piedi. // Poi improvvisamente disse, come aveva già detto Sileno a quelli che lo avevano legato nella caverna: «Slegatemi», con una espressione tanto serena, con uno sguardo ancora meno malvagio di quello che era solito avere, che che ottenne di essere slegato; ed alcuni dei vestiti cha avevano fatto portare li condivisero con lui, dandogli tutti conforto dal dolore che lo opprimeva, causato dallo sbaglio fatto in passato. // Dopo che Orlando fu tornato come era prima, saggio e forte più che mai, si trovò anche liberato dalle catene d’amore; così che lei, Angelica, che tanto bella e gentile gli era sembrata in passato, e che aveva tanto amato, non considera più di quanto consideri una cosa di poco conto. Ogni sua attenzione, ogni suo desiderio rivolse alla volontà di riacquistare quanto aveva perduto a causa dell’amore (onore e gloria).
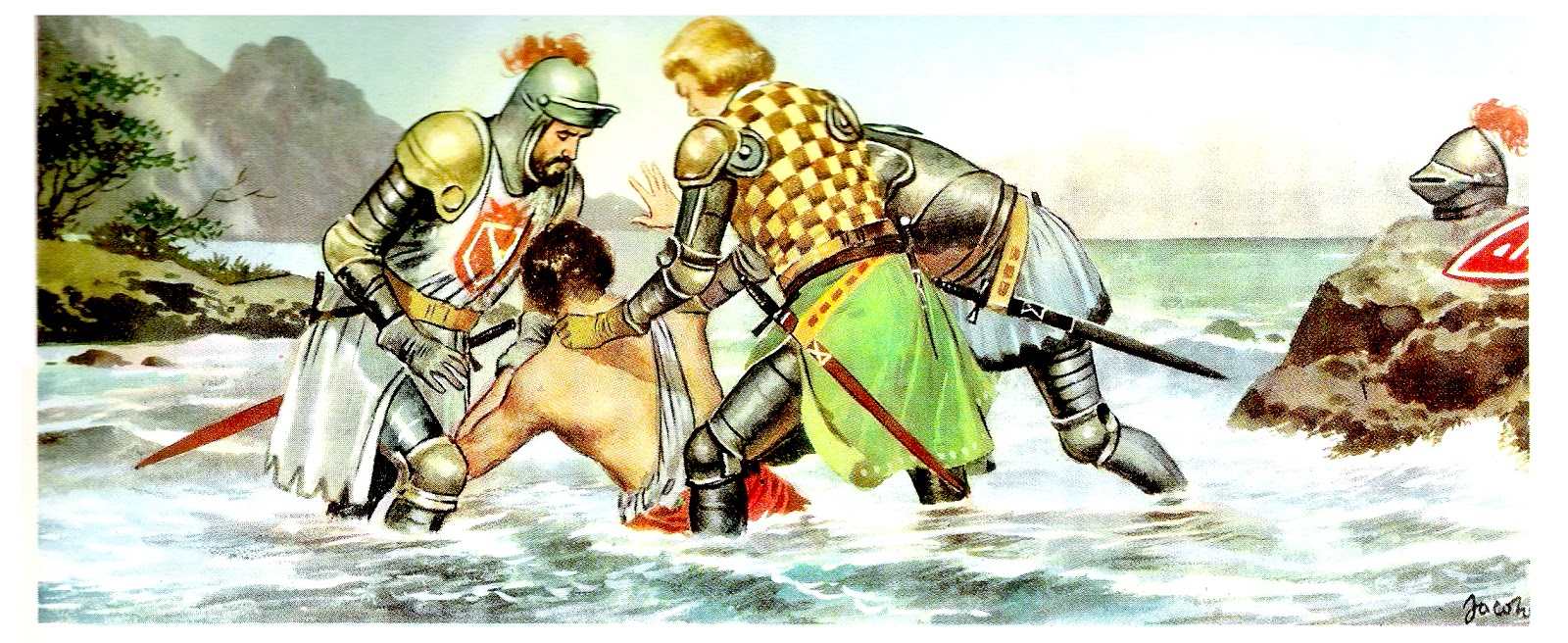
Orlando viene immerso nell’acqua
E’ in questo passo che si può notare il passaggio dalla bestialità d’Orlando alla sua rinascita: tale passaggio avviene attraverso una reminiscenza di tipo teologico, quell’“Ecce homo” che nel poema diventa “Ecco Orlando”, “ecco il conte” pronunciato dai paladini Fiordiligi e Orlando. Ma la rinascita dell’uomo rinascimentale non può che avvenire soltanto grazie all’intelligenza che solo può riportate “onore e gloria”.
Orlando rimane al fianco di Astolfo per dare il suo aiuto nell’assedio di Biserta. La città verrà presa dai cristiani al primo scontro ed i pagani verranno messi in fuga. Tornando in Francia, molti soldati saraceni abbandonano il campo di battaglia e si rifugiano subito sulle navi, tanto temono per la loro vita stando sulla terra ferma. Agramante è abbandonato al pericolo, continua a combattere finché riesce, poi volta le spalle e corre al galoppo verso Arles. Bradamante e Marfisa lo inseguono a tutta velocità ma non riescono a raggiungerlo, il re si rifugia nella città e si imbarca infine con gli altri. Agramante chiude le porte di Arles dietrò di sé e fa tagliare i ponti sul Rodano. Il suo alleato, il re Marsilio si fa condurre in Spagna ed inizia i preparativi per sostenere la successiva guerra che sarà la sua rovina. Agramante fa ritorno in Africa con la sua flotta. Il destino vuole però che la sua flotta incontri quella comandata dal paladino Dudone. Agramante non avrebbe mai creduto di poter essere assalito per mare, non mette pertanto nessuna vedetta a controllare l’orizzonte. L’assalto avviene così di notte ed è una strage di pagani.
Sarà nel canto XL che Agramante fugge portandosi dietro il cavallo Brigliadoro (ricevuto da Ruggiero dopo che Mandricaro era stato ucciso). Tornando a Biserta, l’esercito cristiano è in assetto da guerra ed è pronto a dare inizio alla battaglia. A Sansonetto viene dato il comando di una flotta di navi, a Senapo quello di tenere le mura sotto una pioggia di dardi.

Le mura colpite dalle frecce
Brandimarte conduce la sua parte di esercito sotto le mura. Viene accostata una scala, il paladino sale per primo ed incita gli altri a seguirlo. Non appena raggiunge la passatoia la scala va però in mille pezzi e Brandimarte si trova così solo all’interno delle mura nemiche. Il cavaliere, nonostante le preghiere dei compagni, non torna indietro, si lancia nella città e fa strage di tutti quelli che incontra. Altri paladini si affrettano a porre le scale per entrare oltre le mura ed andare in aiuto del cavaliere. Vengono anche aperte delle brecce utilizzando arieti ed in un solo istante tutto l’esercito cristiano si riversa nella città pagana, che viene così saccheggiata e data in pasto alle fiamme.

La breccia con l’ariete
Il re Agramante, dalla barca con la quale è scampato all’assalto di Dudone, riesce a vedere la città di Biserta avvolta dalle fiamme e vorrebbe uccidersi, ma gli viene consigliato di trovare rifugio in Egitto e lo consola dicendogli infine che non faticherà a trovare nuovi alleati per riconquistare l’Africa. La nave con a bordo il re pagano viene colta da una violenta tempesta mentre si sta dirigendo ad oriente ed è quindi costretta ad approdare su di un’isola posta tra l’Africa e la Sicilia. Trovano sull’isola re Gradasso, che cerca di convincere Agramante a non andare in Egitto, suggerisce quindi un altro piano d’azione: mentre lui sfiderà e sconfiggerà in duello Orlando, le sue genti ed il popolo Etiope di fede non cristiana muoveranno guerra alla parte cristiana dell’Etiopia. Anche gli altri due re scenderanno a “singolar tenzone” con altrettanti paladini. La sede del combattimento sarà l’isola di Lampedusa. Un messaggero viene mandato subito a Biserta per lanciare la sfida al conte Orlando. Il paladino è più che contento di accettare, avendo saputo che re Gradasso è in possesso della sua spada Durindana e che Agramante ha invece il suo cavallo Brigliadoro ed il suo famoso corno. Oliviero e Brandimarte sono i due cavalieri scelti per combattere al suo fianco. Tornando a Parigi, Rinaldo e Ruggiero erano rimasti fuori dal combattimento in attesa di conoscere chi fosse stato per primo a rompere il giuramento ed infine vengono a sapere che è stato re Agramante a muoversi per primo. Nonostante tutte le evidenze, a Ruggiero sembra comunque ingiusto abbandonare il re in quel momento di difficoltà ed è quindi indeciso su cosa fare. Dopo un giorno ed una notte di tormenti, decide infine di seguire in Africa il suo re e torna pertanto ad Arles dove incontra Dudone, i guerrieri etiopi al suo seguito ed i pagani loro prigionieri. Ruggiero non riesce a sopportare la vista dei re pagani in lacrime, si lancia quindi subito contro quelli che li custodiscono. Dudone accorre per sfidare Ruggiero. I due prima si presentano e poi iniziano il duello. Ruggiero viene così a sapere che il suo sfidante, paladino di Francia, è cugino della sua Bradamante e cerca di non ferire l’avversario.

Nel XLI, Dudone è ormai sfinito, riesce a stento a difendersi ma non riceve alcun colpo mortale. Chiede a Ruggiero di fare pace. Quest’ultimo accetta ma a condizione che vengano liberati i re prigionieri e gli sia concesso di raggiungere l’Africa. Dudone non si oppone e lascia fare.

Ruggiero in mare
Ruggiero parte per mare ma, non appena la terra ferma scompare alla vista dei naviganti, ha inizio una terribile tempesta e l’imbarcazione viene battuta da enormi onde. Sembra ormai inevitabile che la nave vada a schiantarsi contro la roccia e Ruggiero si mette a nuotare per raggiungere uno scoglio e salvarsi. La nave nel frattempo, senza nessuno a bordo, cambia improvvisamente rotta ed in tutta tranquillità riprende il proprio viaggio per mare. Alla fine giunge a Biserta, dove viene ritrovata da Orlando. Il conte, Oliviero e Brandimarte salgono sull’imbarcazione e trovano così la spada, il cavallo e l’armatura lasciate da Ruggiero per riuscire a salvarsi a nuoto. I tre cavalieri prendono pertanto le armi di Rinaldo e raggiungono l’isola di Lampedusa, sede stabilita per il duello. Brandimarte, che in precedenza era stato amico di Agramante, cerca di convincere il re pagano ad abbandonare l’impresa, ma Agramante a quella proposta risponde irato dicendo che il suo destino e quello del suo regno è solamente nelle mani di Dio.

Combattimento a Lampedusa
All’alba del giorno dopo sono già tutti pronti per combattere. Tornando ad occuparci di Ruggiero, il cavaliere si affatica a nuoto per cercare di raggiungere lo scoglio e mettersi così in salvo. Il giovane teme di essere vittima della punizione divina per non essersi battezzato quando avrebbe dovuto. Gli ritornano in mente anche tutte le altre promesse mancate, si dice pentito e giura la sua fede cristiana. Promette di non combattere mai più a favore del popolo pagano, di fare gli onori di re Carlo e di sposare infine la sua amata Bradamante. Il cavaliere sente crescere per miracolo le proprie forze, raggiunge a nuoto lo scoglio ed è così l’unico a salvarsi dalle acque. Teme però ora di morire di stenti in quel luogo. Si incammina per esplorare l’isoletta ed incontra così un eremita, che pur avendolo rimproverandolo per aver giurato la propria fedeltà a Dio solo quando si era sentito vittima della sua punizione, lo conforta dicendogli che comunque a nessuno viene mai negato il cielo quando lo chiede. L’eremita conduce Ruggiero alla sua cella, gli insegna quindi le basi della religione cristiana ed il giorno dopo lo battezza. Dio aveva mostrato al religioso ogni aspetto della vita futura di Ruggiero e della sua nobile discendenza. Sull’isola di Lampedusa intanto è iniziato il duello tra i tre pagani ed i tre cristiani. Lo scontro è durissimo: i paladini e i saraceni spesso cambiano di volta in volta gli avversari, le armature, pur incantate, non riescono a difendere totalmente chi le possiede; proprio mentre Brandimarte è chino per inferire su Agramante, Gradasso l’uccide alle spalle.

Il duello prosegue nel XLII canto: Orlando arde d’ira nel vedere che il caro amico Brandimarte giace a terra ucciso da re Gradasso, e si lancia quindi subito contro gli avversari. Il conte taglia di netto la testa ad Agramante. Re Gradasso assiste alla scena e per la prima volta in vita sua trema di paura. Il pagano è ormai rassegnato a morire e non cerca neanche di difendersi dal colpo mortale che gli viene sferrato dal conte cristiano. Orlando non gioisce per la vittoria ottenuta, scende subito da cavallo e corre dall’amico Brandimarte. Il cavaliere muore subito dopo, chiede perdono a Dio per i propri peccati e raccomanda al conte la sua Fiordiligi.

Orlando piange Brandimarte
Il saraceno re Sobrino è disteso al suolo senza forze ed ormai quasi dissanguato. Il conte aiuta Oliviero a liberarsi dal peso del cavallo ed a rialzarsi, poi preleva anche Sobrino e lo fa curare. Orlando vede infine arrivare dal mare un’imbarcazione leggera. Tornando in Francia, Bradamante vede il suo Ruggiero allontanarsi da lei ancora una volta e riprende così a disperarsi e a maledirlo. La donna si sfoga con Marfisa, sorella del cavaliere, che la consola dicendogli che non crede che Ruggiero possa commettere un simile errore, e se anche lo dovesse fare, ci penserà lei a vendicarla. Tutti i paladini si godono la meritata pace, ora che i saraceni sono stati fatti scappare, tranne Rinaldo, che è ancora tormentato dall’amore per la bella Angelica. Il cavaliere la cerca ovunque ed infine decide di affidarsi ai poteri magici di Malagigi per sapere dove essa si trovi. Malagigi informa Rinaldo dei fatti e cerca di convincerlo a non amare più la donna, ormai quasi di sicuro giunta in patria insieme al suo Medoro. Il paladino soffre e si tormenta al pensiero che un altro uomo abbia colto la verginità della sua amata. Spinto dal furore della gelosia, lascia la Francia senza nessuno al seguito. Rinaldo si tormenta perché la donna non gli abbia offerto la verginità. Mentre procede all’interno della Selva Nera, il cielo diviene improvvisamente nuvoloso e da una caverna esce un mostro dalle sembianze femminili (la Gelosia), Il cavaliere ha paura, ma cerca comunque di simulare il solito coraggio, stringe la spada e cerca di difendersi dai colpi del mostro, senza però riuscirci. Il paladino cristiano si mette infine in fuga ma il mostro è veloce a muoversi e sale anch’egli in groppa al suo cavallo. Giunge in suo aiuto un cavaliere (lo Sdegno), che colpisce di lato il mostro, lo fa cadere a terra e lo ricaccia infine nella sua caverna. Rinaldo ringrazia il suo salvatore, ne chiede il nome ma il cavaliere rimanda la risposta. I due giungono presso una gelida fonte, quella che spegne la passione amorosa ed il cavaliere misterioso propone a Rinaldo di rimanere lì a riposare. Il paladino accetta, subito si disseta bevendo alla fonte ed in uno stesso momento si libera della sete e del folle amore per Angelica. Il cavaliere confessa ora al paladino di essere lo Sdegno e subito scompare. Rinaldo prosegue comunque il suo viaggio verso l’India, questa volta veramente con l’intenzione di recuperare Baiardo. Giunto a Basilea viene a sapere che Orlando si sta preparando per sfidare a duello Gradasso e Agramante. Rinaldo vuole combattere al fianco del cugino, cambia meta e si dirige verso l’Italia. Nel cammino incontra un cavaliere che gli chiede se è sposato e, ricevuta una risposta positiva, lo invita quindi nel suo palazzo. Qui vede un’immensa fontana protetta da una volta sostenuta da otto statue di donna, tutte ugualmente belle. Fra di esse una raffigura sicuramente Alessandra Benucci, e chi la sostiene, è certamente Ariosto. Rinaldo ed il cavaliere banchettano in cortile. Terminata la cena, il padrone invita il paladino a bere per vedere se la sua donna gli è fedele o meno: Rinaldo è sul punto di tentare la prova, ma poi riflette su quanto sia pericolosa la verità.

Rinaldo e l’oste
Nel canto XLIII Rinaldo decide di non bere e vede il padrone del castello piangere ed inizia a raccontare la sua storia. Se la fortuna non l’aveva fatto nascere ricco, la natura l’aveva reso bello. Nella sua stessa città aveva vissuto un uomo molto saggio che durante gli ultimi anni, convinse con del denaro una donna a concedersi a lui, rinunciando alla propria verginità. Da lei ebbe quindi una figlia. Non volendo che la figlia fosse simile alla madre, fece costruire quel ricco palazzo in un luogo solitario e lì si trasferì con la bambina. Fece quindi anche ritrarre in tutto il palazzo donne, che fossero da esempio alla ragazza per essersi opposte ad un amore peccaminoso. Quando la figlia raggiunse l’età per sposarsi, il signore del castello, allora ragazzo, venne ritenuto essere l’unico degno di diventarne lo sposo. Erano al quinto anno di matrimonio quando una nobile donna della vicina città, che conosceva la magia, s’innamorò del cavaliere. Il signore amava però a tal punto la sua donna, tanto si fidava della sua fedeltà, che non cedette mai alle richieste della maga, di nome Melissa. La maga tuttavia gli disse che la sua fedeltà era determinata dal non poter incontrare nessun altro uomo. Gli propose quindi di lasciarla sola nel castello, così da poter conoscere la sua vera natura. Melissa consegnò quindi al cavaliere quella brocca, dicendogli che sarebbe servita a mostrargli l’esito della prova. L’uomo assunse le sembianze di un bel cavaliere, governante di Ferrara, che, innamorato di sua moglie, più volte si era fatto avanti con proposte amorose ed altrettante volte era stato cacciato indietro. Il cavaliere, in quelle forme, poté vedere la moglie cedere alle lusinghe di un altro uomo. Riprese le sembianze originali, accusò la donna di essere disposta a tradirlo. Lei si arrabbiò per il gesto del marito ed infine si accese di odio per lui, raggiungendo il cavaliere di Ferrara e vivendo con lui. L’uomo soffre per il suo gesto e trova come unica consolazione il fatto che tutti i cavalieri ai quali aveva offerto la brocca non erano riusciti a bere una sola goccia di quel vino. Dopo aver dormito presso una barca, il mattino dopo il paladino passa presso la città di Ferrara, ripensa alle vicende del signore del palazzo in cui era stato ospite la sera prima. Uno degli uomini dell’imbarcazione dice che quel signore avrebbe dovuto fare tesoro di quanto era già accaduto in precedenza nella vicina Mantova. Viene infatti raccontata la storia di Anselmo e Adonio. Erano ambedue innamorati di una stessa donna, ma lei era moglie del primo, mentre il secondo per lei si era ridotto in miseria. Il povero Adonio, un giorno, vede un contadino cacciare una serpe, la salva e si scopre che essa nasconde la maga Manto. Ricostruito il suo patrimonio ed ottenuto un cane dai poteri magici, in cambio di quest’ultimo l’uomo riesce a vincere la resistenza della donna. Anselmo, deciso ad ucciderla, la cerca in tutta la Lombardia fino a giungere in uno straordinario palazzo il cui padrone è un orrendo etiope. Quest’ultimo chiede ad Anselmo di passare una notte con lui in cambio del palazzo e all’accettazione dell’uomo cade la magia di cui il palazzo faceva parte e appare la moglie che rinfaccia all’uomo che il peccato a lui proposto era molto più grave del suo. Infine decisero di considerare pari le loro colpe e tornarono entrambi a vivere d’amore e d’accordo.

Anselmo, la moglie e l’etiope
Così finisce la storia del marinaio. Rinaldo nel frattempo giunge a Roma e poi a Lampedusa, ma vi giunge quando Orlando ha già ucciso Gradasso ed Agramante. Fiordiligi, intanto, viene a sapere la notizia della morte di Brandimarte e si unisce a Orlando che nel frattempo raggiunge la Sicilia, insieme ad Oliviero, per dare degna sepoltura al cavaliere. Il pomposo funerale si svolge la sera dopo. Fiordiligi deciderà di fare costruire un cella nella tomba dell’amato, e morirà non molto tempo dopo. Orlando, Oliviero, peggiorato in salute, e Rinaldo lasciano la Sicilia e, prima di tornare in Francia, su consiglio del comandante della nave, si fermano presso uno scoglio abitato da un eremita capace di compiere azioni miracolose. Il religioso dà la sua benedizione ad Oliviero e lo fa così guarire all’istante. Re Sobrino, visto il miracolo, subito si dichiara pronto a convertirsi al cristianesimo. Durante il sontuoso banchetto allestito per festeggiare le due guarigioni e la conversione di Sobrino, Ruggiero viene riconosciuto da tutti i cavalieri presenti e quindi festeggiato per la sua fresca conversione religiosa. Tra tutti, è Rinaldo il cavaliere che lo festeggia ed onora con maggiore affetto.
Ci troviamo nel XLIV canto, dove Astolfo, in Africa, sapute le vicende di Lampedusa e vedendo che ormai l’Africa non può più nuocere alla Francia, fa ritornare il popolo etiope alla sua terra di origine. Quindi parte per la Provenza e, su richiesta dell’evangelista Giovanni, lascia libero l’ippogrifo. Anche il suo corno magico non ha ormai più alcun potere, essendo rimasto il suo terribile suono sulla luna tra le cose perse. Astolfo giunge infine a Marsiglia il giorno stesso in cui ci giungono via mare anche gli altri. Tutti i cavalieri proseguono insieme il viaggio verso Parigi e vengono quindi accolti festosamente da Carlo Magno e da tutta la sua corte. Parigi è in festa ed i paladini vengono salutati come liberatori dell’impero. Rinaldo informa il padre Amonio di aver promesso Bradamante in sposa a Ruggiero. Il padre e la madre del cavaliere lo rimproverano però d’aver agito in autonomia e si oppongono alla sua volontà, avendo ormai deciso che la donna diverrà sposa di Leone, sicuramente più ricco e potente di Ruggiero. Viene chiesto a Bradamante di esporre la sua volontà, lei non osa però proferire parola e rimane in silenzio.

Bradamante sola e disperata
Quando si trova finalmente da sola, la donna si dispera, non sapendo come comportarsi: ma, alla fine, si convince ad opporsi alla volontà dei genitori. Anche Ruggiero è tormentato dai suoi pensieri, avendo saputo che Amone e la moglie, Beatrice, volevano fare sposare la sua amata con il figlio dell’imperatore Costantino. Bradamante viene a sapere delle preoccupazioni che affliggono il cavaliere e manda una sua fedele cameriera a dirgli che il suo amore per lui è e rimarrà per sempre forte. Gli dice quindi che nessuna corona né ricchezza potrà mai modellare il suo cuore sull’immagine di un altro uomo. Ripreso il proprio originale coraggio, Bradamante si presenta da re Carlo e gli chiede, come riconoscimento per i servizi svolti, che le prometta di non lasciarla sposare a nessun uomo che non mostri di esserle superiore in armi. Il patto non viene fatto in segreto e la notizia non tarda a giungere alle orecchie dei genitori di Bradamante. Avendo capito che la figlia punta a sposare Ruggiero, Amone e Beatrice allontanano la donna da Parigi e la portano quindi nella loro fortezza di Roccaforte, con l’intenzione di mandarla poi in Oriente. Ruggiero, vedendo che la sua amata gli è stata sottratta e temendo che possa infine andare in sposa a Leone, indossa le armi per muovere guerra all’imperatore Costantino, ucciderlo ed impossessarsi del suo regno. Si mette in viaggio e giunge infine in Bulgaria. Vicino a Belgrado trova l’esercito dell’imperatore intento a combattere contro quello bulgaro, con l’obiettivo di riconquistare la capitale. L’esercito imperiale è nettamente superiore a quello avversario per numero e mezzi, ed in poco tempo i soldati bulgari vengono messi in fuga. Ruggiero interviene allora in difesa degli sconfitti, ferma la loro fuga e si lancia subito all’attacco. Il cavaliere fa una strage e l’esito della battaglia viene totalmente capovolto, sono ora i bulgari ad inseguire gli avversari in fuga. Leone vede gli avvenimenti da un colle e non può fare a meno di apprezzare il valore di quel cavaliere misterioso. Non si cura dei suoi che vengono uccisi ed anzi si preoccupa che l’uomo possa essere ferito. Il figlio dell’imperatore chiama infine la ritirata.
Nel XLV vediamo che un cavaliere rumeno riconosce nelle insegne di Ruggiero quelle del cavaliere misterioso che aveva messo in fuga l’esercito imperiale il giorno prima, ed avvisa quindi subito della sua presenza Costantino. Il cavaliere viene così fatto prigioniero durante la notte. L’imperatore già assapora la vittoria contro i bulgari, sapendo che senza l’aiuto del cavaliere nulla potranno ora contro il suo esercito. Anche il figlio Leone si rallegra per l’avvenimento, non tanto perché Belgrado può ora essere riconquistata, quanto perché spera di farsi amico il valoroso guerriero. La crudele Teodora invece, sorella dell’imperatore, esulta per l’avvenimento in quanto vede la possibilità di vendicare la morte del figlio, ucciso dal guerriero il giorno prima. Ruggiero viene così incantenato in una torre in attesa che Teodora, a cui è stato affidato, decida come farlo morire. Nel frattempo in Francia re Carlo annuncia a tutti la decisione, come richiesto da Bradamante, di non lasciare maritare la donna a nessun cavaliere che non sia in grado di mostrarsi superiore a lei in duello. Amone e Beatrice, per rispettare la volontà del loro re e fanno così nuovamente ritorno a Parigi. Bradamante scopre che il suo amato ha abbandonato la corte di Carlo e teme che voglia dimenticarla. Il più delle volte la donna però si rimprovera per non aver avuto fiducia in Ruggiero e si pente di essere stata gelosa, ed anche di aver sospettato di lui. Bradamante invoca il ritorno dell’amato cavaliere, sapendo che basterà la sua solo vista per spegnere in lei ogni timore e dare nuova forza alla sua speranza. Intanto Leone viene a sapere che il cavaliere misterioso è tenuto prigioniero dalla crudele zia Teodora e, mosso dal profondo amore che nutre per il suo sovraumano valore, decide di salvargli la vita. Quindi con un inganno si fa aprire la cella in cui è tenuto il prigioniero e lo libera. Ruggiero da parte sua ringrazia Leone e si dice disposto a restituirgli il favore in qualunque condizione. Giunge intanto anche in Bulgaria la notizia del bando emesso da re Carlo. Leone, conoscendo i propri limiti, decide così di chiedere al cavaliere misterioso di partecipare al torneo al suo posto, sotto mentite spoglie. Il cavaliere non può che accettare l’incarico, tanto si sente in debito con il giovane. Ruggiero è disperato, sa che andrà incontro alla sua morte: per l’angoscia di vedere la sua amata tra le braccia di un altro uomo o altrimenti per propria mano, ma non può però rifiutare l’incarico e nemmeno pensare di non vincerlo. Il duello viene fissato per il giorno seguente. Ruggiero, per non essere riconosciuto, si presenta al combattimento completamente nascosto dall’armatura, senza il proprio cavallo e con una spada al fianco che non è la sua. Il cavaliere toglie perfino tutto il filo alla spada così da renderla completamente inoffensiva. Dall’altro lato Bradamante si presente con tutt’altri intenti, affila la propria spada e vuole solo poterla affondare nella carne del suo avversario. Si dà il via al combattimento e Bradamante subito assale l’avversario, ma pur colpendolo con tutta la forza non può nulla contro la sua armatura invulnerabile. Ruggiero pensa invece solo a difendersi, cercando di ferirla il meno possibile. Giunge infine la sera ed il combattimento viene interrotto. Leone ha ottenuto Bradamante in sposa. Ruggiero non si toglie l’elmo e torna subito all’accampamento del figlio di Costantino. Leone gli promette eterna riconoscenza. Il cavaliere soffre però d’amore e non riesce a trattenersi troppo; sale in sella al suo Frontino e si lascia da lui condurre ovunque voglia. Ruggiero passa tutta la notte piangendo e sa che per vendicarsi deve prendersela solo contro sé stesso. Ma soprattutto non vuole lasciare senza vendetta la amata Bradamante, alla quale ha arrecato un eguale danno. La mattina seguente Ruggiero giunge in un luogo selvaggio ed isolato, e lo reputa adatto come luogo per la sua morte segreta. Il cavaliere ringrazia Frontino, lo lascia libero e si inoltra poi a piedi nel fitto bosco con l’intenzione di lasciarsi morire. Tornando a Parigi, Bradamante sa di non potersi opporre al matrimonio con Leone, si dispera ed è decisa anche lei a togliersi la vita.

Giosetta Fioroni: Marfisa
Il mattino dopo Marfisa si presenta di fronte a Carlo dicendo di non poter tollerare che a suo fratello Ruggiero venga tolta la sposa, e dichiara quindi di essere pronta a sostenere con la spada la sua causa. La donna dice anche che Bradamante si era già promessa al cavaliere. Il re fa subito chiamare Bradamante e lei, col suo silenzio, fa capire che la promessa è vera. Marfisa propone infine di lasciare che la questione venga decisa dal duello tra Leone e Ruggiero. Il figlio dell’imperatore accetta subito la proposta, credendo che il suo valoroso cavaliere non avrebbe avuto alcuna difficoltà a sconfiggere anche quel Ruggiero. Ma il giovane è ed infine parte Leone stesso con l’intenzione di ritrovarlo.

Melissa e Leone
Nell’ultimo canto, il XLVI, incontriamo la maga Melissa, che vede il cavaliere all’interno di un fitto bosco, deciso a morire di fame. Quindi interviene in suo aiuto. La donna va incontro a Leone, e lo porta da Ruggiero che, stremato dal digiuno, continua a piangere e a dolersi per la sua sorte. Leone convince il cavaliere a esporgli la ragione del suo dolore, e così il cavaliere gli rivela di essere Ruggiero, gli racconta quindi la sua storia. Ascoltata la confessione dell’amico, Leone rimane come impietrito, ma non vuole essere da meno di Ruggiero per cortesia, e gli comunica la propria intenzione a rinunciare a Bradamante in suo favore. Si mettono infine tutti insieme in viaggio per tornare a Parigi. A Parigi Ruggiero troverà ad aspettarlo una ambasciata bulgara, giunta in Francia per incoronarlo re e consegnargli il dominio dei loro territori. Ruggiero, nascondendo la propria identità, si presenta al cospetto di Carlo Magno con le stesse insegne e la stessa sopraveste che aveva tenuto durante il combattimento contro Bradamante. Leone lo presenta quindi al re come colui che ha pieno diritto, stando a quanto dichiarava il bando, di ricevere per moglie la donna. Il giovane dichiara infine che quel cavaliere misterioso è disposto a sostenere con la spada ogni suo diritto acquisito. Marfisa, in assenza del fratello, si prende carico dell’impresa e, mossa dall’ira, è anche pronta a passare subito dalle parole ai fatti. Leone non esita però oltre e toglie l’elmo al cavaliere misterioso, rivelandone così l’identità. Riconosciuto Ruggiero, tutti corrono subito ad abbracciarlo. Leone racconta le vicende del cavaliere, infine si rivolge ad Amone e non solo riesce a fargli cambiare opinione, ma anche a fargli chiedere perdono a Ruggiero, pregandolo di accettarlo come padre e suocero. Saputa la notizia, Bradamante rishia quasi di morire per l’improvvisa gioia. Gli ambasciatori bulgari ricevono da Leone, l’assicurazione che nessuna guerra verrà più mossa contro loro dal suo esercito. Le nozze vengono organizzate dallo stesso re Carlo e sono maestose.

Giungono signori ed ambasciate da ogni parte del mondo per festeggiare gli sposi. L’ultimo giorno dei festeggiamenti, nel momento del banchetto, dalla campagna si vede arrivare a cavallo un cavaliere vestito completamente di nero. Si tratta di Rodomonte. Il feroce guerriero, dopo che Bradamante gli aveva tolto le armi, aveva vissuto come un eremita per un anno, un mese ed un giorno, e terminata la sua punizione, subito si era poi riarmato ed avviato verso Parigi.
IL DUELLO TRA RUGGIERO E RODOMONTE
(XLVI, 105-115; 122-140)
Poi che fu a Carlo et a Ruggiero a fronte,
con alta voce et orgoglioso grido:
«Son» disse «il re di Sarza, Rodomonte,
che te, Ruggiero, alla battaglia sfido;
e qui ti vo’, prima che ’l sol tramonte,
provar ch’al tuo signor sei stato infido;
e che non merti, che sei traditore,
fra questi cavallieri alcun onore.
Ben che tua fellonia si vegga aperta,
perché essendo cristian non pòi negarla;
pur per farla apparere anco più certa,
in questo campo vengoti a provarla:
e se persona hai qui che faccia offerta
di combatter per te, voglio accettarla.
Se non basta una, e quattro e sei n’accetto;
e a tutte manterrò quel ch’io t’ho detto.»
Ruggiero a quel parlar ritto levosse,
e con licenza rispose di Carlo,
che mentiva egli, e qualunqu’altro fosse,
che traditor volesse nominarlo;
che sempre col suo re così portosse,
che giustamente alcun non può biasmarlo;
e ch’era apparecchiato sostenere
che verso lui fe’ sempre il suo dovere:
e ch’a difender la sua causa era atto,
senza tòrre in aiuto suo veruno;
e che sperava di mostrargli in fatto,
ch’assai n’avrebbe e forse troppo d’uno.
Quivi Rinaldo, quivi Orlando tratto,
quivi il marchese, e ’l figlio bianco e ’l bruno,
Dudon, Marfisa, contra il pagan fiero
s’eran per la difesa di Ruggiero;
mostrando ch’essendo egli nuovo sposo,
non dovea conturbar le proprie nozze.
Ruggier rispose lor: «State in riposo;
che per me fôran queste scuse sozze.»
L’arme che tolse al Tartaro famoso,
vennero, e fur tutte le lunghe mozze.
Gli sproni il conte Orlando a Ruggier strinse,
e Carlo al fianco la spada gli cinse.
Bradamante e Marfisa la corazza
posta gli aveano, e tutto l’altro arnese.
Tenne Astolfo il destrier di buona razza,
tenne la staffa il figlio del Danese.
Feron d’intorno far subito piazza
Rinaldo, Namo et Olivier marchese:
cacciaro in fretta ognun de lo steccato
a tal bisogni sempre apparecchiato.
Donne e donzelle con pallida faccia
timide a guisa di columbe stanno,
che da’ granosi paschi ai nidi caccia
rabbia de’ venti che fremendo vanno
con tuoni e lampi, e’l nero aer minaccia
grandine e pioggia, e a’ campi strage e danno:
timide stanno per Ruggier; che male
a quel fiero pagan lor parea uguale.
Così a tutta la plebe e alla più parte
dei cavallieri e dei baron parea;
che di memoria ancor lor non si parte
quel ch’in Parigi il pagan fatto avea;
che, solo, a ferro e a fuoco una gran parte
n’avea distrutta, e ancor vi rimanea,
e rimarrà per molti giorni il segno:
né maggior danno altronde ebbe quel regno.
Tremava, più ch’a tutti gli altri, il core
a Bradamante; non ch’ella credesse
che ’l Saracin di forza, e del valore
che vien dal cor, più di Ruggier potesse;
né che ragion, che spesso dà l’onore
a chi l’ha seco, Rodomonte avesse:
pur stare ella non può senza sospetto;
che di temere, amando, ha degno effetto.
Oh quanto volentier sopra sé tolta
l’impresa avria di quella pugna incerta,
ancor che rimaner di vita sciolta
per quella fosse stata più che certa!
Avria eletto a morir più d’una volta,
se può più d’una morte esser sofferta,
più tosto che patir che ’l suo consorte
si ponesse a pericol de la morte.
Ma non sa ritrovar priego che vaglia,
perché Ruggiero a lei l’impresa lassi.
A riguardare adunque la battaglia
con mesto viso e cor trepido stassi.
Quinci Ruggier, quindi il pagan si scaglia,
e vengonsi a trovar coi ferri bassi.
Le lance all’incontrar parver di gielo;
i tronchi, augelli a salir verso il cielo.
Ha inizio il crudele duello, dapprima con le lance, quindi, spezzate quelle, con le spade. L’armatura del saraceno, al contrario di Ruggiero, non è così impenetrabile, tanto che in più punti essa si è rotta e mostra la carne ferita di Sacripante. Allora quest’ultimo:

Con quella estrema forza che percuote
la machina ch’in Po sta su due navi,
e levata con uomini e con ruote
cader si lascia su le aguzze travi;
fere il pagan Ruggier, quanto più puote,
con ambe man sopra ogni peso gravi:
giova l’elmo incantato; che senza esso,
lui col cavallo avria in un colpo fesso.
Ruggiero andò due volte a capo chino,
e per cadere e braccia e gambe aperse.
Raddoppia il fiero colpo il Saracino,
che quel non abbia tempo a riaverse:
poi vien col terzo ancor; ma il brando fino
sì lungo martellar più non sofferse;
che volò in pezzi, et al crudel pagano
disarmata lasciò di sé la mano.
Rodomonte per questo non s’arresta,
ma s’aventa a Ruggier che nulla sente;
in tal modo intronata avea la testa,
in tal modo offuscata avea la mente.
Ma ben dal sonno il Saracin lo desta:
gli cinge il collo col braccio possente;
e con tal nodo e tanta forza afferra,
che de l’arcion lo svelle, e caccia in terra.
Non fu in terra sì tosto, che risorse,
via più che d’ira, di vergogna pieno;
però che a Bradamante gli occhi torse,
e turbar vide il bel viso sereno.
Ella al cader di lui rimase in forse,
e fu la vita sua per venir meno.
Ruggiero ad emendar presto quell’onta,
stringe la spada, e col pagan s’affronta.
Quel gli urta il destrier contra, ma Ruggiero
lo cansa accortamente, e si ritira,
e nel passare, al fren piglia il destriero
con la man manca, e intorno lo raggira;
e con la destra intanto al cavalliero
ferire il fianco o il ventre o il petto mira;
e di due punte fe’ sentirgli angoscia,
l’una nel fianco, e l’altra ne la coscia.
Rodomonte, ch’in mano ancor tenea
il pome e l’elsa de la spada rotta,
Ruggier su l’elmo in guisa percotea,
che lo potea stordire all’altra botta.
Ma Ruggier ch’a ragion vincer dovea,
gli prese il braccio, e tirò tanto allotta,
aggiungendo alla destra l’altra mano,
che fuor di sella al fin trasse il pagano.
Sua forza o sua destrezza vuol che cada
il pagan sì, ch’a Ruggier resti al paro:
vo’ dir che cadde in piè; che per la spada
Ruggiero averne il meglio giudicaro.
Ruggier cerca il pagan tenere a bada
lungi da sé, né di accostarsi ha caro:
per lui non fa lasciar venirsi adosso
un corpo così grande e così grosso.
E insanguinargli pur tuttavia il fianco
vede e la coscia e l’altre sue ferite.
Spera che venga a poco a poco manco,
sì che al fin gli abbia a dar vinta la lite.
L’elsa e ’l pome avea in mano il pagan anco,
e con tutte le forze insieme unite
da sé scagliolli, e sì Ruggier percosse,
che stordito ne fu più che mai fosse.
Ne la guancia de l’elmo, e ne la spalla
fu Ruggier colto, e sì quel colpo sente,
che tutto ne vacilla e ne traballa,
e ritto se sostien difficilmente.
Il pagan vuole entrar, ma il piè gli falla,
che per la coscia offesa era impotente:
e ’l volersi affrettar più del potere,
con un ginocchio in terra il fa cadere.
Ruggier non perde il tempo, e di grande urto
lo percuote nel petto e ne la faccia;
e sopra gli martella, e tien sì curto,
che con la mano in terra anco lo caccia.
Ma tanto fa il pagan che gli è risurto;
si stringe con Ruggier sì, che l’abbraccia:
l’uno e l’altro s’aggira, e scuote e preme,
arte aggiungendo alle sue forze estreme.
Di forza a Rodomonte una gran parte
la coscia e ’l fianco aperto aveano tolto.
Ruggiero avea destrezza, avea grande arte,
era alla lotta esercitato molto:
sente il vantaggio suo, né se ne parte;
e donde il sangue uscir vede più sciolto,
e dove più ferito il pagan vede,
puon braccia e petto, e l’uno e l’altro piede.
Rodomonte pien d’ira e di dispetto
Ruggier nel collo e ne le spalle prende:
or lo tira, or lo spinge, or sopra il petto
sollevato da terra lo sospende,
quinci e quindi lo ruota, e lo tien stretto,
e per farlo cader molto contende.
Ruggier sta in sé raccolto, e mette in opra
senno e valor, per rimaner di sopra.
Tanto le prese andò mutando il franco
e buon Ruggier, che Rodomonte cinse:
calcògli il petto sul sinistro fianco,
e con tutta sua forza ivi lo strinse.
La gamba destra a un tempo inanzi al manco
ginocchio e all’altro attraversogli e spinse;
e da la terra in alto sollevollo,
e con la testa in giù steso tornollo.
Del capo e de le schene Rodomonte
la terra impresse; e tal fu la percossa,
che da le piaghe sue, come da fonte,
lungi andò il sangue a far la terra rossa.
Ruggier, c’ha la Fortuna per la fronte,
perché levarsi il Saracin non possa,
l’una man col pugnal gli ha sopra gli occhi,
l’altra alla gola, al ventre gli ha i ginocchi.
Come talvolta, ove si cava l’oro
là tra’ Pannoni o ne le mine ibere,
se improvisa ruina su coloro
che vi condusse empia avarizia, fere,
ne restano sì oppressi, che può il loro
spirto a pena, onde uscire, adito avere:
così fu il Saracin non meno oppresso
dal vincitor, tosto ch’in terra messo.
Alla vista de l’elmo gli rappresenta
la punta del pugnal ch’avea già tratto;
e che si renda, minacciando, tenta,
e di lasciarlo vivo gli fa patto.
Ma quel, che di morir manco paventa,
che di mostrar viltade a un minimo atto,
si torce e scuote, e per por lui di sotto
mette ogni suo vigor, né gli fa motto.
Come mastin sotto il feroce alano
che fissi i denti ne la gola gli abbia,
molto s’affanna e si dibatte invano
con occhi ardenti e con spumose labbia,
e non può uscire al pretator di mano,
che vince di vigor, non già di rabbia:
così falla al pagano ogni pensiero
d’uscir di sotto al vincitor Ruggiero.
Pur si torce e dibatte sì, che viene
ad espetirsi col braccio migliore;
e con la destra man che ’l pugnal tiene,
che trasse anch’egli in quel contrasto fuore,
tenta ferir Ruggier sotto le rene:
ma il giovene s’accorse de l’errore
in che potea cader, per differire
di far quel empio Saracin morire.
E due e tre volte ne l’orribil fronte,
alzando, più ch’alzar si possa, il braccio,
il ferro del pugnale a Rodomonte
tutto nascose, e si levò d’impaccio.
Alle squalide ripe d’Acheronte,
sciolta dal corpo più freddo che giaccio,
bestemmiando fuggì l’alma sdegnosa,
che fu sì altiera al mondo e sì orgogliosa.
Dopo che fu di fronte a Carlo e a Ruggiero, con voce alta e pieno di superbia disse: «Sono Rodomonte, re di Sargel (città d’Algeria), che sfido te Ruggiero a duello, e prima che il sole tramonti ti voglio qui dimostrare che sei stato infedele al tuo signore e che, poiché sei un traditore, non meriti alcun onore tra questi cavalieri. // Sebbene la tua viltà si manifesti apertamente, perché essendo diventato cristiano non puoi negarla, tuttavia vengo in questo campo a dimostrarla, per farla apparire ancora più certa: e se hai qualcuno che si offre di combattere al tuo posto, voglio accettarlo. Se non ne basta uno ne accetto anche quattro e sei, e con tutti manterrò fede a quanto detto». // A quelle parole Ruggiero si alzò in piedi e, con il permesso di Carlo, rispose che lui mentiva e chiunque lo avesse chiamato traditore, perché con il suo re si era sempre comportato in modo che nessuno avrebbe potuto a ragione biasimarlo, e che era pronto a sostenere di aver compiuto sempre il proprio dovere verso di lui; // che era capace di difendere la sua causa, senza chiamare nessuno in suo aiuto, e che sperava di dimostrargli nei fatti che ne avrebbe avuto abbastanza e forse troppo di uno solo. In quel momento si erano alzati in difesa di Ruggiero Rinaldo, Orlando, i marchese Oliviero e i suoi figli, uno biondo e uno moro, Dudone, Marfisa; // affermando che, essendo egli appena sposato, non doveva mettere in pericolo le proprie nozze. Ruggiero rispose loro: «Non vi preoccupate, per me queste sarebbero scuse infamanti». Giunsero le armi che egli strappò al famoso Tartaro (Mandricardo) e fu troncata ogni esitazione. A Ruggiero il conte Orlando strinse gli sproni e lo stesso Carlo gli cinse la spada al fianco. // Bradamante e Marfisa gli avevano messo la corazza e le altre parti dell’armatura. Astolfo teneva la briglia di un cavallo di razza, mentre il figlio del Danese (Dudone) reggeva la sella. Rinaldo, Namo e il marchese Oliviero sgomberarono la piazza e cacciarono tutti dallo steccato, sempre preparato a tale scopo. // Donne e giovinette con viso pallido sono timorose come colombe che la furia dei venti, accompagnati da tuoni e lampi, spinge dai campi di grano verso i nidi, e il cielo nero minaccia grandine e pioggia e devastazione e danni per i campi: stanno lì timorose per Ruggiero, che a loro sembrava inferiore a quel feroce saraceno. // Allo stesso modo sembrava a tutta la gente e alla maggior parte dei cavalieri e dei baroni, che conservano ancora la memoria di quello che il Pagano aveva fatto a Parigi, che solo ne aveva messo gran parte a ferro e a fuoco, la cui distruzione ancora rimaneva e lascerà il segno per molti anni ancora: quel regno d’altra parte non ebbe mai maggior danno. // Il cuore di Bradamante tremava più di tutti gli altri, non perché credeva che la forza e il coraggio del saraceno valessero più di quelle di Ruggiero, né che Rodomonte avesse ragione, cosa che spesso conduce alla vittoria: tuttavia ella non può non trovare timore, perché amando, ha un buon motivo per temere. // Oh quanto volentieri avrebbe compiuto l’impresa di quel duello incerto, anche se fosse stata sicura di perdere la vita a causa di quella! Avrebbe scelto di morire più di una volta se si potrebbe morire più di una volta, piuttosto che sopportare che il suo consorte si mettesse in pericolo di vita. // Ma non riesce a trovare preghiera che valga, perché Ruggiero lasci a lei il duello. A guardare dunque lo scontro, con viso triste e cuore trepidante, sta. Da una parte Ruggiero, da una parte il pagano si scagliano l’un contro l’altro con le lance abbassate. Le lance nello scontrarsi sembravano di ghiaccio, i brandelli, uccelli che salivano al cielo.
(…)
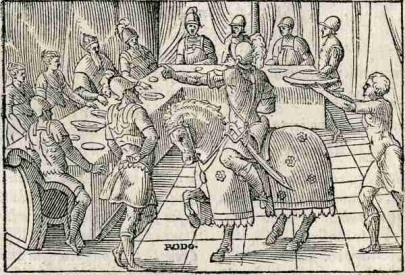
Rodomonte interrompe il banchetto di nozze
Con quella estrema forza con cui colpisce la macchina che sta sul Po sopra due navi e che, sollevata da uomini e carrucole, si lascia cadere su pali appuntiti (battipalo usato per conficcare pali atti alle fondazioni), allo stesso modo il pagano ferisce Ruggiero, quanto più può, con tutt’e due le mani, pesanti più di ogni altro peso: giova a Ruggiero l’elmo incantato, che senza di esso, avrebbe spezzato in un solo colpo lui con il cavallo. // Ruggiero abbassa due volte la testa, e nel cadere aprì gambe e braccia. Il feroce Saracino raddoppia i colpi, affinché l’avversario non abbia tempo di riprendersi; poi aggiunge anche il terzo colpo, ma la spada non resistette a un così lungo martellare, che andò a pezzi, lasciando nuda la mano del crudele pagano. // Rodomonte non si ferma per questo, ma s’avventa su Ruggiero che non sente più nulla, tanto aveva intronata la testa e offuscata la mente. Ma il Saraceno lo costringe a riaversi, cingendogli con il braccio possente il collo e lo afferra con una tale stretta e tale forza che lo disarciona e getta in terra. // Non appena a terra si rialzò, più per vergogna che per ira, perché aveva volto il viso verso Bradamante e vide il suo viso turbarsi. Lei alla sua caduta restò così in dubbio che sembrò che la stessa sua vita venisse meno. Ruggiero per rimediare a quella vergogna, stringe la spada e s’avventa sul pagano. // Quello gli scaglia contro il destriero, ma Ruggiero lo scansa con prontezza, indietreggiando e nel passare afferra le redini con la mano sinistra e gli gira intorno: con la destra, intanto cerca di ferirlo sul ventre e sul petto; gli fece sentire dolore con due colpi, una al fianco, l’altra nella coscia. // Rodomonte che ancora aveva in mano l’impugnatura e la lama spezzata, picchiava Ruggiero sull’elmo, tanto che un’ulteriore botta l’avrebbe stordito. Ma Ruggiero che doveva necessariamente vincere, gli prese il braccio e aggiungendo l’altra mano lo tirò giù, finché lo fece cadere dalla sella. // Ma la sua forza o la sua destrezza fa sì che resti al pari di Ruggiero, voglio dire che cadde in piedi; e tutti giudicarono Ruggiero essere in vantaggio, avendo la spada intatta: Ruggiero cerca di tener lontano da sé il pagano né di avvicinarsi troppo; non sopporterebbe lasciarsi venire addosso un corpo così grande e grosso. // Ma vede insanguinargli il fianco, la coscia e altri parti del corpo. Spera che le forze gli vengano meno, sì che alla fine gli dia vinta la sfida. Il pagano aveva ancora l’elsa e l’impugnatura della spada, e con tutte le forze la scagliò e colpì Ruggiero, in modo da stordirlo più che mai. // Ruggiero fu colpito sul lato dell’elmo e nella spalla, e sente quel colpo così forte che vacilla e barcolla e si mantiene in piedi con difficoltà. Il pagano vuol farsi avanti, ma il piede non lo sorregge, impotente a causa della ferita sulla coscia, e il voler affrettarsi più di quanto possa, lo fa cadere in terra su un ginocchio. // Ruggiero non perde tempo e con un gran colpo lo percuote sul petto e sulla faccia; e lo colpisce sopra la testa e lo tiene alle strette che alla fine lo caccia in terra. Ma il pagano fa tanto che si rialza e si stringe così forte a Ruggiero tanto da abbracciarlo; entrambi si rigirano, si scuotono, si schiacciano, aggiungendo abilità alle loro ultime forze. // A Rodomonte avevano tolto gran parte della forza le ferite al fianco e sulla coscia. Ruggiero aveva abilità, grande capacità, si era esercitato molto nella lotta: sente di essere in vantaggio e non si allontana; e dove vede scorrere più copiosamente il sangue, e dove il pagano ha maggiormente ferite, pone il braccio, il petto ed entrambi i piedi. // Rodomonte, pieno di rabbia e di rancore, prende Ruggiero nel collo e nelle spalle: ora lo tira a sé, ora lo allontana, ora lo solleva e da una parte all’altra lo fa girare, lo tiene stretto e molto lotta per farlo cadere. Ruggiero sta molto attento, e mette in opera intelligenza e capacità, per conservare il vantaggio. // Il franco e buon Ruggiero riuscì a cambiare le prese e a cingere Rodomonte : gli strinse il petto sul fianco sinistro e con tutta la forza lo bloccò. Mise poi la gamba destra sopra il ginocchio sinistro e destro e lo spinse, lo sollevò da terra e lo fece tornare a terra a testa in giù. // Rodomonte impresse la terra con il capo e con la schiena, e tanto grande fu la botta che dalle sue ferite, come fossero fonti, uscì sangue che rosseggiò tutta la terra intorno. Ruggiero, che ha la Fortuna dalla sua parte, affinché il Saracino non possa alzarsi, ha una mano col pugnale sopra gli occhi, un’altra alla gola e le ginocchia sul ventre. // Come talvolta, dove si estrae l’oro, là tra gli Ungheresi o le miniere spagnole, se una frana improvvisa si abbatte su coloro che un’avidità perversa ha condotto fino là e ne restano schiacciati a tal punto che il loro respiro può a malapena avere una fessura da cui uscire, così il Saraceno fu allo stesso modo oppresso dal vincitore, non appena fu gettato a terra. // Ruggiero gli mostra davanti al viso la punta del pugnale che aveva già sguainato; e minacciandolo, tenta di farlo arrendere e gli promette che avrà salva la vita. Ma quello che ha meno paura di morire che di mostrare anche un piccolo atto di viltà, si contorce e si scuote e per porre lui sotto mette ogni forza, né gli risponde. // Come un mastino sotto un feroce alano, che abbia conficcato i denti nella sua gola, si affanna molto e si dibatte inutilmente con occhi ardenti e con labbra che schiumano, e non può sfuggire al suo predatore, che vince per la forza e non per rabbia, allo stesso modo fallisce al Saraceno ogni pensiero, di riuscire a sfuggire a Ruggiero. // Tuttavia si contorce e si dibatte talmente che riesce a liberare il braccio destro e con la mano, che afferra un pugnale, che anche lui tirò fuori, durante quel duello, con cui vuole ferire Ruggiero sotto le reni; ma il giovane s’accorse dell’errore in cui poteva cadere, per indugiare nell’uccidere l’empio Saraceno. // E due e tre volte nella spaventosa fronte di Rodomonte, alzando il più possibile il braccio, conficcò il pugnale e si tolse dall’impaccio. L’empia anima, che fu in vita così altezzosa e orgogliosa, bestemmiando fuggì dal corpo freddo più del ghiaccio verso le squallide rive dell’Acheronte.
E’ questo l’ultimo passo del poema, cui fa seguito solo il motto Pro bono malum (il male per il bene) a suggellare l’intero poema. Come si vede, il racconto ariostesco si chiude con Ruggiero protagonista sia per il suo matrimonio con Bradamante che per lo scontro finale con Sacripante. L’eroe eponimo diventa secondario, dopo la guarigione Orlando compare più come gregario che come un vero e proprio protagonista. Tutto ciò vuole ancora dimostrare la polidietricità del mondo ariostesco: non esiste un personaggio, ma un uomo poliedrico (folle o saggio, fedele o intemperante, avaro o prodigo e via discorrendo) che i vari protagonisti incarnano, ma che l’uomo rinascimentale sente come contemporanei, cui rivolgersi per sapere i suoi limiti e le sue debolezze. Ma per chiudere il poema, Ariosto ha bisogno di un supporto maggiormente letterario, più alto di quanto le chanson finora gli avevano offerto: ed ecco che già da Cloridano e Medoro Virgilio si era mostrato come nume tutelare per l’autore; così sarà per quest’ultimo episodio, modellato sullo scontro tra Enea (Ruggiero) e Turno (Sacripante), con la stesso indugio, che fa perdonare al lettore, la cruenta morte inflitta al nemico. A concorrere all’impressione di una maggiore “epicità” in questo episodio, rispetto ai mille altri letti sinora è l’estremo realismo con cui descrive il duello: non ci troviamo più in un iperrealismo ironico, dove a farla da padrone sono le amplificazioni sì retoriche, ma estremamente ironiche, si pensi al duello tra Bradamante e Sacripante nel primo canto i cui contendenti sono paragonati a leoni o tori (Non si vanno i leoni o i tori in salto a dar di petto, ad accozzar sì crudi, sì come i duo guerrieri al fiero assalto), e il cui duello risuona per tutta la compagna fino alle colline (Fe’ lo scontro tremar dal basso all’alto l’erbose valli insino ai poggi ignudi). Nell’ultimo scontro, invece è il realismo a prevalere: si sente l’odore di terra mista a sudore, sangue copioso; si segue la lotta sin nei minimi particolari di presa, si vede il feroce coltello di Ruggiero entrare nella fronte di Rodomonte, quasi a sentire lo squarcio del colpo. Nessuna parola a chiudere felicemente il racconto, un sorriso per la vittoria di Ruggiero stesso o di Bradamante, solo l’anima “empia” di Rodomonte verso i lidi dell’Inferno. Che si voglia, con questo, anche qui disegnare il fatto che, nonostante i suoi saggi consigli, l’uomo non possa fare a meno di violenza e di sangue (ricordiamoci il periodo storico in cui l’opera venne scritta)?

Il matrimonio di Ruggiero e Bradamante nel disegno di bambini
Ma al di là di questo potremo definire la storia del poema chiusa? Abbiamo già visto come l’Orlando non inizia; parte in medias res, esattamente dove lo termina Boiardo e finisce con un duello; ma percepiamo che nulla sappiamo di che fine facciano gli altri eroi, se Orlando troverà pace con un’altra donna, se Rinaldo, dopo aver bevuto nella fontana dell’odio potrà ancora innamorarsi, se Angelica e Medoro avranno figli e via discorrendo. Cioè l’opera non chiude. Ma perché non chiude? Perché Ariosto non vuole mostrarci una parte del mondo, ma un frammento stesso del mondo, mentre quest’ultimo è gia vissuto, vive e vivrà in segui-to, soprattutto nei continuatori, che a quanto pare saranno numerosi e che poeteranno sulle avventure dei cavalieri cantati già da Boiardo e da Ariosto. Ciò ci testimonia il successo dell’opera del ferrarese, successo testimoniato da un grande autore spagnolo del ’600, Cervantes che afferma, attraverso la voce di un personaggio:
Ah! lo conosco molto bene, rispose il curato; ecco qua il signor Rinaldo di Montalbano cogli amici e compagni suoi più ladri di Caco, e i dodici paladini col loro storico veritiero Turpino la verità che sarei per condannarli soltanto ad eterno bando, non per altro se non perché hanno avuto gran parte nella invenzione del celebre Matteo Bojardo, d’onde ha poi ordila la sua tela il cristiano poeta Lodovico Ariosto; al quale, se qui si trovasse, e parlasse un idioma diverso dal suo proprio, non porterei rispetto, ma se fosse nel suo linguaggio originale, me lo riporrei sopra la testa. – Io lo tengo in italiano, disse il barbiere, ma non l’intendo. – Non è neppur bene che da voi sia inteso, rispose il curato; e perdoniamo per ora a quel signor capitano che lo ha tradotto in lingua castigliana, togliendogli gran parte del nativo suo pregio: ma così averrà a tutti coloro che s’impegnano a tradurre libri poetici, mentre, per quanto studio vi pongano, per quanta attitudine vi abbiano, non potranno mai darceli tali quali essi nacquero.





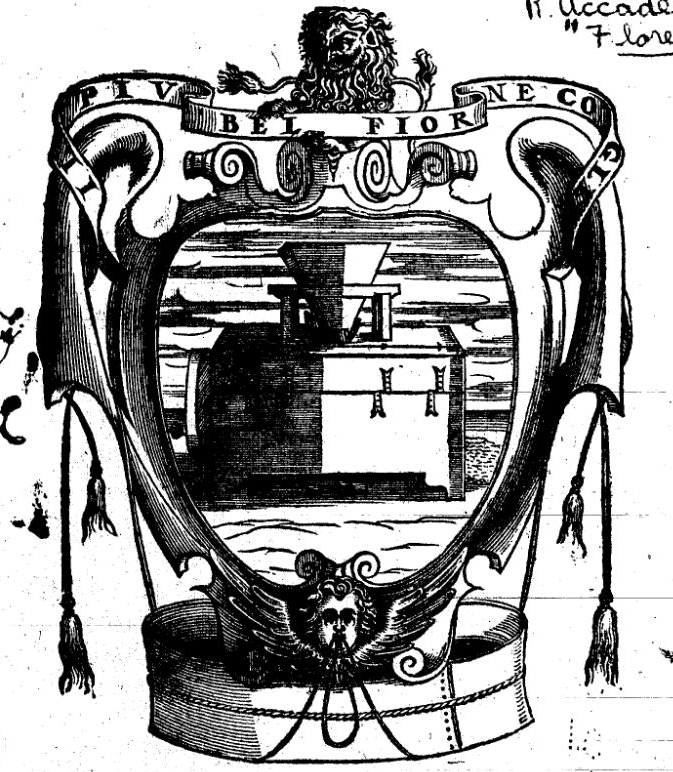


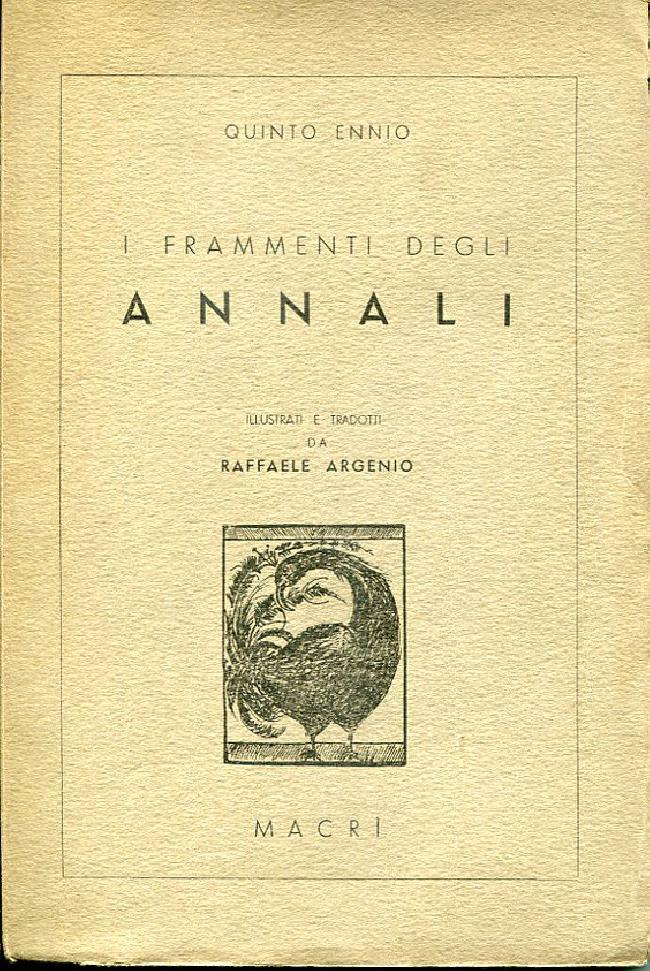





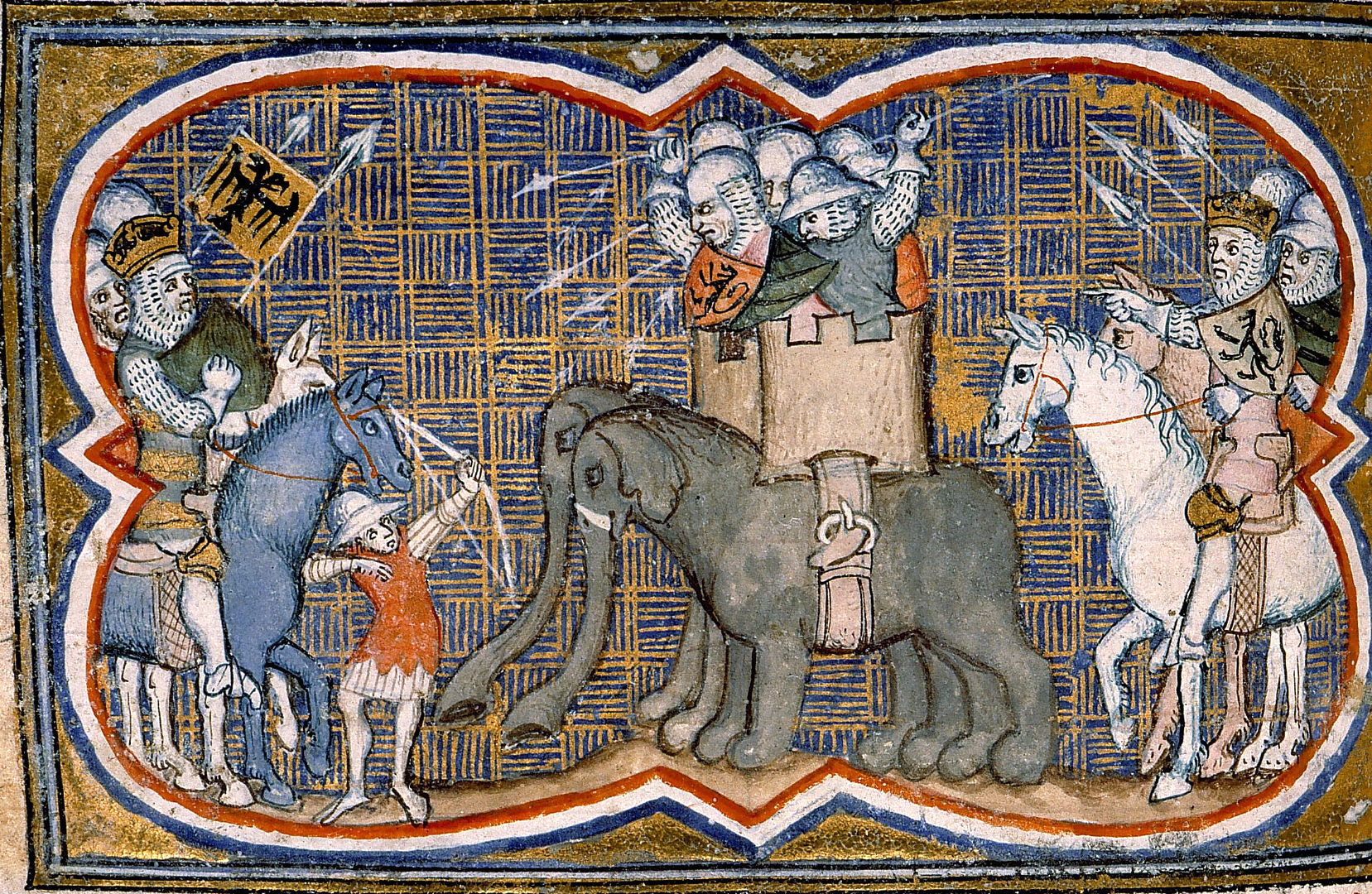

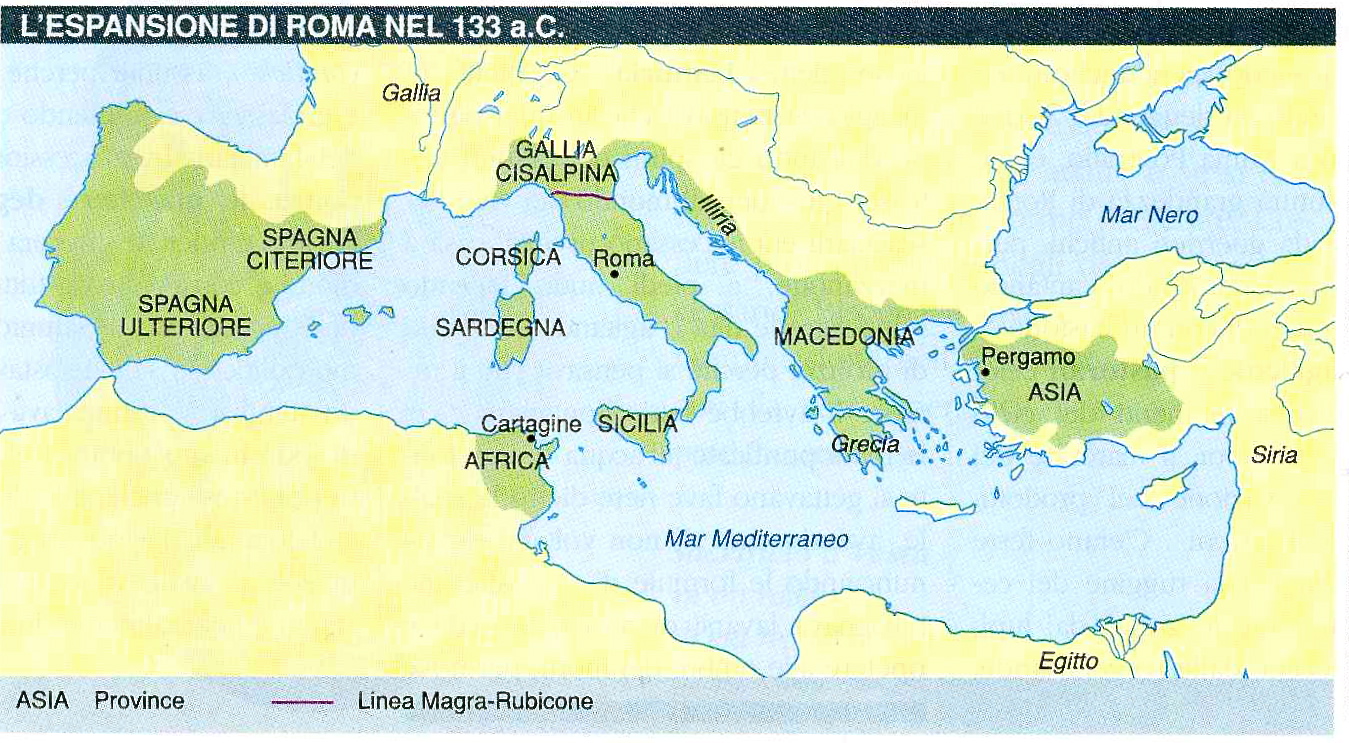


 Peter Paul Rubens – Romulo and Remo (1615)
Peter Paul Rubens – Romulo and Remo (1615)





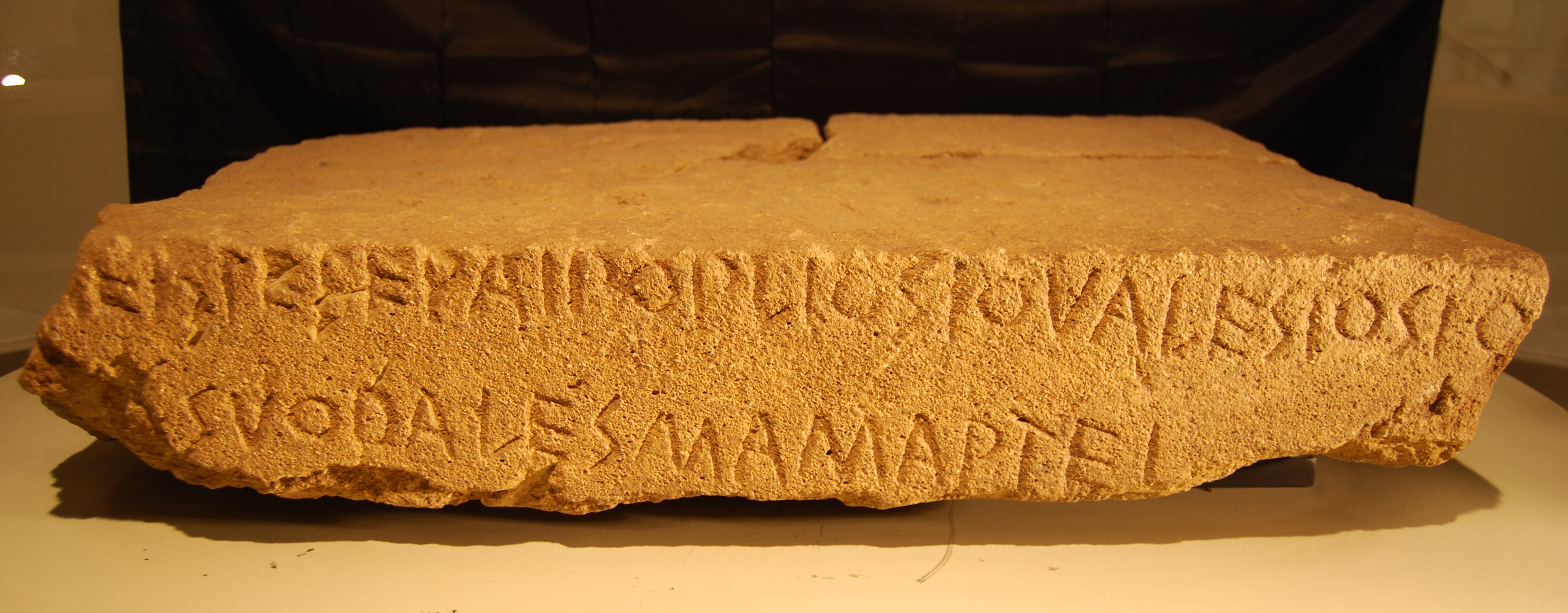




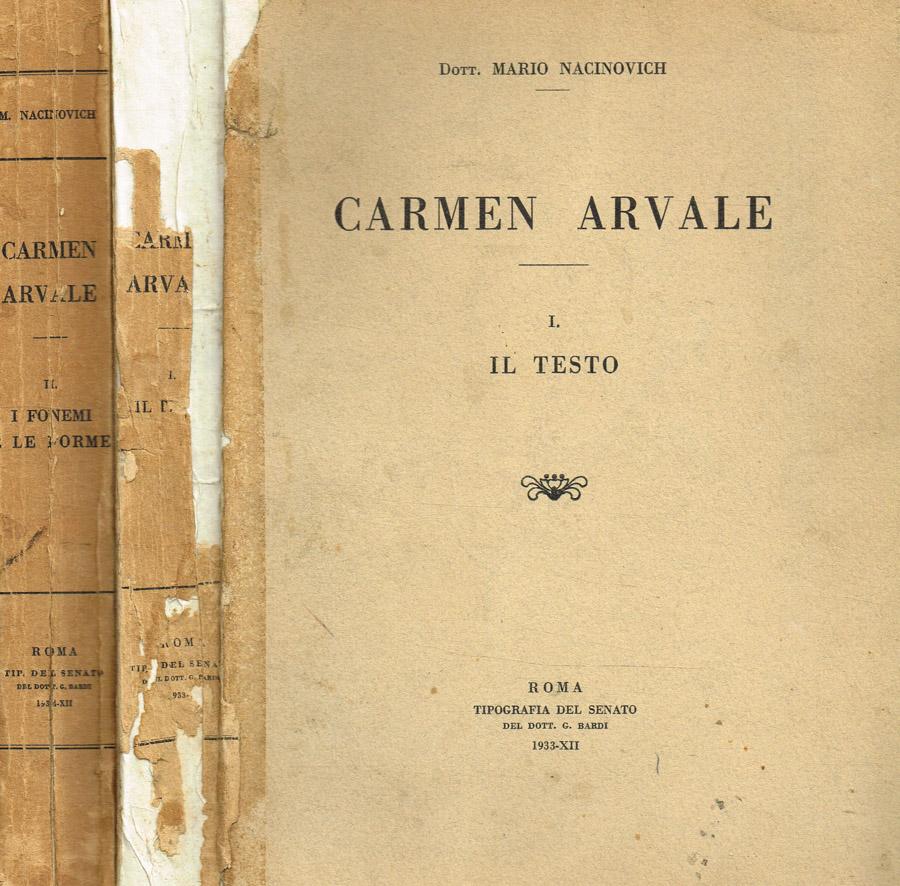


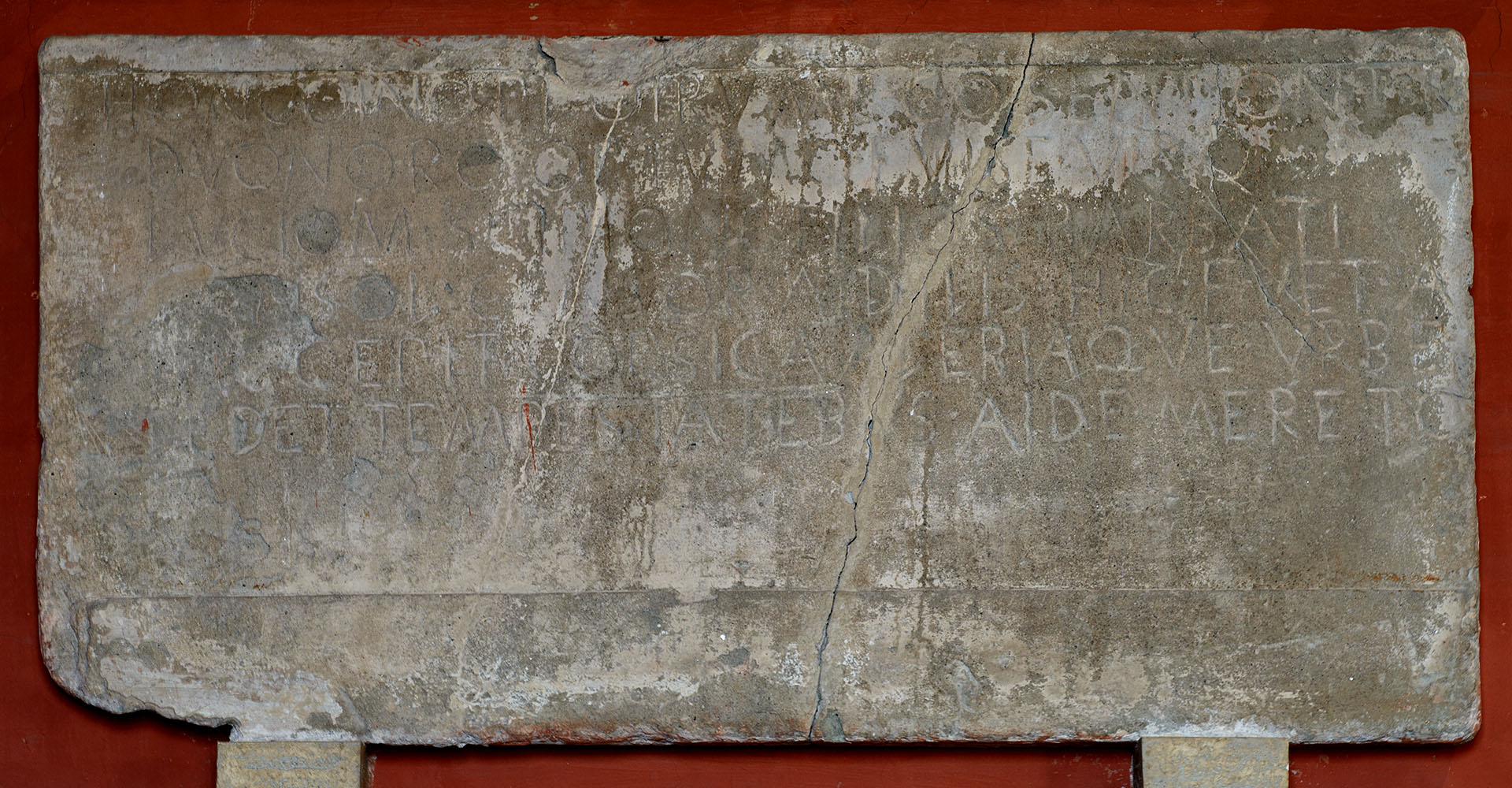


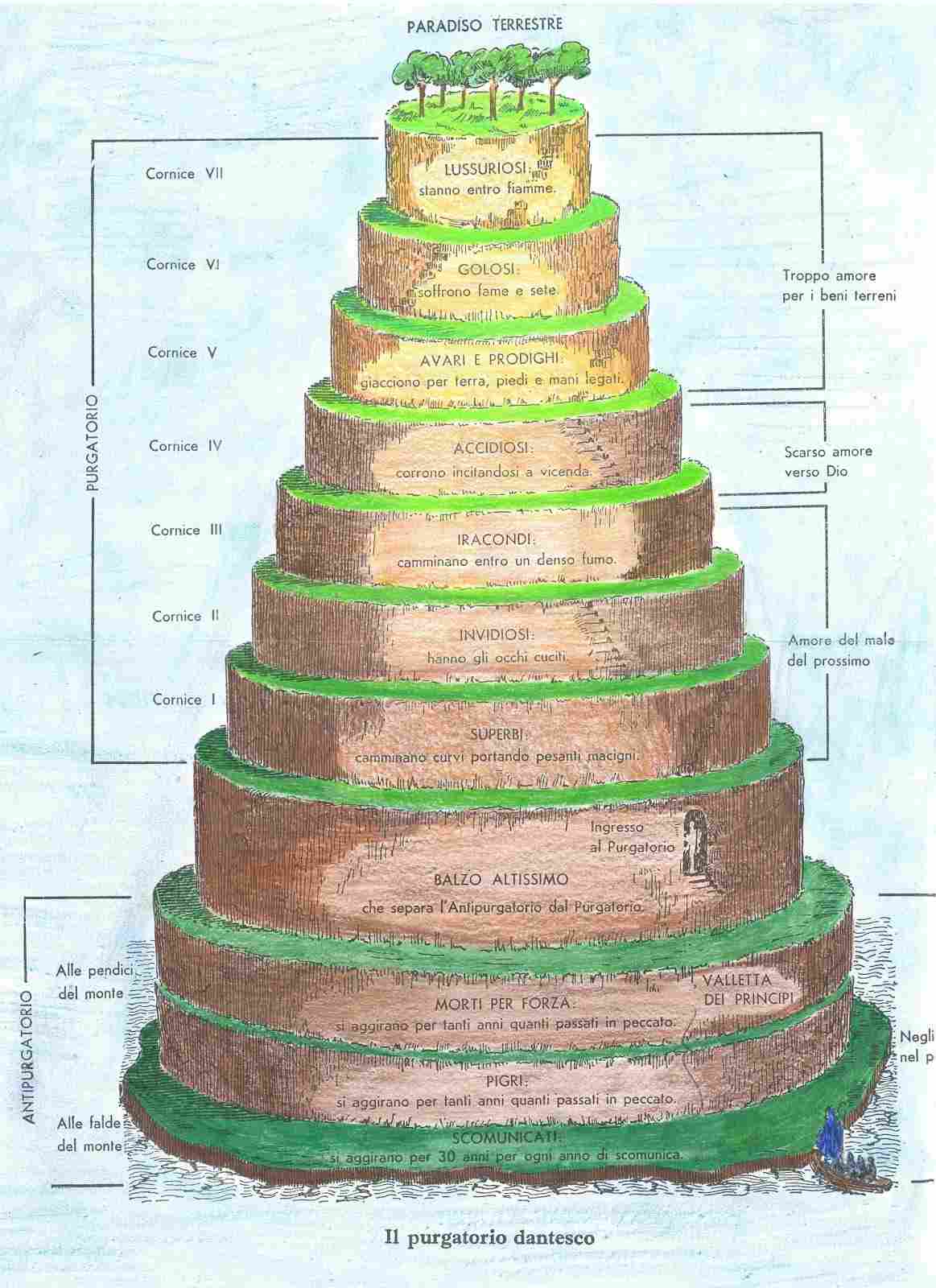

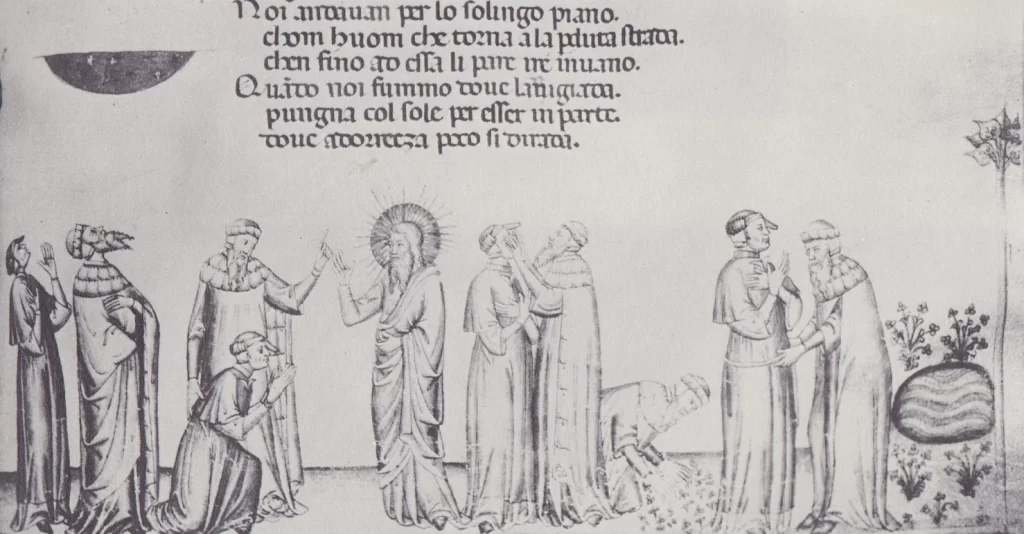





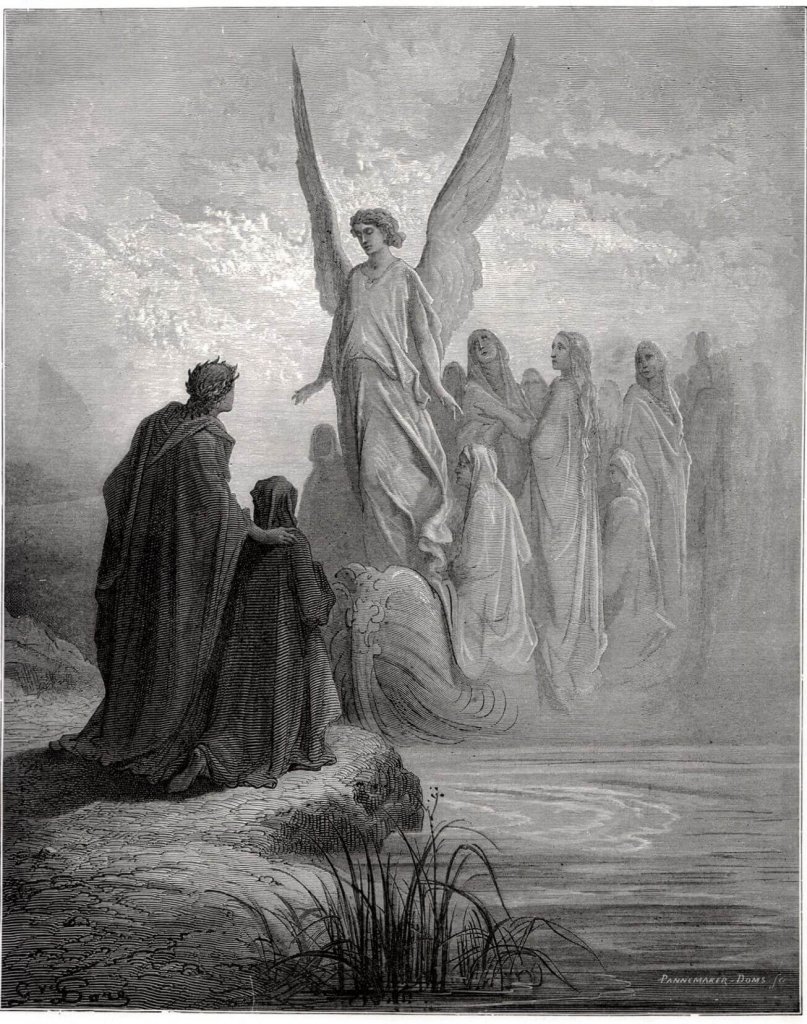 L’angelo con Dante in ginocchio
L’angelo con Dante in ginocchio
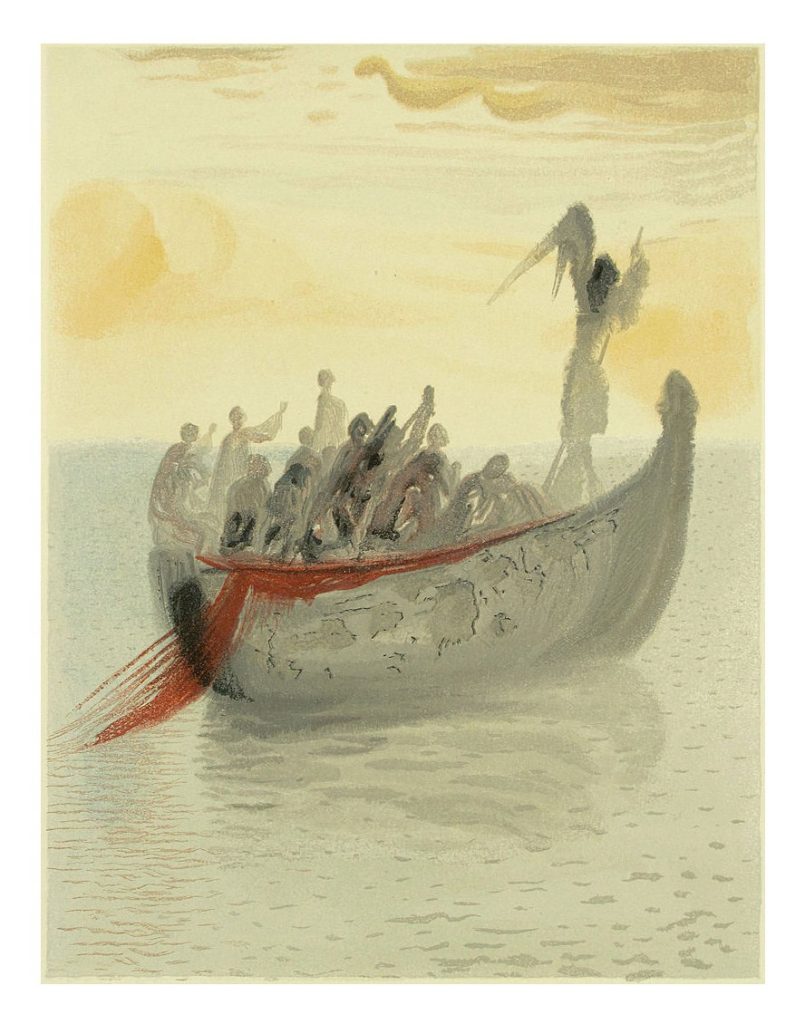






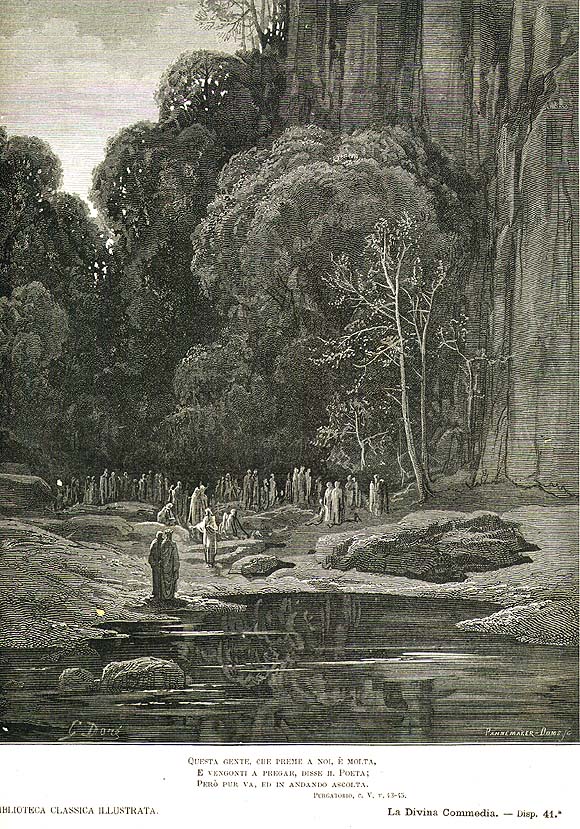













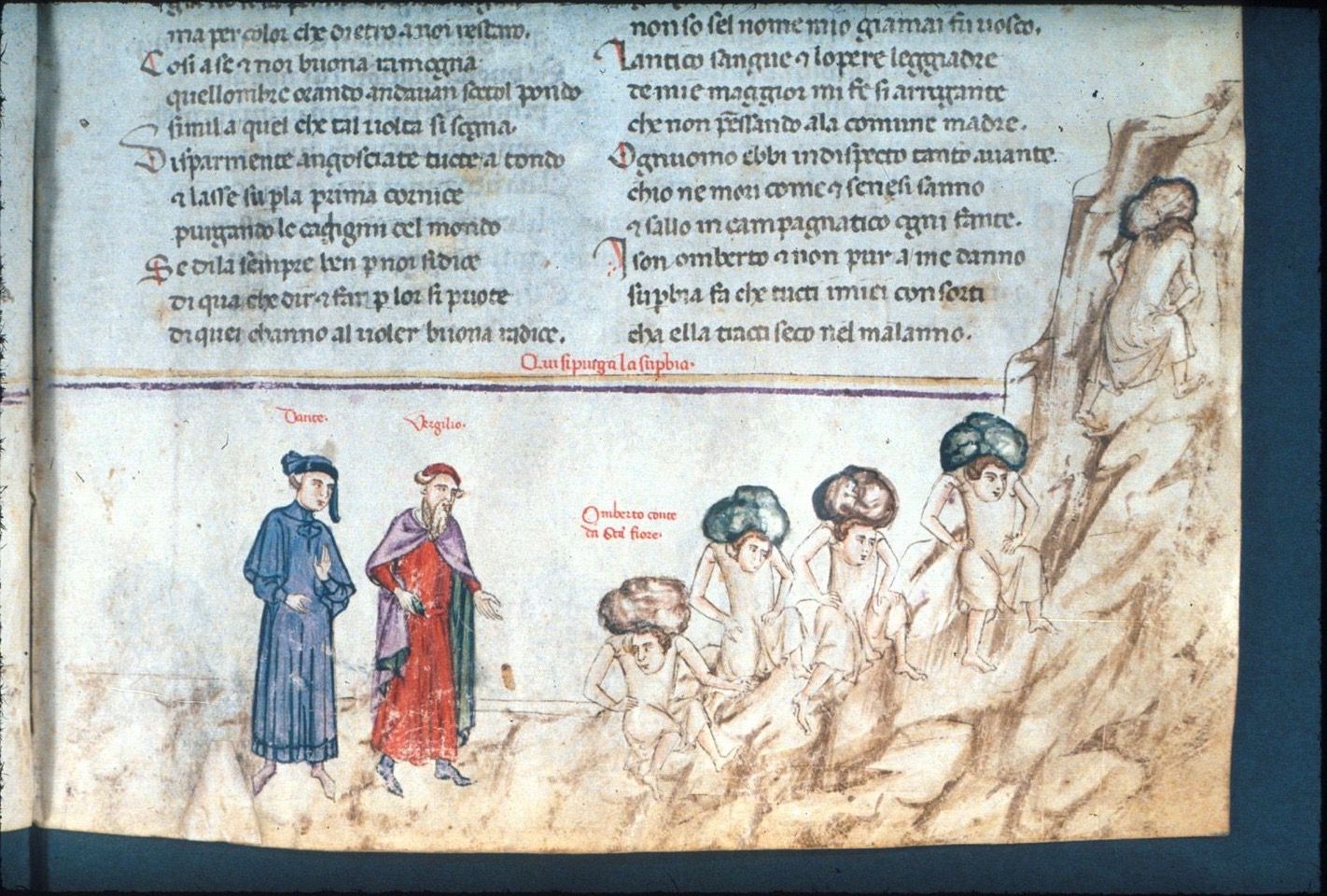
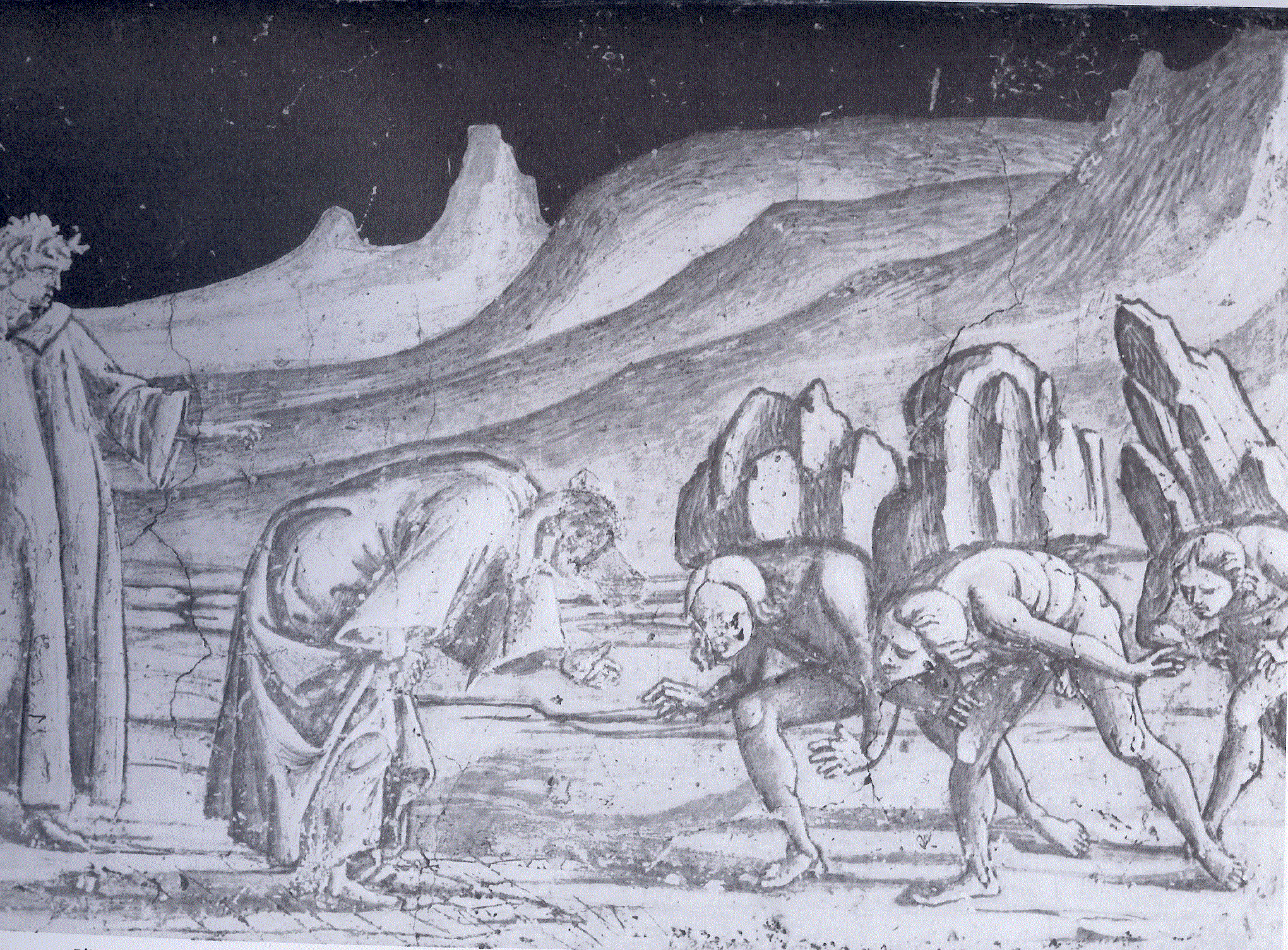


 Amos Cassioli: Provenzano Salviati a Piazza del Campo (1873)
Amos Cassioli: Provenzano Salviati a Piazza del Campo (1873)

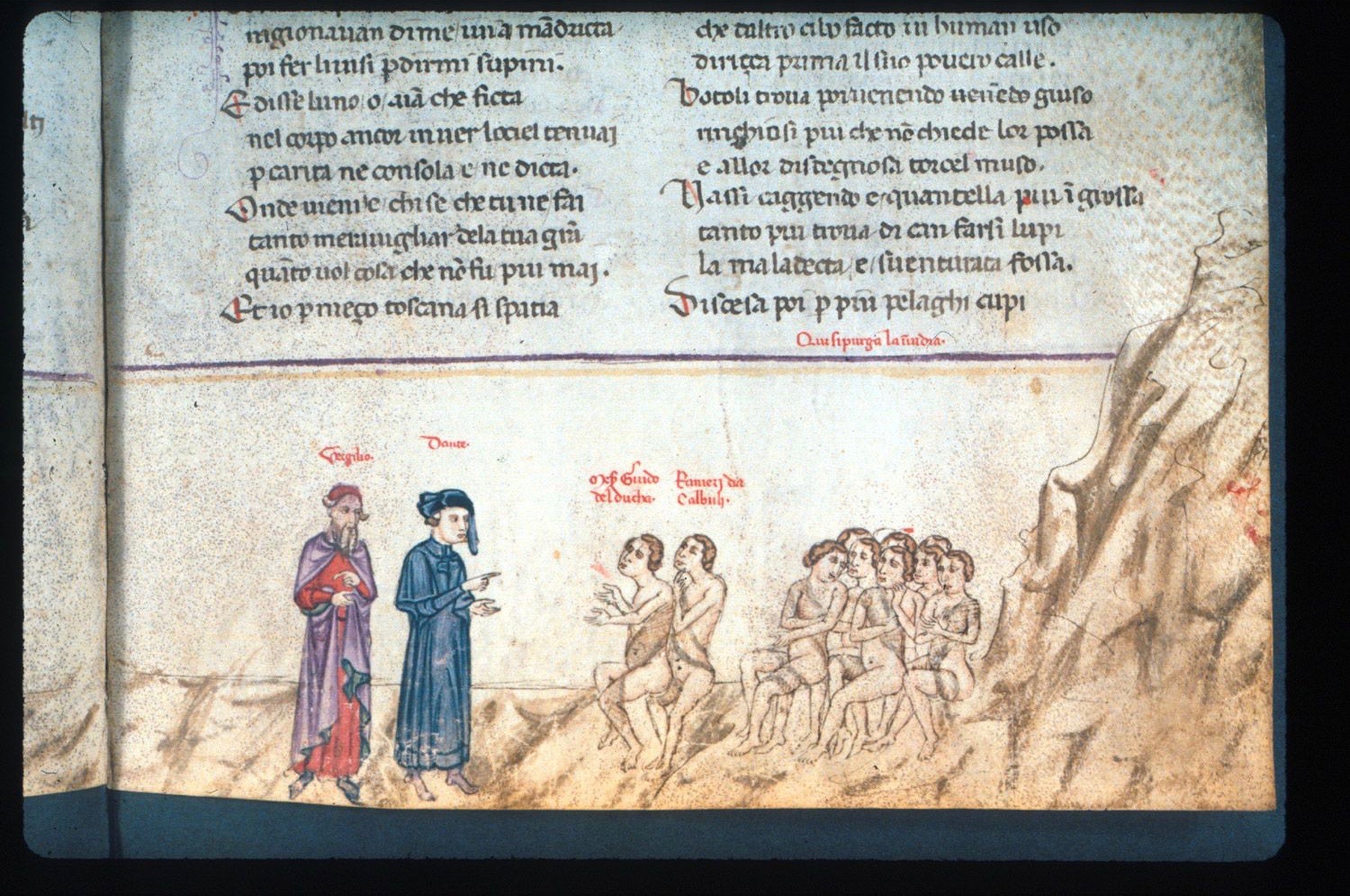


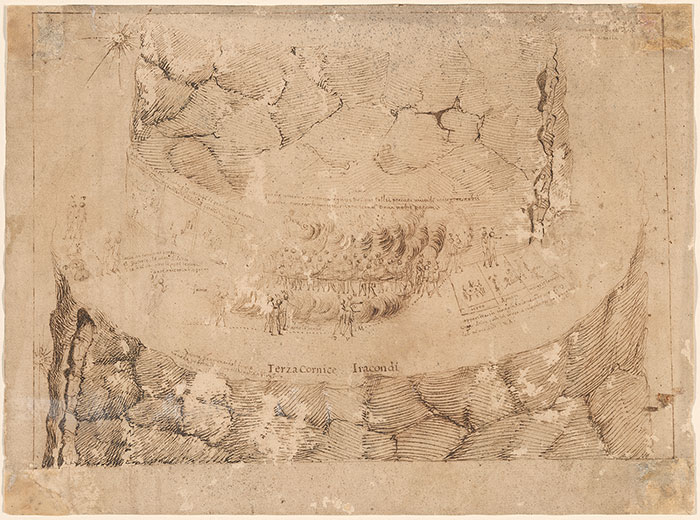


 Affresco che illustra la IV cornice del Purgatorio
Affresco che illustra la IV cornice del Purgatorio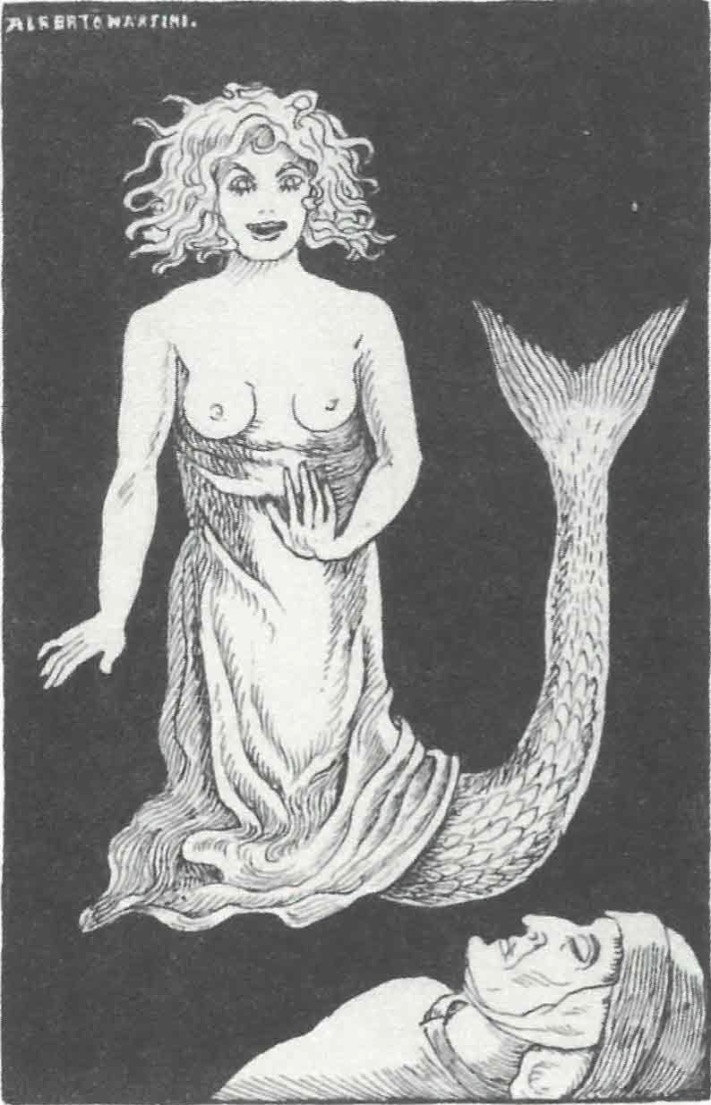
 Ugo Capeto
Ugo Capeto
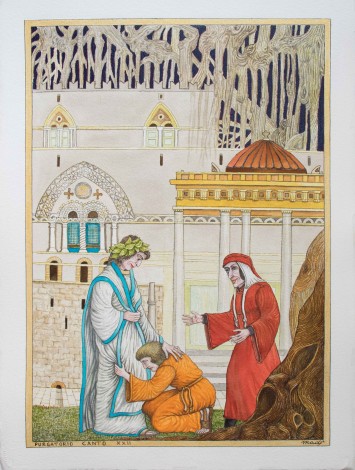
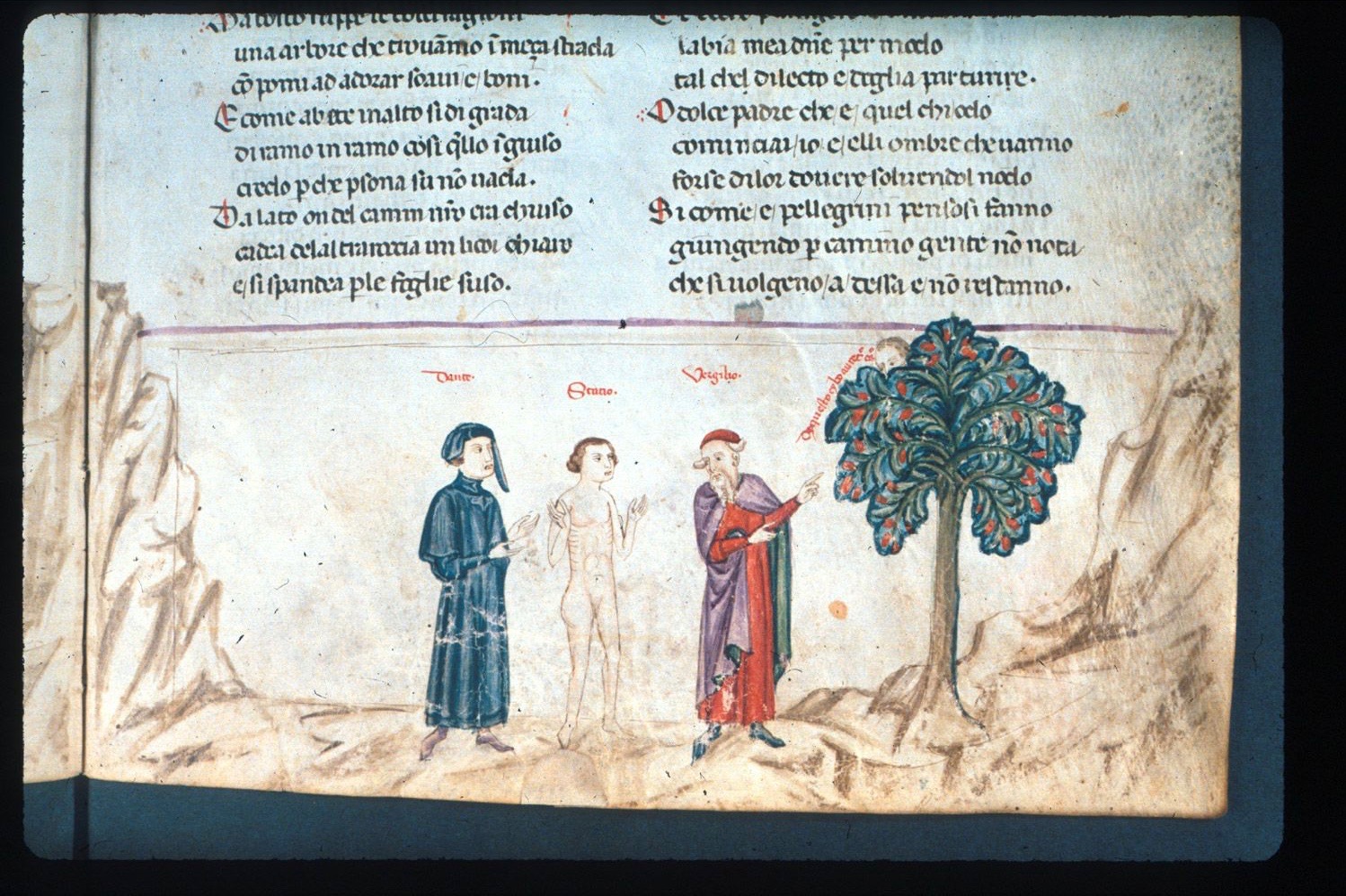 Codice che illustra il canto XXII
Codice che illustra il canto XXII



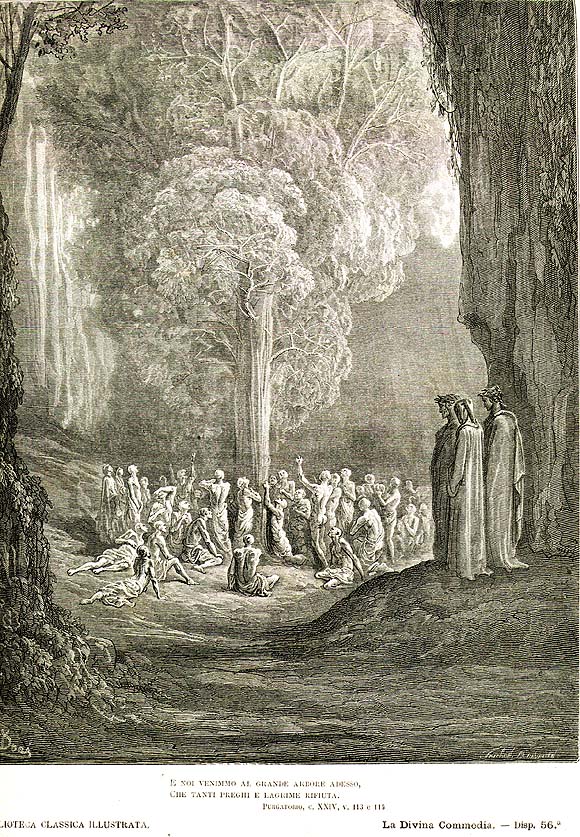
 e come prima, si avvicinarono a me quelle stesse anime che mi avevano pregato di parlare, attenti nel loro atteggiamento ad ascoltarmi. Io, che per due volte avevo visto come costoro gradivano conoscere, cominciai: «O anime certe di raggiungere, quanto che sia, lo stato di pace eterna, le mie membra non sono rimaste giù in terra ne prematuramente né in età matura, ma sono qui com me con il loro sangue e con le loro articolazioni. Da qui salgo nel cielo per non essere più nelle tenebre dell’errore; c’è una donna più in alto che mi procura la grazia per poter condurre il mio corpo mortale nel vostro mondo. Ma possa il vostro maggiore desiderio presto addivenire, sicché possiate risiedere nel cielo che è pieno d’amore e che è infinito, ditemi, affinché lo scriva, chi siete voi e chi quella turba di anime che procede in direzione a voi opposta». Non diversamente si mostra stupito il montanaro e guardandosi attorno ammutolisce, quando rozzo e selvatico entra in città, allo stesso modo fecero all’apparenza quelle anime, ma dopo aver superato lo stupore, che negli spiriti superiori subito si smorza: «Beato te che delle nostre contrade», ricominciò colui che prima mi chiese di parlare «raccogli l’esperienza, per morire in grazia di Dio!». La gente che non cammina con noi, paga l’offesa di ciò che Cesare, durante il trionfo, si sentì rivolgersi contro l’epiteto di regina, per questo si allontanano con il grido di Sodoma, rinfacciandosi il peccato al fine di accrescere la sete di espiazione con la vergogna. Il nostro peccato fu eterosessale, ma poiché non usammo la legge umana, ma seguimmo bestialmente l’appetito, quando partiamo da noi si dice, in vergogna di noi stessi, il nome di Pasife che si nascose in una bestia lignea (per unirsi con il toro). Ora conosci i nostri peccati e perché fummo colpevoli: se forse vuoi conoscere il nome delle anime che vi sono qui, non c’è abbastanza tempo e non lo conosco di tutte. Tuttavia di soddisferò del mio: sono Guido Guinizzelli, e qui mi purgo per essermi pentito prima della morte». Come nella disgrazia di Licurgo (che condannò a morte Isifile, per aver lasciato incustodito il figlio) corsero i due figli a vedere la madre (per salvarla), allo stesso modo io, ma non a giungere a tanto (gettarmi nel fuoco), quando sentii il nome di mio padre e dei compagni migliori di me, che in ogni tempo scrissero rime d’amore dolci ed eleganti; e in silenzio camminai per un bel po’ di tempo, osservandolo, non avvicinandomi più vicino a lui per il fuoco. Dopo averlo guardato, tutto mi offrii per accontentare ogni suo desiderio, con un giuramento che rende veritiero il mio dire. Ed egli a me: «Tu lasci una tale traccia, per quello che io sento, in me e tanto luminosa che il fiume Leté non potrà cancellare né oscurarla. Ma se le tue parole hanno detto il vero, dimmi qual è il motivo per cui dimostri nel parlare e nel guardarmi, di volermi così bene» E io a lui «I vostri scritti, che per quanto durerà la lingua volgare, renderanno graditi i codici in cui verranno vergati». «O fratello», disse «questo che io ti indico col dito» e mi mostrò uno spirito davanti a lui «fu il più grande artefice del suo volgare. Superò tutti nella poesia d’amore e nei romanzi cortesi, e lascia perdere gli sciocchi che antepongono a lui Giraut de Bornelh (nato nella regione del Lemosino). Danno retta più alla voce corrente che alla verità, e così formano la loro opinione prima d’ascoltare arte e la ragione. Così hanno fatto molti con Guittone, dandogli importanza di voce in voce, finché dal confronto con altri poeti, ha vinto la verità. Ora se tu hai un così grande privilegio di andare nel luogo dove è Cristo signore, recitagli per me un padrenostro, quanto è necessario a noi del purgatorio, dove non possiamo più peccare». Poi, forse per cedere il posto ad altri che gli erano vicini, sparì nel fuoco, allo stesso modo di un pesce in fondo all’acqua. Io mi diressi un poco più vicino alla persona indicata, e gli chiesi il suo nome che avrebbe ricevuto una gradita accoglienza. Ed egli così cominciò liberamente a dire: «Tanto mi piace la vostra gentile domanda, che io non voglio e non posso nascondermi a te. Io sono Arnaut (Daniel), che piango e vado cantando; afflitto vedo la passata follia, e vedo goioso davanti a me il giorno che aspetto con speranza. Quindi, vi prego, in nome di quella grazia che vi guida al sommo della scala purgatoriale, che al tempo opportuno vi sovvenga del mio dolore». Poi si nascose nel fuoco che purifica.
e come prima, si avvicinarono a me quelle stesse anime che mi avevano pregato di parlare, attenti nel loro atteggiamento ad ascoltarmi. Io, che per due volte avevo visto come costoro gradivano conoscere, cominciai: «O anime certe di raggiungere, quanto che sia, lo stato di pace eterna, le mie membra non sono rimaste giù in terra ne prematuramente né in età matura, ma sono qui com me con il loro sangue e con le loro articolazioni. Da qui salgo nel cielo per non essere più nelle tenebre dell’errore; c’è una donna più in alto che mi procura la grazia per poter condurre il mio corpo mortale nel vostro mondo. Ma possa il vostro maggiore desiderio presto addivenire, sicché possiate risiedere nel cielo che è pieno d’amore e che è infinito, ditemi, affinché lo scriva, chi siete voi e chi quella turba di anime che procede in direzione a voi opposta». Non diversamente si mostra stupito il montanaro e guardandosi attorno ammutolisce, quando rozzo e selvatico entra in città, allo stesso modo fecero all’apparenza quelle anime, ma dopo aver superato lo stupore, che negli spiriti superiori subito si smorza: «Beato te che delle nostre contrade», ricominciò colui che prima mi chiese di parlare «raccogli l’esperienza, per morire in grazia di Dio!». La gente che non cammina con noi, paga l’offesa di ciò che Cesare, durante il trionfo, si sentì rivolgersi contro l’epiteto di regina, per questo si allontanano con il grido di Sodoma, rinfacciandosi il peccato al fine di accrescere la sete di espiazione con la vergogna. Il nostro peccato fu eterosessale, ma poiché non usammo la legge umana, ma seguimmo bestialmente l’appetito, quando partiamo da noi si dice, in vergogna di noi stessi, il nome di Pasife che si nascose in una bestia lignea (per unirsi con il toro). Ora conosci i nostri peccati e perché fummo colpevoli: se forse vuoi conoscere il nome delle anime che vi sono qui, non c’è abbastanza tempo e non lo conosco di tutte. Tuttavia di soddisferò del mio: sono Guido Guinizzelli, e qui mi purgo per essermi pentito prima della morte». Come nella disgrazia di Licurgo (che condannò a morte Isifile, per aver lasciato incustodito il figlio) corsero i due figli a vedere la madre (per salvarla), allo stesso modo io, ma non a giungere a tanto (gettarmi nel fuoco), quando sentii il nome di mio padre e dei compagni migliori di me, che in ogni tempo scrissero rime d’amore dolci ed eleganti; e in silenzio camminai per un bel po’ di tempo, osservandolo, non avvicinandomi più vicino a lui per il fuoco. Dopo averlo guardato, tutto mi offrii per accontentare ogni suo desiderio, con un giuramento che rende veritiero il mio dire. Ed egli a me: «Tu lasci una tale traccia, per quello che io sento, in me e tanto luminosa che il fiume Leté non potrà cancellare né oscurarla. Ma se le tue parole hanno detto il vero, dimmi qual è il motivo per cui dimostri nel parlare e nel guardarmi, di volermi così bene» E io a lui «I vostri scritti, che per quanto durerà la lingua volgare, renderanno graditi i codici in cui verranno vergati». «O fratello», disse «questo che io ti indico col dito» e mi mostrò uno spirito davanti a lui «fu il più grande artefice del suo volgare. Superò tutti nella poesia d’amore e nei romanzi cortesi, e lascia perdere gli sciocchi che antepongono a lui Giraut de Bornelh (nato nella regione del Lemosino). Danno retta più alla voce corrente che alla verità, e così formano la loro opinione prima d’ascoltare arte e la ragione. Così hanno fatto molti con Guittone, dandogli importanza di voce in voce, finché dal confronto con altri poeti, ha vinto la verità. Ora se tu hai un così grande privilegio di andare nel luogo dove è Cristo signore, recitagli per me un padrenostro, quanto è necessario a noi del purgatorio, dove non possiamo più peccare». Poi, forse per cedere il posto ad altri che gli erano vicini, sparì nel fuoco, allo stesso modo di un pesce in fondo all’acqua. Io mi diressi un poco più vicino alla persona indicata, e gli chiesi il suo nome che avrebbe ricevuto una gradita accoglienza. Ed egli così cominciò liberamente a dire: «Tanto mi piace la vostra gentile domanda, che io non voglio e non posso nascondermi a te. Io sono Arnaut (Daniel), che piango e vado cantando; afflitto vedo la passata follia, e vedo goioso davanti a me il giorno che aspetto con speranza. Quindi, vi prego, in nome di quella grazia che vi guida al sommo della scala purgatoriale, che al tempo opportuno vi sovvenga del mio dolore». Poi si nascose nel fuoco che purifica. 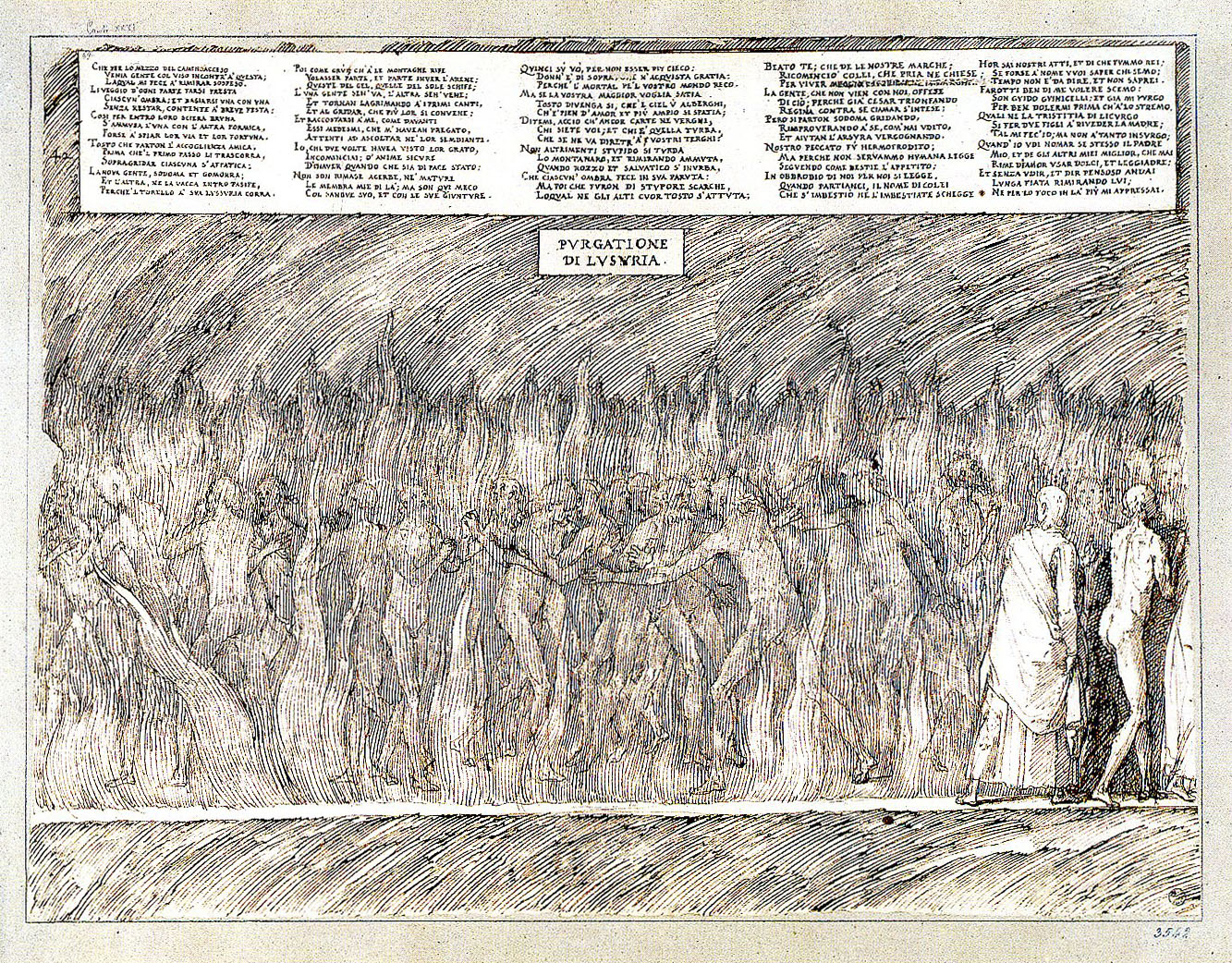
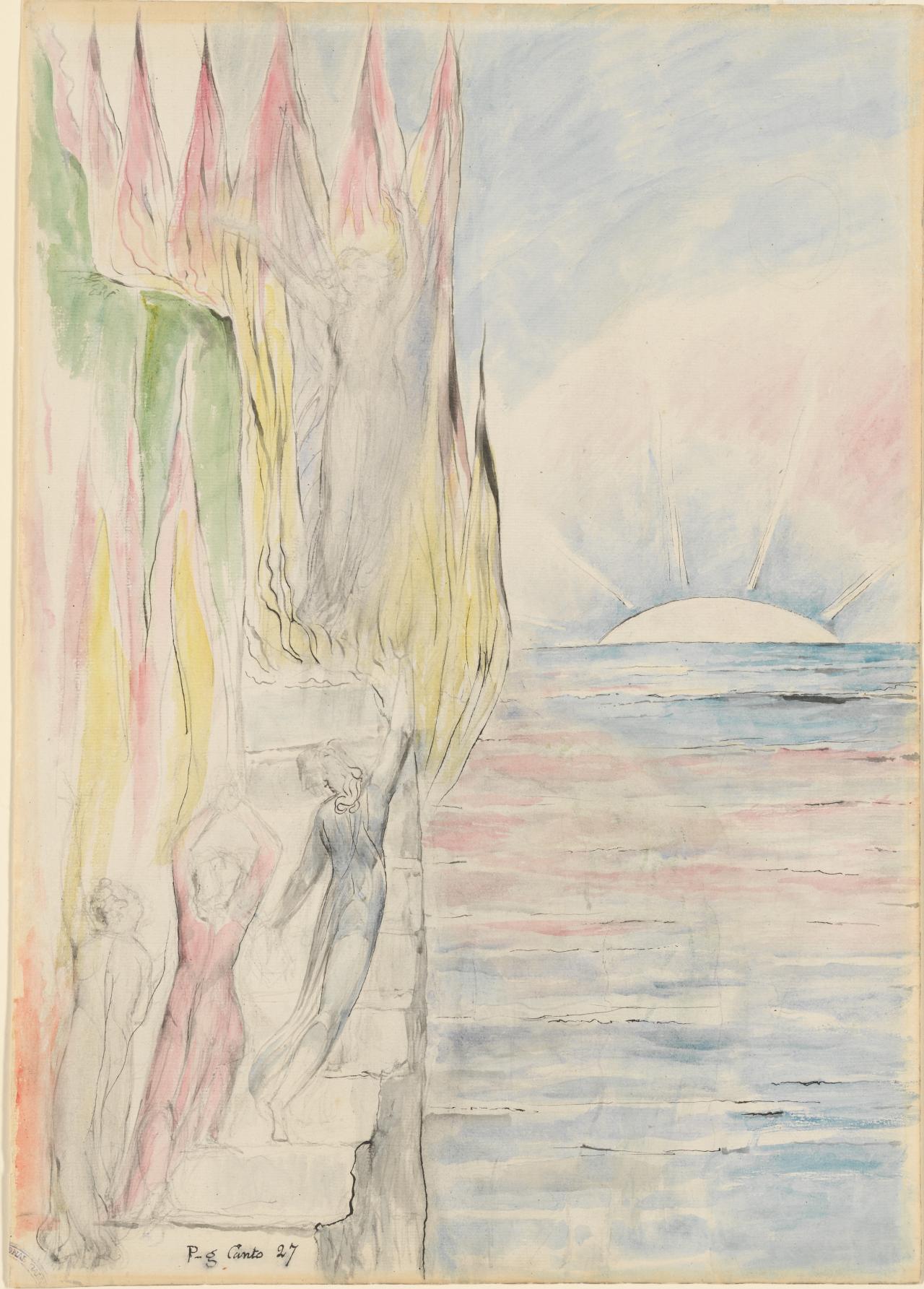
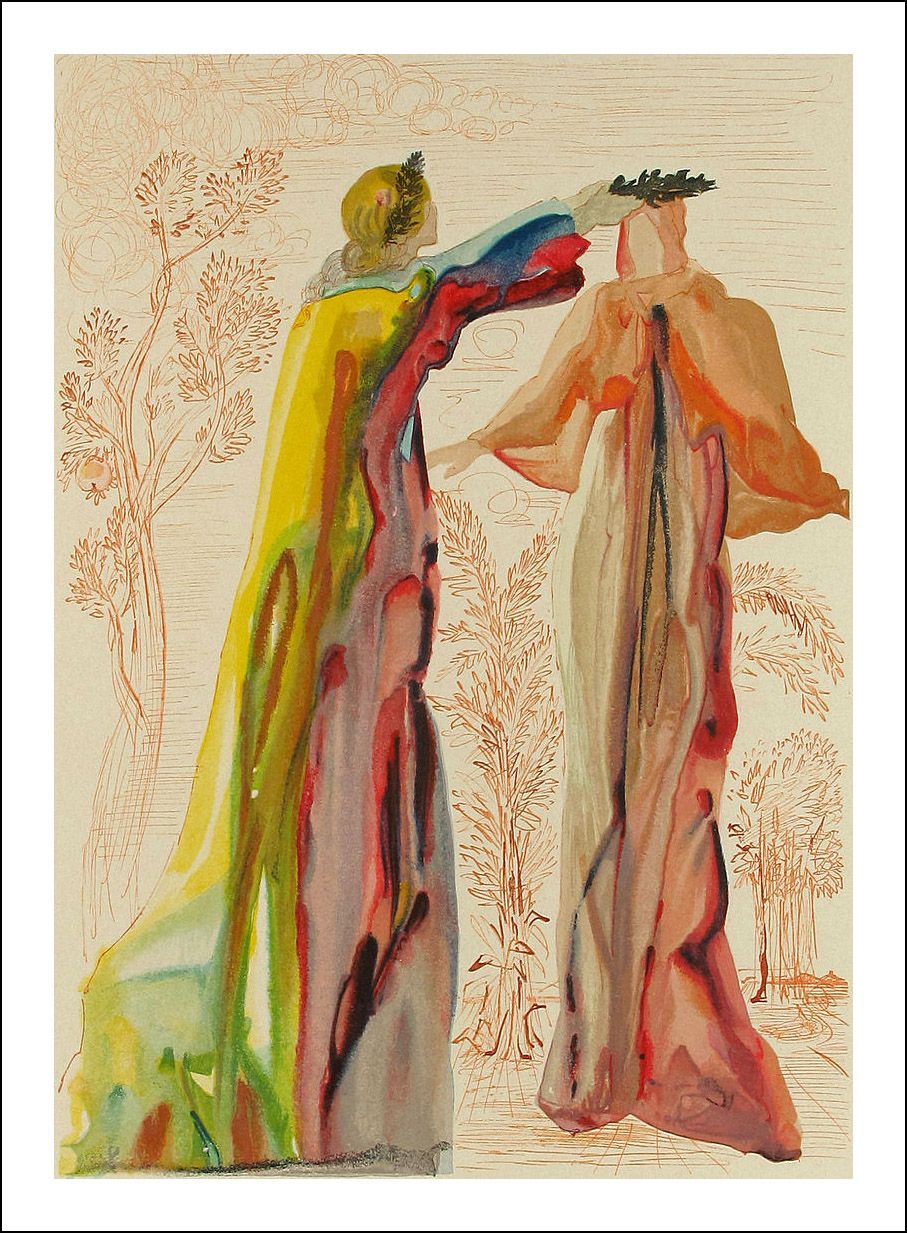
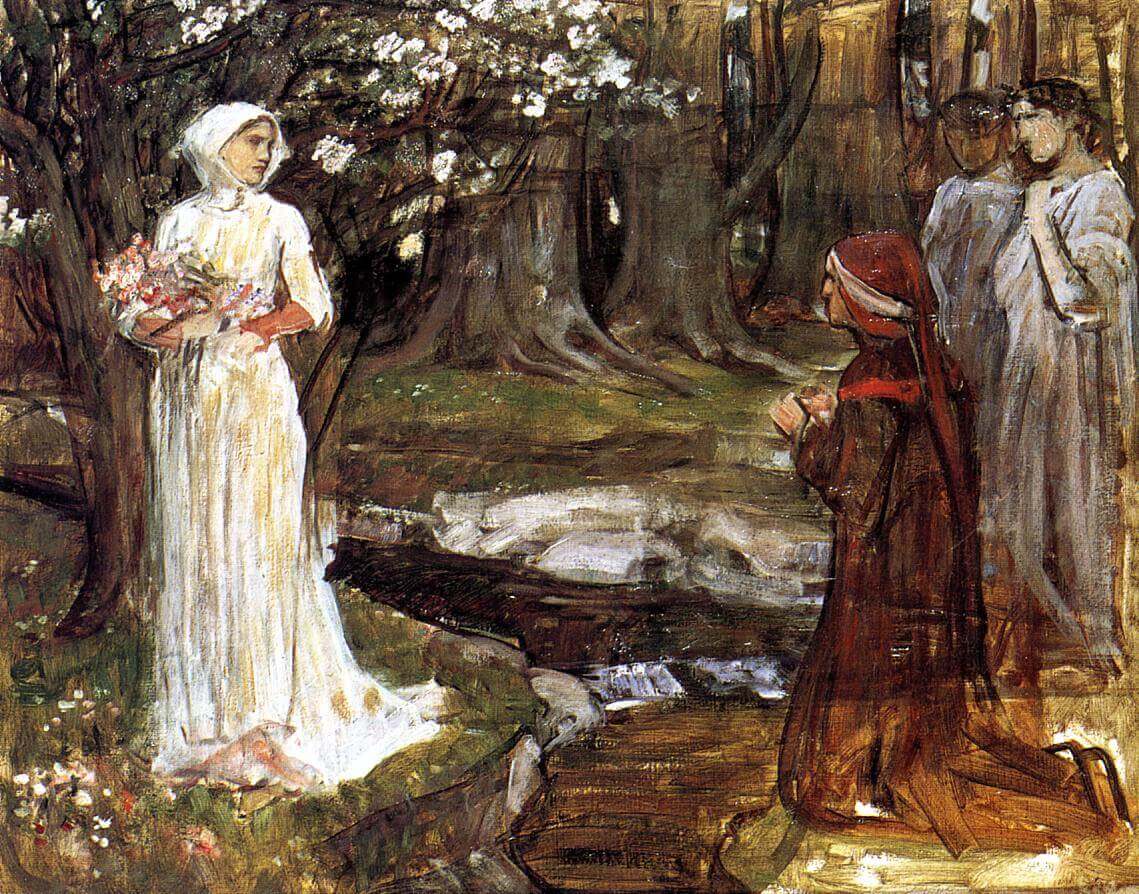


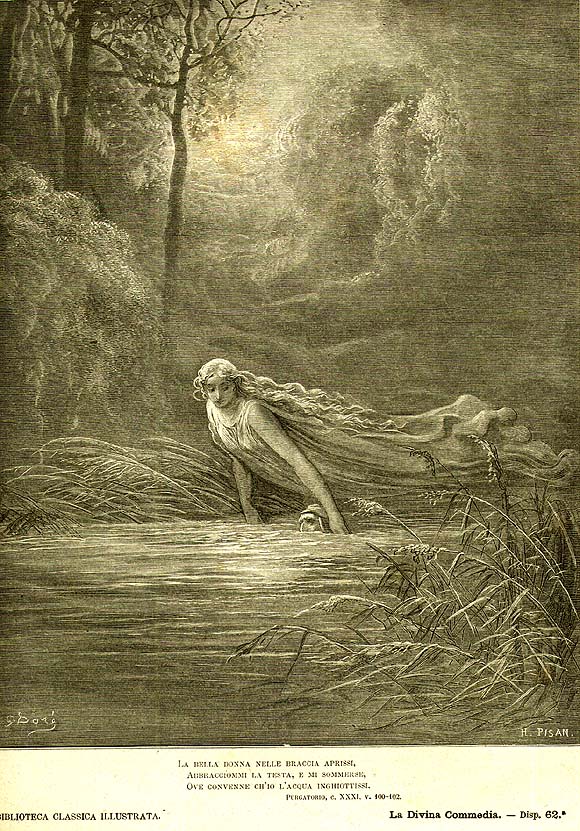






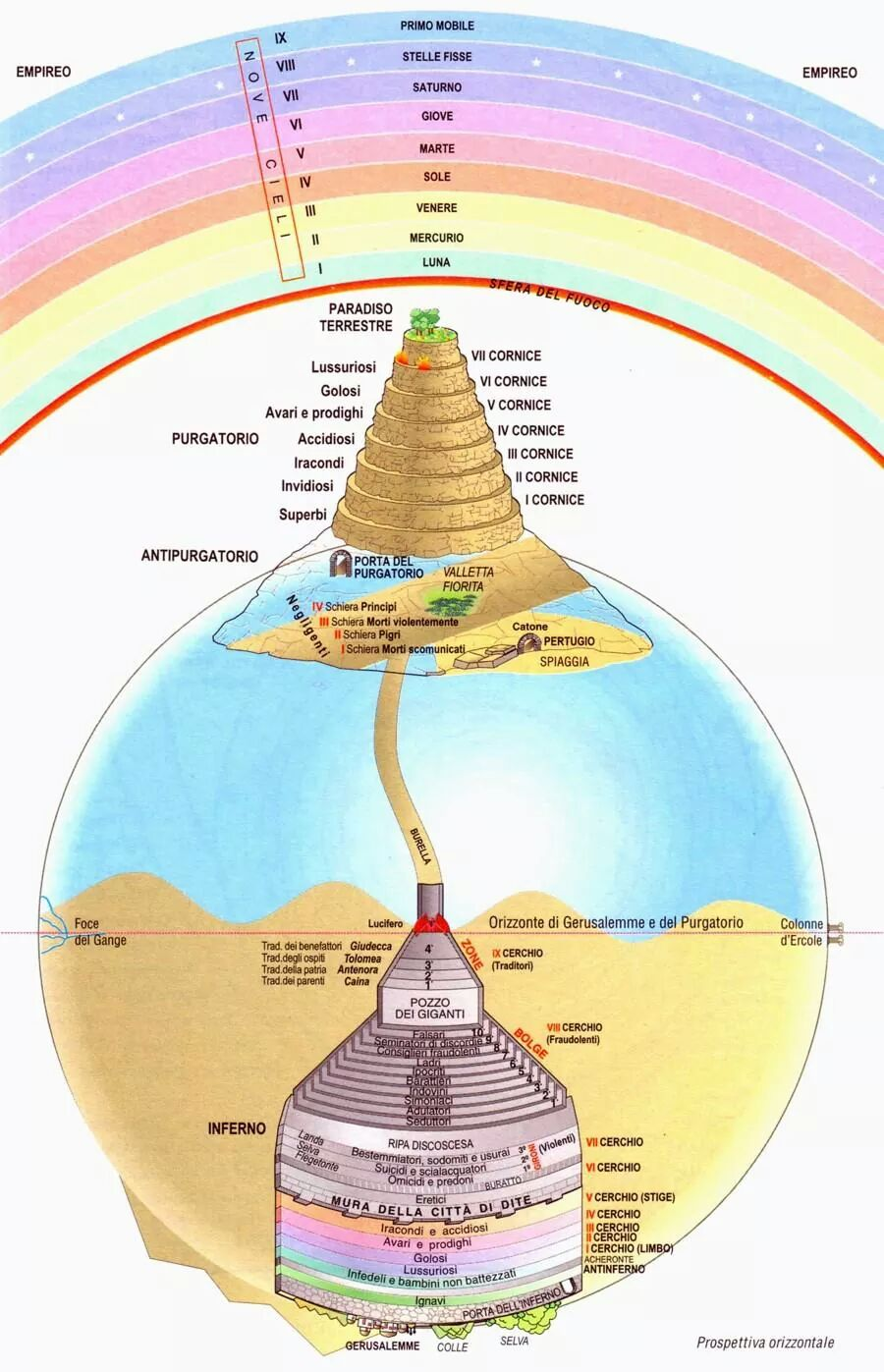
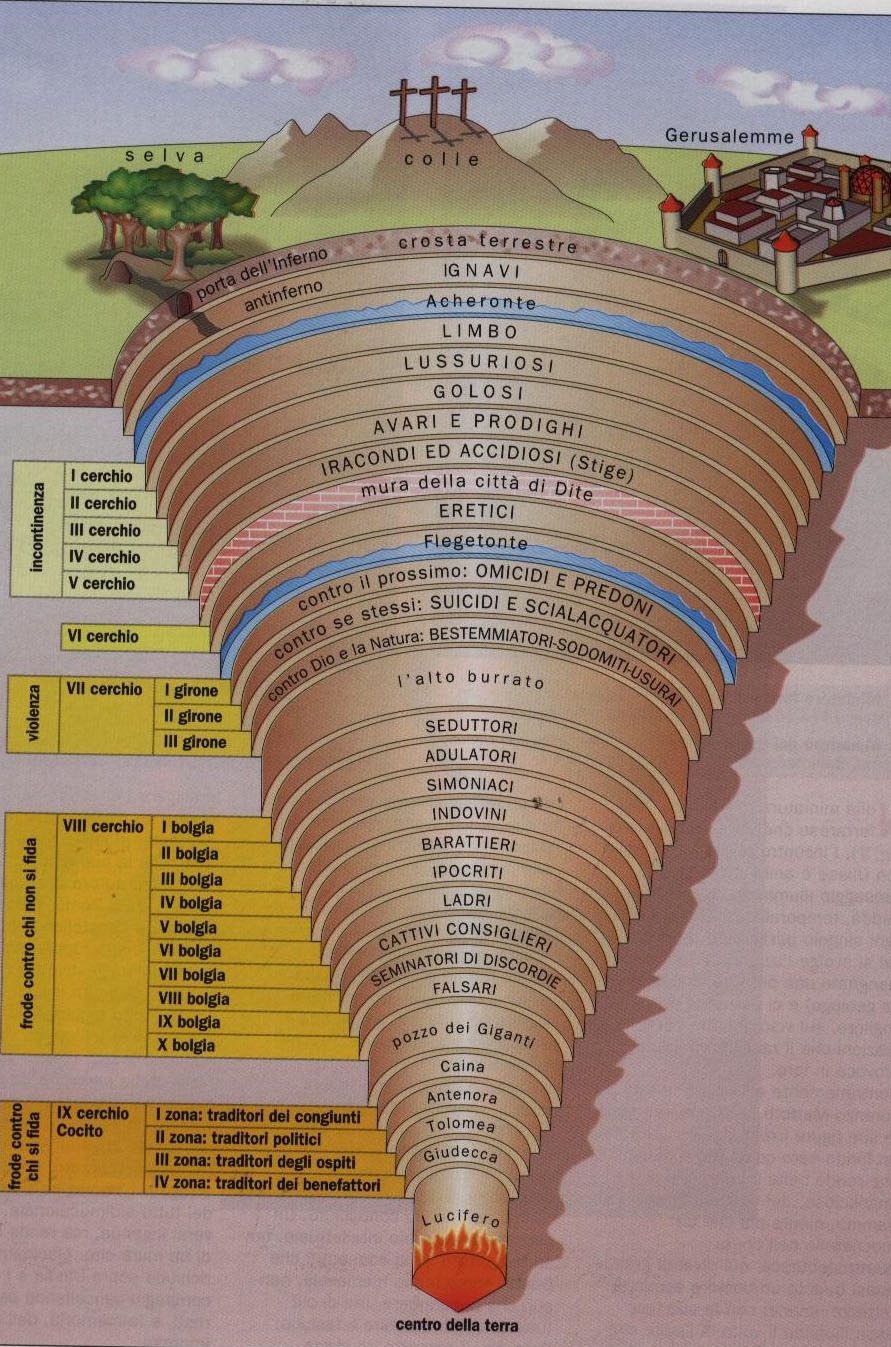
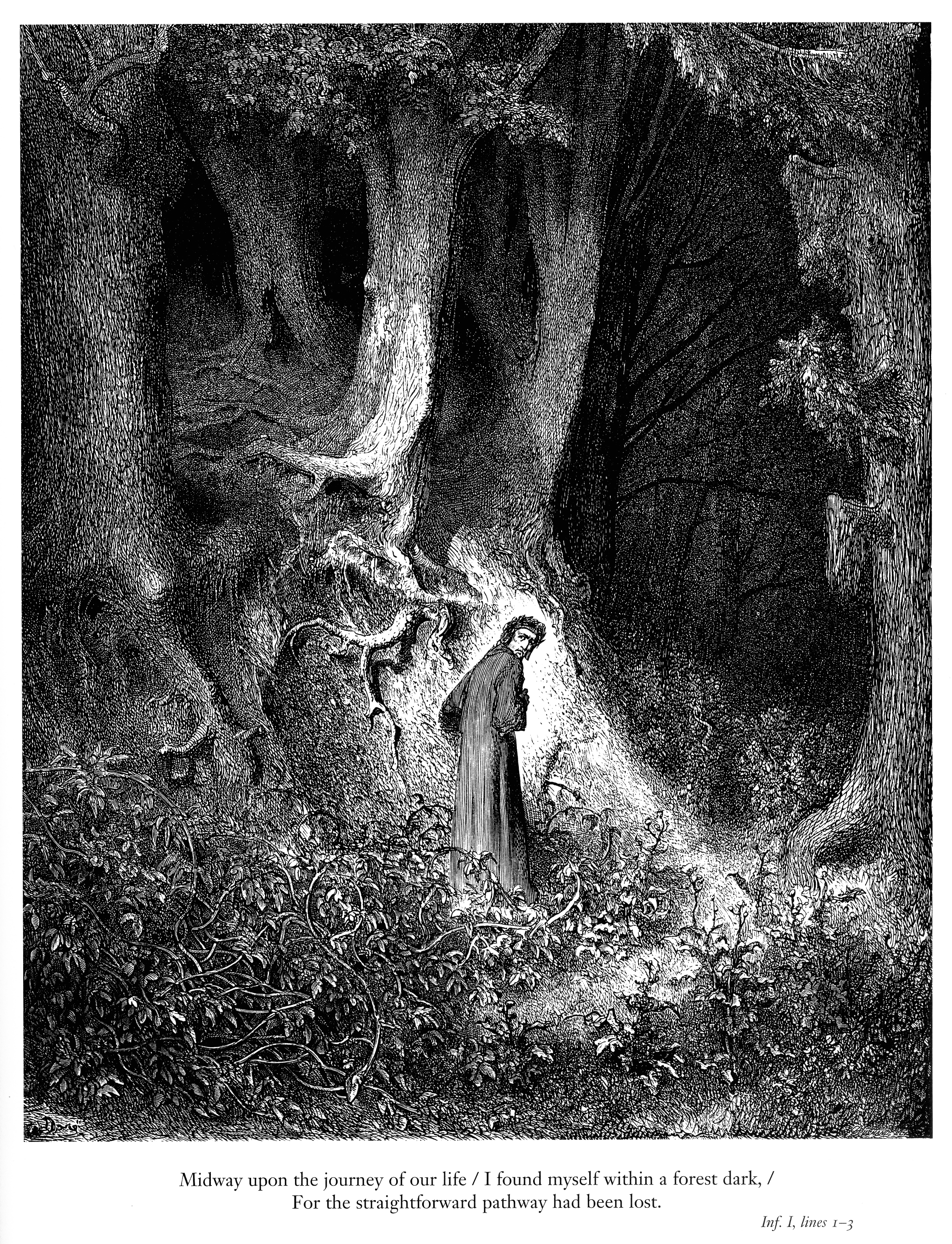

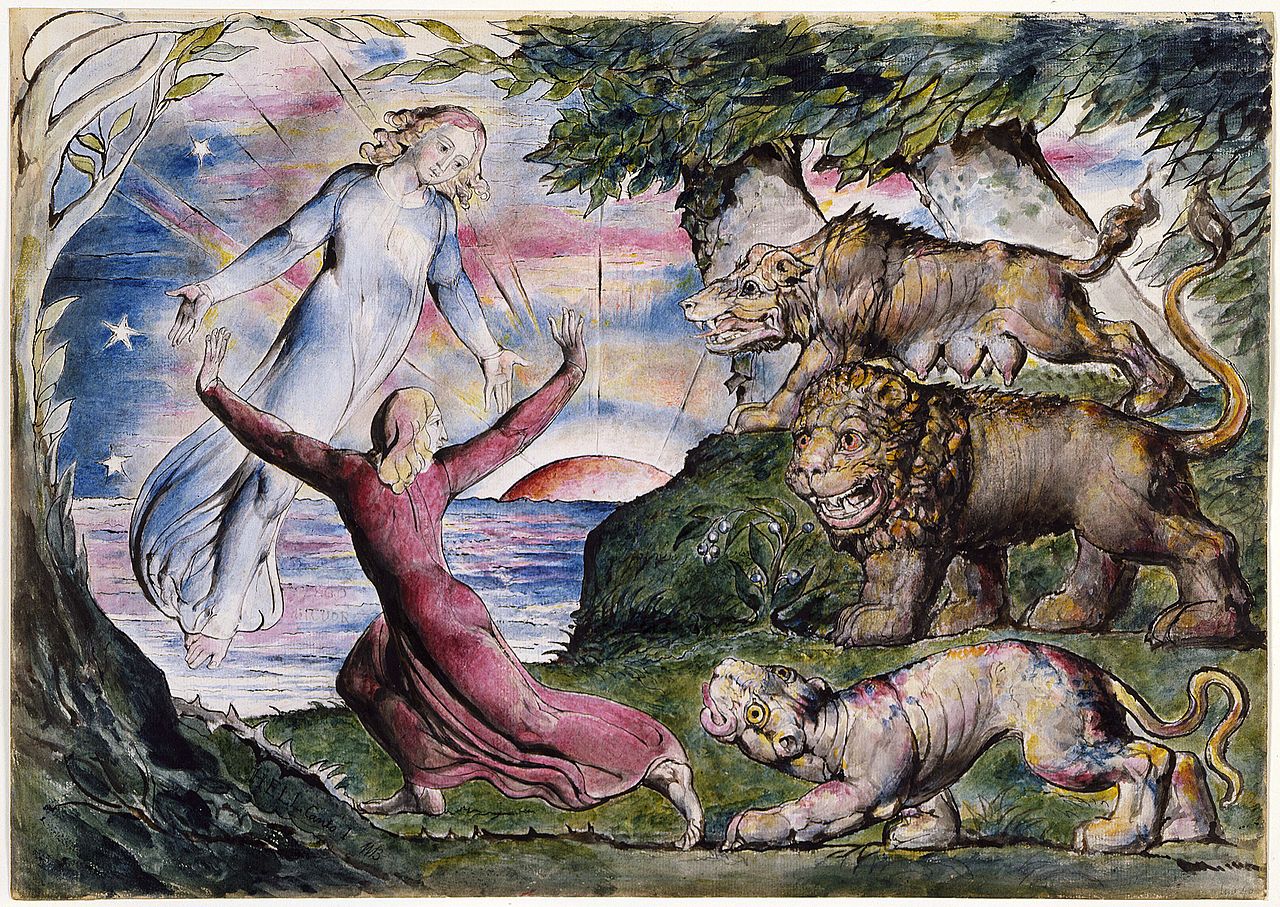


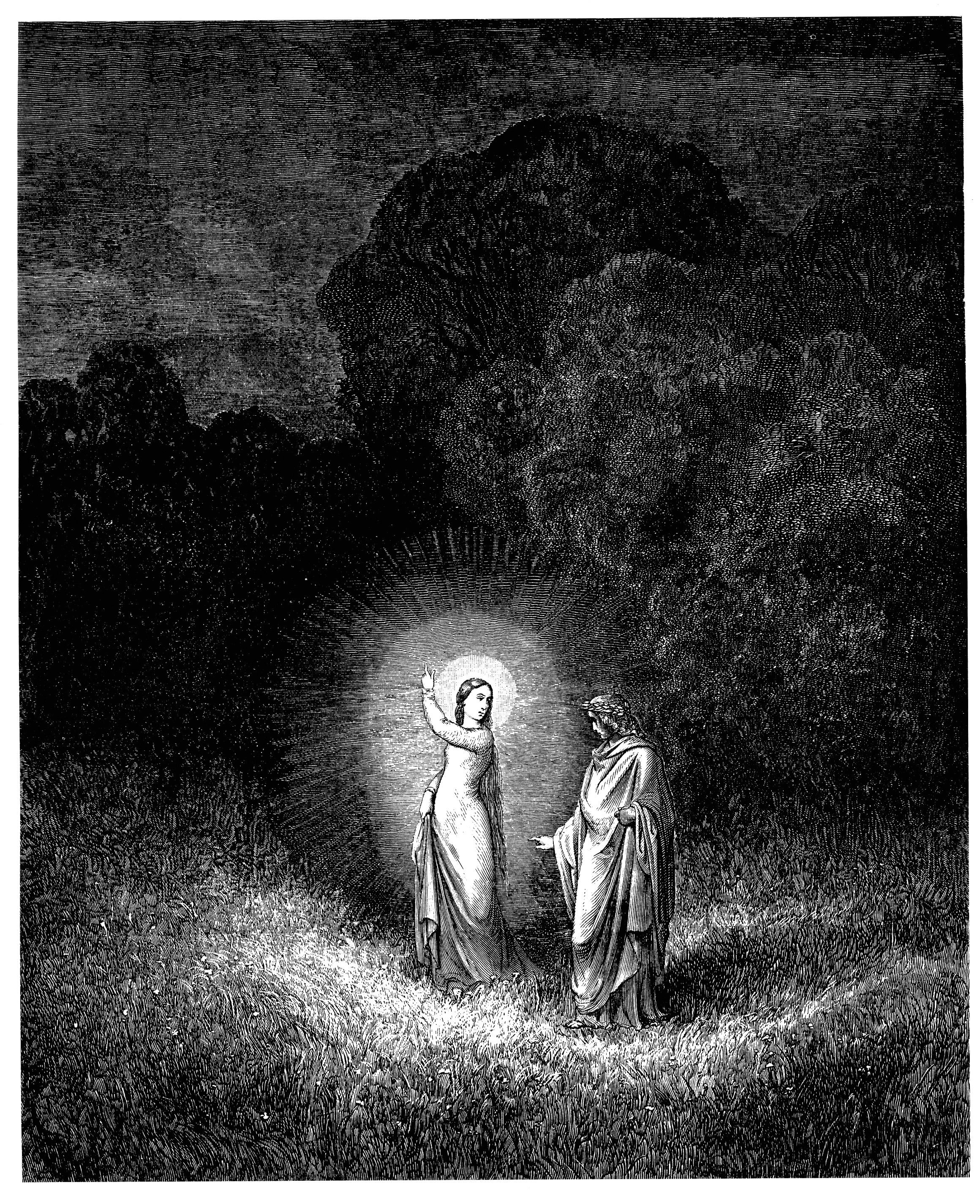



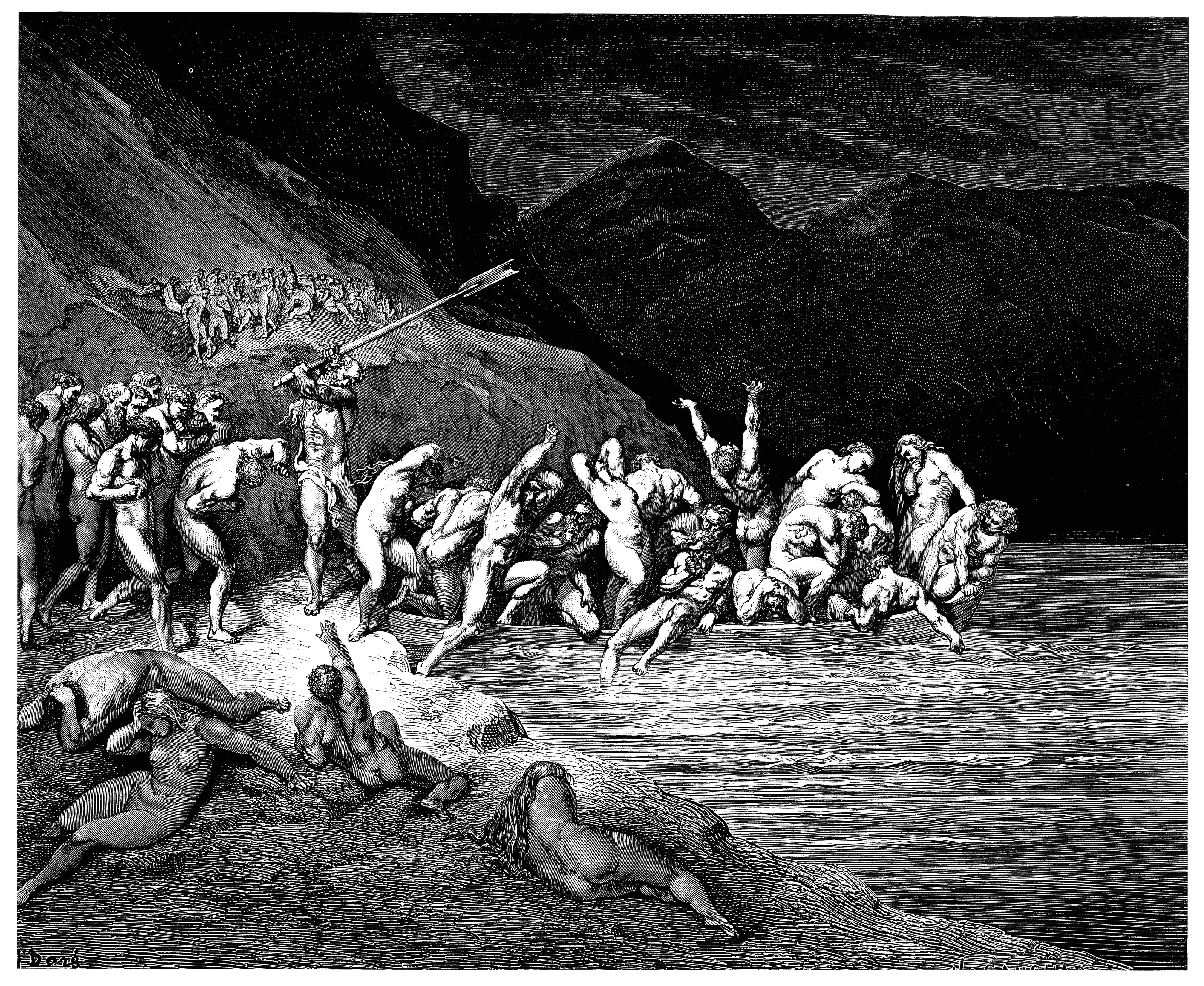








 Anselm Feuerbach: Paolo e Francesca (1864)
Anselm Feuerbach: Paolo e Francesca (1864)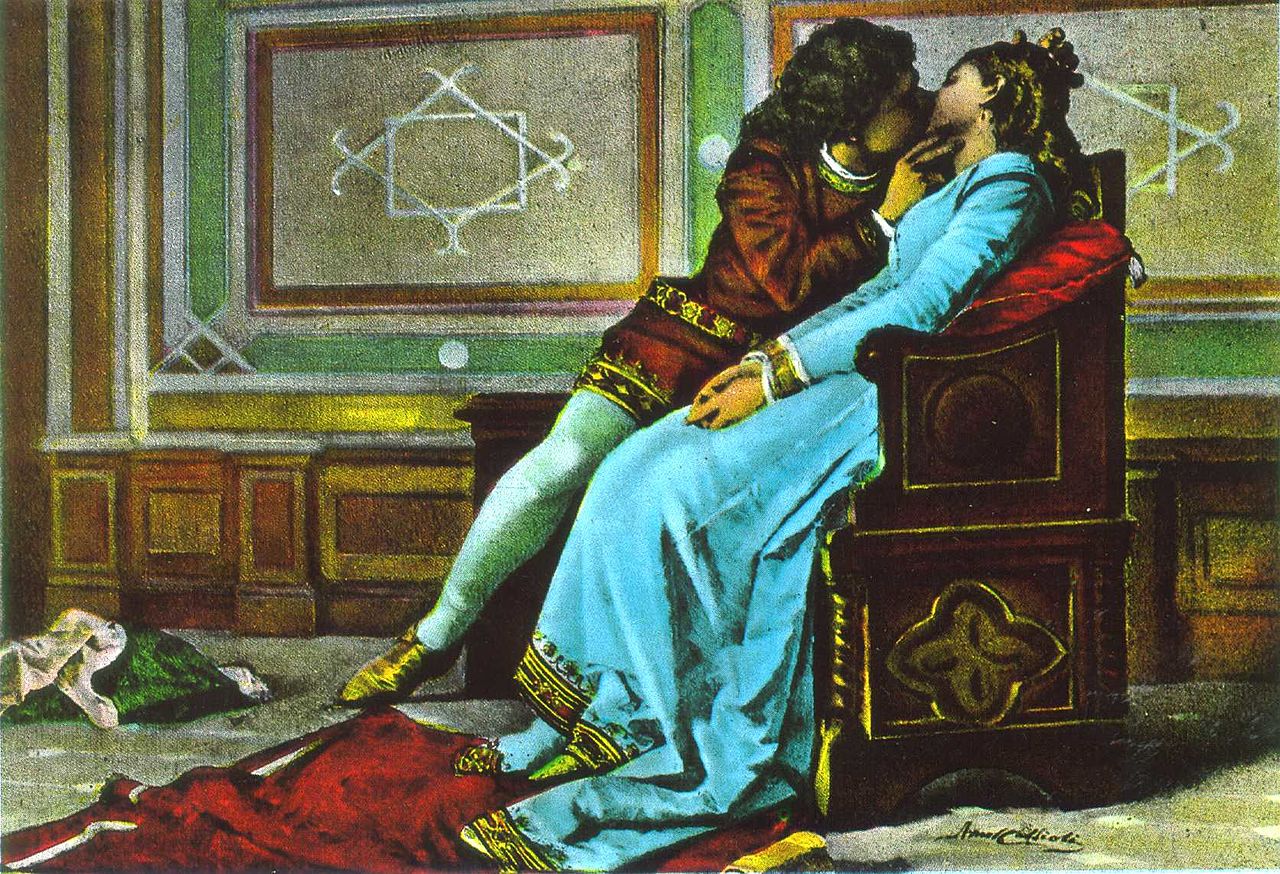

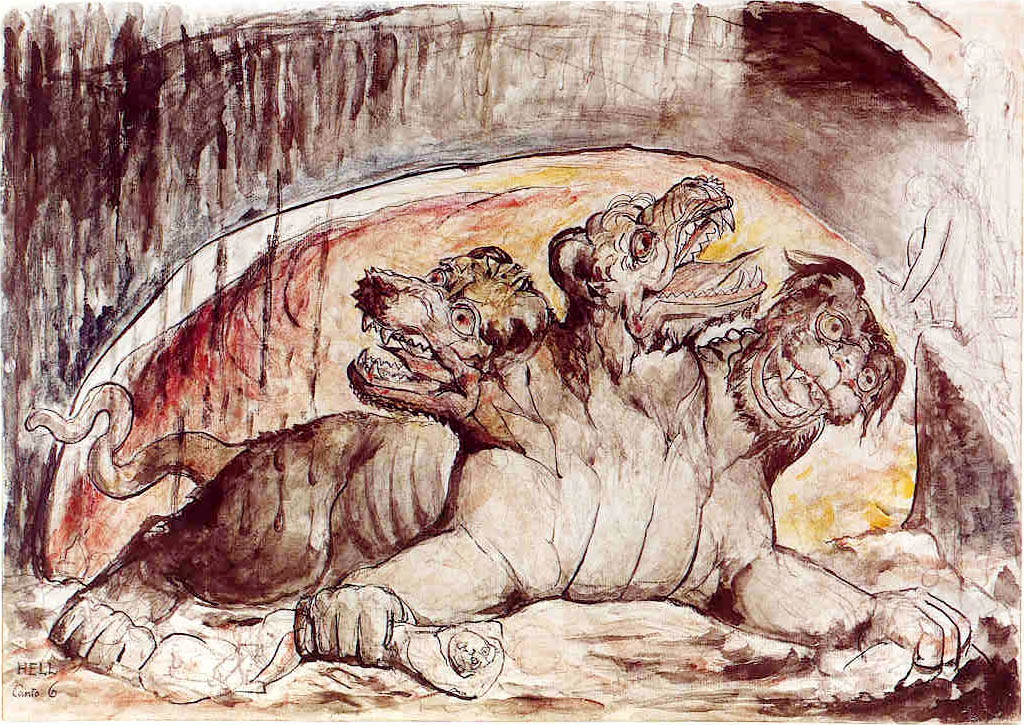

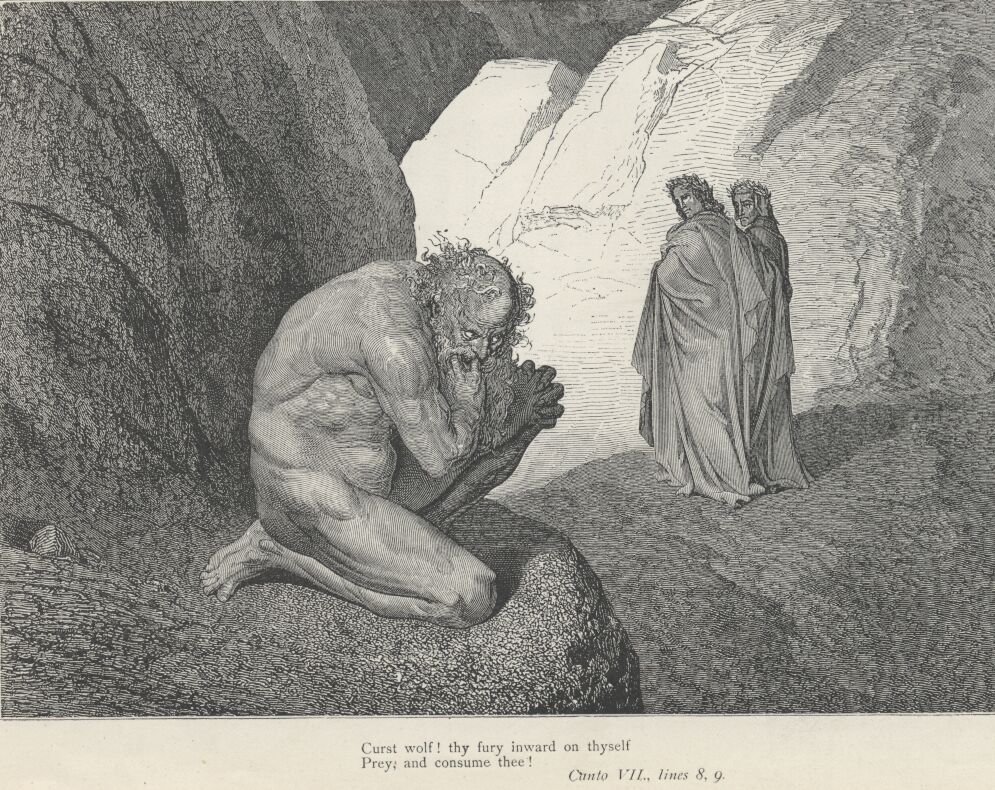




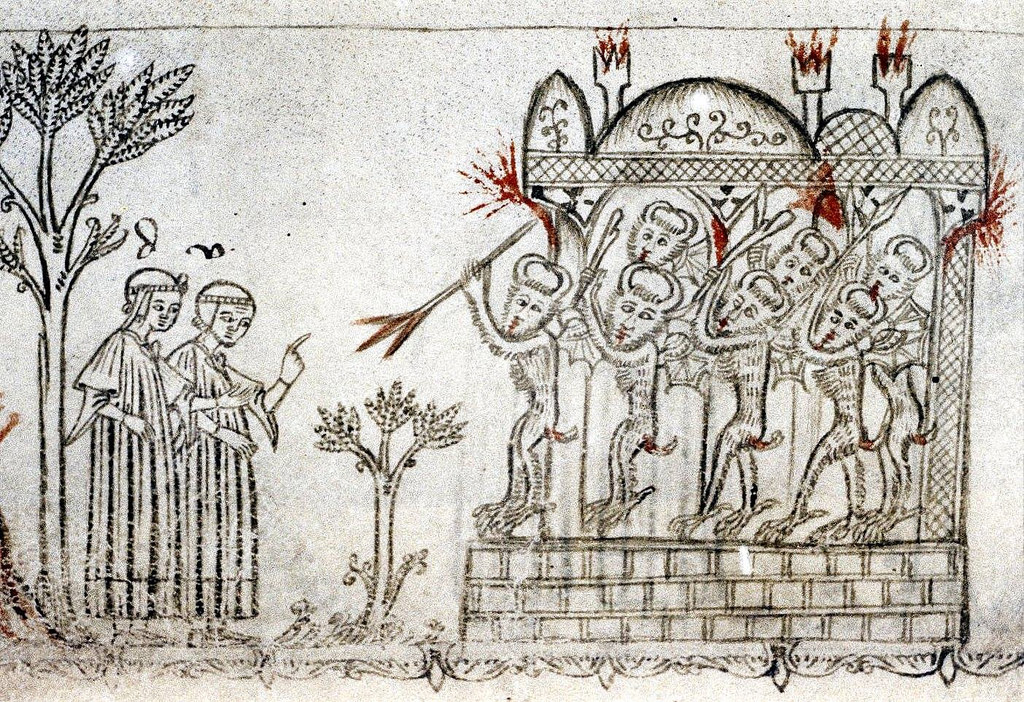 Dante e Virgilio e i diavoli (Miniatura, Biblioteca di Firenze)
Dante e Virgilio e i diavoli (Miniatura, Biblioteca di Firenze) Bartolomeo Pinelli: Dante e Virgilio di fronte alle Erinni
Bartolomeo Pinelli: Dante e Virgilio di fronte alle Erinni Caravaggio: Medusa (1597)
Caravaggio: Medusa (1597)



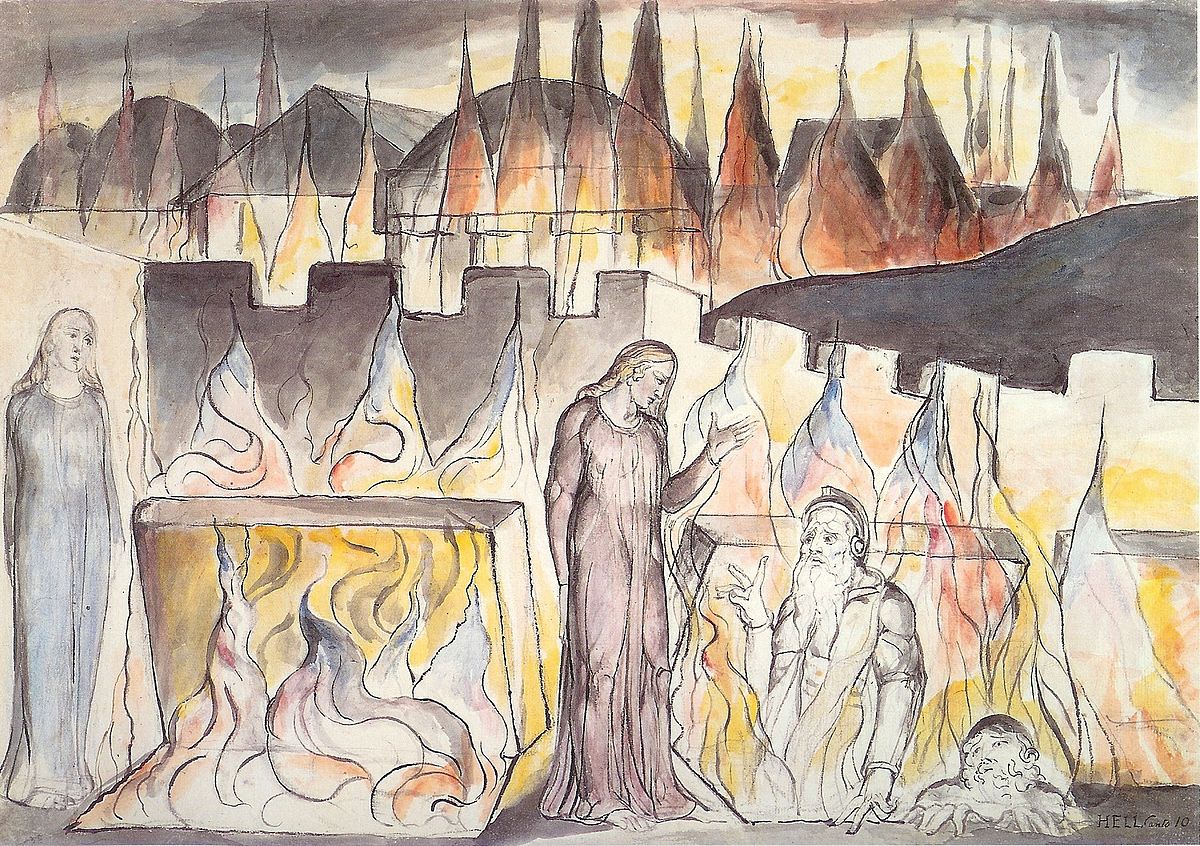

 Priamo Della Quercia (XV secolo)
Priamo Della Quercia (XV secolo)
 Priamo Della Quercia (XV secolo)
Priamo Della Quercia (XV secolo)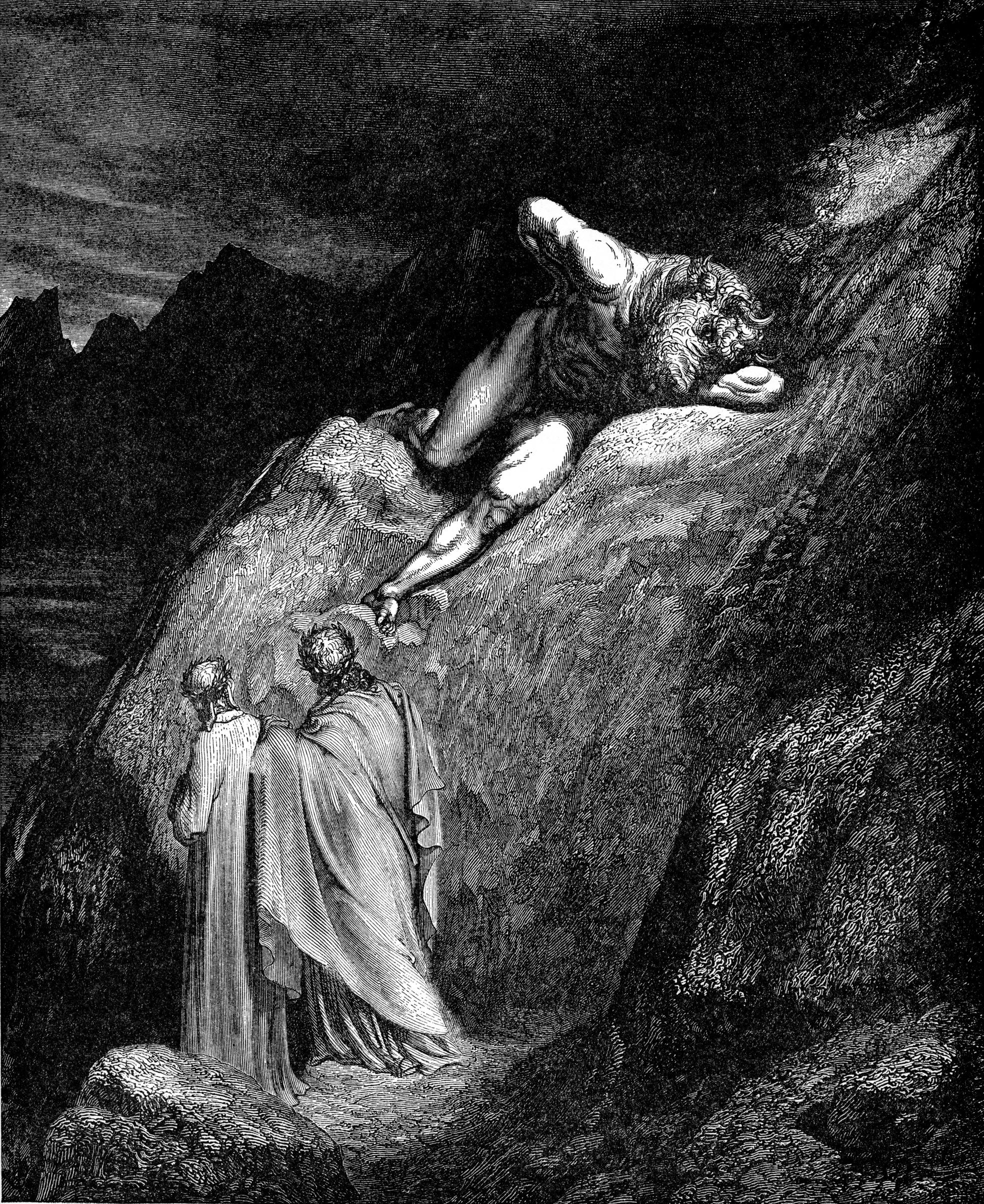


 Bartolomeo Pinelli: Dante e Virgilio in groppa a Nesso
Bartolomeo Pinelli: Dante e Virgilio in groppa a Nesso






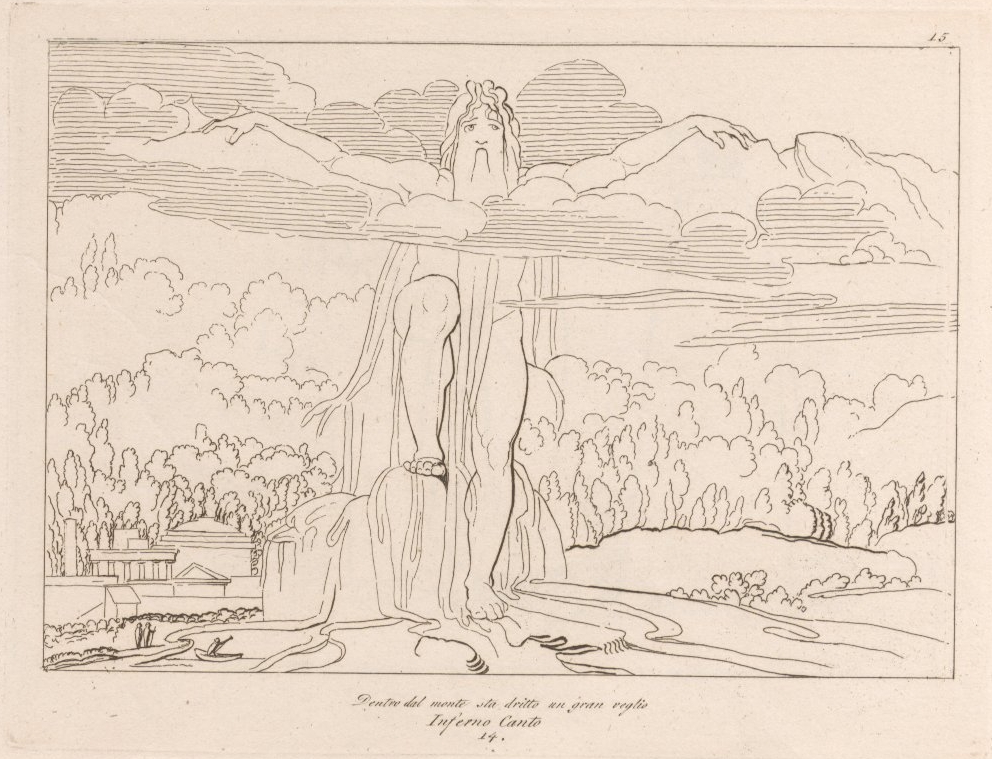




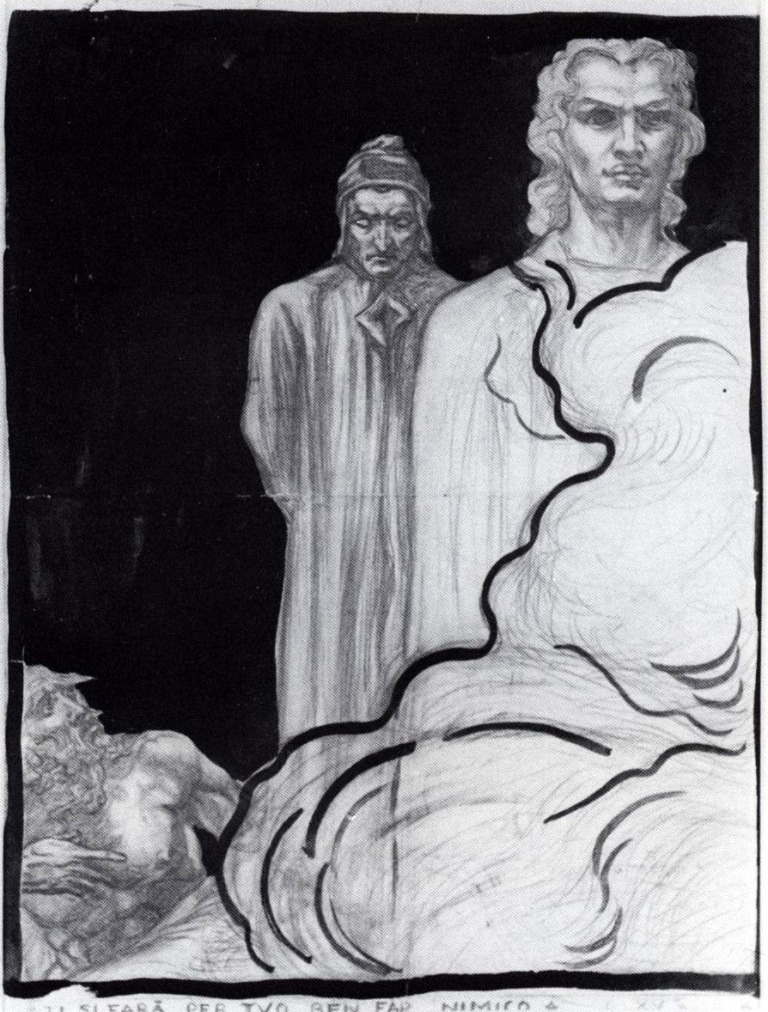

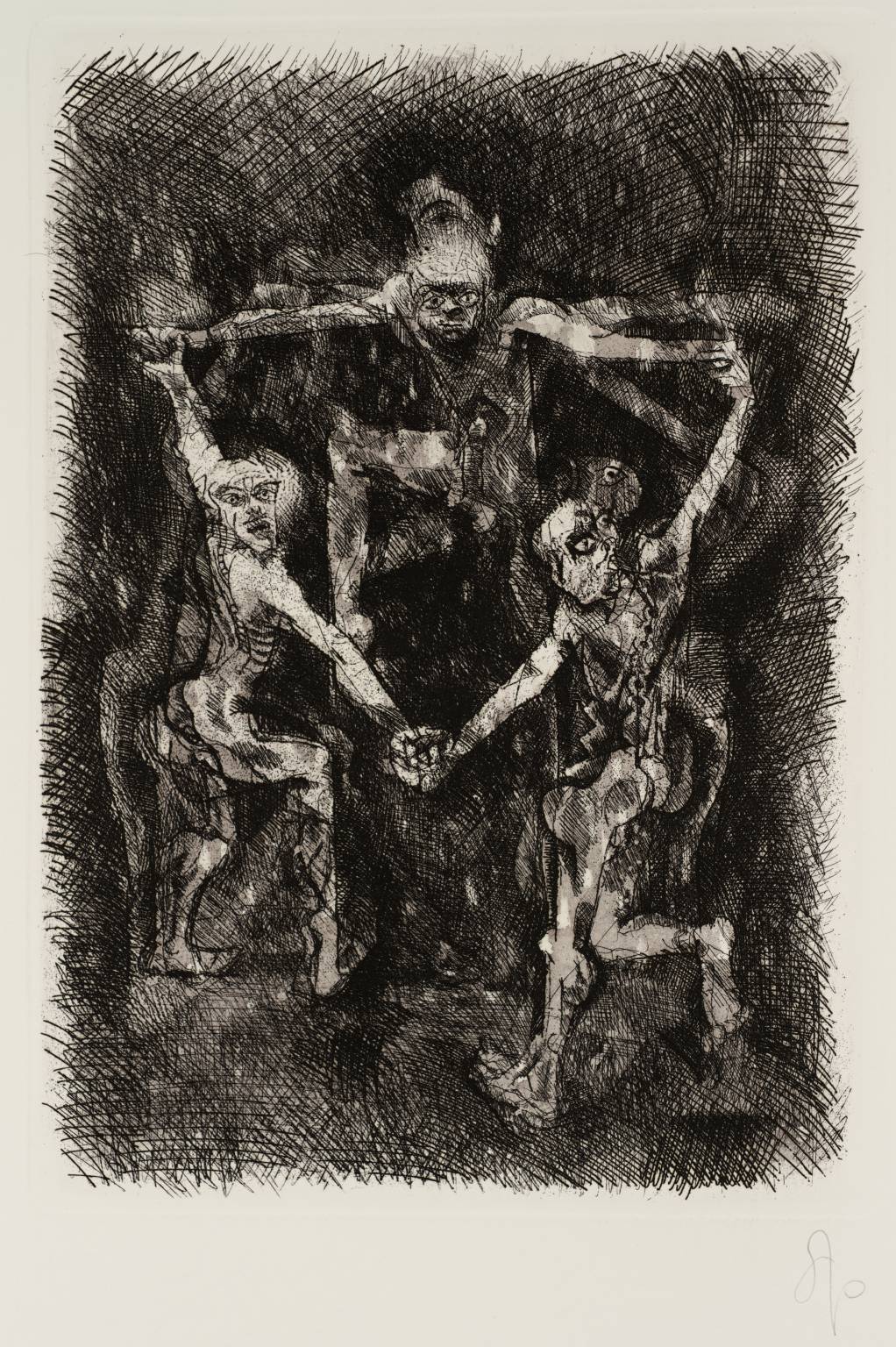
 Dante si sofferma ad osservare la cascata del Flegetonte
Dante si sofferma ad osservare la cascata del Flegetonte


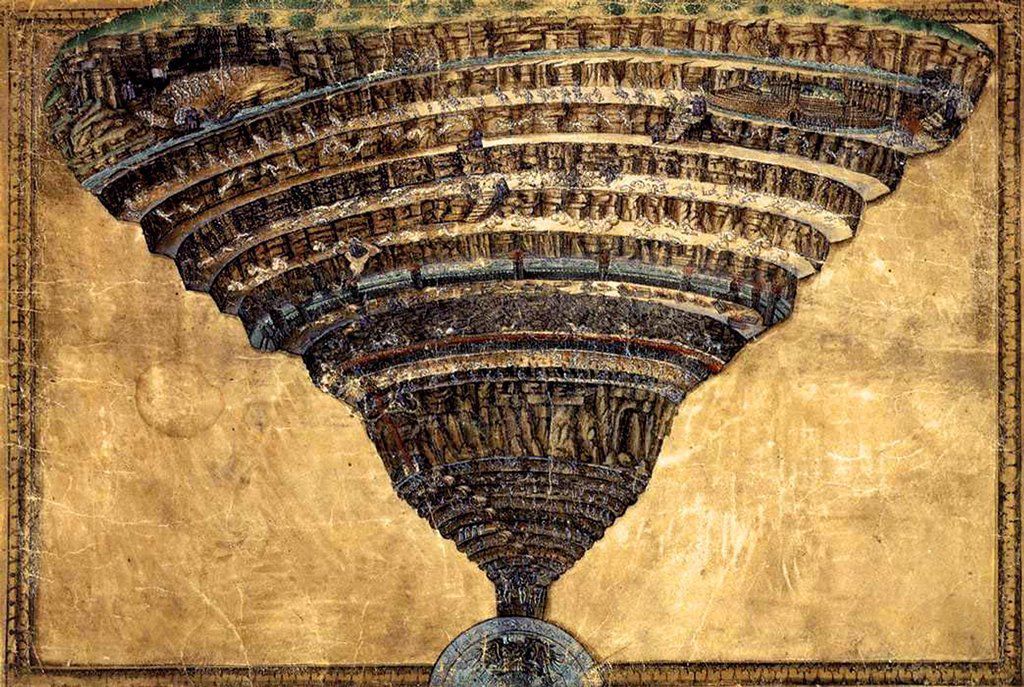




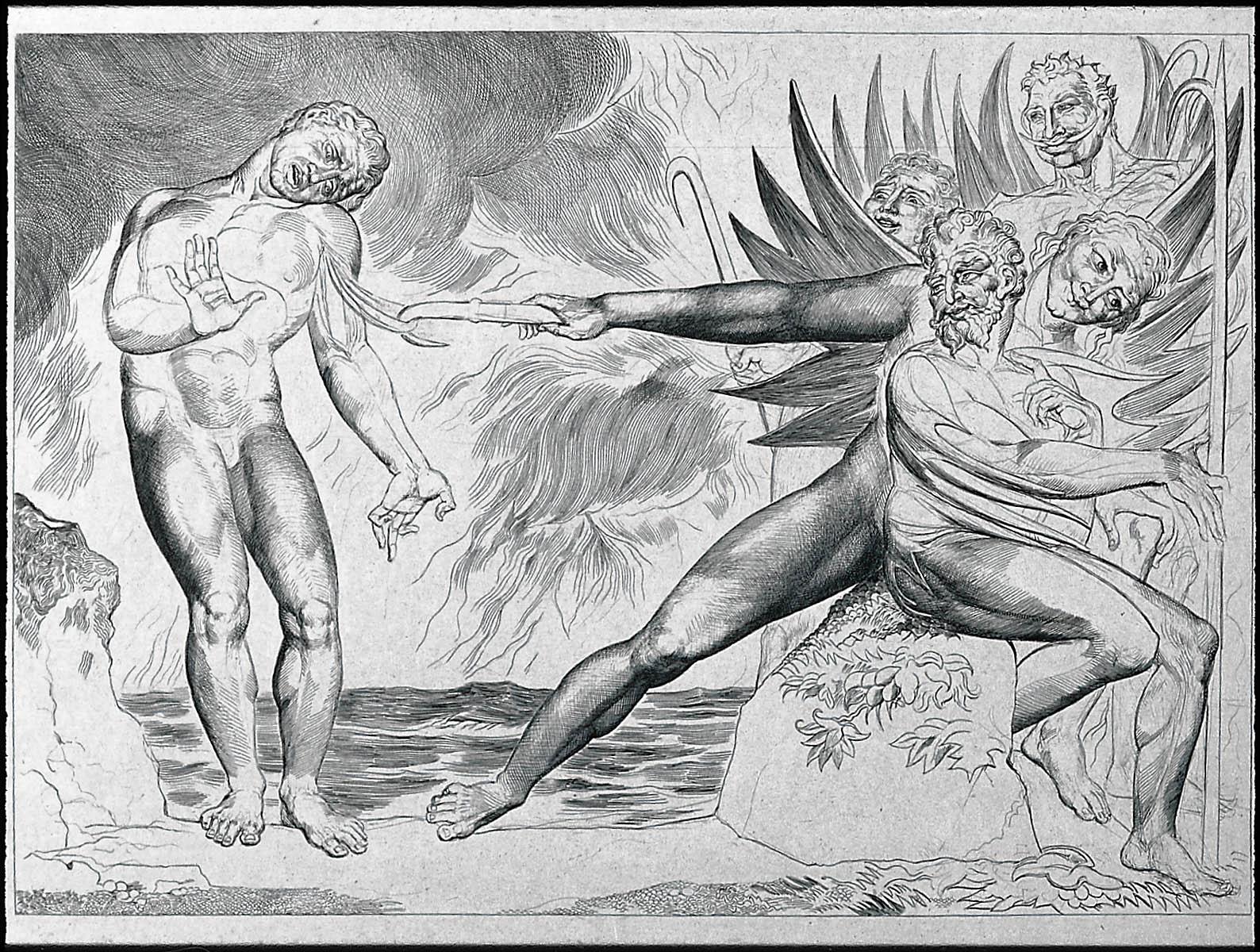






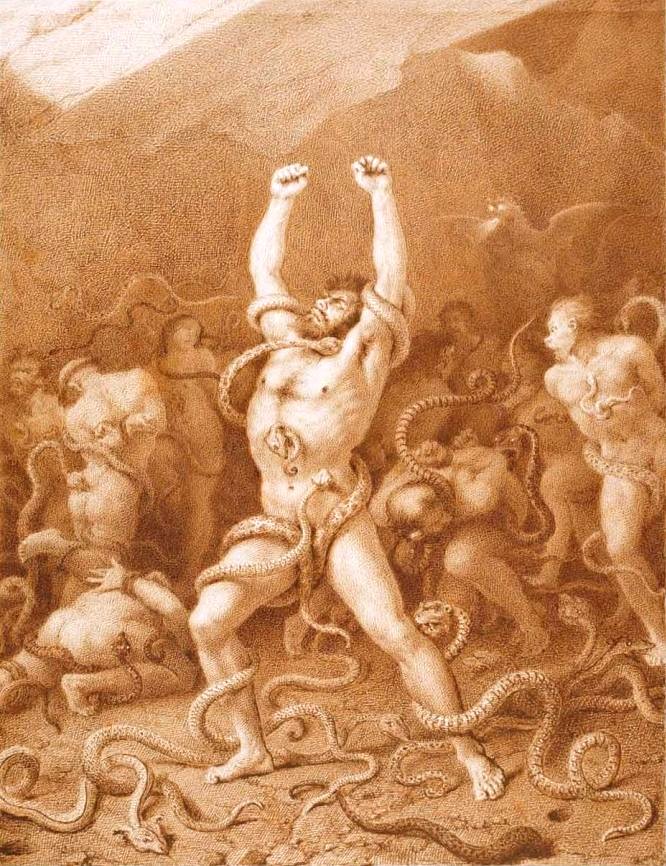

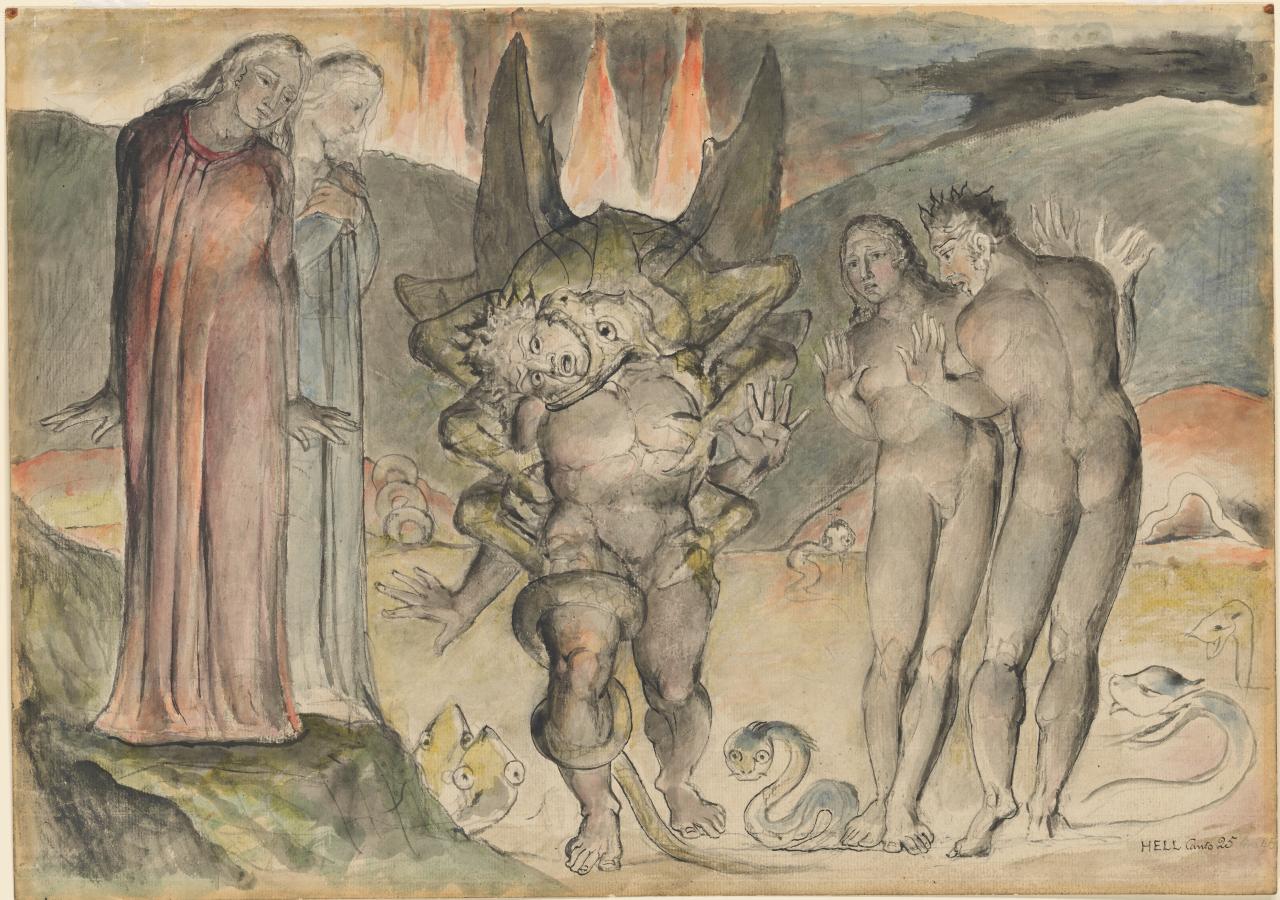





 Suloni Robertson: Guido di Montefeltro
Suloni Robertson: Guido di Montefeltro

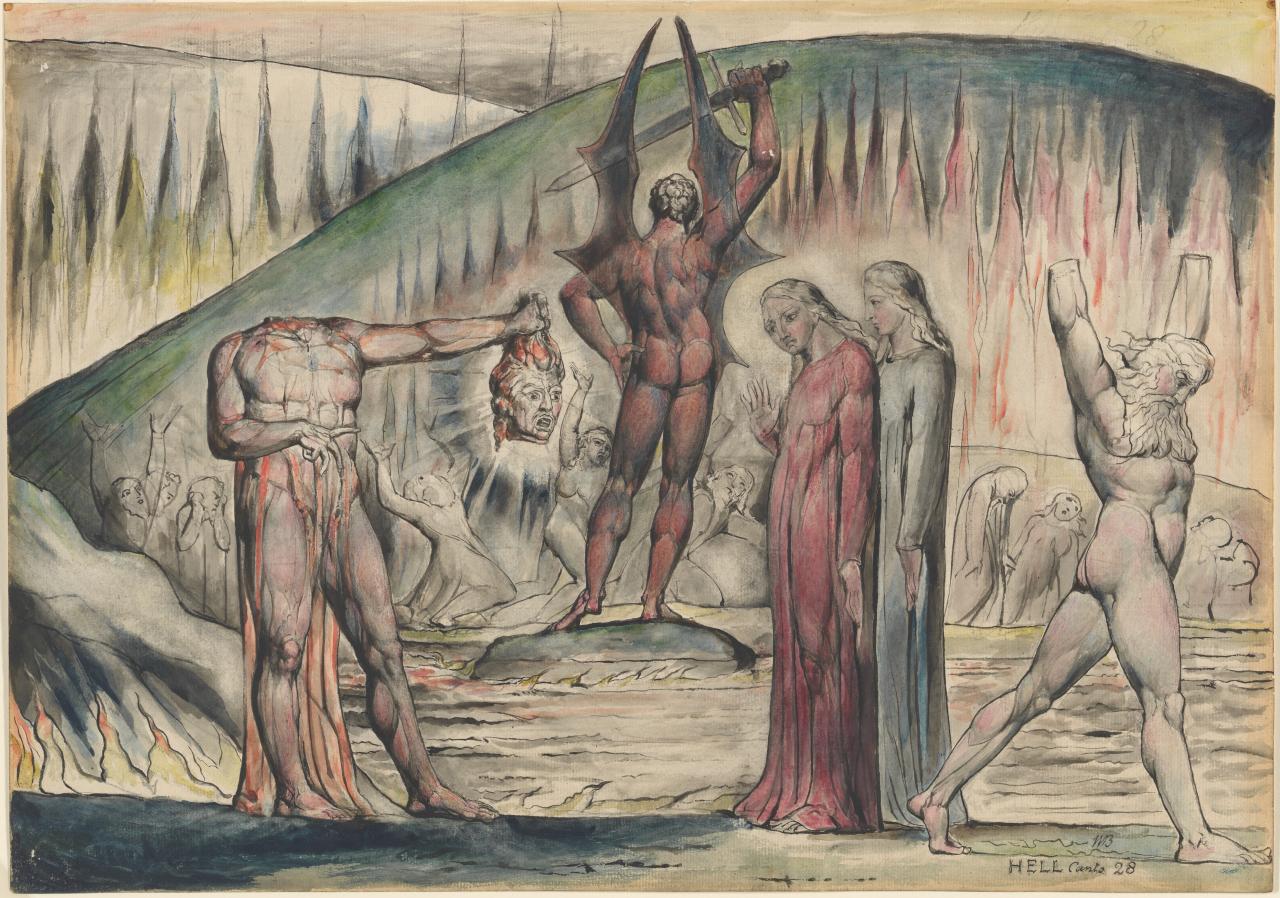
 Gustave Doré: Geri il Bello
Gustave Doré: Geri il Bello
 Priamo della Quercia: canto XXX
Priamo della Quercia: canto XXX Giovanni Stradano: I falsari (1857)
Giovanni Stradano: I falsari (1857)





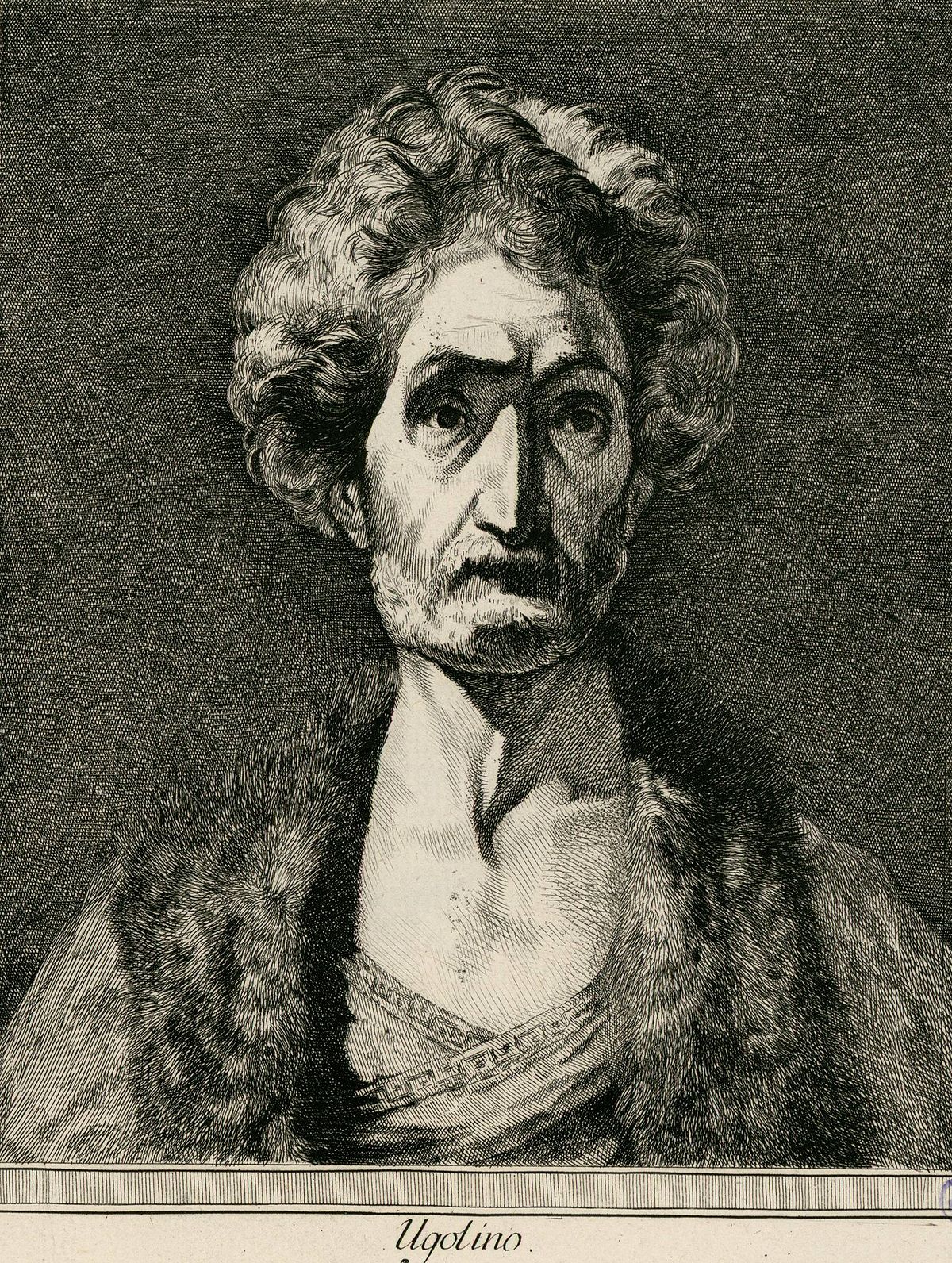

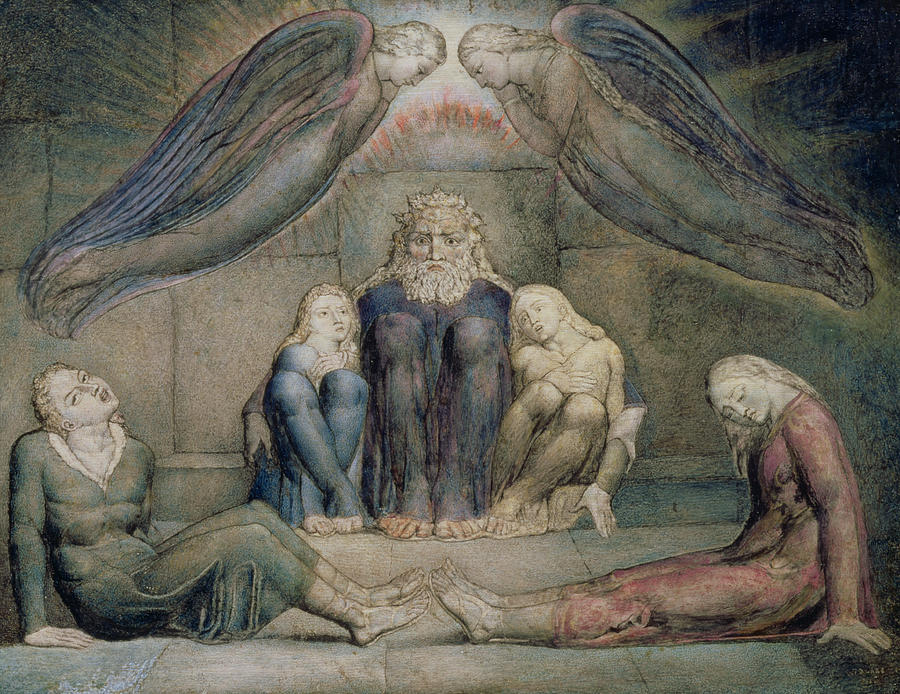

 Priamo della Quercia: canto XXXIV
Priamo della Quercia: canto XXXIV







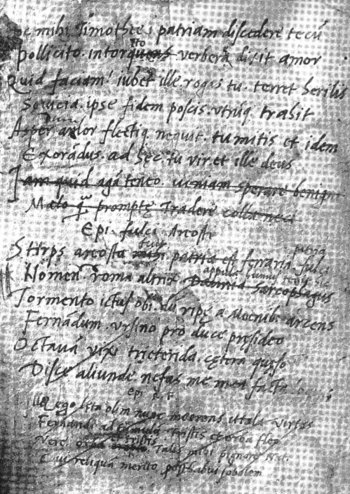

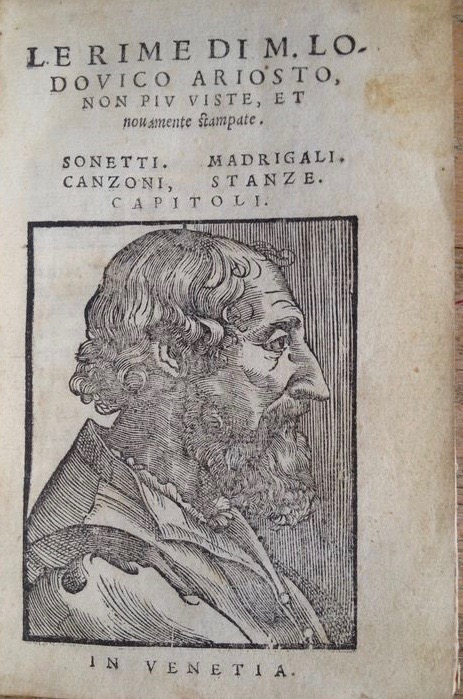


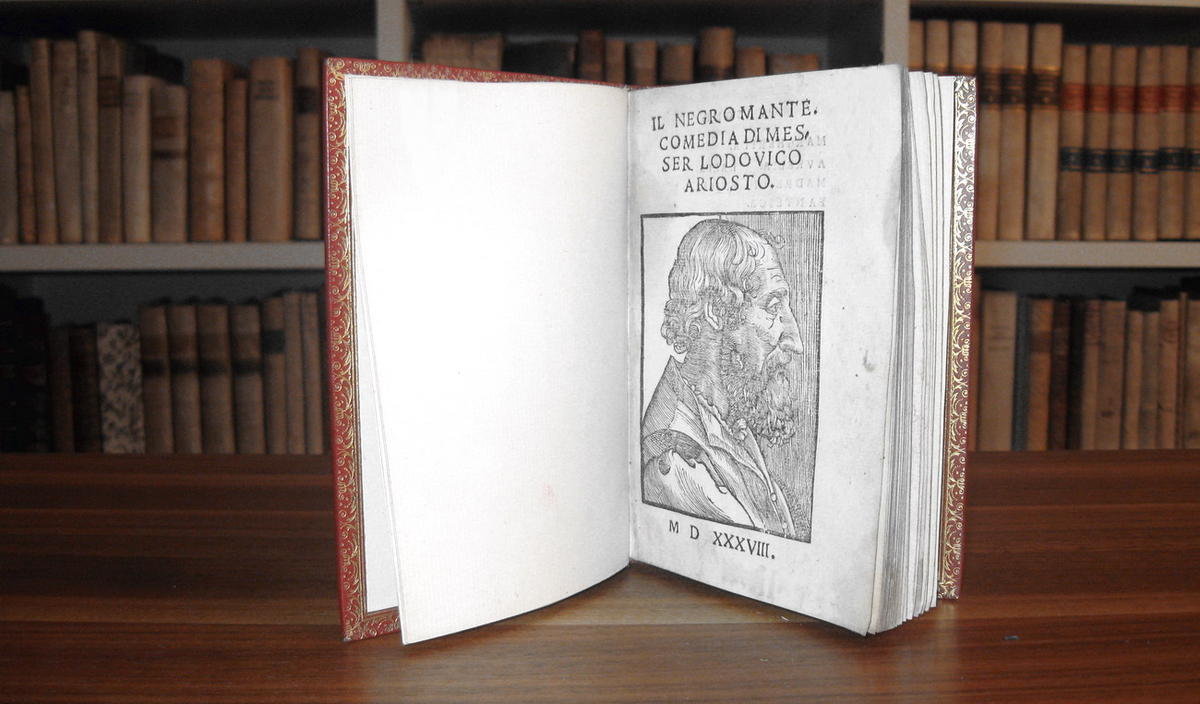
![Sette_libri_di_satire_di_[...]Arioste_L'_bpt6k314470k.JPEG](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2018/08/sette_libri_di_satire_di_-arioste_l_bpt6k314470k.jpeg) Edizione 1560
Edizione 1560









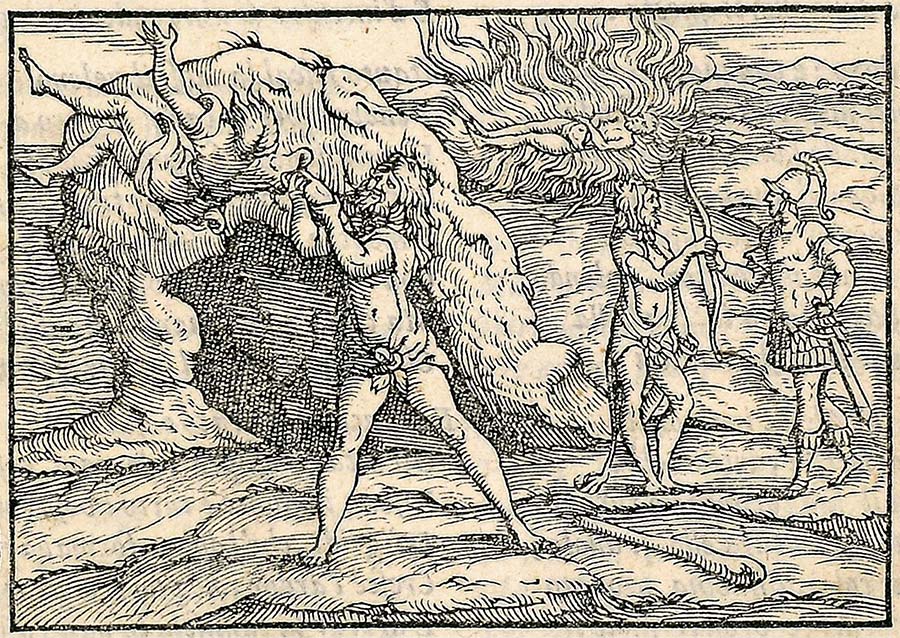








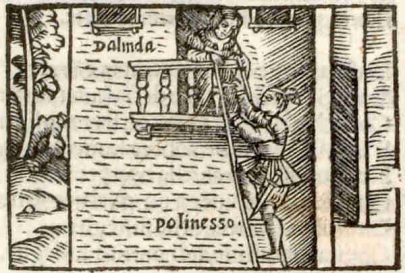










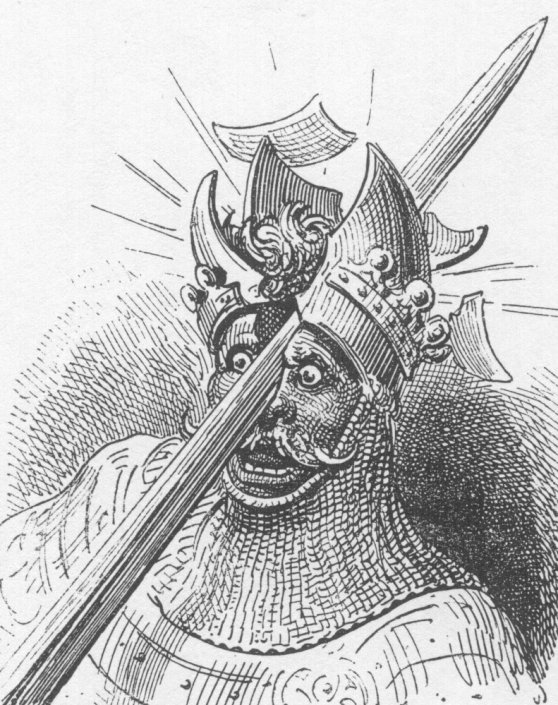





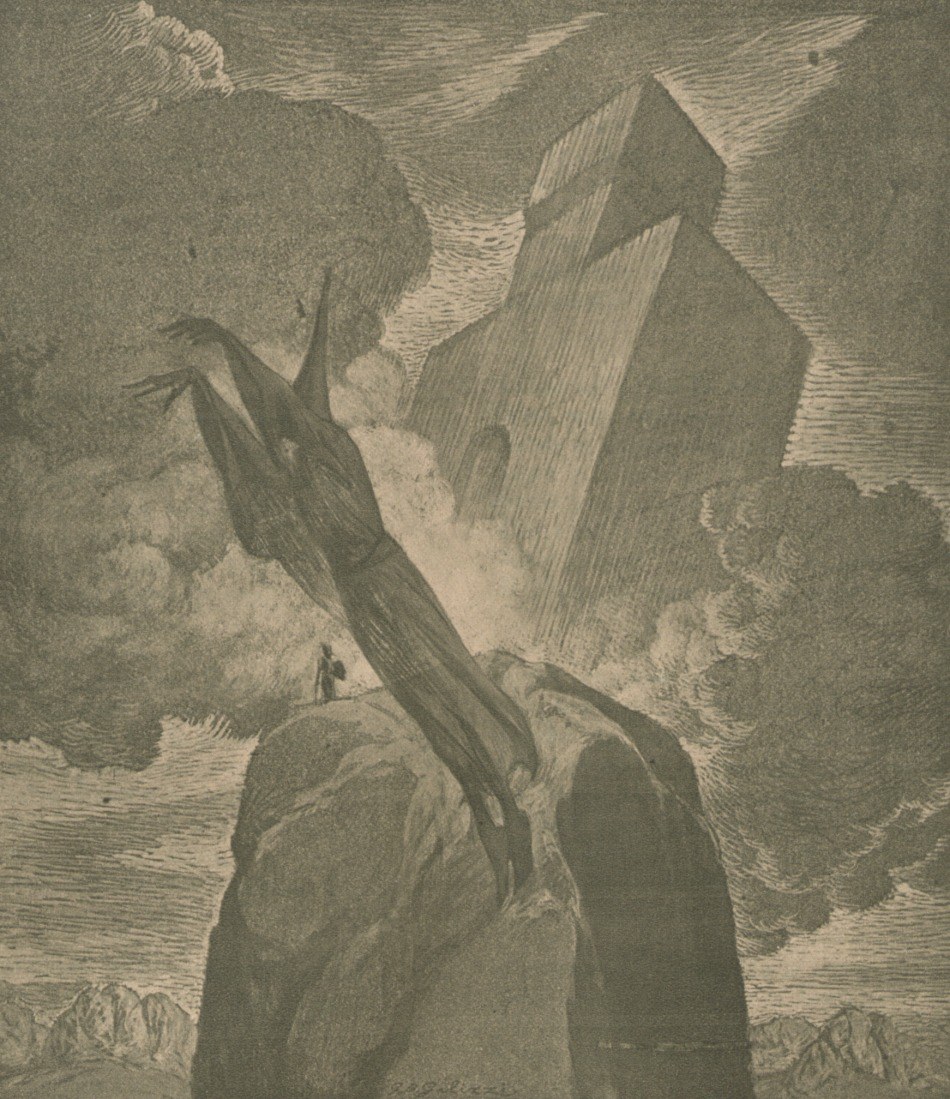
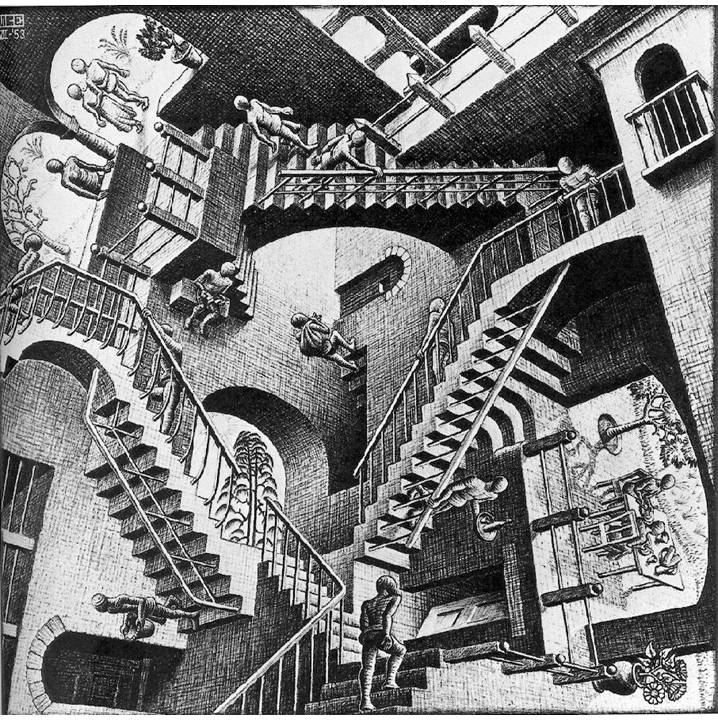









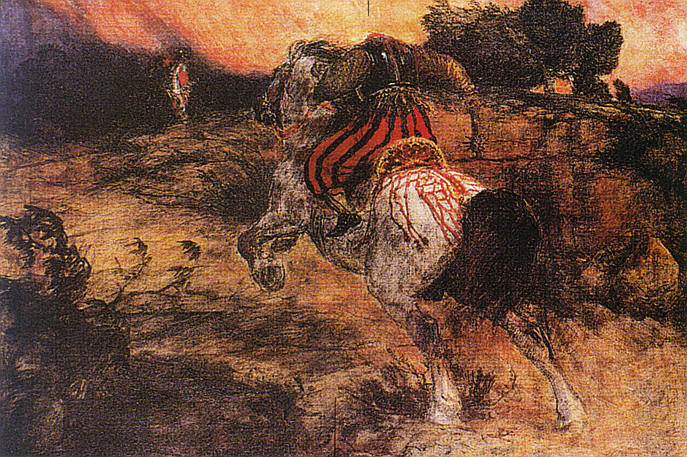










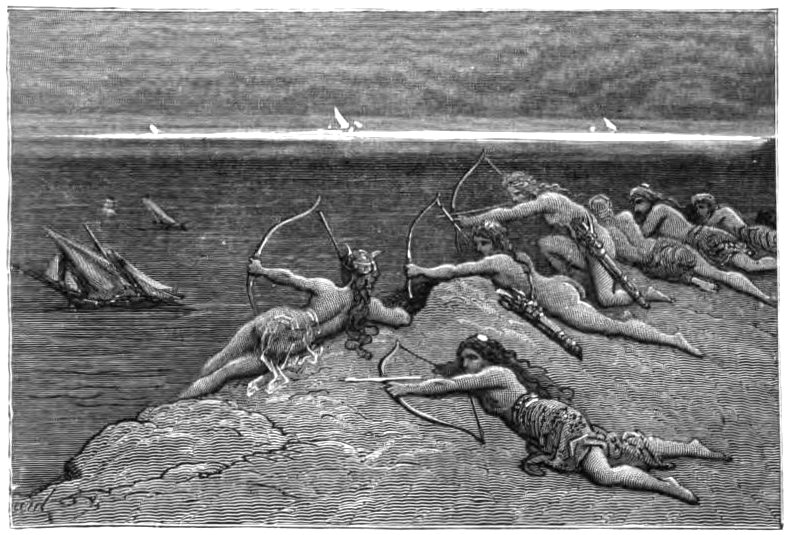
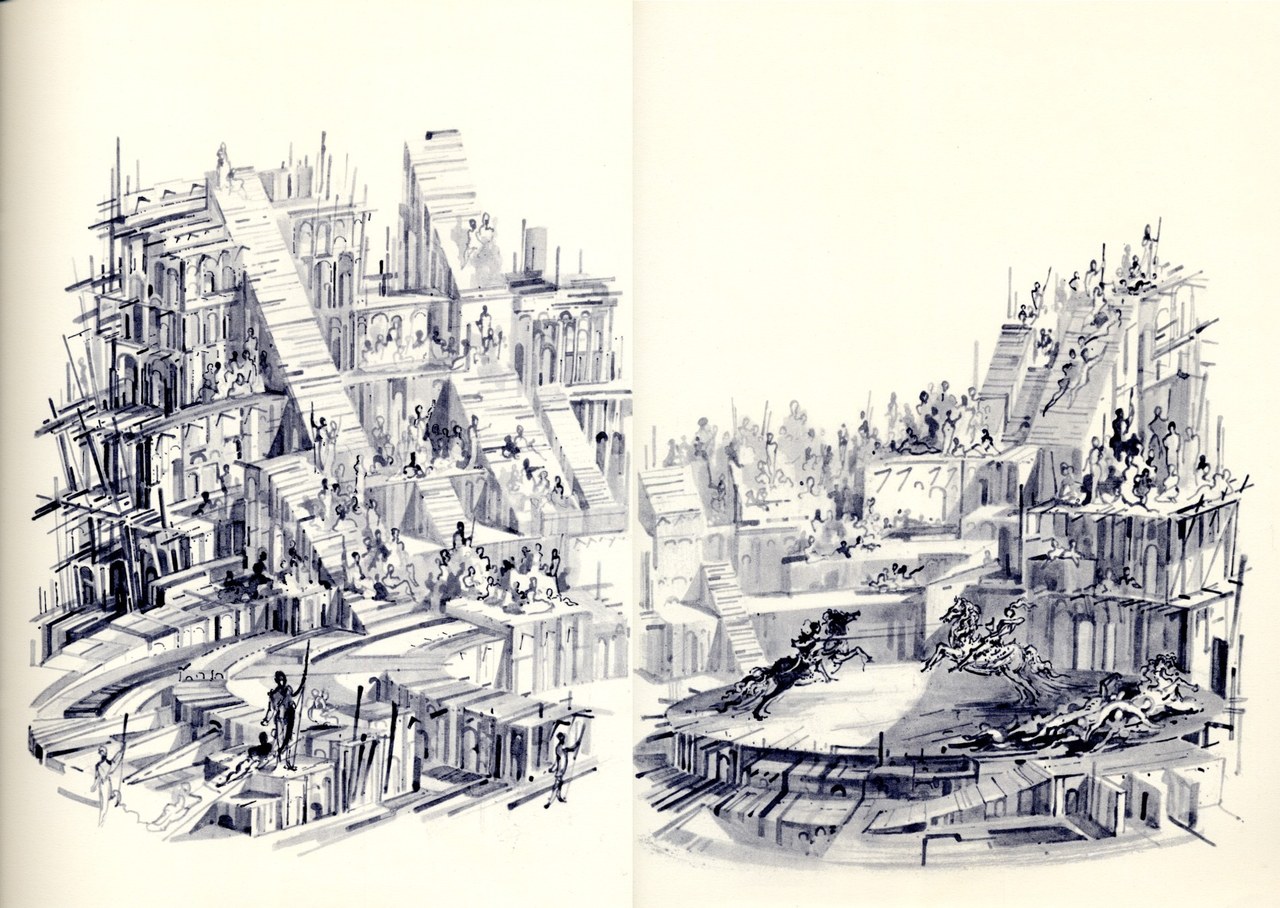

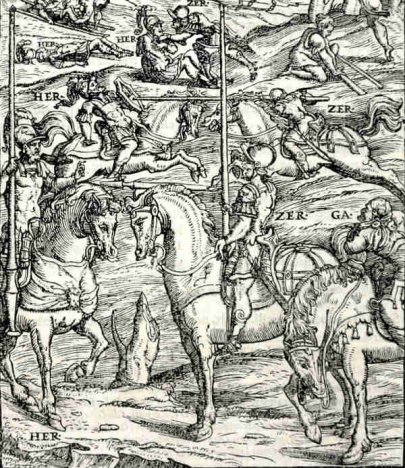



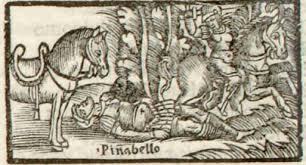



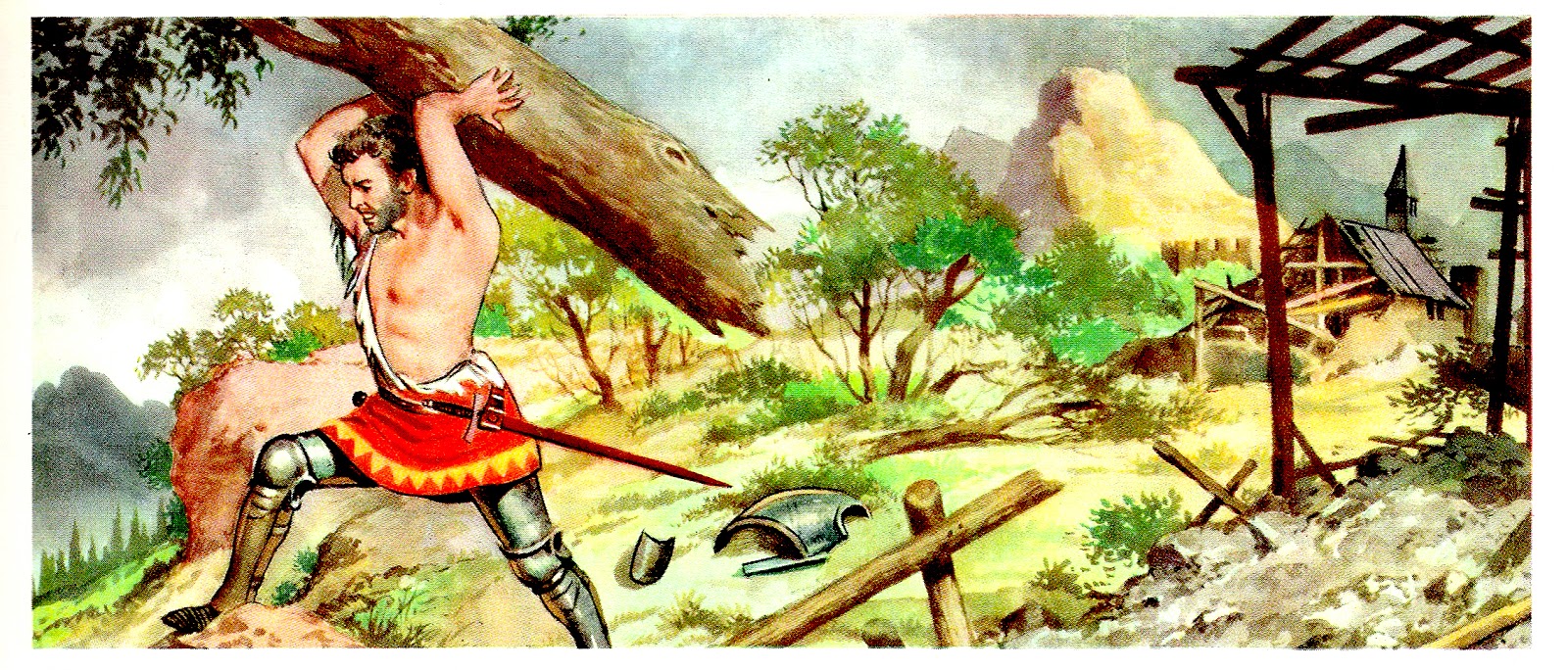
















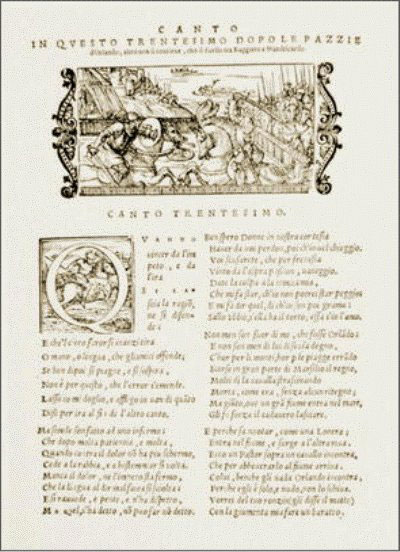

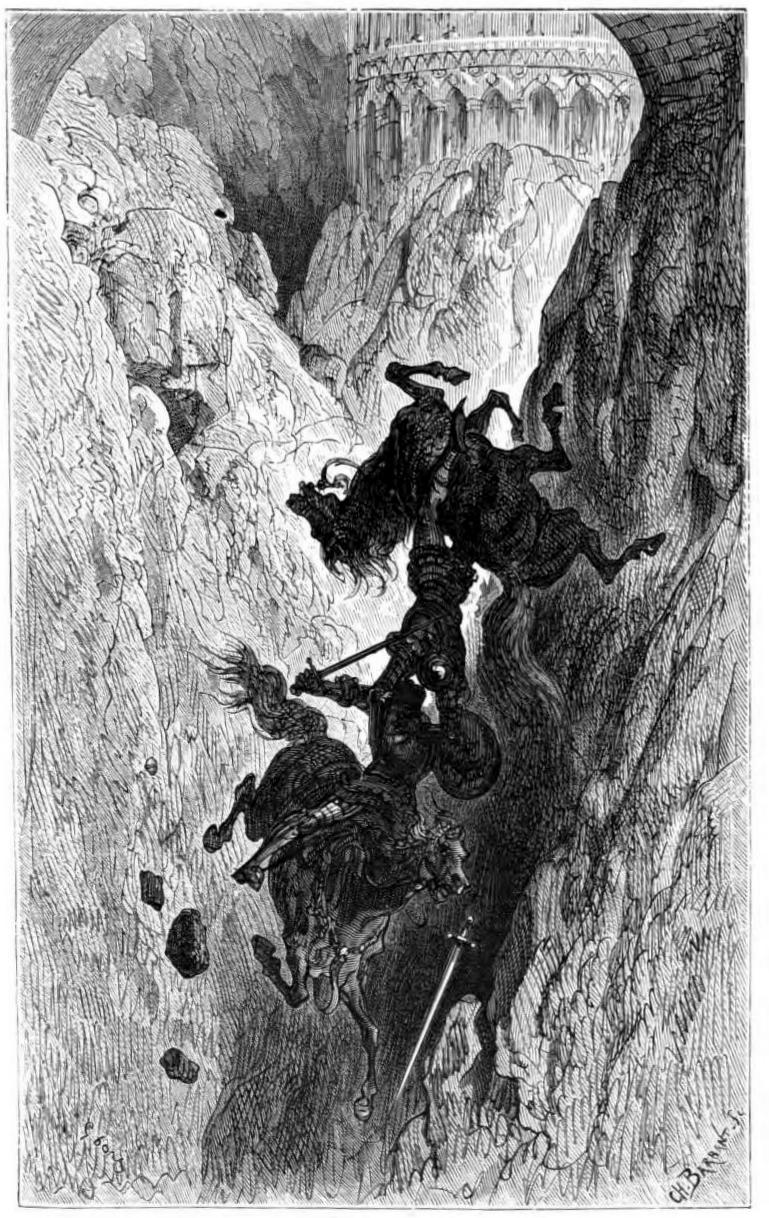






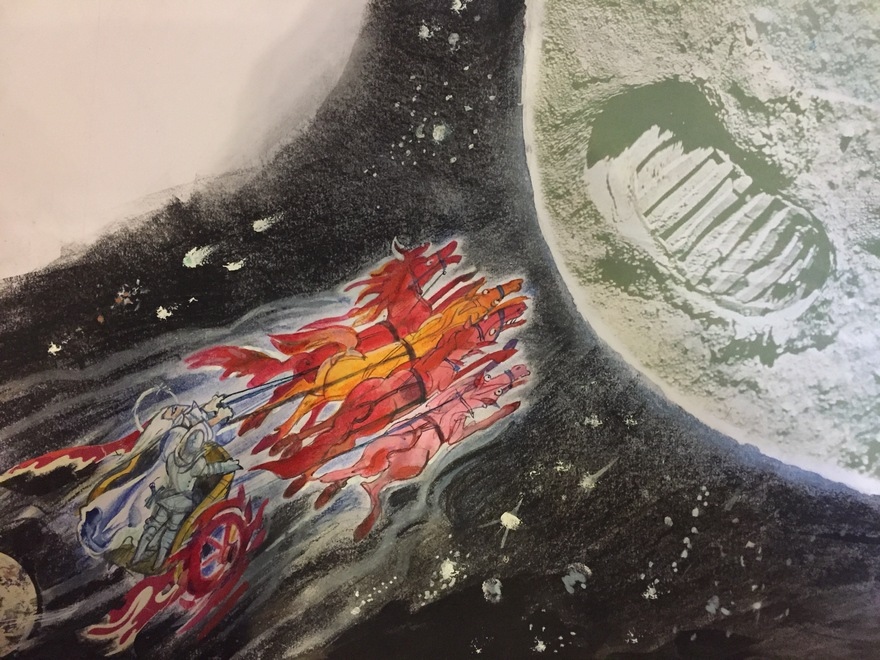

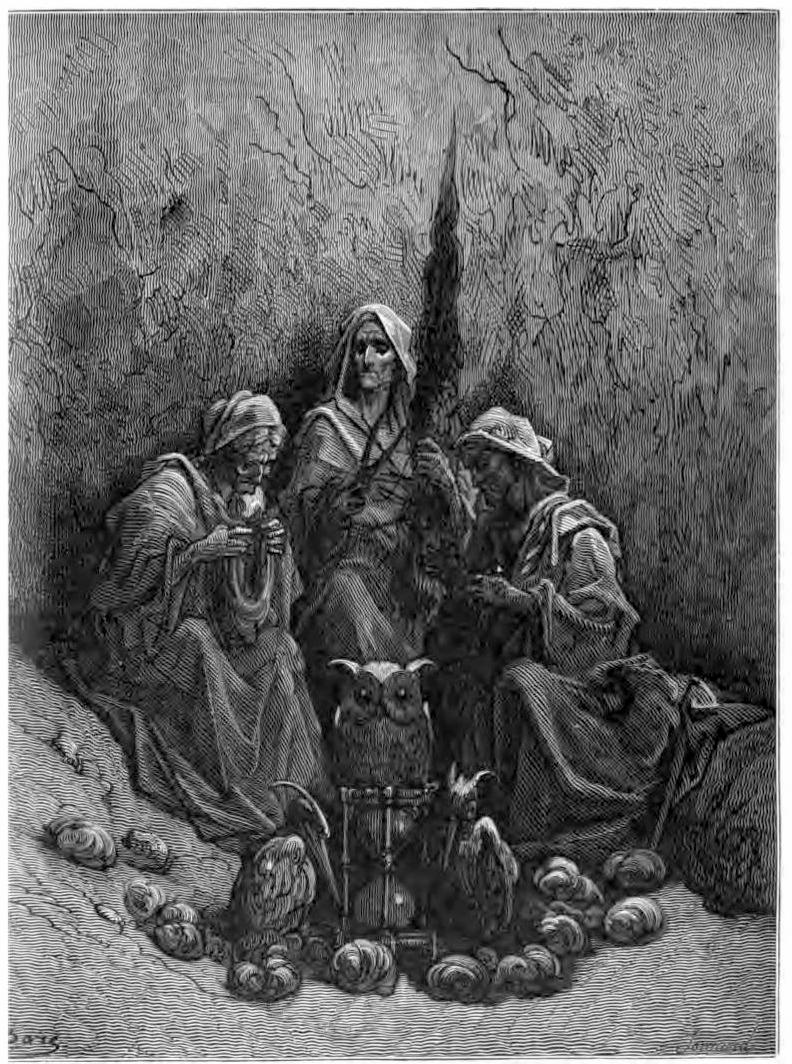


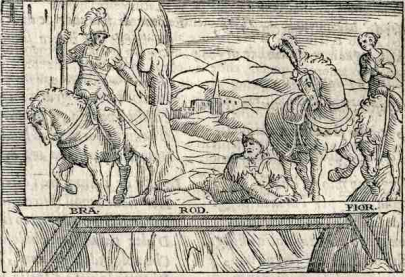




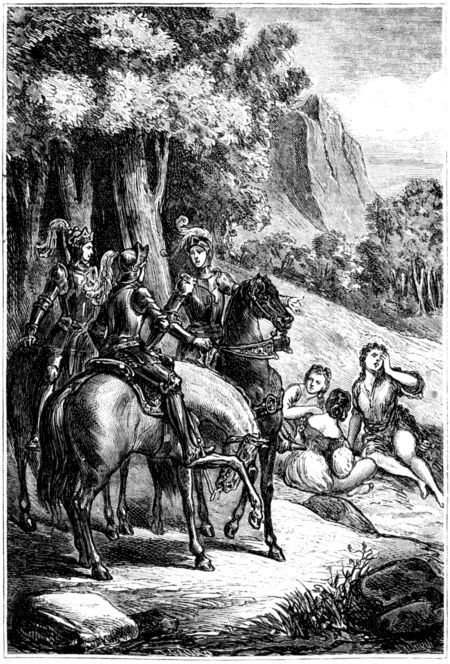








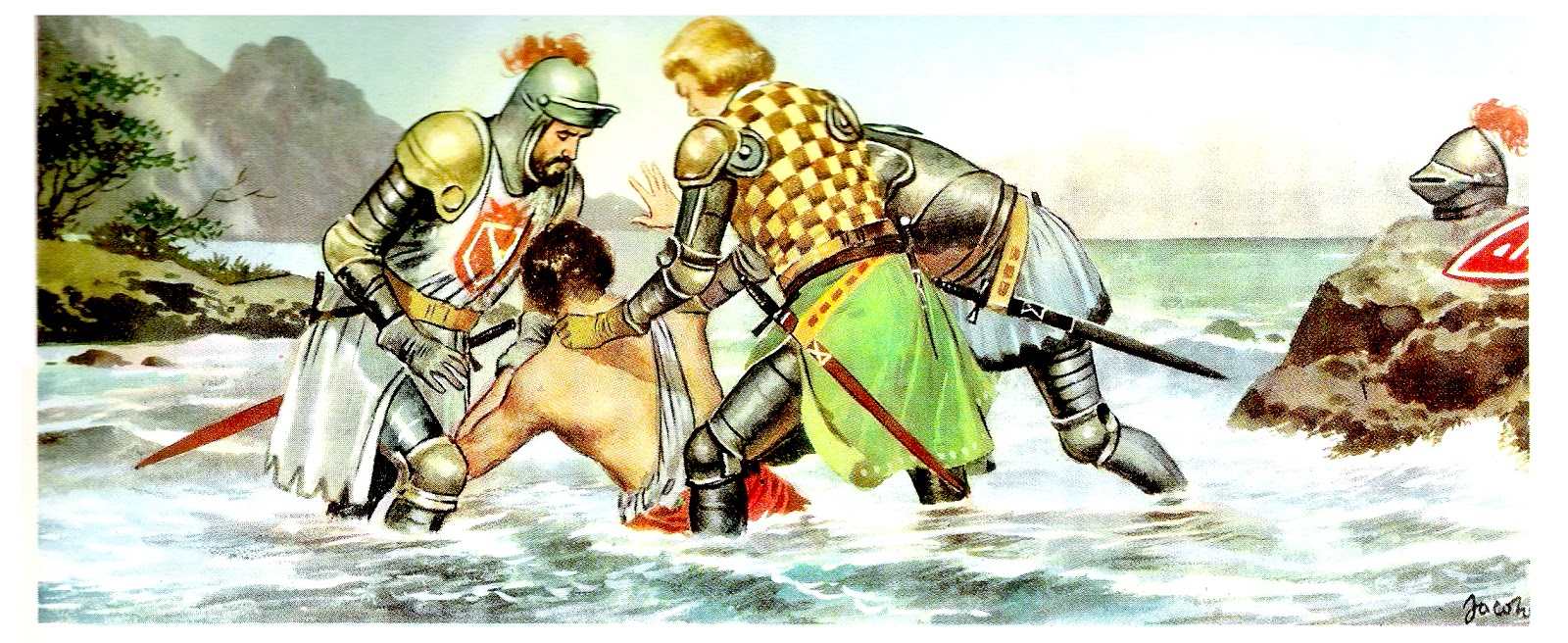














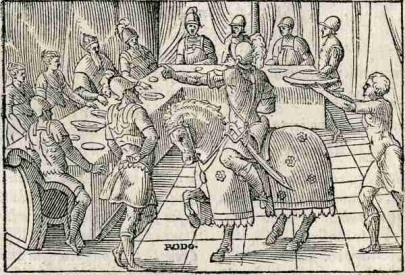



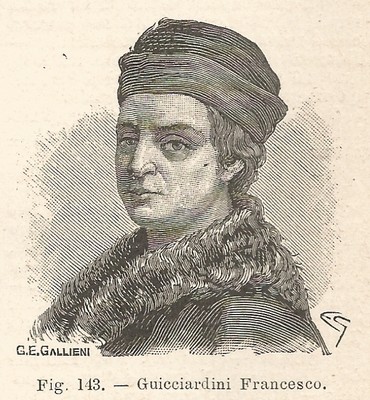




 Maerten van Heemskerk: I pericoli dell’ambizione umana (1549)
Maerten van Heemskerk: I pericoli dell’ambizione umana (1549)