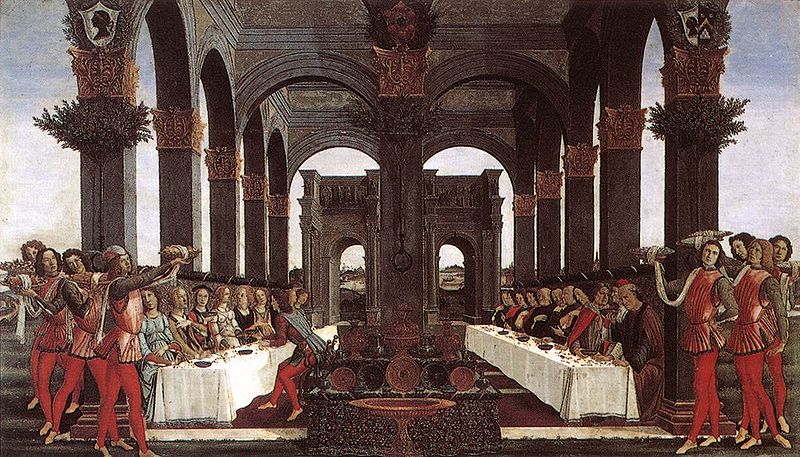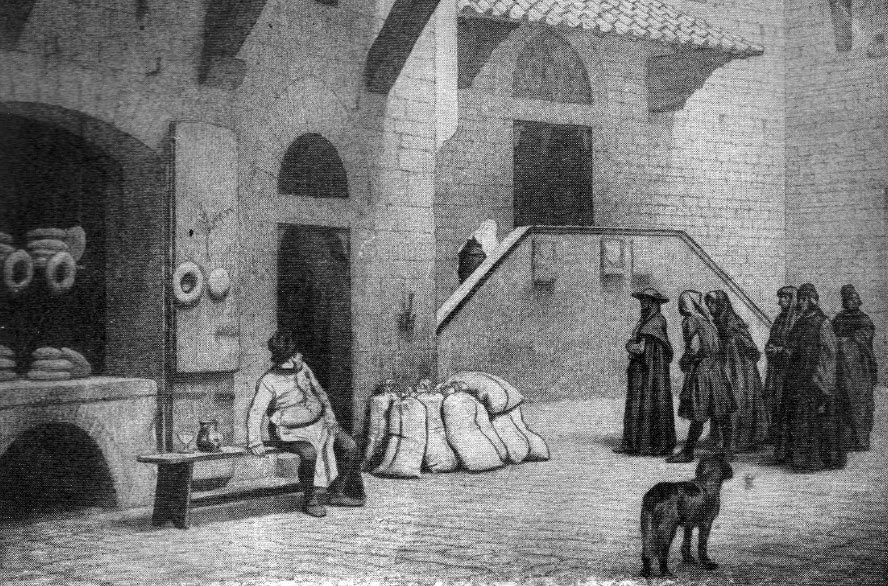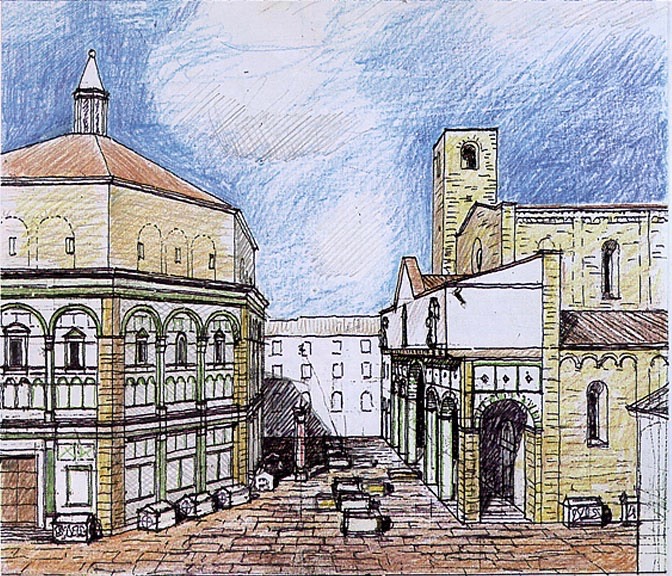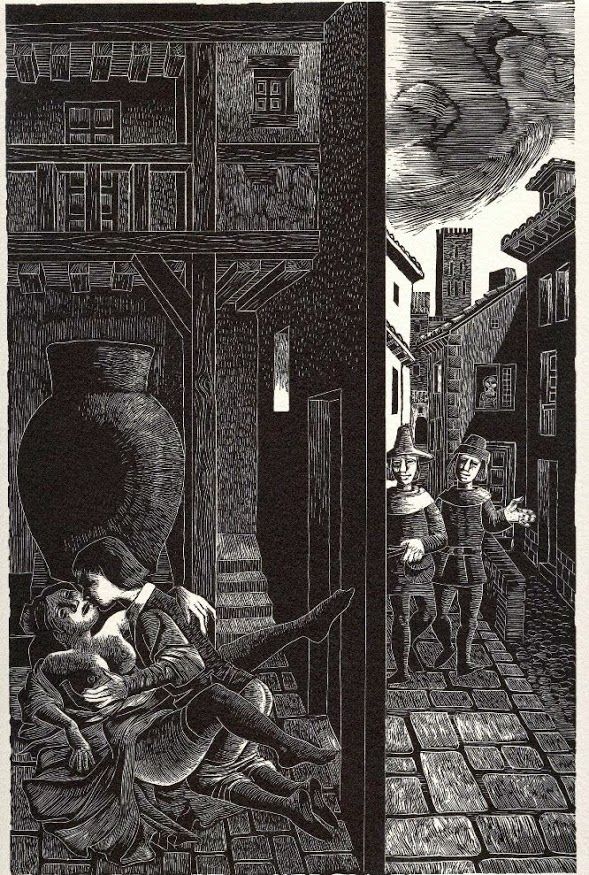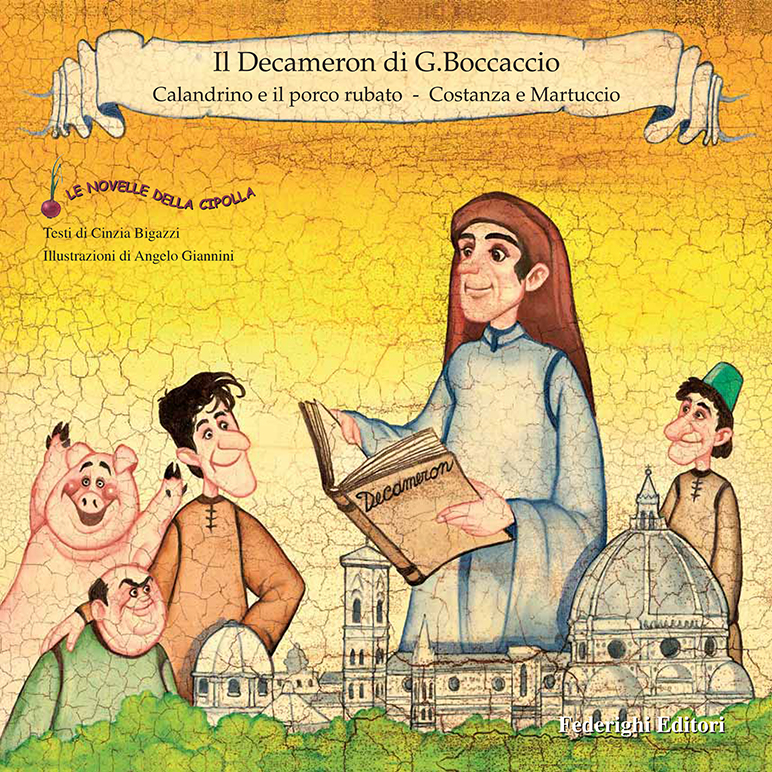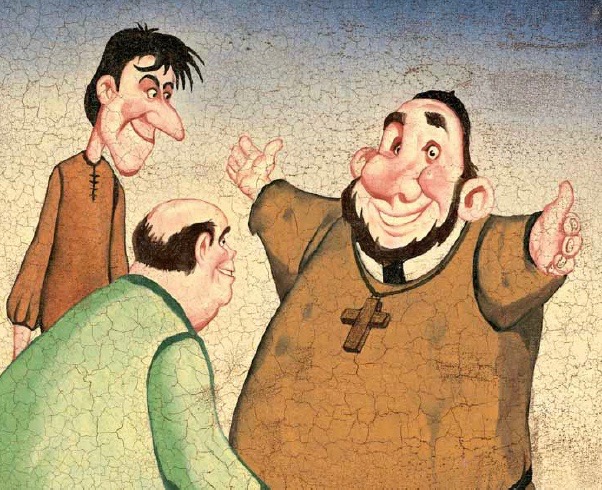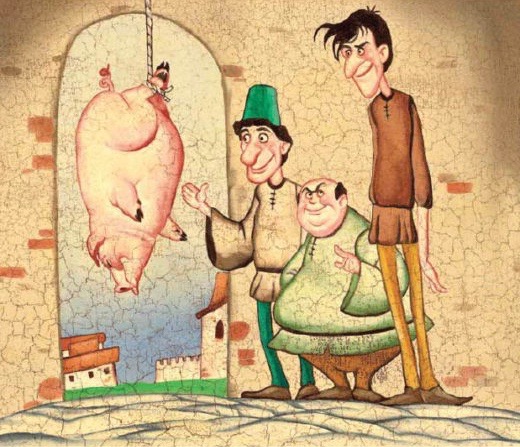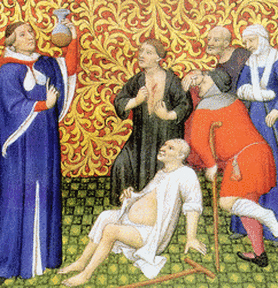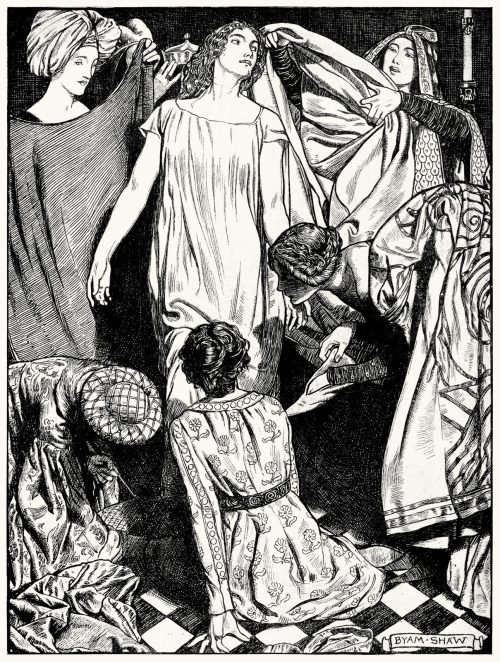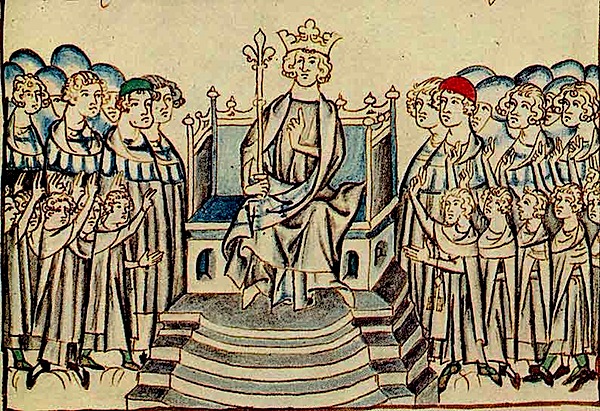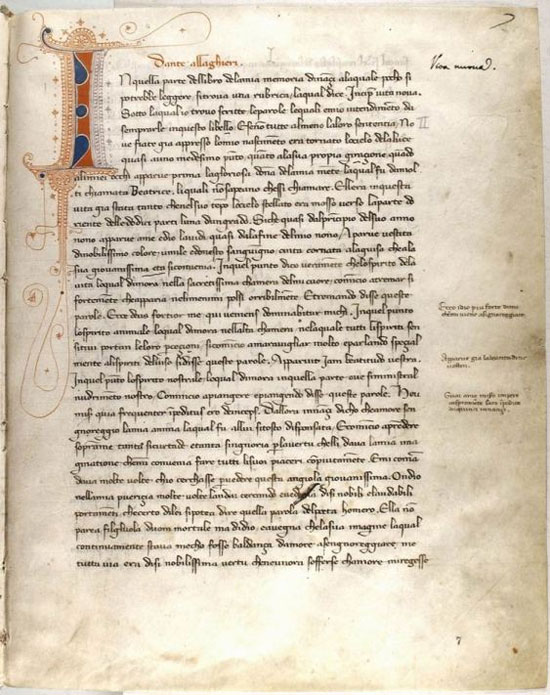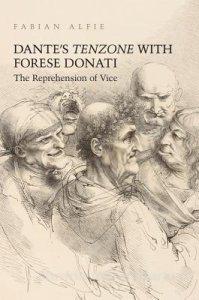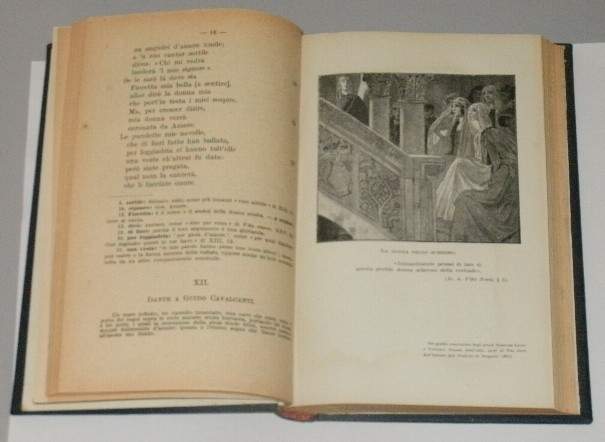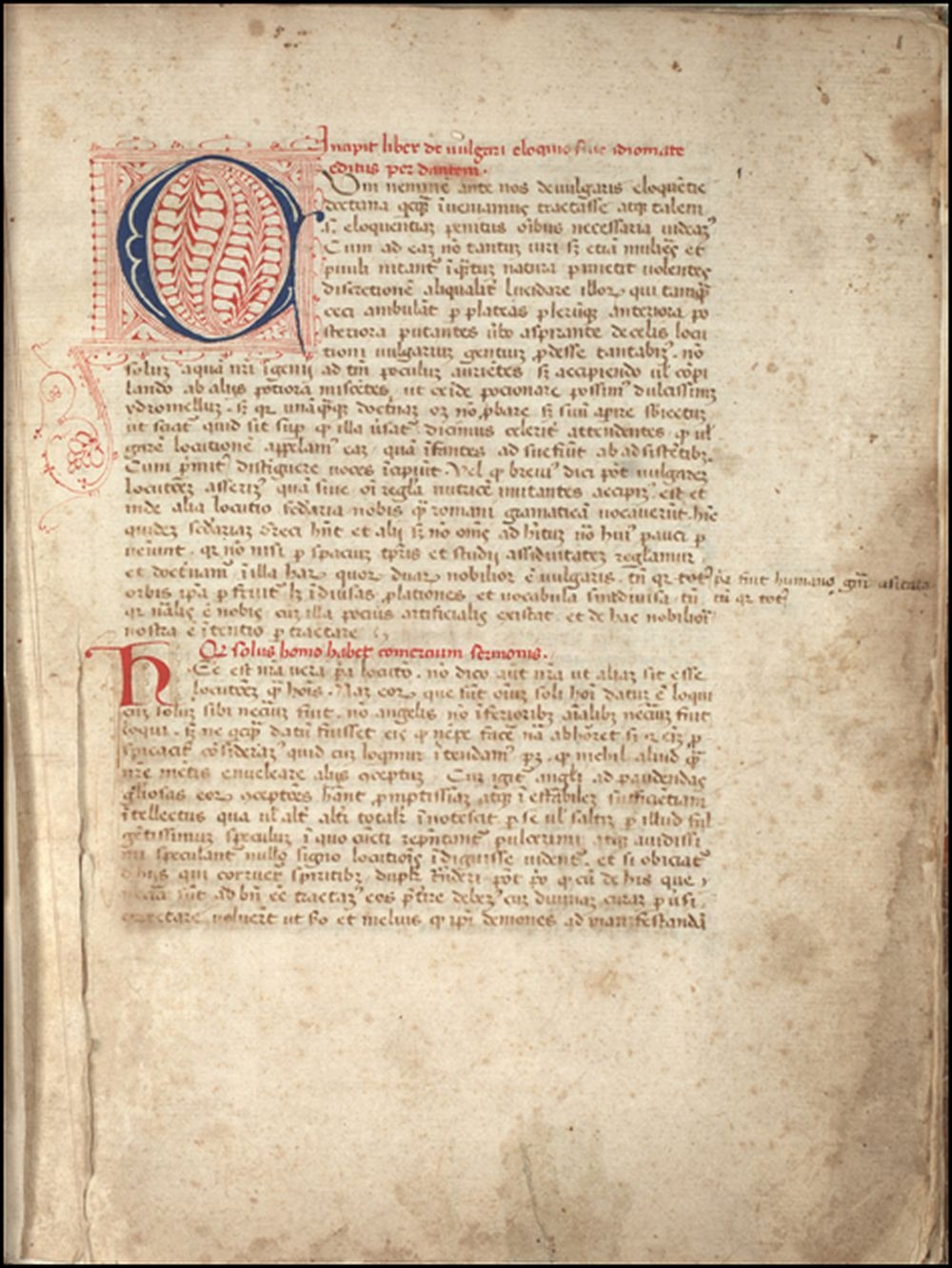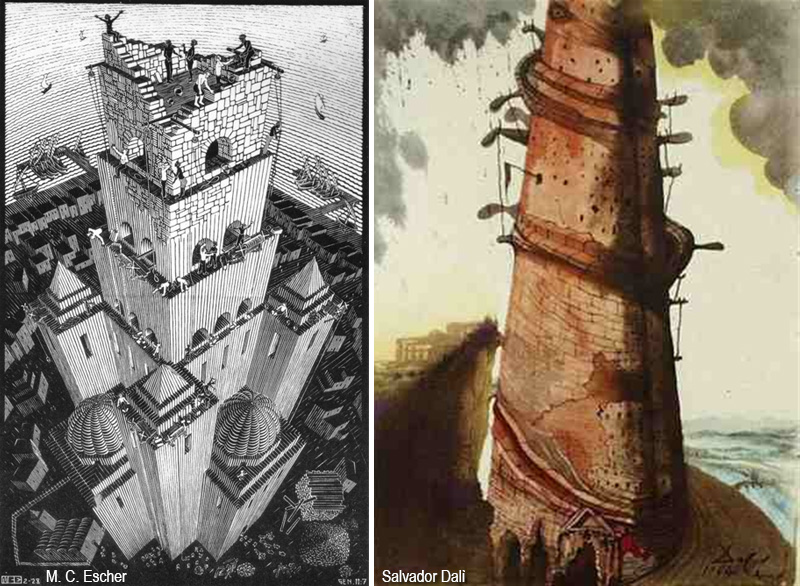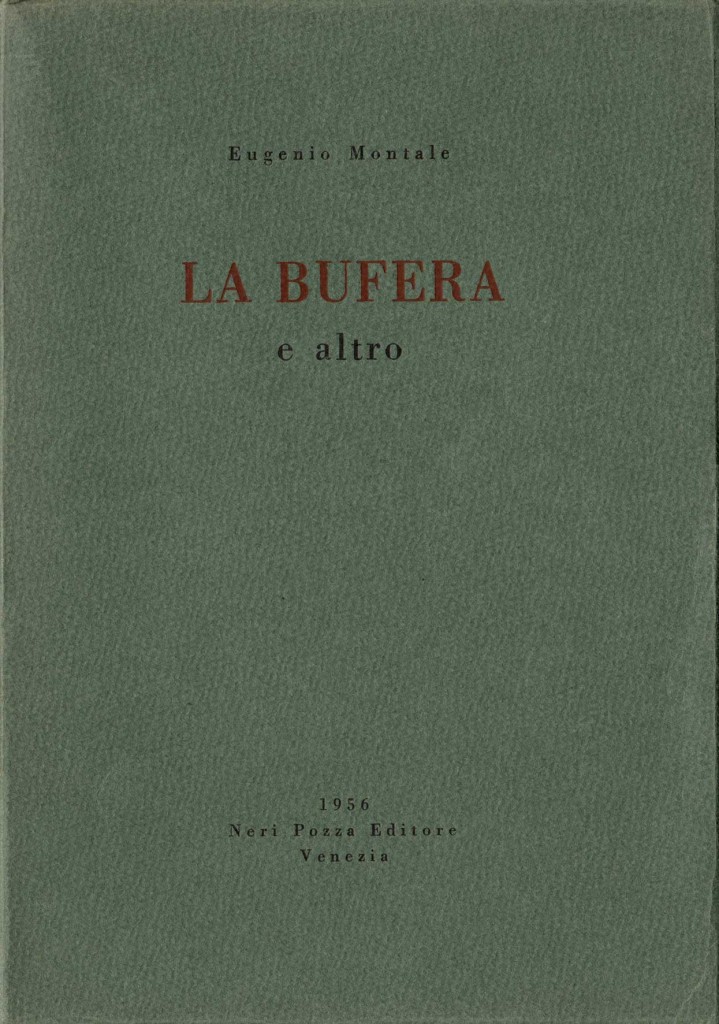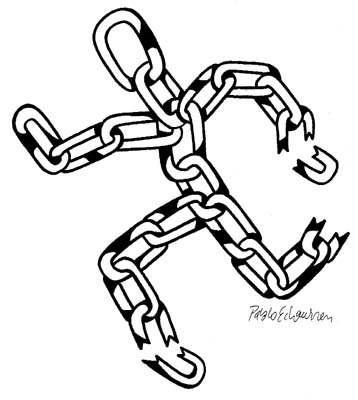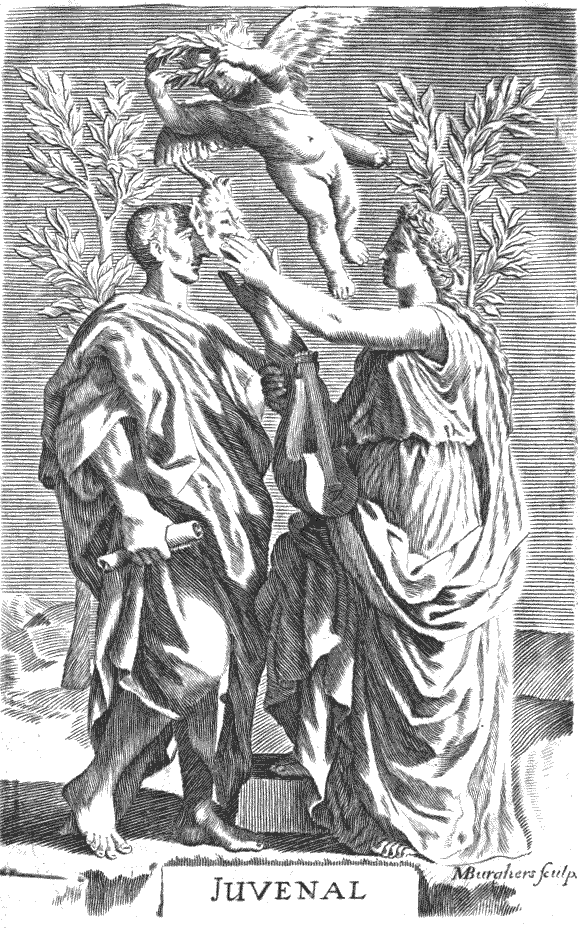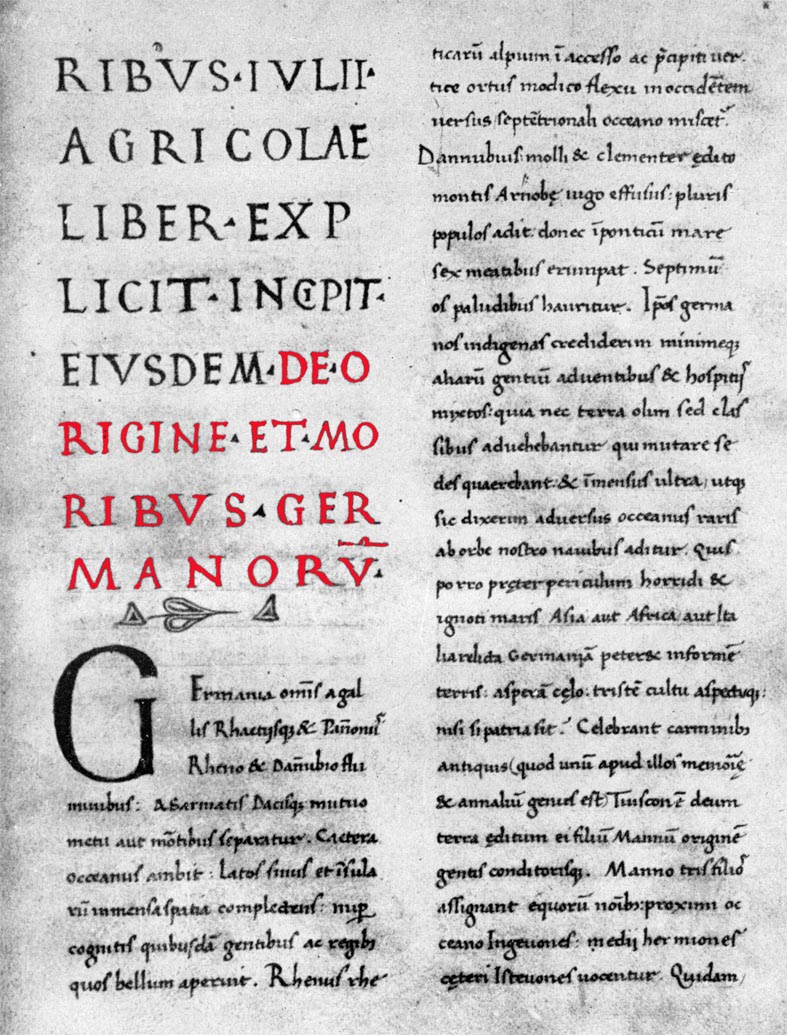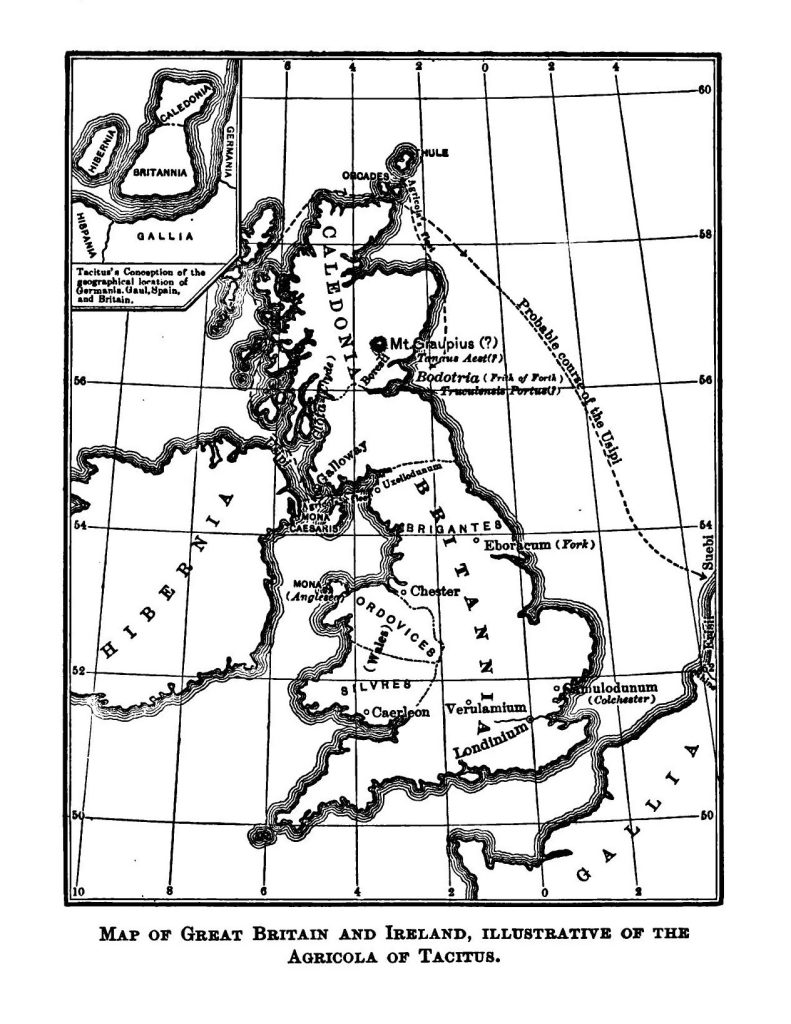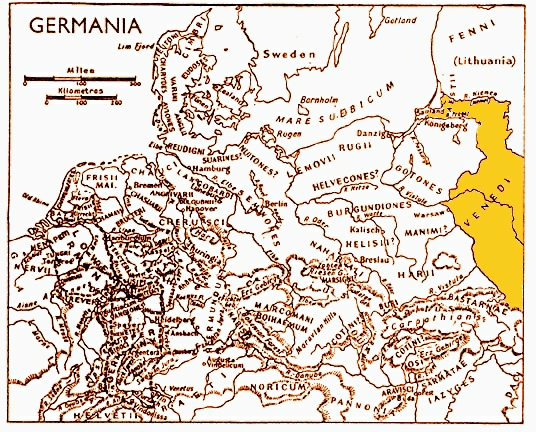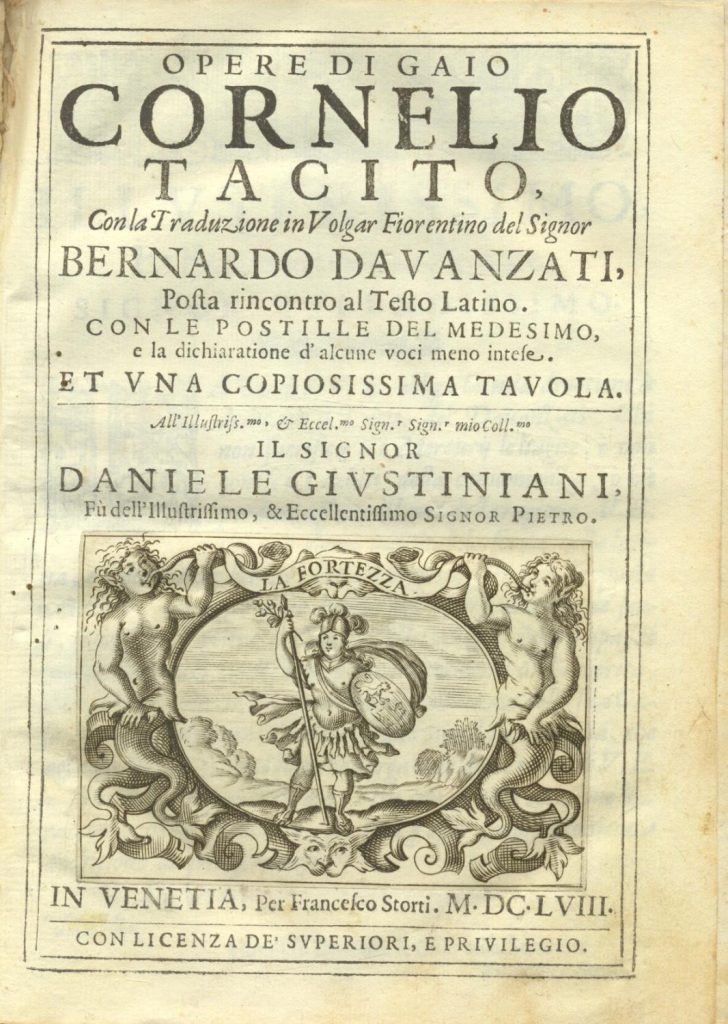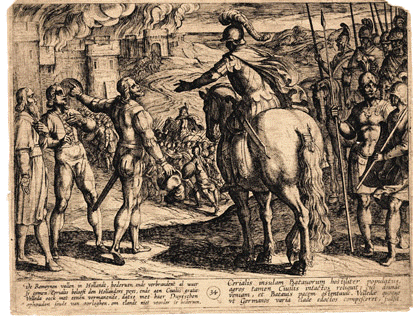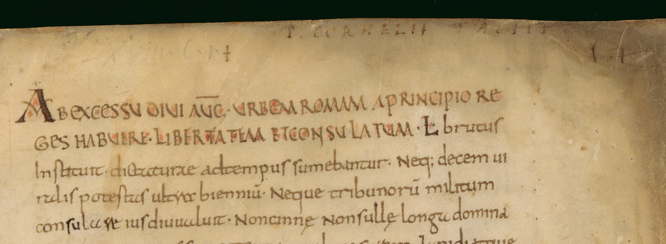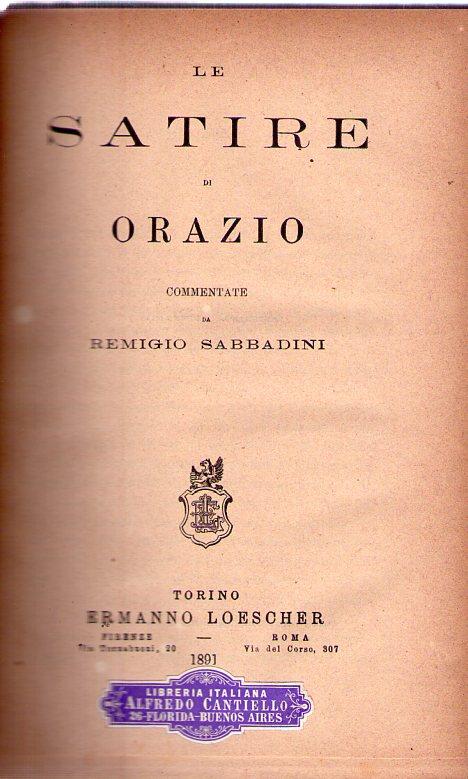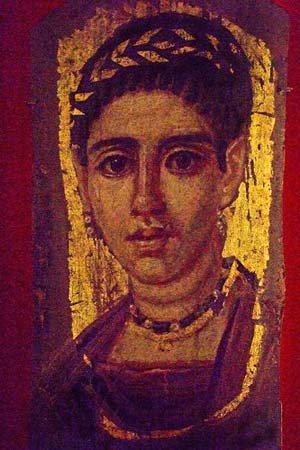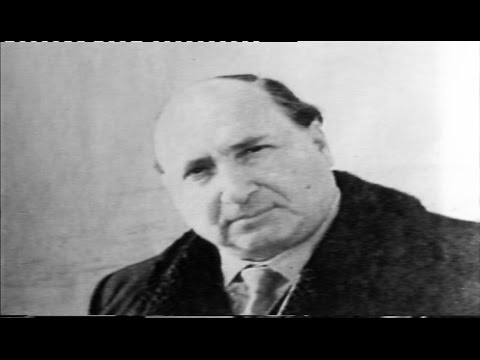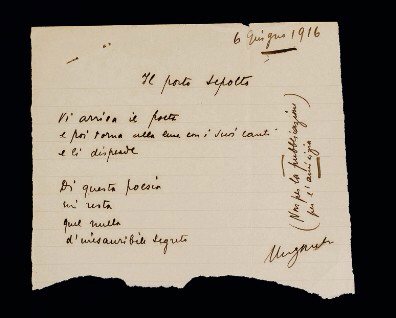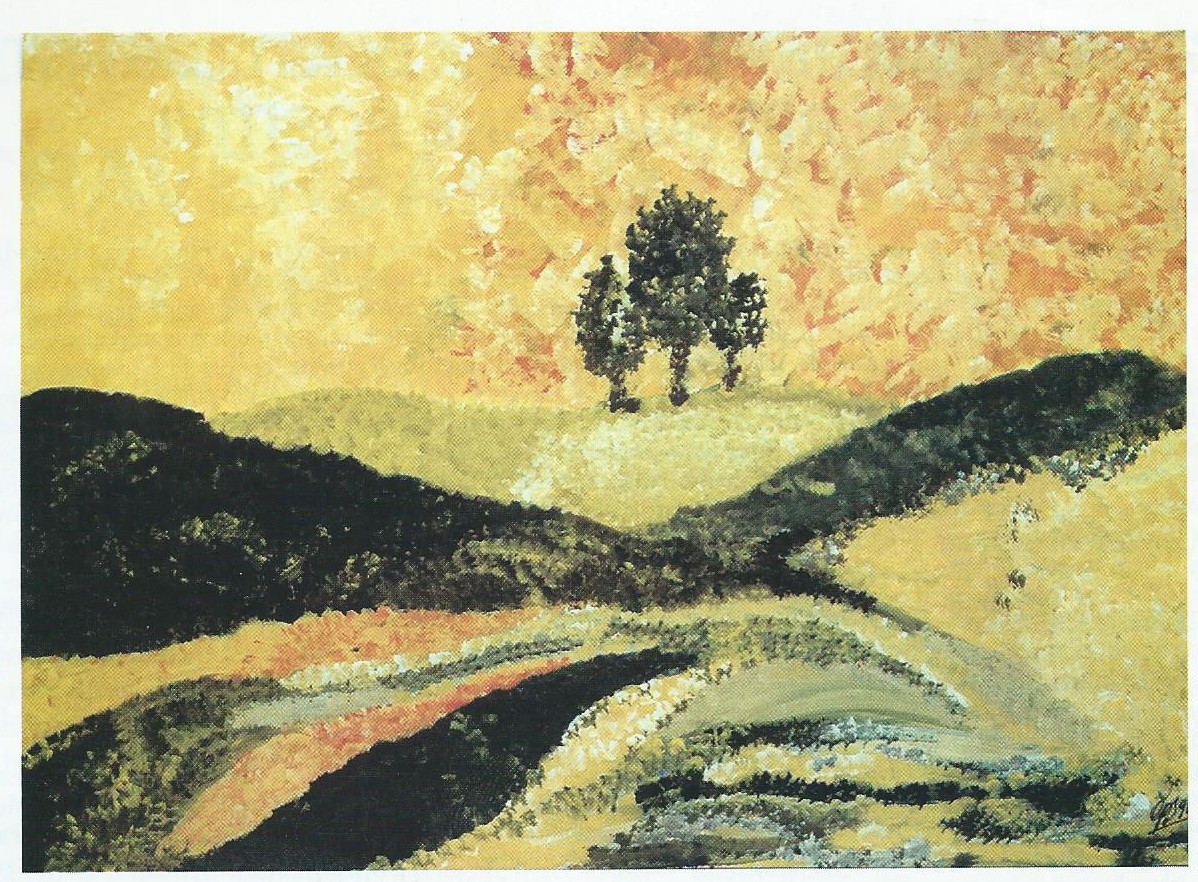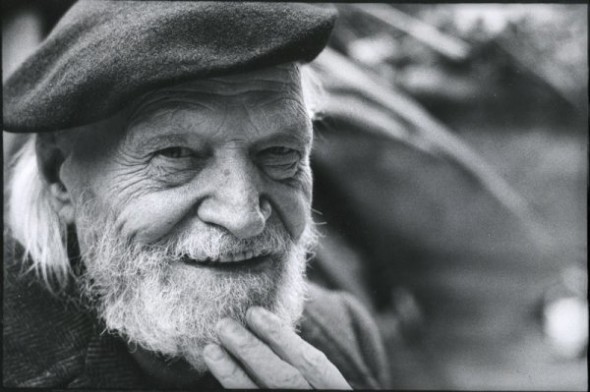Andrea del Castagno: Ritratto di Giovanni Boccaccio (particolare)
Si crede che Giovanni Boccaccio sia nato a Certaldo nel 1313 da una relazione illegittima di Boccaccino di Chellino, agente dell’agenzia bancaria dei Bardi. Tale credenza è messa in dubbio dal fatto che molti ritengono più probabile la nascita in Firenze, mentre lui, da giovane, avrebbe sviluppato la “favola” di una sua origine parigina. Impara i primi rudimenti grammaticali da un ecclesiastico, che instilla in lui, sin da giovane, un incredibile amore per Dante.

La statua di Boccaccio a Certaldo in Toscana
Nel 1327 circa Boccaccino è sicuramente a Napoli, nel regno di Roberto d’Angiò a guidare una succursale della banca dei Bardi; egli, sin da subito, porta con sé il figlio Giovanni, perché apprenda i rudimenti del suo mestiere. In tale città il giovane sarà bene accolto sia negli ambienti aristocratici della corte, dove il padre svolge i suoi affari sia con il re, sia con i ricchi mercanti fiorentini che in quella città gravitano.

Simone Martini: Roberto d’Angiò, Museo di Capodimonte (Napoli)
In questo periodo Giovanni, da autodidatta, legge moltissimo: frequenta con passione i classici latini, legge romanzi cortesi, che la biblioteca di corte possiede in quantità, ma non disdegna la letteratura popolare, come quella dei giullari, che allieta le piazze della città partenopea. Durante la sua permanenza nel Regno di Napoli, Boccaccio conduce una vita spensierata e gaudente, intreccia vari amori e scrive, in onore delle belle donne di corte, varie opere, che lo fanno conoscere e aprono a lui le porte per intrecciare avventure galanti. Tali opere sono: La caccia di Diana, il Filoloco, il Filostrato, il Teseida. Ma insieme a tali opere “narrative” scrive anche un certo numero di rime.

P. Salinas: Boccaccio alla corte di Giovanna di Napoli, 1892
Nel 1340 la banca dei Bardi fallisce e Boccaccio deve tornare, insieme al genitore, a Firenze. E’ un periodo di difficoltà economica per cui cerca protezione presso i signori. Continua nel frattempo a scrivere opere come il Ninfale d’Ameto, l’Amorosa visione, il Ninfale fiesolano e l’Elegia di Madonna Fiammetta. Tra il 1349 ed il 1351 scrive il suo capolavoro, il Decameron; è un periodo fertile culturalmente, ma grave di lutti: gli muore il padre e Violante, la prima di cinque figli, avuti tutti fuori dal matrimonio. Il successo del Decameron lo porta ad essere apprezzato in città, tanto che la stessa gli affida incarichi importanti come ambasciatore. E’ di questo periodo anche l’amicizia, che durerà tutta la vita, con Francesco Petrarca, cui già un decennio prima aveva dedicato un’opera dal titolo De vita et moribus domini Francisci Petrachi. Sotto l’influenza del poeta aretino, approfondirà lo studio degli scrittori di Roma, che lo porteranno a elaborare alcune opere in latino. Ma egli non dimenticherà mai l’amore per Dante, tanto che scriverà, nel 1351, un libello in suo nome: Trattatello in lode di Dante. Di questo periodo è anche un’altra opera, piuttosto tarda, il Corbaccio. Comincia, come il suo amico a cercare nei monasteri testi classici; ma quando si libera un posto a Napoli come segretario, si reca in città per ottenerlo, ma senza riuscirvi. La città partenopea gli rimarrà sempre nel cuore, ma non riuscirà mai a stabilirvisi. Nel 1360 è colpito da una profonda crisi religiosa: si fa sacerdote e promuove lo studio del greco, non solo per lui, ma per l’intera cultura europea, chiamando Leonzio Pilato, monaco calabrese, allo “Studio fiorentino”, che potremmo definire coma la prima cattedra di lingua e cultura greca in territori non bizantini. Si racconta, ma senza fondamento, che tra gli effetti di tale crisi vi sia anche il senso di colpa per l’opera maggiore che ha scritto, tanto da volerla bruciare. Sarà il suo amico Petrarca a distoglierlo da tale atto.
Ormai povero e malato si ritira a Certaldo, fra il calore di vecchi e nuovi amici. Soprattutto questi ultimi (i futuri umanisti) lo saluteranno come un grande maestro.
Nel 1373 Firenze lo richiama per leggere pubblicamente la Divina Commedia di Dante nella chiesa di Santo Stefano. Accetterà tale incarico per amore verso il sommo poeta. Ma farà in tempo a leggere soltanto 17 canti. Morirà, nel 1375, dopo aver appreso la notizia della morte del suo amico Petrarca, sopravvivendogli appena un anno.
L’uomo
Boccaccio è contemporaneo di Petrarca, vive pertanto la stessa situazione storica dell’amico aretino. Tuttavia tra i due vi sono notevoli differenze:
- L’adolescenza e la giovinezza a Napoli, all’interno di una corte dove ancora molto forte è la presenza della cultura “narrativa” cortese;
- Il lavoro paterno e l’ambiente, borghesia e nobiltà. Saranno proprio questi due elementi che contraddistingueranno l’ideologia di fondo boccacciana e che troveranno voce in alcune novelle del suo capolavoro;
- L’amore per Dante e per il modo con cui l’autore della Divina Commedia, osserva il reale. Noteremo, infatti, come anche Boccaccio sia più portato non tanto a scrutare l’io, quanto la vita nella sua molteplicità;
- L’amore per i classici che metterà a frutto non solo in opere, certamente meno riuscite di quelle di Petrarca, ma nel suo stile volgare, dove ricreerà una eleganza modellandola sull’insegnamento stilistico degli uomini di Roma.

Le statue di Dante, Petrarca e Boccaccio a Ponte Vecchio (Firenze)
E’ chiaro da quanto detto che si potrebbe istituire una linea che dal medioevo conduce alla nuova età umanistica, quella che caratterizzerà la cultura del 1400, proprio a partire da quella che è stata definita la nostra triade letteraria fiorentina: se infatti Dante è completamente proiettato verso il divino, Petrarca è l’uomo che, con le sue contraddizioni, sembra incapace a scegliere tra Dio e l’uomo, e il nostro Boccaccio, che chiude il discorso, è proiettato, con l’elogio verso l’amore sensuale, alla terra. Ma è estremamente semplicistico ridurre i nostri grandi autori a tale definizione: potremo dire che in modo diverso, dettato dall’età e dalla sensibilità di ognuno di loro, tutti e tre vivano con difficoltà il rapporto col divino: ce lo dimostra Dante stesso, nell’episodio di Francesca o d’Ulisse, quando, pur accusandoli per aver messo l’amore e la conoscenza al di sopra di Dio, non può che provare nei loro confronti profonda comprensione e stima; ce lo dice lo stesso Petrarca, e Agostino con lui, come l’amore verso la vanità e la gloria letteraria (tutta terrena) non le permettano di vivere, senza timori e difficoltà, il desiderio della serenità della fede; ma sarà di ciò testimone anche Boccaccio che se anche racconterà, col sorriso sulle labbra, di frati bugiardi e di monache vogliose di sesso, saprà disegnarci, nell’ultima novella, una storia in cui è evidente l’allegoria verso la figura della Madonna.
Periodo napoletano
Caccia di Diana (1334): poemetto in terza rima in 18 canti. La narrazione è fatta in prima persona. Il richiamo metrico è dantesco (la terza rima), mentre a livello di contenuto si richiama alla letteratura cortese.
Il protagonista sta pensando come fare per ripararsi dai colpi d’amore, ma viene distolto da una voce che, in modo soave, chiama ad unirsi le donne della corte di Diana. Arrivano le donne più belle della reggia di Roberto d’Angiò. Esse, dopo essersi raccolte intorno alla dea, si dividono in gruppi e iniziano la caccia che viene descritta per quattordici canti. Diana dà l’ordine di sospendere la caccia e invita le donne a rendere sacrifici a Giove. Ma l’ultima donna dichiara di preferire fare sacrifici in onore di Venere. La dea appare e, riconoscente per la fedeltà a lei dimostrata dalle donne, fa apparire dalle fiamme del fuoco approntato per i sacrifici alcuni giovani allegri e piacenti.

Miniatura da La Caccia di Diana di Boccaccio
L’APPARIZIONE DI VENERE E I MIRACOLI D’AMORE
Caccia de’ petti nostri i pensier vili,
e per la tua virtù fa’ eccellenti
gli animi nostri, e’ cor larghi e gentili.
Deh fa sentire a noi quanto piacenti
sieno gli effetti tuoi, e facci ancora,
alcuno amando, gli animi contenti.
(…)
E poi, verso del foco rivoltata,
non so che disse: se non che di fuori
ciascuna fiera che v’era infiammata,
mutata in forma d’uom, di quelli ardori
usciva giovinetto gaio e bello,
tutti correndo sopra ’l verde e’ fiori;
e tutti entravan dentro al fiumicello,
e, quindi uscendo ciascun, d’un vermiglio
e nobil drappo si facean mantello,
(…)
E vidimi alla bella Donna offerto,
e di cervio mutato in creatura
umana e razionale esser per certo;
ma non ingiustamente, che natura
non mise mai valor nè gentilezza,
quant’è in lei onestissima e pura;
il viso suo angelica bellezza
del ciel discesa veramente pare,
venuta a dare agli occhi uman chiarezza
discreta e saggia nel suo ragionare,
e signorevol donna nello aspetto,
lieta e baldanzosa nello andare;
Manda via dalla nostra mente i pensieri malvagi, e grazie alla tua virtù, o Venere, rendi i nostri animi elevati e i cuori accoglienti e nobili. Dunque fa sentire a noi quanto piacevoli siano i tuoi effetti e rendici gli animi felici con l’amare qualcuno. (…) E poi, rivolta verso il fuoco, disse non so cosa, se non che tutti i corpi avvolti nelle fiamme furono esteriormente mutati in uomini; da quel calore uscivano giovinetti belli e felici, che correvano sopra il prato verde e fiorito. e tutti si gettavano dentro un fiumiciattolo dal quale, uscendo, venivano ricoperti con un rosso mantello. (…)
E’ evidente in questa giovanile opera come Boccaccio, accanto a elementi classicheggianti, primi fra tutti quelli ovidiani, subisca l’influenza del “dolce stilnovo”. Infatti anche qui viene ripreso il concetto guinizzelliano dell’amore e del cuore gentile. D’altra parte è anche vero che tale tema viene “ingentilito” dall’esistenza stessa, nella corte di Roberto d’Angiò, da giovani e giovinette, ambedue portatori di cuore gentili: infatti Boccaccio canta l’amore come sentimento che ingentilisce l’uomo facendolo passare da essere ferino a possessore d’un gentil core.
Filostrato (1335): il cui titolo, secondo l’autore certaldino significherebbe “vinto d’amore” (in realtà vuol dire “amante degli eserciti”). Dopo un proemio in prosa, l’opera è costituita da nove parti in ottave dove si racconta la seguente storia:
Troiolo, ultimo figlio del re di Troia Priamo s’innamora di Criseida, figlia dell’indovino Calcante. Grazie al fratello di lei e suo amico, Pandaro, l’innamoramento sembra andare a buon fine. Ma Criseida, per uno scambio di prigionieri, deve andare al campo greco, scortata da Diomede che se ne innamora. Troiolo, convinto d’essere stato tradito, cerca di vendicarsi, ma viene ucciso da Achille.

Manoscritto del Filostrato (Regione Veneto)
Le fonti di questo testo sono da ricercare nel romanzo francese Roman de Troie di Bernoit de Saint-Maure o Historia troiana di Guido delle Colonne della fine del XIII secolo. E’ evidente, pertanto, come il giovane Boccaccio è attratto dalla letteratura cortese anche quando i riferimenti sono classici (qui la guerra di Troia) e pertanto il suo sguardo è attirato dai modelli delle chanson medievali, ricche d’avventura e d’amore, più dell’epica.
Lo dimostra, d’altra parte, l’invocazione:
INVOCAZIONE
(I, 1-6)
Alcun di Giove sogliono il favore
ne’ lor principii pietosi invocare;
altri d’Apollo chiamano il valore;
io di Parnaso le muse pregare
solea ne’ miei bisogni, ma amore
novellamente m’ha fatto mutare
il mio costume antico e usitato,
poi fu’ di te, madonna, innamorato.
Tu donna se' la luce chiara e bella,
per cui nel tenebroso mondo accorto
vivo; tu se’ la tramontana stella
la qual’io seguo per venire al porto;
ancora di salute tu se’ quella
che se’ tutto il mio bene e ’l mio conforto;
tu mi se’ Giove, tu mi sei Apollo,
tu se’ mia musa, io l’ho provato e sollo.
Per che volendo per la tua partita,
più greve a me che morte e più noiosa,
scriver qual fosse la dolente vita
di Troilo, da poi che l’amorosa
Griseida da Troia sen fu gita,
e come pria gli fosse grazïosa;
a te convienmi per grazia venire,
s’io vo’ poter la mia ’mpresa fornire.
Adunque, o bella donna, alla qual fui
e sarò sempre fedele e soggetto,
o vaga luce de’ begli occhi in cui
Amore ha posto tutto il mio diletto;
o isperauza sola di colui,
che t’ama più che sè d’amor perfetto,
guida la nostra man, reggi l’ingegno,
nell’opera la quale a scriver vegno.
Tu se’ nel tristo petto effigïata
con forza tal, che tu vi puoi più ch’io;
pingine fuor la voce sconsolata
in guisa tal, che mostri il dolor mio
nell’altrui doglie, e rendila sì grata,
che chi l’ascolta ne divenga pio;
tuo sia l’onore, e mio si sia l’affanno,
se i detti alcuna laude acquisteranno.
E voi amanti prego che ascoltiate
ciò che dirà ’l mio verso lagrimoso;
e se nel cuore avvien che voi sentiate
destarsi alcuno spirito pietoso,
per me vi prego ch’amore preghiate,
per cui siccome Troilo doglioso
vivo lontan dal più dolce piacere,
che a creatura mai fosse in calere.
Alcuni usano invocare, in principio della loro opera, la protezione di Giove, altri invocano la virtù di Apollo; io, in soccorso delle mie necessità, usavo pregare le Muse, ma recentemente Amore mi ha fatto mutare la mia antica e consueta abitudine, allorché mi innamorai di te, madonna. // Tu, o donna, sei la luce chiara e bella per la quale io vivo prudente nel mondo tenebroso; tu sei la stella tramontana che io seguo per giungere al porto; àncora di salvezza, tu (sola) rappresenti tutto il mio bene e il mio conforto; tu sei per me Giove, sei Apollo, tu sei la mia musa, ed io l’ho provato e ne sono certo. // Perciò volendo raccontare, in occasione della tua partenza, che è per me più dura e dolorosa da sopportare della morte stessa, quale sia stata la triste storia di Troiolo dopo la morte dell’amata Criseida, e come invece prima (quella vita) gli fosse piacevole, è opportuno che io chieda la tua grazia, se io voglio portare a termine la mia impresa. // Dunque, o bella donna, alla quale fui e sarò sempre assoggettato, o splendida luce dei begli occhi nei quali Amore ha posto tutto il mio piacere; o sola speranza di colui che ti ama più di quanto ami se stesso, di un amore perfetto, guida la mia mano, sorreggi la mia intelligenza, nell’opera che mi accingo a scrivere. // Tu sei ritratta nel mio petto addolorato con una tale forza, che su di me eserciti un potere più forte del mio stesso potere; infine fanne uscire la voce sconsolata, così che mostri il mio dolore attraverso (il racconto di) quello di qualcun altro, e rendila (la voce) così piacevole, che chi la sente diventi virtuoso. Tuo sarà l’onore e mia la fatica, se i versi riceveranno qualche lode. // E voi, amanti, vi prego di ascoltare ciò che diranno i miei versi addolorati, e se accadrà che voi sentiate destarsi nel cuore qualche pietà, vi prego di pregare per me Amore, a causa del quale, come Troiolo, vivo nel dolore, lontano dal più dolce piacere che abbia mai potuto avere qualche importanza per una creatura.
in cui convergono elementi derivati dalla scuola poetica siciliana, guinizzelliani, cavalcantiani ed anche danteschi, per meglio dire l’intera tradizione della poesia erotica italiana. Quello che tuttavia caratterizza il poemetto è l’amore concreto, vissuto rapidamente da due giovani, e non più l’amore idealizzato.
 Troilo e Criseide si incontrano e vanno a letto insieme”, miniatura tratta dal ‘Filostrato’ (terzo quarto del XV secolo)
Troilo e Criseide si incontrano e vanno a letto insieme”, miniatura tratta dal ‘Filostrato’ (terzo quarto del XV secolo)
L’importanza del Filostrato è tutta nella scelta metrica, l’ottava rima, otto versi endecasillabi con rima ABABABCC (6 versi rima alternata, gli ultimi due baciata) che sarà alla base della narrazione epico-cavalleresca dal ’400 fino al ’600.
Filocolo (1336): il titolo significa “fatica d’amore”. L’opera rappresenta il primo tentativo di “romanzo” da parte del Boccaccio e lo dedica a Fiammetta (senhal per Maria d’Aquino).

Giovanni Boccaccio, Filocolo, per Filippo Giunti, 1594 (Biblioteca Marucelliana)
Florio, figlio del Re di Spagna e Biancofiore, un’orfana, si amano dopo essere cresciuti insieme. Per l’opposizione dei sovrani spagnoli che mandano Florio in giro per l’Europa a studiare e vendono Biancofiore ad un ammiraglio d’Oriente, i due giovani sono costretti ad affrontare molte peripezie e disgrazie che li dividono, ma alla fine, dopo numerosi viaggi di Florio alla ricerca dell’amata, con lo pseudonimo di Filocolo, si ritrovano e la storia termina con un lieto fine.
LETTERATURA E AMORE
Sì tosto come Amore dalla sua madre fu partito, così ella nella lucida nuvoletta fendendo l’aere pervenne a’ medesimi tetti, e, tacitamente preso il vecchio re, il portò in una camera sopra un ricco letto, dove d’un soave sonno l’occupò. Nel qual sonno il re vide una mirabile visione: che a lui pareva esser sopra un alto monte e quivi avere presa una cerbia bianchissima e bella, la quale a lui molto parea avere cara; la quale tenendola nelle sue braccia, gli pareva che del suo corpo uscisse un leoncello presto e visto, il quale egli insieme con questa cerbia sanza alcuna rissa nutricava per alcuno spazio. Ma, stando alquanto, vedeva discender giù dal cielo uno spirito di graziosa luce risplendente, il quale apriva con le propie mani il leoncello nel petto; e quindi traeva una cosa ardente, la quale la cerbia disiderosamente mangiava. E poi gli pareva che questo spirito facesse alla cerbia il simigliante; e fatto questo si partiva. Appresso questo, egli temendo non il leoncello volesse mangiar la cerbia, la lontanava da sé: e di ciò pareva che l’uno e l’altro si dolesse. Ma, poco stante, apparve sopra la montagna un lupo, il quale con ardente fame correva sopra la cerbia per distruggerla, e il re gliele parava davanti; ma il leoncello correndo subitamente tornò alla difesa della cerbia, e co’ propii unghioni quivi dilacerò sì fattamente il lupo, che egli il privò di vita, lasciando la paurosa cerbia a lui che dolente gliele pareva ripigliare, tornandosi all’usato luogo. Ma non dopo molto spazio gli parea vedere uscir de’ vicini mari due girfalchi, i quali portavano a’ piè sonagli lucentissimi sanza suono, i quali egli allettava; e venuti ad esso, levava loro da’ piedi i detti sonagli, e dava loro la cerbia cacciandogli da sé. E questi, presa la cerbia, la legavano con una catena d’oro, e tiravansela dietro su per le salate onde infino in Oriente: e quivi ad un grandissimo veltro così legata la lasciavano. Ma poi, sappiendo questo, il leoncello mugghiando la ricercava; e presi alquanti animali, seguitando le pedate della cerbia, n’andavano là ove ella era; e quivi gli parea che il leoncello, occultamente dal cane, si congiungesse con la cerbia amorosamente. Ma poi avedendosi il veltro di questo, l’uno e l’altro parea che divorar volesse co’ propii denti. E subitamente cadutagli la rabbia, loro rimandava là onde partiti s’erano. Ma inanzi che al monte tornassero, gli parea che essi si tuffassero in una chiara fontana, della quale il leoncello uscendone, pareva mutato in figura di nobilissimo e bel giovane, e la cerbia simigliantemente d’una bella giovine: e poi a lui tornando, lietamente li ricevea; e era tanta la letizia la quale egli con loro facea che il cuore, da troppa passione occupato, ruppe il soave sonno. E stupefatto delle vedute cose si levò, molto maravigliandosi, e lungamente pensò sopra esse; ma poi non curandosene, venne alla reale sala del suo palagio in quell’ora che Amore s’era da’ suoi nuovi suggetti partito. Taciti e soli lasciò Amore i due novelli amanti, i quali riguardando l’un l’altro fiso, Florio primieramente chiuse il libro, e disse: «Deh, che nuova bellezza t’è egli cresciuta, o Biancifiore da poco in qua, che tu mi piaci tanto? Tu non mi solevi tanto piacere; ma ora gli occhi miei non possono saziarsi di riguardarti!». Biancifiore rispose: «Io non so, se non che di te poss’io dire che in me sia avvenuto il simigliante. Credo che la virtù de’ santi versi, che noi divotamente leggiamo, abbia accese le nostre menti di nuovo fuoco, e adoperato in noi quello già veggiamo che in altrui adoperarono». «Veramente» disse Florio «io credo che come tu di’ sia, però che tu sola sopra tutte le cose del mondo mi piaci». «Certo tu non piaci meno a me che io a te» rispose Biancifiore. E così stando in questi ragionamenti co’ libri serrati avanti, Racheio, che per dare a’ cari scolari dottrina andava, giunse nella camera e loro gravemente riprendendo, cominciò a dire: «Questa che novità è, che io veggio i vostri libri davanti a voi chiusi? Ov’è fuggita la sollecitudine del vostro studio?». Florio e Biancifiore, tornati i candidi visi come vermiglie rose per vergogna della non usata riprensione, apersero i libri; ma gli occhi loro più disiderosi dell’effetto che della cagione, torti, si volgeano verso le disiate bellezze, e la loro lingua, che apertamente narrare solea i mostrati versi, balbuziendo andava errando. Ma Racheio, pieno di sottile avvedimento, veggendo i loro atti, incontanente conobbe il nuovo fuoco acceso ne’ loro cuori, la qual cosa assai gli dispiacque; ma più ferma esperienza della verità volle vedere, prima che alcuna parola ne movesse ad alcuno altro, sovente sé celando in quelle parti nelle quali egli potesse lor vedere sanza essere da essi veduto. E manifestamente conoscea, come da loro partitosi, incontanente chiusi i libri, abbracciandosi si porgeano semplici baci, ma più avanti non procedeano, però che la novella età, in che erano, non conoscea i nascosi diletti. E già il venereo fuoco gli avea sì accesi, che tardi la freddezza di Diana li avrebbe potuti rattiepidare.

Ulisse Sartini: Florio e Biancifiore (2012)
Così come Cupido immediatamente s’allontanò dalla madre, allo stesso modo Venere avvolta in una nube, giunse agli stessi tetti e silenziosamente, preso il vecchio re, lo portò in camera su un letto riccamente ricamato e occupò la sua mente con un dolce sogno. Una straordinaria immagine apparve al sovrano durante il sonno: gli sembrava di essere in un monte elevato e d’aver catturato una cerva bianchissima e bella, e gli sembrava avere verso di lei un sentimento di protezione; tenendola fra le braccia le pareva che da lei uscisse un piccolo leone, veloce e vispo, che insieme alla cerva egli stesso nutriva per qualche tempo. Ma, dopo qualche anno, vedeva scender giù dal cielo uno spirito risplendente, che apriva il petto del leoncino, ne traeva il cuore che la cerva mangiava con desiderio. Gli sembrava inoltre che lo stesso spirito avesse fatto lo stesso con il petto della cerva e con il leoncino che gustava il suo cuore, quindi si allontanava. Dopo ciò vedendo che il piccolo leone s’avvicinava alla cerva e pensando che la volesse mangiare, lo allontanava e le pareva che ambedue si dolessero per questo. Ma dopo poco apparve sopra la montagna un lupo, che con fame rabbiosa andava verso la cerva e il re gliela offriva; ma il leoncino, correndo prontamente, tornò per difendere la cerva e con le unghie lacerò il corpo del lupo, uccidendolo, e restituì la paurosa cerva al re che sembrava dolersi del suo ritorno. In seguito gli sembrava che due girfalchi provenissero dai mari con nelle zampette dei sonagli che non emettevano suono. Egli li attirava e consegnava loro la cerva e quindi li allontanava. e loro la prendevano, la legavano con una catena d’oro e la portavano, attraverso il mare, in Oriente: e qui ad un grandissimo cane da caccia, così come l’avevano legata, la lasciarono. Il leoncino, avendolo saputo, lamentandosi cominciò a cercarla, e facendosi accompagnare da altri animali , seguitando le orme della cerva, arrivò a trovarla e qui, nascostamente dal cane, sembra che con lei si congiungesse. Ma avendolo il cane scoperto, sembra che li volesse divorare entrambi, ma improvvisamente, essendogli cessata la rabbia, li respedì da dove erano giunti. Ma prima che raggiungessero il monte, in sogno gli apparve che il leoncino e la cerva si tuffassero in una fontana, dalla quale uscirono come bel giovane e piacente donna. Quindi, tornati dal re, venivano benignamente accolti, ed era tanta l’allegria di rivederli, tanto da fargli scoppiare il cuore che all’improvviso si risvegliò. Stupefatto del sogno, si rialzò meravigliandosi assai e vi pensò a lungo; ma poi non curandosene, venne nella sala reale del suo palazzo nello stesso in cui Venere se n’era andata. La dea dell’amore lasciò soli i due giovani, i quali si guardavano fissamente. Florio dapprima chiuse il libro e disse: «Quale straordinaria bellezza ti è cresciuta, o Bianciofiore, in così poco tempo, per cui ora tu mi piaci tanto? Tu prima non mi provocavi un così grande piacere, mentre ora i miei occhi non sono sazi di guardarti fissamente». Biancifiore rispose: «Non so, se non che lo stesso è successo a me nei tuoi confronti. Credo che la virtù dei versi che noi attentamente leggiamo, abbia acceso le nostre menti con un nuovo fuoco e a causato a noi quello che, come abbiamo visto, ha già causato in altri menti (l’innamoramento). Disse Florio: «Credo tu abbia ragione, dal momento che solo tu, tra tutte le cose del mondo, mi piaci». Rispose Biancifiore: «Sicuramente tu non piaci a me meno di quanto io piaccia a te». E parlando, così, con i libri chiusi, vennero scoperti da Racheio, che andava da loro per insegnare, giunse nella camera e rimproverandoli aspramente disse: «Che novità è questa, vedere i libri chiusi? dove è andata l’attenzione verso il vostro studio?». Florio e Biancifiore arrossiti per la vergogna a causa del rimprovero cui non erano abituati, riaprirono i libri ma i loro sguardi, spinti dall’attenzione reciproca che il libro provocava, distolti si rivolgevano alle loro bellezze e la loro lingua, che era solita narrare in modo chiaro i versi studiati, balbettando esitava. Ma Racheio, uomo d’esperienza, vedendo i loro atti, capì che si erano innamorati e se ne dispiacque; ma volle accertarsi della verità, prima di riferire a qualcuno, nascondendosi in luoghi dai quali poteva vederli senza essere visto. E apertamente conobbe appena si allontanò da loro che chiusero di nuovo i libri si abbracciavano, porgendosi casti baci, non facendo altro, dal momento che la loro giovinezza non conosceva ancora i piaceri. E già la passione d’amore li aveva così presi che a stento la freddezza di Diana li avrebbe potuti raffreddare.
E’ evidente come la letteratura conosciuta da Boccaccio operi, soprattutto quando si tratti di Virgilio (Cupido che fa innamorare Enea e Didone come qui fa innamorare Florio e Biancifiore) e dell’amato Dante: vi è in questo passo il riferimento alla Vita Nuova, quando racconta il sogno, definito, come nel poeta fiorentino, “mirabile visione”, ma vi è di più il ricordo del V canto dell’Inferno, quello di Paolo e Francesca in cui “galeotto fu il libro”, come in Florio e Biancofiore ai quali i “santi versi” fecero scoprire l’amore. “Posto che è sempre difficile stabilire il livello di consapevolezza di una citazione non esplicita, specie in presenza di elementi non entrati in un immaginario diffuso come quelli provenienti dall’Eneide e dalla Vita Nuova, è certo che questi passaggi del Filoloco dimostrano quanto intimamente agiscano nel Boccaccio alcune delle sue letture. E, com’è naturale, il suo libro di nutre dei libri ch’egli legge e ha letto” (Corrado Bologna)
Il tenue filo narrativo del romanzo, tuttavia, è appesantito da numerose digressioni, monologhi e disputazioni. Vi è dunque una sovrapposizione di elementi eterogenei in cui convivono elementi pagani e cristiani, magici e miracolosi, fantastici e reali.
Teseida (1341): iniziato a Napoli, ma terminato a Firenze. E’ un poema epico in 12 canti in ottava rima.
Teseo muove guerra contro le Amazzoni, le sconfigge e sposa la loro regina Ippolita, che porta insieme con sé ad Atene la sorella Emilia. In seguito ad un’altra guerra contro i Tebani, Teseo conduce con sé, sempre ad Atene, due amici: Arcita e Polemone. Ambedue s’innamorano di Emilia e nasce fra loro una forte rivalità, tanto da giungere ad un duello. Teseo, per risolvere la questione, indice un torneo, dove i due, ciascuno con cento cavalieri, si fronteggeranno. Al vincitore andrà in sposa Emilia. Arcita vince, ma per le gravi ferite riportate è sul punto di morire. Allora chiama l’amico e gli offre la donna ancora vergine.
E’ il primo poema epico-cavalleresco della letteratura italiana. Boccaccio è consapevole di essere il primo e cerca di colmare la lacuna rifacendosi ai grandi poemi epici classici:,
INVOCAZIONE E ARGOMENTO
(I, 1-5)
O Sorelle Castalie, che nel monte
Elicona contente dimorate
d’intorno al sacro gorgoneo fonte,
sottesso l’ombra delle frondi amate
da Febo, delle quali ancor la fronte
spero d’ornarmi sol che ’l concediate,
le sante orecchie a’ miei preghi porgete,
e quegli udite come voi dovete.
E’ m’è venuta voglia con pietosa
rima di scriver una storia antica,
tanto negli anni riposta e nascosa,
che latino autor non par ne dica,
per quel ch’i’ senta, in libro alcuna cosa.
Dunque sì fate che la mia fatica
sia grazïosa a chi ne fia lettore,
o in altra maniera ascoltatore.
Siate presenti, o Marte rubicondo,
nelle tue armi rigido e feroce,
e tu, Madre d’Amor, col tuo giocondo
e lieto aspetto, e ’l tuo Figliuol veloce
co’ dardi suoi possenti in ogni mondo;
e sostenete la mano e la voce
di me, che intendo i vostri effetti dire
con poco bene e pien d’assai martíre.
E voi, nel cui cospetto il dir presente
forse verrà, com’io spero ancora,
quant’io più posso prego umilemente,
per quel signor ch’e’ gentili innamora,
che attendiate con intera mente:
voi udirete com’egli scolora
ne’ casi avversi ciascun suo seguace,
e come dopo affanno e’ doni pace.
E questo con assai chiara ragione
comprenderete, udendo raccontare
d’Arcita i fatti e del buon Palemone,
di real sangue nati, come appare,
e amenduni Tebani, e a quistione,
parenti essendo, per superchio amare
Emilia bella, vennero, Amazzona,
d’onde l’un d’essi perdè la persona.

Emilia nel roseto, manoscritto francese del 1460 ca.
O Muse, che vivete felici presso il monte Elicona, intorno alla fonte gorgonea, all’ombra delle frondi (d’alloro) amate da Apollo, delle quali spero ancora di ornarmi la fronte, se solo lo permetterete: prestate orecchio alle mie preghiere e ascoltatele, come e giusto. // Mi è venuta voglia di scrivere in forma umile una storia antica, a tal punto messa da parte e dimenticata negli anni, che, per quanto ne so, sembra che alcun autore latino ne parli in un qualche libro; fate dunque in modo che il mio racconto sia gradito a chi ne sarà lettore o in altro modo ascoltatore. // Siate presenti, o Marte dalle guance rosse, rigido e feroce nel condurre le tue armi, e tu, Venere, con il tuo aspetto gioioso e lieto, e Cupido, il tuo figlio veloce, che con i suoi dardi è presente in tutto il mondo; e sostenete la mano e il canto di me, che intendo raccontare gli effetti che voi producete, dai quali viene poco bene e molto dolore. // E voi, che forse come io spero ancora, udirete questo racconto, vi prego umilmente per quanto è possibile, in nome di quel dio che fa innamorare le genti, che porgiate tutta la vostra attenzione; voi ascolterete come egli fa sbiancare il volto nelle sorti avverse ogni suo seguace, e come dopo il travaglio egli doni pace. // E questo vedrete dimostrato assai chiaramente, sentendo raccontare le vicende di Arcita e del buon Palemone, nati, come pare, da famiglia reale, ed entrambi tebani, e (sentirete raccontato) di come, pur essendo parenti, si trovarono in conflitto, a causa dell’eccessivo amore di entrambi per la bella amazzone Emilia; a causa di questo conflitto, uno dei due morì.

Giovanni dal Ponte: Episodi finali del Teseida: Arcita morente, il matrimonio tra Emilia e Polemone, la festa di nozze (1420-1425)
Infatti intitola il suo poema Teseida, come Virgilio e Stazio intitolarono i loro poemi epici Eneide e Tebaide; allo stesso modo li divide in XII canti e sanziona in modo definitivo l’ottava come misura metrica per il poema. In lui operano non solo la cultura classica, ma anche il romanzo d’amore (nei primi due viene spiegato l’antefatto, dal III al X la storia d’amore, l’XI e il XII il compianto di Archita, i riti funebri, e le perplessità di Emilia che vorrebbe conservare la castità, ma viene convinta a sposare Polemone).
Periodo fiorentino
Comedìa delle ninfe fiorentine (o Ninfale d’Ameto) (1342) è un prosimetro, cioè una narrazione in prosa, inframmezzata da componimenti in terzina cantati da vari personaggi.

Edizione della Comedia delle ninfe fiorentine del 1558
Ameto, un rozzo pastore, un giorno incontra delle ninfe devote a Venere e si innamora di una di esse, Lia. Nel giorno della festa della dea le ninfe si raccolgono intorno al pastore e gli raccontano le loro storie d’amore. Alla fine Ameto è immerso in un bagno purificatore e comprende così il significato allegorico della sua esperienza: infatti le ninfe rappresentano la virtù e l’incontro con esse lo ha trasformato da essere rozzo e animalesco in uomo.
AMETO INCONTRA LE NINFE
Sopra le nate erbette disteso il grave corpo, alle soavi aure aperse il ruvido seno; e, cacciatisi dal viso i sucidi sudori con la rozza mano, l’arida bocca rinfrescò con l’umide frondi delle verdi piante; e ricreato alquanto, colli suoi cani, ora l’uno ora l’altro chiamando, cominciò a ruzzare; e quindi levato in piedi, trascorrendo tra loro or qua or là, all’uno la gola, all’altro la coda e qual per li piedi tirando scherzando, dalla lasciviente turba da diverse parti era assalito; e talvolta i non ricchi drappi stracciati da quella il moveano ad ira: in questo trastullo, ora stendendoli in terra, ora sé fra loro stendendo, si stava. Ma, mentre che così prendeva in nuova maniera sollazzo, essendo il sole caldissimo, subito dalla vicina riva pervenne a’ suoi orecchi graziosa voce, in mai più non udita canzone; per che egli, avendo di ciò maraviglia, fra sé disse: “Iddii sono in terra discesi; e io più volte oggi l’ho conosciuto, ma nol credea; i boschi più pieni d’animali si sono dati che non soleano e Febo più chiari n’ha pòrti i raggi suoi, e l’aure più soavemente m’hanno le fatiche levate, e l’erbe e i fiori, in quantità grandissima cresciuti più che l’usato, testimoniano la loro venuta. Essi, per lo caldo affannati come io, qui vicini si posano e usano i celestiali diletti colle loro voci, forse avvilendo i mondani. Io non ne vidi mai alcuno; e, disideroso di vederli, se così sono bella cosa come si dice, ora li andrò a vedere, il sole guidante i passi miei; e, acciò che mi sieno benivoli, se di preda li vedrò vòti, della mia abbondevoli li farò, se vorranno”. E con fatica a’ cani, a quali con lusinghe, a quali con occhi torvi e con voce sonora mazze mostrando, puose silenzio e verso quella parte, ove il canto estimava, porse, piegando la testa sopra la manca spalla, l’orecchio ritto; e, ascoltando alquanto, rivolto a’ cani, quelli con gli usati legami attaccati, alla presente quercia raccomandò, e, preso uno noderoso bastone, col quale, portando la pesante preda, a’ suoi omeri alcuno alleggiamento porgeva, verso quella parte, dove udiva la dolce nota, volse i passi suoi; e, colla testa alzata, non prima le chiare onde scoperse del fiumicello che egli all’ombra di piacevoli arbuscelli, fra’ fiori e l’erba altissima, sopra la chiara riva vide più giovinette delle quali, alcuna mostrando nelle basse acque i bianchi piedi, per quelle con lento passo vagando s’andavano. Altre, posti giuso i boscherecci archi e gli strali, sopra quelle sospesi i caldi visi, sbracciate, colle candide mani rifaceano belli con le fresche onde. E, alcune, data da’ loro vestimenti da ogni parte all’aure via, sedeano attente a ciò che una di loro più gioconda sedendo cantava; dalla quale conobbe la canzone prima alle sue orecchie esser venuta. Né più tosto le vide che, loro dee stimando, indietro timido ritratto, s’inginocchiò e, stupefatto, che dir si dovesse non conoscea. Ma i giacenti cani delle riposanti ninfe, levati di colui alla vista, esso forse pensando fiera, veloci, con alto latrato gli corsero sopra; ed egli, poiché fuggire non gli valse, sopraggiunto da quelli, col bastone, con le mani, con la fuga e con le rozze parole, da sé, quanto poteva, cessava i morsi loro; le quali non conosciute dagli orecchi usati ricevere i donneschi suoni, più fieri, lui, già più morto per paura che vivo, seguieno; ed egli, rimembrandosi d’Atteone, con le mani si cercava per le corna la fronte, in sé dannando il preso ardire di volere riguardare le sante dee. Ma le ninfe, turbato il loro sollazzo per la canina rabbia, levate con alte voci, appena in pace puosero i presti cani e lui con piacevole riso, conosciuto suo essere, racconsolando, feciono sicuro.

Desco da parto con scene dalla Comedia delle ninfe fiorentine
(Ameto), disteso sopra l’erbetta appena nata, tirò un ampio respiro nell’aria rinfrescante e, passandosi la rozza mano sul volto, cacciò il sudicio sudore e si rinfrescò la bocca con le foglie umide delle piante; dopo essersi riposato, cominciò a giocare con i suoi cani, chiamandone ora uno ora l’altro, e alzatosi in piedi, correndo in mezzo a loro, ad uno afferrava la gola, ad un altro tirava la coda, ad un altro ancora tirava le gambe scherzando e allo stesso tempo era assalito dalla scherzosa turba dei cani, e talvolta i suoi non ricchi indumenti stracciati da essi lo spingevano ad irarsi: in questo sollazzo, ora gettandoli in terra, ora gettandosi in mezzo a loro, trascorreva il tempo. Ma mentre si divertiva con nuovi giochi, essendo il sole già alto, gli giunse all’orecchio una voce piena di grazia dal fiume vicino, per cui, meravigliandosi, disse fra sé: “Sono scesi gli dei, e oggi l’ho sentito e l’ho pensato, ma non ci prestavo attenzione: i boschi si sono riempiti d’animali più del solito e Febo, dio del sole, ci ha regalato raggi più splendenti, e le brezze, soffiando più dolcemente, mi hanno alleviato le fatiche. Gli dei, accaldati come me, si riposano qui vicino e usano piacevoli celestiali con le loro voci , forse per umiliare i mondani. Io non ne ho visto mai nessuno e desidero vederli, se sono così belli ora lo sperimentò con la guida della luce del sole e affinché mi siano benevoli, se li vedrò senza preda, li renderò ricchi con la mia, se vorranno.” E con fatica impose il silenzio ai cani, alcuni gratificandoli, altri mostrando loro gli occhi torti, altri ancora a colpi di mazza e urla e si avviò dove pensava provenisse il canto, volgendosi verso sinistra, l’orecchio attento per capire la direzione. Dopo aver ascoltato i canti, assicurò i cani ad una quercia con i soliti guinzagli e si aiutò con un bastone nodoso che gli alleggeriva il peso della preda, avviandosi da dove giungevano le celestiali voci. Con la testa dritta, non prima di aver scoperto all’ombra di ombrosi alberi un ruscello tra fiori ed alta erba, e sopra il rivo vide giovinette di cui alcune mostravano i bianchi piedi immersi nell’acqua, altre camminavano con passo lento. Altre, posti in terra gli archi e le frecce, con le braccia nude e le bianche mani si pulivano il viso con l’acqua fresca. Alcune avevano allentato le loro vesti, affinché la frescura dell’aria vi penetrasse, facendo attenzione al canto che una di loro modulava, canto che precedentemente Ameto aveva udito. Non appena le vide, timidamente indietreggiò e s’inginocchiò non sapendo cosa dir loro, reputandole delle dee. Ma i cani delle ninfe, accortisi della sua presenza e credendo lui una preda selvaggia, velocemente lo assalirono e a nulla gli valse la corsa che, sopraggiunto cercava con il bastone, con le urla con le mani, con la forza di evitare i morsi loro, ma i cani, non riconoscendo la sua voce, abituati a quelle femminili delle ninfe, non cedevano e nonostante cercasse di scappare già si vedeva morto, rimpiangendo di non essere Atteone, cercandosi le corna di cervo nella fronte e maledicendosi per aver voluto vedere le dee. Ma le ninfe, turbato il loro piacere per l’abbaiare dei loro cani, richiamatoli, li calmarono e, saputo chi fosse, mitigarono la paura di Ameto, con piacevoli sorrisi.
Il passo va letto come esemplificazione del concetto rozzezza/ virtù: se infatti nella prima parte anche linguisticamente (grave corpo, ruvido seno, sudici sudori) Ameto rappresenta la ferinità (il suo mescolarsi con i cani) il tutto inserito in un paesaggio idillico, nella seconda il canto funge da richiamo civilizzatore e se anche i cani delle ninfe lo rifiutano e perché non si è ancora tuffato nelle acque che lo trasformeranno in un giovane degno dell’amore di Lia.
Ma l’opera è importante perché anticipa a struttura tipica che poi sarà del Decameron: una volta che Ameto avrà dichiarato l’amore per Lia, quest’ultima inviterà le altre ninfe, nelle ore calde della giornata a raccontare le loro vicende d’amore. Vi è cioè l’idea di raccontare delle storie all’interno di una cornice. Anche qui è evidente l’influenza di Dante: ne è spia l’allegoria delle virtù nelle ninfe.
Amorosa visione: (1343) poema in terzine in 50 canti.
Il protagonista (Boccaccio stesso) è colpito da una freccia da Cupido. S’addormenta e sogna di trovarsi in un bosco dove incontra una donna, Fiammetta. Ella lo porta di fronte ad un castello che ha due porte, una stretta, che conduce alle virtù, l’altra larga promette fama e ricchezza. Convinto da due giovani, il protagonista imbocca la seconda e attraversa sale dove sono dipinte i vizi e le virtù. Quindi raggiunge una fontana, le cui figure rimandano le virtù cardinali, i tre tipi d’amore (carnale, venale, puro) e tre animali (superbia, avarizia, lussuria). Quindi si trova in un giardino, dove vede tre donne e tra di esse Fiammetta. S’allontanano in luogo solitario e cerca di possederla. A questo punto finisce il sogno e la guida lo rimprovera affermando che potrà avere Fiammetta dopo aver imboccato la via delle virtù.
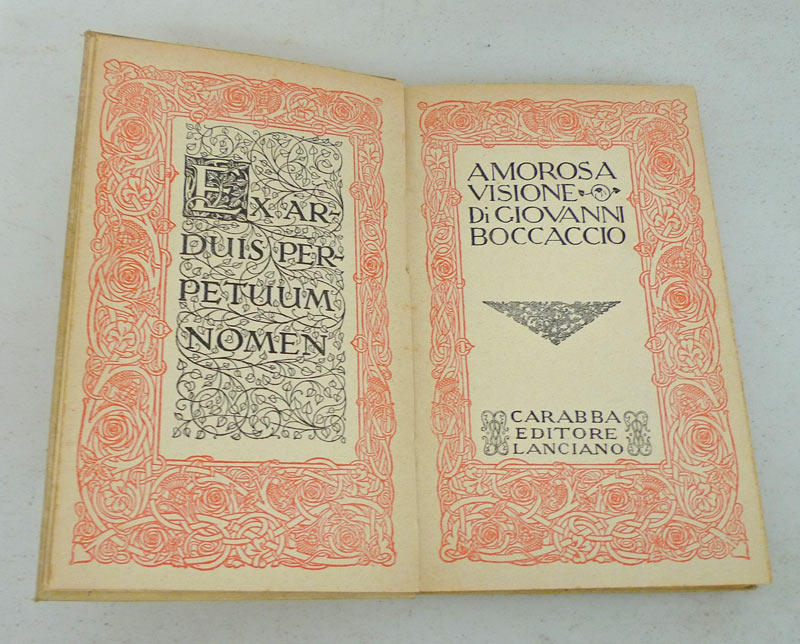
Edizione del 1911 dell’Amorosa visione
L’opera ebbe un enorme successo nel periodo in cui fu scritta proprio perché rappresentava allora un processo allegorico assai diffuso e che aveva avuto in Dante un notevolissimo predecessore. Il suo successo è inoltre testimoniato dal fatto che gli stessi Trionfi del Petrarca siano posteriori e quindi abbiano influenzato il grande poeta. Oggi, invece, risultano di difficile lettura: l’allegoria prevale sulla narrazione, la descrizione delle virtù è troppo dettagliata, l’imitazione dantesca è forse troppo spinta. Ma non bisogna dimenticare che l’opera s’inserisce a pieno titolo nella cultura medievale.
Elegia di Madonna Fiammetta (1344): romanzo.
La protagonista è una nobildonna napoletana che racconta, in prima persona, la sua vicenda sentimentale: innamoratasi al primo sguardo di Panfilo, mercante fiorentino identificabile con l’autore, vive una stagione di felicità interrotta però dalla partenza dell’amante per Firenze. La promessa infranta di Panfilo di un successivo ritorno a Napoli è il primo evento di una serie di peripezie: la donna apprende prima che Panfilo si è sposato, ma quando è in procinto di riconquistare una rassegnata serenità, viene a sapere che quella notizia era falsa e che l’amato ha invece una relazione con una donna fiorentina. Folle di gelosia, Fiammetta vuol darsi la morte ma ciò le viene impedito dalla vecchia nutrice. Arriva infine la notizia di un prossimo ritorno a Napoli dell’amato e Fiammetta torna nuovamente a sperare.
L’opera potrebbe considerarsi un romanzo psicologico, composto da nove capitoli più un prologo. Nel prologo l’autore dichiara che il suo scritto è dedicato alle donne, donne cortesi, appartenenti alla cerchia di Roberto d’Angiò e con esperienze d’amore. Solo così potranno comprendere il romanzo a loro destinato. La novità sta nell’attenta analisi psicologica della protagonista, che si muove tra speranze e delusioni.

Dante Gabriel Rossetti: Fiammetta (1878)
FIAMMETTA S’INNAMORA DI PANFILO
Mentre che io in cotal guisa, poco altrui rimirando, e molto da molti rimirata, dimoro, credendo che la mia bellezza altrui pigliasse, avvenne che l’altrui me miseramente prese. E già essendo vicina al doloroso punto, il quale o di certissima morte o di vita più che altra angosciosa dovea essere cagione, non so da che spirito mossa, gli occhi con debita gravità elevati, intra la multitudine de’ circustanti giovini con acuto riguardamento distesi; e oltre a tutti, solo e appoggiato ad una colonna marmorea, a me dirittissimamente uno giovine opposto vidi; e, quello che ancora fatto non avea d’alcuno altro, da incessabile fato mossa, meco lui e li suoi modi cominciai ad estimare. Dico che, secondo il mio giudicio, il quale ancora non era da amore occupato, egli era di forma bellissimo, negli atti piacevolissimo e onestissimo nell’abito suo, e della sua giovinezza dava manifesto segnale crespa lanugine, che pur mo’ occupava le guance sue; e me non meno pietoso che cauto rimirava tra uomo e uomo. Certo io ebbi forza di ritrarre gli occhi da riguardarlo alquanto, ma il pensiero, dell’altre cose già dette estimante, niuno altro accidente, né io medesima sforzandomi, mi poté tòrre. E già nella mia mente essendo l’effigie della sua figura rimasa, non so con che tacito diletto meco la riguardava, e quasi con più argomenti affermate vere le cose che di lui mi pareano, contenta d’essere da lui riguardata, talvolta cautamente se esso mi riguardasse mirava.
Ma intra l’altre volte che io, non guardandomi dagli amorosi lacciuoli, il mirai, tenendo alquanto più fermi che l’usato ne’ suoi gli occhi miei, a me parve in essi parole conoscere dicenti: “O donna, tu sola se’ la beatitudine nostra”. Certo, se io dicessi che esse non mi fossero piaciute, io mentirei; anzi sì mi piacquero, che esse del petto mio trassero un soave sospiro, il quale veniva con queste parole: “E voi la mia”. Se non che io, di me ricordandomi, gli le tolsi. Ma che valse? Quello che non si esprimea, il cuore lo ’ntendeva con seco, in sé ritenendo ciò che, se di fuori fosse andato, forse libera ancora sarei. Adunque, da questa ora innanzi concedendo maggiore arbitrio agli occhi miei folli, di quello che essi erano già vaghi divenuti li contentava; e certo, se gl’iddii, li quali tirano a conosciuto fine tutte le cose, non m’avessero il conoscimento levato, io poteva ancora essere mia, ma ogni considerazione all’ultimo posposta, seguitai l’appetito, e subitamente atta divenni a potere essere presa; per che, non altramente il fuoco se stesso d’una parte in un’altra balestra, che una luce, per un raggio sottilissimo trascorrendo, da’ suoi partendosi, percosse negli occhi miei, né in quelli contenta rimase, anzi, non so per quali occulte vie, subitamente al cuore penetrando, se ne gìo. Il quale, nel sùbito avvenimento di quella temendo, rivocate a sé le forze esteriori, me palida e quasi freddissima tutta lasciò. Ma non fu lunga la dimoranza, che il contrario sopravvenne, e lui non solamente fatto fervente sentii, anzi le forze tornate ne’ luoghi loro, seco uno calore arrecarono, il quale, cacciata la palidezza, me rossissima e calda rendé come fuoco, e quello mirando onde ciò procedeva, sospirai. Né da quell’ora innanzi niuno pensiero in me poteo, se non di piacergli.
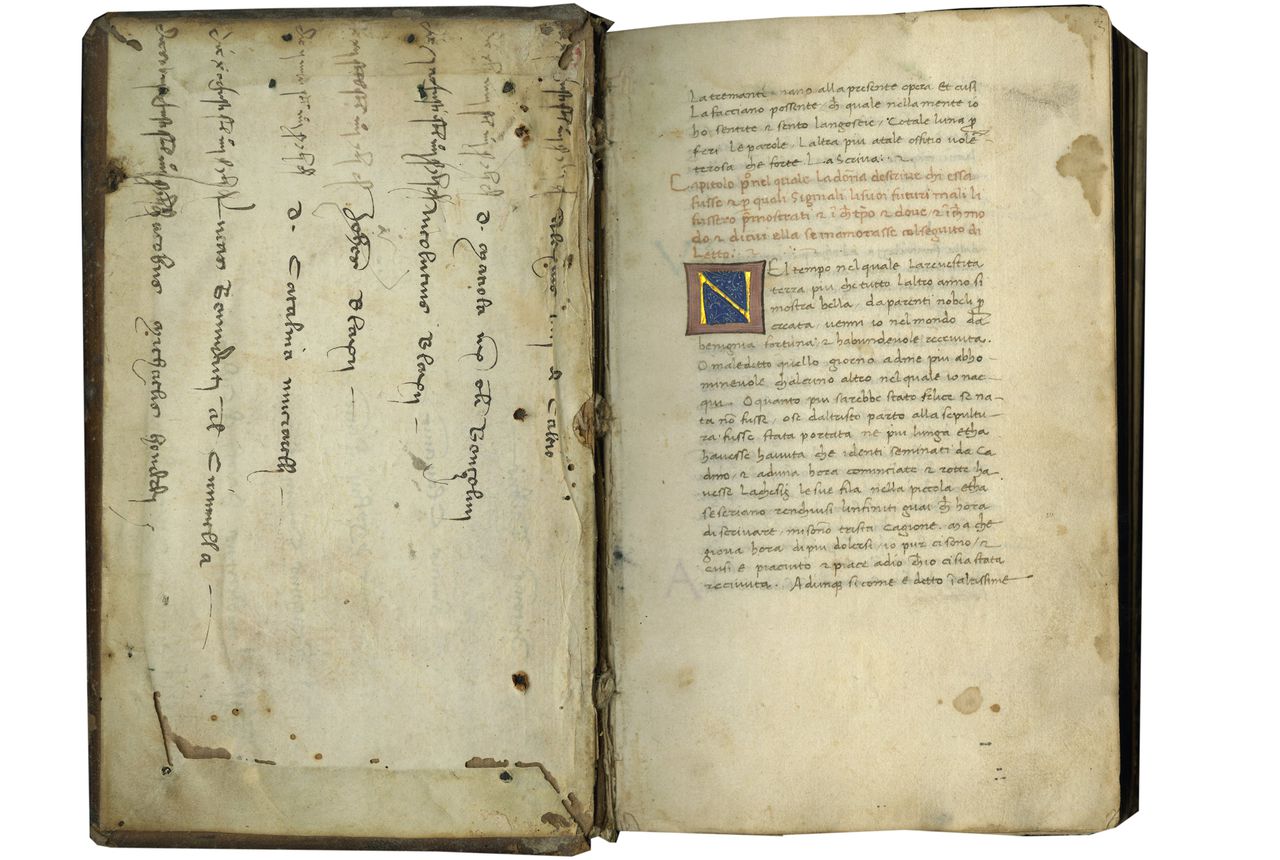
Manoscritto miniato su carta dell’Italia centrale del 1458
(Fiammetta si trova in chiesa dove si sta celebrando la Pasqua). Mentre io sto in quell’atteggiamento di chi è abituato ad essere ammirato più che ad ammirare, pensando che la bellezza potesse catturare, avvenne che la bellezza altrui catturasse me. E già essendo vicina al momento che doveva esser motivo o di morte certa o di una vita piena d’angoscia, non so che da sentimento spinta, alzati gli occhi con composta devozione, alzai gli occhi guardando attentamente tra i molti giovani presenti, e, al di là di tutti un giovane solo che stava di fronte a me appoggiato ad una colonna di marmo e, cosa che non avevo fatto mai con alcun altro, spinta da un inevitabile destino, cominciai ad apprezzare tra me la sua persona ed i suoi atteggiamenti. Dico che, secondo il mio giudizio, non ancora occupato dall’amore, egli era d’aspetto bellissimo, piacevolissimo negli atti ed onestissimo nel comportamento, e della sua giovinezza rendeva evidente una barbetta che solo da poco tempo ricopriva le guance e mi guardava, fra una persona e l’altra, timidamente e in modo da destare tenerezza. Io trovai la forza di distogliere gli occhi dal fissarlo troppo, ma nessun altro evento, nonostante io compissi gli sforzi, potè deviare il pensiero dall’apprezzamento delle sue qualità sopra descritte. Ed essendosi impressa definitivamente la sua immagina nella mia mente, non so con quale segreto piacere tra me continuavo a figurarmela, e quasi confermando come vere, con maggiori argomenti, le qualità che di lui mi apparivano, talvolta con cautela osservavo se lui continuava a fissarmi, contenta di essere da lui guardata.
Ma ogni volta che io, non prendendo difesa dai lacci d’amore, lo guardavo lasciando i miei occhi fissi nei suoi più del dovuto, mi sembrava di scorgere in essi parole che dicevano: “Donna, tu sola sei la nostra beatitudine”. Certo se dicessi che tale parle non mi fossero piaciute, mentirei; anzi mi piacquero a tal punto che emisi un dolce sospiro che diceva “E voi la mia”. Se non che io, tornando me stessa, sottrassi le parole al sospiro. ma a cosa valse? Quello che non diceva, lo capiva il cuore, trattenendolo dentro di sé, che se fosse andato fuori, forse sarei libera. Dunque da questo momento in poi, concedendo maggiore libertà ai miei occhi folli, li appagavo di ciò di cui essi erano desiderosi; e certamente se gli dei, che muovono ogni cosa ad un determinato fine, non mi avessero privata della capacità di discernere, io sarei ancora in me; ma nonostante ogni proponimento fatto, assecondai il desiderio e subito mi misi nella condizione di essere catturata, per la qual cosa, come il fuoco scaglia se stesso da una parte all’altra, (così) una luce partì dai suoi occhi e traversando un raggio sottilissimo colpì i miei, ma non si accontentò di fermarsi in essi e anzi, non so per quali nascoste vie, se ne andò (da loro) penetrando subito nel cuore. Il cuore, spaventato dall’improvviso sopraggiungere di quella luce, richiamate a sé le forze esterne, mi lasciò pallida e quasi morta. Ma non fu lunga l’attesa, che sopraggiunse un evento contrario e non sentii il cuore solamente reso fervente, anzi le forze tornate nelle loro membra portarono con sé un calore, il quale cacciato il pallore mi rese rossissima e calda come il fuoco e chiedendomi meravigliata da dove quel fenomeno provenisse, sospirai. Nè da quel momento in poi potei avere nessun pensiero se non di piacere a lui.
Tuttavia, pur grazie ad un vero e proprio lavoro di scavo sull’animo femminile, l’opera, a livello di richiami, le Heroides di Ovidio, la Vita nuova di Dante, è ancorata ad una visione del mondo tipicamente medievale.

Anonimo: Ritratto di Boccaccio (1568)
Ninfale fiesolano (1346): poemetto eziologico di 473 ottave.
Il pastore Africo corteggia, ma inutilmente la ninfa Mensola che appartiene al corteo di Diana, dea della caccia, e perciò votata alla castità. Con l’aiuto di Venere, dopo essersi travestito da donna, Africo riesce ad avvicinarla e a possederla. Temendo la punizione della dea, Mensola sfugge Africo, nonostante sia innamorata di lui, e il giovane, disperato, si uccide precipitandosi nelle acque del fiume che prende il suo nome. La ninfa partorisce un bambino, Pruneo; ma, nel tentativo di sfuggire all’ira di Diana che ha scoperto la sua trasgressione, anche Mensola cade in un ruscello e viene trasformata in acqua dalla dea. Si ripete così la vicenda di Mugnone, il nonno di Africo innamorato di una ninfa e trasformato anch’egli da Diana in un fiume. Pruneo sarà allevato dai genitori di Africo e diventerà ministro di Atlante, mitico fondatore di Fiesole.
E’ forse l’opera che mescolando la tradizione popolare con quella classica permette a Boccaccio un più accentuato realismo rispetto alle opere precedenti. Sono descritti con maggiore proprietà non solo gli ambienti campestri che si richiamano alla poesia elegiaca, ma anche reazioni e sentimenti degli stessi protagonisti.
AFRICO E MENSOLA
Mentre che tal consiglio si teneva,
Un giovinetto, ch’Affrico avea nome,
Il qual forse vent’anni o meno aveva,
Senz’aver barba ancora, e le sue chiome
Bionde e crespe, e ’l suo viso pareva
Un giglio o rosa, ovver un fresco pome;
Costui ind’oltre abitava col padre,
Senz’altra vicinanza, e con la madre.
Il giovine era quivi in un boschetto
Presso a Dïana, quando il ragionare
Delle ninfe sentì, che a suo diletto
Ind’oltre s’era andato a diportare:
Perchè fattosi innanzi il giovinetto
Dopo una grotta si mise ascoltare,
Per modo che veduto da costoro
Non era, ed e’ vedeva tutte loro.
Vedea Dïana sopra all’altre stante
Rigida nel parlare e nella mente,
Con le saette e l’arco minacciante,
E vedeva le ninfe parimente
Timide e paurose tutte quante,
Sempre mirando il suo viso piacente.
Ognuna stava cheta, umíle e piana
Pe ’l minacciare che facea lor Dïana.
Poi vide che Dïana fece in piede
Levar dritta una ninfa, che Alfinea
Aveva nome, però ch’ella vede
Che più che alcun’altra tempo avea,
Dicendo: «Ora m’intenda qual qui siede:
Io vo’ che questa qui in mio loco stea,
Però ch’intendo partirmi da voi,
Sì che com’io obbedita sia poi.»
Affrico stante costoro ascoltando,
Una ninfa a’ suoi occhi gli trascorse,
La quale alquanto nel viso mirando,
Sentì ch’amor per lei al cor gli corse,
Che gli fer sentir gioia sospirando
Le fiaccole amorose che gli porse;
E un sì dolce disio, che già saziare
Non si potea della ninfa mirare.
E fra sè stesso dicea: “Chi saria
Di me più grazioso e più felice,
Se tal fanciulla io avessi per mia
Isposa? chè per certo il cor mi dice
Che al mondo sì conlento uom non saria;
E se non che paura mel disdice
Di Dïana, io l’avrei per forza presa,
Che l’altre non potrebbon far difesa.”
Lo innamorato amante in tal maniera
Nascoso stava in fra le fresche fronde,
Quando Dïana veggendo che sera
Già si faceva, e che ’l sol si nasconde,
Che già perduta avea tutta la spera,
Con le sue ninfe assai liete e gioconde
Si levar ritte, e al poggio salendo
Di dolce melodia canzon dicendo.
Affrico quando vide che levata
S’era ciascuna, e simil la sua amante,
Udì che da un’altra fu chiamata:
Mensola adianne, e quella su levante,
Con l’altre tosto sì si fu inviata:
E così via n’andaron tutte quante,
Ognuna a sua capanna si tornoe,
Poi Diana si partì e lor lascioe.
Avea la ninfa forse quindici anni,
Biondi com’oro e grandi i suoi capelli,
E di candido lin portava i panni;
Due occhi ha in testa rilucenti e belli,
Che chi gli vede non sente mai affanni,
Con angelico viso e atti snelli,
E in man portava un bel dardo affilato:
Or vi ritorno al giovane lasciato;
Il qual soletto rimase pensoso
Oltramodo dolente del partire
Che fe’ la ninfa col viso vezzoso,
E ripetendo il passato disire,
Dicendo: “Lasso a me, che ’l bel riposo
C’ho ricevuto mi torna in martire,
Pensando ch’io non so dove in qual parte
Cercarmene giammai, o con qual arte.

Libero Andreotti: Africo e Mensola (1933)
Mentre aveva luogo il concilio delle ninfe, un giovane di nome Africo, dell’età di vent’anni o forse meno, ancora imberbe, dai capelli biondi e ricciuti ed un viso che sembrava un giglio o una rosa o un fresco frutto, (ebbene) costui abitava poco più in là col padre e con la madre, e non aveva altri vicini. // Il giovane si trovava in un boschetto vicino a Diana, quando udì il parlare delle ninfe, mentre era andato a passeggiare per svago; essendosi avvicinato a causa di ciò, il giovane si mise ad ascotare dietro una roccia, in modo tale da vedere tutte le ninfe e non essere visto. // Vedeva Diana che stava in posizione di preminenza sulle altre, severa nelle parole e nell’animo, mentre le minacciava con le saette e l’arco; e vedeva le ninfe tutte quante ugualmente timide e timorose, che contemplavano il bel viso di Diana e che stavano tutte in silenzio, umili e sottomesse, a causa dell’atteggiamento minaccioso di Diana nei loro confronti. // Poi vide che Diana ordinò ad una ninfa di nome Alfinea di alzarsi dritta in piedi, in quanto si accorse che quella aveva più anni delle altre, e disse: «Ora mi ascolti chiunque sieda qui: io voglio che questa ninfa prenda il mio posto, poiché io ho intenzione di allontanarmi da voi, cosicché voi ubbidiate in seguito a lei, così come (ora) a me.» // Mentre Africo le stava ascoltando, tra le altre ninfe gliene appare una e, contemplando a lungo il suo viso, si accorse che Amore lo stava facendo innamorare di lei, tanto che produsse in lui, cher già sospirava, il fuoco della passione: ciò gli procurò un desiderio così dolce, che non era mai appagato dal guardare quella ninfa. // E fra sé diceva: “Chi sarebbe più privilegiato e più felice di me se potessi sposare quella fanciulla? Perché il cuore mi dice che certamente al mondo un uomo così fortunato; e se non fosse che la paura che provo nei confronti di Diana me lo sconsiglia, io la costringerei con la forza, perché le altre non potrebbero difenderla.” // L’amante innamorato stava nascosto fra i freschi rami, quando Diana, accorgendosi che ormai si stava facendo sera e che il sole stava calando e l’intero globo era già nascosto sotto la linea dell’orizzonte, insieme alle sue ninfe si alzarono in piedi e salirono sull’altura, cantando canzoni di belle melodie. // Africo, quando vide che ognuna delle ninfe si era alzata, ed anche la sua amata, la sentì chiamare da un’altra: «Mensola, andiamocene»; e quella, alzandosi, raggiunse immediatamente le altre. E così se ne andarono via tutte quante: ognuna tornò alla sua capanna e poi Diana si allontanò e le lasciò. // La ninfa aveva forse quindici anni; i suoi capelli erano biondi e lunghi, e portava vestiti di candido lino; (aveva) gli occhi luminosi e belli, (tanto) che chi li guarda non è oppresso da preoccupazioni; aveva un viso angelico e i suoi gesti (erano) pieni di grazia, e in mano portava una bella freccia affilata. Ora torno a raccontarvi del giovane Africo che abbiamo lasciato. // Costui rimase da solo a pensare, alquanto addolorato per l’allontanamento della ninfa dal bel viso e, rimpiangendo il desiderio passato diceva: “Povero me, che il momento di gioia che ho appena vissuto si trasforma ora per me in sofferenza, perchè penso che non saprei dove o in qual luogo cercare quella gioia ormai, o con quale espediente.”

Libero Andreotti: Africo e Mensola (1933)
Al di là della convenzionalità del testo in cui si affronta il tema della castità (Diana) e dell’amore (Venere), quello che qui colpisce e la facilità versificatoria la quale sembra rifarsi ai cantari popolari. D’altra parte anche questa volta ricorre al mito delle ninfe come votate alla castità, in quanto ancelle di Diana (si veda la Caccia di Diana), mentre vuole esaltare l’amore “naturale” comandato da Venere, ma al di là della realizzazione di esso, quello che qui conta è la maggiore capacità, grazie al distacco, della narrazione in sé. E’ evidente, d’altra parte, che il tema sia mescolato con quello eziologico ad imitazione ovidiana, laddove appunto si parla di metamorfosi con cui si dà spiegazione ai fiumi fiorentini.
DECAMERON
Il capolavoro di Boccaccio s’inserisce ed interpreta in modo mirabile il concetto secondo il quale la narrazione non è solo una rappresentazione del mondo così com’è, ma una sua interpretazione, secondo le esigenze narrative dell’autore.
Per far questo Boccaccio raccoglie, non si sa quanto consapevolmente, nel suo lavoro una serie di fonti che potremo qui sintetizzare:
- Tradizione classica, soprattutto Ovidio ed il romanzo di Apuleio L’asino doro o le Metamorfosi;
- Il romanzo cortese-cavalleresco sia in senso alto con i romanzi francesi/cortesi, sia in senso popolare, con la loro riproposizione da giullari di corte e saltimbanchi di piazza);
- I libri di cronaca contemporanea;
- Il Novellino, raccolta anonima del XIII sec.
- Una conoscenza (probabilmente indiretta) della novellistica araba (Le Mille e una notte);
- La Comedìa dantesca, da lui follemente amata.
Il titolo dell’opera, termine coniato dalla lingua greca, sta a significare “di dieci giorni”: dieci sono infatti i giorni in cui i giovani dell’“onesta brigata” raccontano cento novelle, lontano dalla terribile peste (seppur la loro permanenza sarà di due settimane).

Edizione del Decameron del 1813
La struttura con cui si struttura l’opera presenta:
Un proemio, con un narratore di primo grado che dedica l’opera alle donne e ne spiega il motivo;

Franz Xaver Winterhalter: Il Decameron (1837)
PROEMIO
Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente richesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hannol trovato in alcuni; fra’ quali, se alcuno mai n’ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Per ciò che, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato d’altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo, si richiedesse, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne io ne fossi lodato e da molto più reputato, nondimeno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire, certo non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito: il quale, per ciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non m’era spesse volte sentir mi facea. Nella qual noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d’alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avenuto che io non sia morto. Ma sì come a Colui piacque il quale, essendo Egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine, il mio amore, oltre a ogn’altro fervente e il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né piegare, per se medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé nella mente m’ha al presente lasciato quel piacere che egli è usato di porgere a chi troppo non si mette ne’ suoi più cupi pelaghi navigando; per che, dove faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser rimaso.
Ma quantunque cessata sia la pena, non per ciò è la memoria fuggita de’ benifici già ricevuti, datimi da coloro a’ quali per benivolenza da loro a me portata erano gravi le mie fatiche; né passerà mai, sì come io credo, se non per morte. E per ciò che la gratitudine, secondo che io credo, trall’altre virtù è sommamente da commendare e il contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero dir mi posso, e se non a coloro che me atarono, alli quali per avventura per lo lor senno o per la loro buona ventura non abisogna, a quegli almeno a’ quali fa luogo, alcuno alleggiamento prestare. E quantunque il mio sostentamento, o conforto che vogliam dire, possa essere e sia a’ bisognosi assai poco, nondimeno parmi quello doversi più tosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto.
E chi negherà questo, quantunque egli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare? Esse dentro a’ dilicati petti, temendo e vergognando, tengono l’amorose fiamme nascose, le quali quanto più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che l’hanno provate: e oltre a ciò, ristrette da’ voleri, da’ piaceri, da’ comandamenti de’ padri, delle madri, de’ fratelli e de’ mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, seco rivolgendo diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre sieno allegri. E se per quegli alcuna malinconia, mossa da focoso disio, sopraviene nelle lor menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa: senza che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere; il che degli innamorati uomini non avviene, sì come noi possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleggiare o da passar quello, per ciò che a loro, volendo essi, non manca l’andare a torno, udire e veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giucare o mercatare: de’ quali modi ciascuno ha forza di trarre, o in tutto o in parte,l’animo a sé e dal noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o con altro, o consolazion sopraviene o diventa la noia minore.
Adunque, acciò che in parte per me s’amendi il peccato della fortuna, la quale dove meno era di forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, per ciò che all’altre è assai l’ago e ‘l fuso e l’arcolaio, intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e di tre giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità fatta, e alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto. Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno così ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già dette donne, che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare: le quali cose senza passamento di noia non credo che possano intervenire. Il che se avviene, che voglia Idio che così sia, a Amore ne rendano grazie, il quale liberandomi da’ suoi legami m’ha conceduto il potere attendere a’ lor piaceri.
E’ umano aver compassione delle persone afflitte, e benché si addica a tutti, è soprattutto richiesto a coloro i quali hanno già ricevuto conforto e lo hanno trovato in alcune persone; fra le quali, se alcuno n’ebbe bisogno, e gli fu gradito e ne ha già ricevuto piacere, io sono uno di quelli. Per il fatto che, sin dalla gioventù fino ad oggi, essendo stato estremamente acceso da un altissimo e nobile amore, sembrerebbe, se lo narrassi, forse più alto di quanto convenisse alla mia bassa condizione, per quanto presso coloro che erano discreti e che ne avevano avuto notizia io ne fossi lodato e da molti considerato, nonostante ciò (quest’amore) fu per me di grandissima fatica a sopportare, certo non per crudeltà della donna amata, ma per un eccessivo fuoco della mente concepito da un desidero non regolato; il quale, dal momento che nessun limite mi lasciava soddisfatto, più dolore di quanto avessi bisogno, mi faceva spesso provare. Nel quale dolore tanto conforto mi diedero i ragionamenti di qualche amico e le sue lodevoli consolazioni, che sono fermamente convinto che grazie a ciò non sia avvenuto che io sia morto. Ma come piacque a Dio, che, nella sua infinità, diede per legge inesorabile la fine di ogni cosa terrena, il mio amore, più appassionato di ogni altro, che nessun proposito o consiglio o vergogna o anche pericolo che ne poteva derivare, non era valso a spezzare e terminare, da se stesso, in un lasso di tempo, diminuì di modo che, ora, mi ha lasciato solo un ricordo piacevole, che è dato a chi non è solito recarsi in mari pericolosi, il quale (ricordo) prima era doloroso, e ora, andato via l’affanno, si è trasformato in dilettevole. Sebbene la pena sia terminata, non è perduta la memoria dei benefici ottenuti da coloro ai quali per benevolenza erano affannose le mie fatiche; né terminerà mai, se non con la morte. E per il fatto che la gratitudine, tra le altre virtù, è da lodare grandemente e non biasimare, per non sembrare ingrato mi sono proposto di voler, per quanto io possa, in cambio di quella che ho ricevuto, dal momento che mi sono liberato dalle pene d’amore, e non certamente a coloro che mi aiutarono, i quali mostrano di non averne bisogno o per caso, o per capacità o per fortuna, a coloro ai quali è necessario, voler offrire qualche sollievo. E sebbene il mio sollievo o conforto, se preferiamo chiamarlo così, possa essere poca cosa a coloro che ne abbiano bisogno, tuttavia mi sembra doverlo porgere dove il bisogno sia maggiore, sia perché sarà utile, sia perché sarà più gradito l’averlo ricevuto. E chi negherà, sebbene sia piccola cosa, dover offrire il conforto più alle donne che agli uomini? Esse, dentro i petti delicati, con paura e vergogna, tengono le fiamme amorose nascoste, che, come sa chi ne ha esperienza, hanno più forza di quelle rivelate; oltre a ciò, costrette dai voleri, dai piaceri e dai comandi dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti, la maggior parte del tempo lo passano chiuse nel piccolo ambito delle loro camere e siedono oziose, desiderando e non desiderando nello stesso tempo, rivolgendo diversi pensieri con se stesse, che non è possibile siano sempre allegri. E se per quei pensieri, un po’ di malinconia sopraggiunge, derivata dal fuoco dell’amore, è necessario, in loro è inevitabile che si dimori con turbamento, se tale malinconia non è rimossa da nuovi pensieri: per non dire che le donne sono meno forti degli uomini a sopportarla; ciò non avviene agli uomini innamorati, come è facile dimostrare. Loro, se qualche pena d’amore li affligge, hanno molti modi per trovare sollievo o superarla; infatti, solo volendolo, hanno la possibilità di andare in giro, ascoltare e vedere molte cose, andare a caccia di uccelli e di selvaggina, pescare, andare a cavallo, giocare o fare il mercante, dai quali modi, ognuno di essi ha la forza, in tutto o in parte, di trarre a sé il pensiero o allontanarlo per un certo periodo di tempo, a seguito del quale o si giunge alla consolazione o ad un tormento d’amore minore. Dunque, affinché io possa ricompensare il torto della fortuna (fatto alle donne), la quale laddove esse erano meno forti, come vediamo essere le donne, fu più avara nel sostentarle, in soccorso e rifugio di quelle che sanno cosa sia l’amore, perché alle altre basta l’ago, il fuso e l’arcolaio, intendo raccontare cento novelle, o favolette o parabole o storie, come le vogliamo chiamare, raccontate in dieci giorni da un’“onesta brigata” di sette donne e tre giovani uomini, nel tempo della pestilenza che ha portato molti lutti e alcune canzonette cantate dalle donne secondo il loro piacere. Nelle cui novelle troveranno piacevoli e tristi storie d’amore, ed altri soggetti a caso sia dei tempi moderni come degli antichi; dalle cui novelle le donne, dopo averle lette, potranno prendere diletto e utile consiglio, in quanto potranno conoscer ciò che bisogna “imitare” o “fuggire, le cui cose, senza noia, non credo possano accadere. E se ciò dovesse avvenire, voglia Iddio che sia così, ne rendano grazie ad Amore, il quale liberandomi dai suoi lacci, mi ha permesso di dedicarmi ai loro piaceri.
Il Proemio presenta, efficacemente, alcuni temi fondamentali:
- Il fatto di inserirlo, all’inizio dell’opera, come elemento in cui si sottolinea sia l’autobiografismo che il destinatario altro (le donne), fa percepire che la stessa è unitaria e non una raccolta casuale di racconti;
- Il rispetto della tradizione cortese che vede le donne lettrici di romanzi cortesi (si pensi, qui, all’episodio dantesco di Paolo e Francesca); tuttavia qui Boccaccio sottolinea quali donne siano le loro lettrici: nobili, ricche borghesi, colte;
- Novelle con scopo edonistico e non solo: si ripete “classicamente” il concetto di insegnare e nel contempo offrire piacere. E’ ben inserito e sottolineato il fine dell’opera: far sì che le giovani donne imparino cosa è giusto fare e come comportarsi in una società uscita dallo sconvolgimento della peste.

Luigi Sabatelli: Incisione sulla peste di Firenze del 1348 dal Boccaccio descritta
Al Proemio segue un’introduzione alla prima giornata, sempre con un narratore di primo grado, in cui si racconta della peste del 1348, dell’incontro dei giovani in chiesa, della decisione di recarsi in campagna e di come strutturare il tempo, cioè con l’organizzarsi nel raccontare, ognuno di loro, una novella al giorno sotto la direzione di una o un giovane che si alterneranno nel ruolo di re / regina che ne detterà l’argomento (soltanto due giorni, il primo e il nono, saranno a tema libero). All’impegno di raccontare secondo il tema deciso, sarà esonerato il solo Dioneo.
La peste del 1348:
INTRODUZIONE: LA PESTE
Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. E in quella non valendo alcuno senno né umano provedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da officiali sopra ciò ordinati e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera, a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte: ma nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun’altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno.
A cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto: anzi, o che natura del malore nol patisse o che la ignoranza de’ medicanti (de’ quali, oltre al numero degli scienziati, così di femine come d’uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che si movesse e per consequente debito argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra ‘l terzo giorno dalla apparizione de’ sopra detti segni, chi più tosto e chi meno e i più senza alcuna febbre o altro accidente morivano. E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme s’avventava a’ sani, non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché non solamente il parlare e l’usare cogli infermi dava a’ sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator transportare. Maravigliosa cosa è a udire quello che io debbo dire: il che, se dagli occhi di molti e da’ miei non fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fededegna udito l’avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenzia narrata nello appiccarsi da uno a altro, che non solamente l’uomo all’uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell’uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell’uomo, non solamente della infermità il contaminasse ma quello infra brevissimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei, sì come poco davanti è detto, presero tra l’altre volte un dì così fatta esperienza: che, essendo gli stracci d’un povero uomo da tale infermità morto gittati nella via publica e avvenendosi a essi due porci, e quegli secondo il lor costume prima molto col grifo e poi co’ denti presigli e scossiglisi alle guance, in piccola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento, come se veleno avesser preso, amenduni sopra li mal tirati stracci morti caddero in terra.
Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti o maggiori nacquero diverse paure e imaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fine tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di fuggire gl’infermi e le lor cose; e così faccendo, si credeva ciascuno a se medesimo salute acquistare.
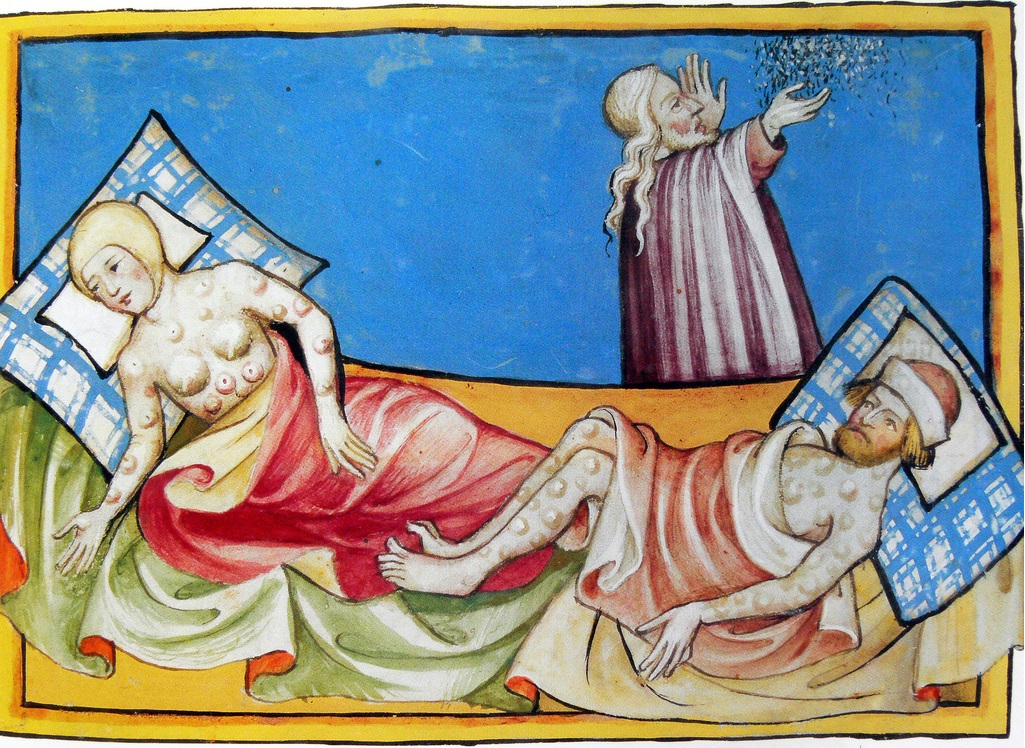
Ammalati di peste bubbonica (Illustrazione del 1411)
Erano ormai trascorsi 1348 anni dall’Incarnazione di Cristo, quando nella nobile città di Firenze, la più bella tra tutte le altre città, giunse la pestilenza, la quale o a causa dei cieli, o per colpa delle nostre colpe peccaminose mandata da Dio sopra i mortali, già iniziata, alcuni anni prima in Oriente, dove aveva causato innumerevoli morti, senza mai fermarsi, passando di luogo in luogo era giunta in Occidente con incredibili conseguenze. E poiché non valeva alcun senno o proponimento, per il quale la città fu pulita da molte sporcizie grazie ad ufficiali preposti a tale officio, per il divieto di alcun malato di entrare in città, di consigli per la pubblica sanità, e né ancora umili suppliche e processioni devozionali fatte da persone puramente religiose, all’inizio della primavera la peste cominciò a mostrare i suoi terribili effetti. E non si era manifestata come ad Oriente, dove l’uscita del sangue dal naso era indizio sicuro di morte, ma fa certi bubboni nell’inguine o sotto le ascelle sia nei maschi che nelle femmine; alcuni di questi crescevano delle dimensioni o di una mela comune, o di un uovo o tra l’uno o l’altro e queste il popolo chiamava ” “gaviccioli”. Da queste due parti corporali il bubbone cominciava ad espandersi ad altre parti del corpo; in seguito la malattia comincia a manifestarsi in macchie livide o nere, le quali nelle cosce, nelle braccia ed in altre parti del corpo apparivano a molti, ad alcuni spesse e rade, ad altri piccole e numerose. E come il bubbone era stato per coloro a cui era venuto indizio di morte, lo stesso per coloro che erano stati colpiti da macchie scure e livide. Per curare tale infermità non valevano né i consigli dei medici, né nessuna virtù medicinale: anzi o che la pestilenza non li sopportasse o l’ignoranza degli uomini (sia di medici che di maschi e femmine che non avevano alcuna scienza, ma il cui numero era cresciuto enormemente) che non capiva da dove provenisse tale malattia e pertanto non si sapesse come curarla, fece sì che non solamente pochi ne guarivano, anzi dopo tre giorni dall’apparizione dei segni, chi più e chi meno ne morivano. E questa pestilenza fu di particolare virulenza tanto che soltanto il comunicare tra un malato ed un sano determinava l’infezione di quest’ultimo, non diversamente come fa il fuoco con le cose secche o unte, che gli si sono avvicinate troppo. E più avanti ancora casi più gravi avvenivano, perché non solamente il parlare insieme infettava i sani, ma anche toccare i panni o qualunque cosa fosse stata toccata dalle persone malate. E’ straordinario quello che voglio dirvi, che se non fosse stato veduto da molta gente e da me, anch’io avrei avuto difficoltà a crederci, meno che mai a scriverlo, anche se l’avessi udito da persona degna di fede. Dico che la trasmissione della malattia dall’uno all’altro fosse tanto efficace, che non solamente da uomo a uomo, ma, cosa assai maggiore, fece sì che una cosa posseduta da un malato, o morto di pestilenza, toccata da un altro animale, che non sia uomo, non solamente contaminasse all’animale la malattia, ma lo conducesse addirittura alla morte. Ho visto con gli occhi miei, come ho detto precedentemente, che, essendo gli stracci di un uomo morto di pestilenza gettati in strada e avventandosi su di essi due maiali e, secondo il loro costume, avvicinandosi prima col muso, poi presi per i denti e dopo averli scossi con la bocca, dopo poco tempo, dopo alcuna contorsione, come se avessero assunto del veleno, ambedue sopra i panni malamente gettati in strada caddero morti. Da queste cose e e da altri simili nacquero sospetti e paure in quelli che rimanevano vivi, tutti attenti ad un solo fine: evitare ed allontanare i malati, credendo, così, di salvarsi.
A questo passo segue la descrizione di come la peste non abbia solo recato morte e distruzione, ma anche un allentamento della fondamentale legge morale che regola la vita in comune: chi pensando di morire in poco tempo, si lasciava andare a piaceri eccessivi, o, al contrario, si ritirava tanto da non veder più nessuno; chi, all’interno delle stesse famiglie, laddove ci fosse un malato, dimenticava ogni affetto familiare disconoscendo i genitori e questi i figli. Anche le esequie dei morti perdono il loro decoro, visto il numero eccessivo dei decessi e la paura di toccarli.

William Waterhouse: A tail from Decameron (1916)
In questo disordine prende vita una nuova società. All’interno della Chiesa di Santa Maria Novella, sette donne, tra i diciotto e ventotto anni, tutte “cortesi” e dal nobile portamento, su consiglio di Pampinea, decidono di allontanarsi da quel luogo di desolazione e rifugiarsi in campagna. Ma si ritiene opportuna la presenza maschile, che viene esaudita dall’arrivo di tre giovani uomini (di cui il più piccolo aveva venticinque anni). Si forma così l’onesta “brigata”, che il giorno seguente, preceduta dai fanti di ciascuno, si reca in campagna:
LOCUS AMOENUS
Era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle nostre strade, di varii arbuscelli e piante tutte di verdi fronde ripiene piacevoli a riguardare; in sul colmo della quale era un palagio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte ciascuna verso di sé bellissima e di liete dipinture raguardevole e ornata, con pratelli da torno e con giardini maravigliosi e con pozzi d’acque freschissime e con volte di preziosi vini: cose più atte a curiosi bevitori che a sobrie e oneste donne. Il quale tutto spazzato, e nelle camere i letti fatti, e ogni cosa di fiori quali nella stagione si potevano avere piena e di giunchi giuncata la vegnente brigata trovò con suo non poco piacere.
Il luogo era su una piccola montagnetta, lontano da tutte le nostre strade, piacevole a guardare per i diversi alberelli e per le piante dalle verdi foglie; sulla cima di tale montagnetta vi era un palazzo, con un cortile bello e grande all’interno, un loggiato, sale e camere, tutte bellissime per sé e rese eleganti e ornate con piacevoli dipinti, con piccoli prati che le circondavano e con giardini meravigliosi e pozzi d’acqua limpidissima e cantine di vini preziosi: cose più adatte ai bevitori esigenti che ad oneste donne. Tutto era pulito, i letti fatti e ogni angolo della casa abbellito di fiori di stagione e di giunchi.
Giunti in tale luogo si dispone che venga eletto un re o una regina per ciascun giorno e che disponga cosa si debba fare. Viene eletta per la prima giornata Pampinea, la quale, dopo aver distribuito i compiti per i vari fanti e aver fatto rilassare i compagni, li riunisce e propone loro di raccontare, ciascuno, una novella, il cui argomento sarà deciso appunto dal re o dalla regina. Lei, essendo la prima, lascerà libera scelta a ciascun novellatore.
L’Introduzione alla prima giornata ha un orrido cominciamento, come ci dice lo stesso autore. Perché? E’ piuttosto naturale che tale scelta sia dovuta per:
- credibilità narrativa: sarebbe stato impossibile per sette donne e tre uomini allontanarsi da soli in campagna senza la motivazione di non aver la possibilità di incorrere nel contagio della pestilenza;
- chiaroscuro tonale: l’immagine dei giovani si contrappone a quella dei morti, così come la loro voglia di stare insieme alla solitudine dei malati; si veda ancora il verde e l’aria pura della campagna contro l’aria ammorbata dentro le mura;
- Il divario tra fortuna e virtù (fondamentale in Boccaccio): sembra quasi che al caso che ha deciso di seminare morte e barbarie si contrapponga la virtù dei dieci giovani il cui vivere in modo onesto allontani il pericolo.
Concludiamo la cosiddetta parte della cornice con una riflessione dello stesso narratore di primo grado, posta come introduzione alla quarta giornata:
INTRODUZIONE ALLA QUARTA GIORNATA
Carissime donne, sì per le parole de’ savi uomini udite e sì per le cose da me molte volte e vedute e lette, estimava io che lo ‘mpetuoso vento e ardente della invidia non dovesse percuotere se non l’alte torri o le più levate cime degli alberi; ma io mi truovo dalla mia estimazione ingannato. Per ciò che, fuggendo io e sempre essendomi di fuggire ingegnato il fiero impeto di questo rabbioso spirito, non solamente pe’ piani, ma ancora per le profondissime valli tacito e nascoso mi sono ingegnato d’andare. Il che assai manifesto può apparire a chi le presenti novellette riguarda, le quali, non solamente in fiorentin volgare e in prosa scritte per me sono e senza titolo, ma ancora in istilo umilissimo e rimesso quanto il più possono. Né per tutto ciò l’essere da cotal vento fieramente scrollato, anzi presso che diradicato e tutto da’ morsi della invidia esser lacerato, non ho potuto cessare. Per che assai manifestamente posso comprendere quel lo esser vero che sogliono i savi dire, che sola la miseria è senza invidia nelle cose presenti.
Sono adunque, discrete donne, stati alcuni che, queste novellette leggendo, hanno detto che voi mi piacete troppo e che onesta cosa non è che io tanto diletto prenda di piacervi e di consolarvi, e alcuni han detto peggio, di commendarvi, come io fo. Altri, più maturamente mostrando di voler dire, hanno detto che alla mia età non sta bene l’andare omai dietro a queste cose, cioè a ragionar di donne o a compiacer loro. E molti, molto teneri della mia fama mostrandosi, dicono che io farei più saviamente a starmi con le Muse in Parnaso che con queste ciance mescolarmi tra voi.
E son di quegli ancora che, più dispettosamente che saviamente parlando, hanno detto che io farei più discretamente a pensare dond’io dovessi aver del pane che dietro a queste frasche andarmi pascendo di vento. E certi altri in altra guisa essere state le cose da me raccontate che come io le vi porgo, s’ingegnano, in detrimento della mia fatica, di dimostrare.
Adunque da cotanti e da così fatti soffiamenti, da così atroci denti, da così aguti, valorose donne, mentre io ne’ vostri servigi milito, sono sospinto, molestato e infino nel vivo trafitto. Le quali cose io con piacevole animo, sallo Iddio, ascolto e intendo; e quantunque a voi in ciò tutta appartenga la mia difesa, nondimeno io non intendo di risparmiar le mie forze; anzi, senza rispondere quanto si converrebbe, con alcuna leggiera risposta tormegli dagli orecchi, e questo far senza indugio. Per ciò che, se già, non essendo io ancora al terzo della lo mia fatica venuto, essi sono molti e molto presummono, io avviso che avanti che io pervenissi alla fine essi potrebbono in guisa esser multiplicati, non avendo prima avuta alcuna repulsa, che con ogni piccola lor fatica mi metterebbono in fondo, né a ciò, quantunque elle sien grandi, resistere varrebbero le forze vostre.

Donne del Medioevo
L’autore racconta la novella di Filippo Balducci e delle papere. Il fiorentino Filippo Balducci, rimasto sconvolto dalla morte della moglie, decide di ritirarsi in un eremo con il figlio di due anni, lontano da ogni tentazione temporale, per dedicarsi solo alla preghiera e all’amore per Dio: recatosi molti anni dopo a Firenze, di fronte alla curiosità del figlio, ormai adulto, che gli chiede che cosa mai siano alcune belle ragazze che in quel momento passano per strada, risponde che si chiamano papere e sono mala cosa. Il figlio, per niente convinto, risponde che sono più belle degli angeli dipinti che il padre gli ha mostrato e di fare in modo di condurne una a casa che le darà da beccare (con significato equivoco)

Meli Valdés Sozzani: Novella delle papere (2013)
Dicono adunque alquanti de’ miei riprensori che io fo male, o giovani donne, troppo ingegnandomi di piacervi, e che voi troppo piacete a me. Le quali cose io apertissimamente confesso, cioè che voi mi piacete e che io m’ingegno di piacere a voi; e domandogli se di questo essi si maravigliano, riguardando, lasciamo stare l’aver conosciuti gli amorosi baciari e i piacevoli abbracciari e i congiugnimenti dilettevoli che di voi, dolcissime donne, sovente si prendono; ma solamente ad aver veduto e veder continuamente gli ornati costumi e la vaga bellezza e l’ornata leggiadria e oltre a ciò la vostra donnesca onestà, quando colui che nutrito, allevato, accresciuto sopra un monte salvatico e solitario, infra li termini di una piccola cella, senza altra compagnia che del padre, come vi vide, sole da lui disiderate foste, sole addomandate, sole con l’affezion seguitate.
Riprenderannomi, morderannomi, lacerrannomi costoro se io, il corpo del quale il ciel produsse tutto atto ad amarvi, e io dalla mia puerizia l’anima vi disposi sentendo la virtù della luce degli occhi vostri, la soavità delle parole melliflue e la fiamma accesa da’ pietosi sospiri, se voi mi piacete o se io di piacervi m’ingegno, e spezialmente guardando che voi prima che altro piaceste ad un romitello, ad un giovinetto senza sentimento, anzi ad uno animal salvatico? Per certo chi non v’ama, e da voi non disidera d’essere amato, sì come persona che i piaceri né la virtù della naturale affezione né sente né conosce, così mi ripiglia, e io poco me ne curo.
E quegli che contro alla mia età parlando vanno, mostra mal che conoscano che, perché il porro abbia il capo bianco, che la coda sia verde. A’quali lasciando stare il motteggiare dall’un de’ lati, rispondo che io mai a me vergogna non reputerò infino nello estremo della mia vita di dover compiacere a quelle cose alle quali Guido Cavalcanti e Dante Alighieri già vecchi, e messer Cino da Pistoia vecchissimo, onor si tennono e fu lor caro il piacer loro. E se non fosse che uscir sarebbe del modo usato del ragionare, io producerei le istorie in mezzo, e quelle tutte piene mosterrei d’antichi uomini e valorosi, ne’loro più maturi anni sommamente avere studiato di compiacere alle donne: il che se essi non sanno, vadino e sì l’apparino.
Che io con le Muse in Parnaso mi debbia stare, affermo che è buon consiglio, ma tuttavia né noi possiam dimorare con le Muse né esse con esso noi; se quando avviene che l’uomo da lor si parte, dilettarsi di veder cosa che le somigli, questo non è cosa da biasimare. Le Muse son donne, e benché le donne quello che le Muse vagliono non vagliano, pure esse hanno nel primo aspetto simiglianza di quelle; sì che, quando per altro non mi piacessero, per quello mi dovrebber piacere. Senza che le donne già mi fur cagione di comporre mille versi, dove le Muse mai non mi furon di farne alcun cagione. Aiutaronmi elle bene e mostraronmi comporre que’mille; e forse a queste cose scrivere, quantunque sieno umilissime, si sono elle venute parecchie volte a starsi meco, in servigio forse e in onore della simiglianza che le donne hanno ad esse; per che, queste cose tessendo, né dal monte Parnaso né dalle Muse non mi allontano, quanto molti per avventura s’avvisano.
Ma che direm noi a coloro che della mia fame hanno tanta compassione che mi consigliano che io procuri del pane? Certo io non so; se non che, volendo meco pensare qual sarebbe la loro risposta se io per bisogno loro ne dimandassi, m’avviso che direbbono: – Va cercane tra le favole – . E già più ne trovarono tra le lor favole i poeti, che molti ricchi tra’lor tesori. E assai già, dietro alle lor favole andando, fecero la loro età fiorire, dove in contrario molti nel cercar d’aver più pane che bisogno non era loro, perirono acerbi. Che più? Caccinmi via questi cotali qualora io ne domando loro; non che, la Dio mercé, ancora non mi bisogna; e, quando pur sopravenisse il bisogno, io so, secondo l’Apostolo, abbondare e necessità sofferire; e per ciò a niun caglia più di me che a me.
Quegli che queste cose così non essere state dicono, avrei molto caro che essi recassero gli originali, li quali, se a quel che io scrivo discordanti fossero, giusta direi la loro riprensione e d’amendar me stesso m’ingegnerei; ma infino che altro che parole non apparisce, io gli lascerò con la loro oppinione, seguitando la mia, di loro dicendo quello che essi di me dicono. E volendo per questa volta assai aver risposto, dico che dallo aiuto di Dio e dal vostro, gentilissime donne, nel quale io spero, armato, e di buona pazienza, con esso procederò avanti, dando le spalle a questo vento e lasciandol soffiare; per ciò che io non veggio che di me altro possa avvenire, che quello che della minuta polvere avviene, la quale, spirante turbo, o egli di terra non la muove, o se la muove, la porta in alto, e spesse volte sopra le teste degli uomini, sopra le corone dei re e degli imperadori, e talvolta sopra gli alti palagi e sopra le eccelse torri la lascia; delle quali se ella cade, più giù andar non può che il luogo onde levata fu.
E se mai con tutta la mia forza a dovervi in cosa alcuna compiacere mi disposi, ora più che mai mi vi disporrò; per ciò che io conosco che altra cosa dir non potrà alcuna con ragione, se non che gli altri e io, che vi amiamo, naturalmente operiamo; alle cui leggi, cioè della natura, voler contastare, troppe gran forze bisognano, e spesse volte non solamente in vano ma con grandissimo danno del faticante s’adoperano. Le quali forze io confesso che io non l’ho né d’averle disidero in questo; e se io l’avessi, più tosto ad altrui le presterrei che io per me l’adoperassi. Per che tacciansi i morditori, e se essi riscaldar non si possono, assiderati si vivano, e ne lori diletti, anzi appetiti corrotti standosi, me nel mio, questa brieve vita che posta n’è, lascino stare.
Carissime donne, sia per aver ascoltato le parole dei saggi uomini, sia per le cose viste e lette, credevo che l’impetuoso vento dell’invidia non dovesse colpire se non le alti torri o le più elevate cime degli alberi: ma ho scoperto di essermi sbagliato. Per questo che mi ero ingegnato di andare soltanto per pianure e profondissime valli, e ciò appare palese a chi osservi le presenti novelle, che non solamente sono state scritte da me in fiorentino volgare ed in prosa e senza alcun titolo, ma sono anche (state scritte) in uno stile umilissimo e dimesso più di quanto si potesse fare. Nonostante ciò non ho potuto evitare di essere fortemente scrollato, anzi vicino allo sradicamento dal vento dell’invidia e completamente lacerato dai suoi morsi; per questo è evidente quanto si dice da parte dei saggi uomini, che solamente la miseria è senza invidia nelle cose terrene.
Ci sono stati alcuni, discrete donne, che leggendo queste novellette, hanno detto che voi mi piacete troppo e non è onesto che io provi tanto piacere nel piacervi e divertirvi e, alcuni hanno detto peggio, di elogiarvi, come faccio io. Altri, mostrando di volermi riprendere in modo più saggio, hanno detto che alla mia età non sta bene andare dietro a queste cose, cioè a ragionare di donne o a compiacerle. E molti, mostrandosi interessati alla mia fama, dicono che sarebbe meglio io stessi con le Muse sul monte Parnaso, piuttosto che mescolarmi in tale chiacchiere con voi. Altri ancora che, più con dispetto che con ragione, hanno detto che mi comporterei più saggiamente pensando a come guadagnarmi la vita piuttosto che nutrirmi di vento con tali sciocchezze. E certi altri, per togliere valore alla mia fatica, s’ingegnano di dimostrare che le cose da me raccontate sono andate in maniera diversa da come le racconto io.
Dunque da così intensi e inspirati venti dell’invidia, da zanne così atroci ed appuntite, mentre scrivo in vostro onore, valorose donne, sono sospinto, molestato e colpito nel vivo. Chiacchiere che io, con animo tranquillo, lo sa Dio, ascolto e capisco: e benché la mia difesa contro queste accuse spetti tutta a voi, non intendo affatto venir meno da me stesso, anzi, senza rispondere con la durezza che sarebbe necessaria, con qualche risposta arguta, senza alcun indugio, togliermi (quel chiacchiericcio) dagli orecchi. Perché, già ora che non sono giunto neppure ad un terzo della mia opera (si è appena conclusa la terza giornata), gli invidiosi e sono molti ed hanno abbastanza baldanza e temo che prima che io giunga alla fine dell’opera, essi potrebbero moltiplicarsi e con un minimo sforzo mi rovinerebbero, se ora non dessi loro una risposta. Né per questo, sebbene le vostre forze siano grandi, potrebbero resistere.
(…)

Donne del Medioevo
Giovani donne, dicono molti dei miei accusatori che io faccio male nello sforzarmi di piacervi e che voi mi piacete troppo. Cose che confesso senza difficoltà, cioè che voi mi piacete e che io mi sforzo di piacervi: vorrei domandare loro se si meravigliano di questo mio interesse per voi, considerando, non dico quel che tutti hanno conosciuto, i baci d’amore, i piacevoli abbracci, gli incontri intimi gioiosi che con voi, donne dolcissime, spesso si hanno, ma solamente di aver veduto e continuamente visto gli eleganti costumi, la raffinata bellezza e la garbata grazia e, oltre a ciò, la femminile onestà, quando colui che nutrito, allevato, cresciuto in un monte solitario e selvatico, entro angusti limiti, senz’altra compagnia se non paterna, appena vi vide foste da lui desiderate, richieste, affettuosamente domandate. (Si riferisce alla novella di Filippo Balducci).
Mi riprenderanno, mi morderanno, mi lacereranno costoro se io, il corpo del quale è stato fatto da Dio per amarvi, sin dalla fanciullezza volsi l’anima verso di voi, sentendo la virtù dei vostri occhi, la dolcezza delle vostre parole e il divampare d’amore per i vostri pietosi sospiri; se voi mi piacete e io mi sforzo di piacervi, soprattutto pensando che voi prima di ogni altra cosa siete piaciute ad un piccolo eremita, ad un giovane che non conosceva i sentimenti, anzi a un animale selvatico? Certamente sono ripreso da chi non vi ama e non desidera essere amato da voi, come una persona che non conosce e non sente i naturali affetti; ma di costoro non mi curo.
E coloro che parlano contro la mia età, mostrano di non conoscere che il porro ha il capo bianco ma la coda verde: a costoro, lasciando da parte gli scherzi, risponderò che mai mi vergognerò fino alla fine della mia vita di compiacere quelle cose che Guido Cavalcanti e Dante Alighieri già vecchi e il vecchissimo Cino da Pistoia onorarono e fu gradito loro il compiacerle. E se non fosse fuori dal ragionamento, metterei in mezzo la storia, e mostrerei come essa è piena di uomini antichi e valorosi che pur avanti negli anni hanno non hanno cessato di compiacere le donne e se chi mi critica non lo fa, studino la storia e la imparino.
Che io debba stare con le Muse ritengo sia un buon coniglio, ma noi non possiamo stare sempre con esse, né esse con noi. Se talvolta capita che l’uomo si allontani da esse, non è da biasimare se si rivolge a cose che somigliano a loro: le Muse sono donne e seppure le donne non le possono eguagliare, a prima vista le somigliano, tanto che, se le donne non dovessero piacermi, dovrei amarle solo per questo; senza aggiungere che esse furono il motivo della composizione di più di mille versi, mentre le Muse per alcuno. Mi aiutarono tuttavia e mi mostrarono come comporre quei mille; e forse a scrivere queste novelle, quantunque siano estremamente umili, sono venute spesso a stare con me, in servizio e in onore della somoglianza che le donne hanno con loro, per cui, elaborando le novelle, né mi allontano dal monte Parnaso né dalle Muse, quanto molti magari ritengono.
Ma che diremo noi a coloro che, preoccupandosi della mia sorte, mi consigliano di guadagnare il pane (con altro pèiuttosto che con le novelle)? Non lo so, senonché, pensando a quale sarebbe la loro risposta se dovessi domandarlo loro, credo mi direbbero: «Va e cercalo tra le favole”. E già ne trovarono (di sostentamento) più tra le favole i poeti, che molti ricchi tra i tesori, e molti, andando dietro alle favole, vissero a lungo, al contrario, molti ricchi, cercando d’esserlo di più, morirono in giovane età. Che più? Mi caccino costoro se chiedo loro del pane, benché, grazie a Dio, ancora non ne abbia bisogno e quando sopravvenisse la necessità io so, come disse San Paolo, vivere bene nell’abbondanza e sopportare con pazienza la povertà, e per ciò a nessuno importa più di me che a me stesso.
Quelli che dicono che i fatti raccontati nelle mie novelle non si sono svolti in questo modo, vorrei me la dicessero loro la verità, che se fosse così diversa da ciò che scrivo, direi che hanno ragione e mi adopererei per correggermi, ma finché essi si limitano a riprendermi con le parole, li lascerò della loro opinione, seguendo io la mia, dicendo di loro ciò che loro dicono di me.
E avendo per questa volta risposto a sufficienza, affermo che con l’aiuto di Dio e con il vostro, gentilissime donne, aiuto nel quale io spero, armato di buona pazienza, procederò, lasciandomi alle spalle questo vento (d’invidia) e lasciandolo soffiare, perché io reputo che non mi possa accadere che quello che accade alla polvere sottile, la quale, quando soffia un vento impetuoso, o lo stesso non la muove da terra o, se la muove, la porta in alto sopra la testa degli uomini e talvolta la lascia sopra gli alti palazzi e sopra le torri elevate; da cui, quando cade, non può andare più giù da dove era partita. E se mai avevo deciso di compiacervi con tutta la mia forza, ora più che mai mi ci proverò, dal momento che so che nessuno potrà dirmi altro con ragione se non che gli altri ed io che vi amiamo, operiamo secondo l’ordine delle cose, alle quali, se volessimo opporci ci vorrebbero grandi forze che spesso s’adoperano non solamente in modo inutile, ma anche con danno di chi le ha adoperate. Queste forze confesso di non averle né le desidero per questo lavoro e se le avessi piuttosto le presterei piuttosto d’adoperarle. Per cui tacciano i malevoli e se essi non possono provare il sentimento dell’amore, vivano nel gelo; e stando così nel loro diletto, anzi nelle loro voglie corrotte, lascino stare me nel mio (diletto) per questa breve vita che ci è concessa.
E’ un passo importante perché a delle accuse circostanziate troviamo delle risposte altrettanto circostanziate che ci dicono anche quale sia la sua visione poetica.
I critici verso di lui affermano che:
- Egli loda troppo le donne;
- Donne ed amori non sono adatti all’età matura;
- La sua opera è di genere letterario troppo basso
- Tratta di una materia inutile
- Non racconta cose vere
Le sue risposte sono:
- Se tutti desiderano le donne, esse sono “naturalmente” buone (a tale fine scrive la novella di Filippo Balducci dimostrando come l’attrazione verso di esse sia naturale);
- Il desiderio sessuale non cessa con l’età matura e ciò viene dimostrato da tutta la letteratura precedente (che ne racconta la bellezza);
- Le donne sono Muse e le Muse sono donne. Se le prime lo hanno ispirato, le seconde si sono sedute al suo fianco anche se la sua produzione è umile, cioè rivendicando ad essa la letterarietà;
- Forse la cultura non arricchisce “materialmente”, ma rende ricca la civiltà cui è rivolta;
- Afferma che egli nelle novelle abbia seguito il vero e quindi rivendica la natura essenzialmente realistica della sua opera;
Vogliamo qui ricordare che il Proemio, l’Introduzione alla Prima giornata, l’Introduzione alla Quarta giornata e le Conclusioni dell’Autore costituiscono la cosiddetta “cornice” entro la quale inserire la molteplicità del reale boccacciano.

Raffaello Sorbi: Decamerone (1876)
PRIMA GIORNATA
Quindi dopo aver disposto i compiti tra i fanti e giunta l’ora, l’“onesta brigata” si riunisce e la regina, Pampinea, dispone che “Per questa prima giornata voglio che libero sia a ciascuno di quella materia ragionare che più gli sarà a grado.”, cioè il tema del narrare sia libero, e lascia la parola al primo novellatore, Panfilo.
Costui, prima di cominciare il raccontare vero e proprio, fa una lunga e articolata premessa nella quale scinde tra il giudizio divino ed il giudizio umano; infatti l’uomo, nella sua umiltà, non sempre si rivolge per esaudire le sue preghiere a Dio, ma ai santi; tuttavia l’uomo non può sapere se la persona cui si rivolge è stata effettivamente accolta dal Signore o, come dice Panfilo stesso, esiliata da Lui. Tuttavia basta la sincerità con la quale gli si rivolge, al di là del mezzo cui ci serviamo, e ciò permette al Signore stesso di esaudirci.

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. La vicenda di Ser Ciappelletto
SER CEPPARELLO CON UNA FALSA CONFESSIONE INGANNA UN SANTO FRATE E MUORSI; E, ESSENDO STATO UN PESSIMO UOMO IN VITA, E’ MORTO REPUTATO PER SANTO e CHIAMATO SAN CIAPPELLETTO.
(I,1)
Ragionasi adunque che essendo Musciatto Franzesi di ricchissimo e gran mercatante in Francia cavalier divenuto e dovendone in Toscana venire con messer Carlo Senzaterra, fratello del re di Francia, da papa Bonifazio addomandato e al venir promosso, sentendo egli gli fatti suoi, sì come le più volte son quegli de’ mercatanti, molto intralciati in qua e in là e non potersi di leggiere né subitamente stralciare, pensò quegli commettere a più persone; e a tutti trovò modo; fuor solamente in dubbio gli rimase cui lasciar potesse sofficiente a riscuoter suoi crediti fatti a più borgognoni. E la cagion del dubbio era il sentire li borgognoni uomini riottosi e di mala condizione e misleali; e a lui non andava per la memoria chi tanto malvagio uom fosse, in cui egli potesse alcuna fidanza avere che opporre alla loro malvagità si potesse. E sopra questa essaminazione pensando lungamente stato, gli venne a memoria un ser Cepperello da Prato, il qual molto alla sua casa in Parigi si riparava. Il quale, per ciò che piccolo di persona era e molto assettatuzzo, non sappiendo li franceschi che si volesse dire Cepperello, credendo che cappello, cioè ghirlanda, secondo il loro volgare, a dir venisse, per ciò che piccolo era come dicemmo, non Ciappello, ma Ciappelletto il chiamavano; e per Ciappelletto era conosciuto per tutto, là dove pochi per ser Cepperello il conoscieno.
Era questo Ciappelletto di questa vita: egli, essendo notaio, avea grandissima vergogna quando uno de’ suoi strumenti, come che pochi ne facesse, fosse altro che falso trovato; de’ quali tanti avrebbe fatti di quanti fosse stato richesto, e quelli più volentieri in dono che alcun altro grandemente salariato. Testimonianze false con sommo diletto diceva, richesto e non richesto; e dandosi a que’ tempi in Francia a’ saramenti grandissima fede, non curandosi fargli falsi, tante quistioni malvagiamente vincea a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. Aveva oltre modo piacere, e forte vi studiava, in commettere tra amici e parenti e qualunque altra persona mali e inimicizie e scandali, de’ quali quanto maggiori mali vedeva seguire tanto più d’allegrezza prendea. Invitato ad un omicidio o a qualunque altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente v’andava; e più volte a fedire e ad uccidere uomini colle propie mani si trovò volentieri. Bestemmiatore di Dio e de’ santi era grandissimo; e per ogni piccola cosa, sì come colui che più che alcun altro era iracundo. A chiesa non usava giammai; e i sacramenti di quella tutti, come vil cosa, con abominevoli parole scherniva; e così in contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli. Delle femine era così vago come sono i cani de’ bastoni; del contrario più che alcun altro tristo uomo si dilettava. Imbolato avrebbe e rubato con quella conscienzia che un santo uomo offerrebbe. Gulosissimo e bevitore grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli facea noia. Giucatore e mettitor di malvagi dadi era solenne. Perché mi distendo io in tante parole? Egli era il piggiore uomo forse che mai nascesse. La cui malizia lungo tempo sostenne la potenzia e lo stato di messer Musciatto, per cui molte volte e dalle private persone, alle quali assai sovente faceva ingiuria, e dalla corte, a cui tuttavia la facea, fu riguardato.
Venuto adunque questo ser Cepperello nell’animo a messer Musciatto, il quale ottimamente la sua vita conosceva, si pensò il detto messer Musciatto costui dovere essere tale quale la malvagità de’ borgognoni il richiedea; e perciò, fattolsi chiamare, gli disse così: «Ser Ciappelletto, come tu sai, io sono per ritrarmi del tutto di qui, e avendo tra gli altri a fare co’ borgognoni, uomini pieni d’inganni, non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio da loro più convenevole di te; e perciò, con ciò sia cosa che tu niente facci al presente, ove a questo vogli intendere, io intendo di farti avere il favore della corte e di donarti quella parte di ciò che tu riscoterai che convenevole sia».
Ser Ciappelletto, che scioperato si vedea e male agitato delle cose del mondo e lui ne vedeva andare che suo sostegno e ritegno era lungamente stato, senza niuno indugio e quasi da necessità costretto si diliberò, e disse che volea volentieri. Per che, convenutisi insieme, ricevuta ser Ciappelletto la procura e le lettere favorevoli del re, partitosi messer Musciatto, n’andò in Borgogna dove quasi niuno il conoscea; e quivi, fuor di sua natura, benignamente e mansuetamente cominciò a voler riscuotere e fare quello per che andato v’era, quasi si riserbasse l’adirarsi al da sezzo.
E così faccendo, riparandosi in casa di due fratelli fiorentini, li quali quivi ad usura prestavano e lui per amor di messer Musciatto onoravano molto, avvenne che egli infermò; al quale i due fratelli fecero prestamente venire medici e fanti che il servissero e ogni cosa opportuna alla sua santà racquistare. Ma ogni aiuto era nullo, per ciò che ‘l buono uomo, il quale già era vecchio e disordinatamente vivuto, secondo che i medici dicevano, andava di giorno in giorno di male in peggio, come colui ch’aveva il male della morte; di che li due fratelli si dolevan forte.
E un giorno, assai vicini della camera nella quale ser Ciappelletto giaceva infermo, seco medesimi cominciarono a ragionare: «Che farem noi» diceva l’uno all’altro «di costui? Noi abbiamo dei fatti suoi pessimo partito alle mani, per ciò che il mandarlo fuori di casa nostra così infermo ne sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno, veggendo la gente che noi l’avessimo ricevuto prima, e poi fatto servire e medicare così sollecitamente, e ora, senza potere egli aver fatta cosa alcuna che dispiacere ci debba, così subitamente di casa nostra e infermo a morte vederlo mandar fuori. D’altra parte, egli è stato sì malvagio uomo che egli non si vorrà confessare né prendere alcuno sacramento della Chiesa; e, morendo senza confessione, niuna chiesa vorrà il suo corpo ricevere, anzi sarà gittato a’ fossi a guisa d’un cane. E, se egli si pur confessa, i peccati suoi son tanti e sì orribili che il simigliante n’avverrà, per ciò che frate né prete ci sarà che ‘l voglia né possa assolvere; per che, non assoluto, anche sarà gittato a’ fossi. E se questo avviene, il popolo di questa terra, il quale sì per lo mestier nostro, il quale loro pare iniquissimo e tutto ‘l giorno ne dicon male, e sì per la volontà che hanno di rubarci, veggendo ciò, si leverà a romore e griderrà: “Questi lombardi cani, li quali a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si vogliono più sostenere”; e correrannoci alle case e per avventura non solamente l’avere ci ruberanno, ma forse ci torranno oltre a ciò le persone; di che noi in ogni guisa stiam male, se costui muore».
Ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, presso giacea là dove costoro così ragionavano, avendo l’udire sottile, sì come le più volte veggiamo avere gl’infermi, udì ciò che costoro di lui dicevano; li quali egli si fece chiamare, e disse loro: «Io non voglio che voi di niuna cosa di me dubitiate né abbiate paura di ricevere per me alcun danno. Io ho inteso ciò che di me ragionato avete e son certissimo che così n’avverrebbe come voi dite, dove così andasse la bisogna come avvisate; ma ella andrà altramenti. Io ho, vivendo, tante ingiurie fatte a Domenedio che, per farnegli io una ora in su la mia morte, né più né meno ne farà. E per ciò procacciate di farmi venire un santo e valente frate, il più che aver potete, se alcun ce n’è, e lasciate fare a me, ché fermamente io acconcerò i fatti vostri e i miei in maniera che starà bene e che dovrete esser contenti».
I due fratelli, come che molta speranza non prendessono di questo, nondimeno se n’andarono ad una religione di frati e domandarono alcuno santo e savio uomo che udisse la confessione d’un lombardo che in casa loro era infermo; e fu lor dato un frate antico di santa e di buona vita e gran maestro in Iscrittura e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e spezial divozione aveano, e lui menarono. Il quale, giunto nella camera dove ser Ciappelletto giacea e allato postoglisi a sedere, prima benignamente il cominciò a confortare, e appresso il domandò quanto tempo era che egli altra volta confessato si fosse. Al quale ser Ciappelletto, che mai confessato non s’era, rispose: «Padre mio, la mia usanza suole essere di confessarmi ogni settimana almeno una volta, senza che assai sono di quelle che io mi confesso più; è il vero che poi ch’io infermai, che son presso a otto dì, io non mi confessai, tanta è stata la noia che la infermità m’ha data».
Disse allora il frate: «Figliuol mio, bene hai fatto, e così si vuol fare per innanzi; e veggio che, poi sì spesso ti confessi, poca fatica avrò d’udire o di domandare».
Disse ser Ciappelletto: «Messer lo frate, non dite così; io non mi confessai mai tante volte né sì spesso, che io sempre non mi volessi confessare generalmente di tutti i miei peccati che io mi ricordassi dal dì ch’i’ nacqui infino a quello che confessato mi sono; e per ciò vi priego, padre mio buono, che così puntualmente d’ogni cosa mi domandiate come se mai confessato non mi fossi. E non mi riguardate perch’io infermo sia, ché io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni che, faccendo agio loro, io facessi cosa che potesse essere perdizione della anima mia, la quale il mio Salvatore ricomperò col suo prezioso sangue».
Queste parole piacquero molto al santo uomo e parvongli argomento di bene disposta mente; e poi che a ser Ciappelletto ebbe molto commendato questa sua usanza, il cominciò a domandare se egli mai in lussuria con alcuna femina peccato avesse. Al qual ser Ciappelletto sospirando rispose: «Padre mio, di questa parte mi vergogno io di dirvene il vero, temendo di non peccare in vanagloria».
Al quale il santo frate disse: «Dì sicuramente, ché il ver dicendo né in confessione né in altro atto si pecco’ giammai».
Disse allora ser Ciappelletto: «Poiché voi di questo mi fate sicuro, e io il vi dirò: io son così vergine come io uscì del corpo della mamma mia».
«Oh benedetto sia tu da Dio!» disse il frate «come bene hai fatto! e, faccendolo, hai tanto più meritato, quanto, volendo, avevi più d’arbitrio di fare il contrario che non abbiam noi e qualunque altri son quegli che sotto alcuna regola sono costretti».
E appresso questo il domandò se nel peccato della gola aveva a Dio dispiaciuto; al quale, sospirando forte, ser Ciappelletto rispose del sì, e molte volte; perciò che con ciò fosse cosa che egli, oltre a’ digiuni delle quaresime che nell’anno si fanno dalle divote persone, ogni settimana almeno tre dì fosse uso di digiunare in pane e in acqua, con quello diletto e con quello appetito l’acqua bevuta avea, e spezialmente quando avesse alcuna fatica durata o adorando o andando in pellegrinaggio, che fanno i gran bevitori il vino; e molte volte aveva disiderato d’avere cotali insalatuzze d’erbucce, come le donne fanno quando vanno in villa; e alcuna volta gli era paruto migliore il mangiare che non pareva a lui che dovesse parere a chi digiuna per divozione, come digiunava egli.
Al quale il frate disse: «Figliuol mio, questi peccati sono naturali e sono assai leggieri; e per ciò io non voglio che tu ne gravi più la conscienzia tua che bisogni. Ad ogni uomo addiviene, quantunque santissimo sia, il parergli dopo lungo digiuno buono il manicare, e dopo la fatica il bere».
«Oh!» disse ser Ciappelletto «padre mio, non mi dite questo per confortarmi; ben sapete che io so che le cose che al servigio di Dio si fanno, si deono fare tutte nettamente e senza alcuna ruggine d’animo; e chiunque altri menti le fa, pecca».
Il frate contentissimo disse: «E io son contento che così ti cappia nell’animo, e piacemi forte la tua pura e buona conscienzia in ciò. Ma, dimmi: in avarizia hai tu peccato, disiderando più che il convenevole, o tenendo quello che tu tener non dovesti?»
Al quale ser Ciappelletto disse: «Padre mio, io non vorrei che voi guardaste perché io sia in casa di questi usurieri: io non ci ho a far nulla; anzi ci era venuto per dovergli ammonire e gastigare e torgli da questo abbominevole guadagno; e credo mi sarebbe venuto fatto, se Iddio non m’avesse così visitato. Ma voi dovete sapere che mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui avere, come egli fu morto, diedi la maggior parte per Dio; e poi, per sostentare la vita mia e per potere aiutare i poveri di Cristo, ho fatte mie picciole mercatantie, e in quelle ho desiderato di guadagnare, e sempre co’ poveri di Dio quello che ho guadagnato ho partito per mezzo, l’una metà convertendo né miei bisogni, l’altra metà dando loro; e di ciò m’ha sì bene il mio Creatore aiutato che io ho sempre di bene in meglio fatti i fatti miei».
«Bene hai fatto», disse il frate «ma come ti se’ tu spesso adirato?»
«Oh!» disse ser Ciappelletto «cotesto vi dico io bene che io ho molto spesso fatto. E chi se ne potrebbe tenere, veggendo tutto il dì gli uomini fare le sconce cose, non servare i comandamenti di Dio, non temere i suoi giudici? Egli sono state assai volte il dì che io vorrei più tosto essere stato morto che vivo, veggendo i giovani andare dietro alle vanità e vedendogli giurare e spergiurare, andare alle taverne, non visitare le chiese e seguir più tosto le vie del mondo che quella di Dio».
Disse allora il frate: «Figliuol mio, cotesta è buona ira, né io per me te ne saprei penitenzia imporre. Ma, per alcuno caso, avrebbeti l’ira potuto inducere a fare alcuno omicidio o a dire villania a persona o a fare alcun’altra ingiuria?»
A cui ser Ciappelletto rispose: «Ohimè, messere, o voi mi parete uom di Dio: come dite voi coteste parole? o s’io avessi avuto pure un pensieruzzo di fare qualunque s’è l’una delle cose che voi dite, credete voi che io creda che Iddio m’avesse tanto sostenuto? Coteste son cose da farle gli scherani e i rei uomini, de’ quali qualunque ora io n’ho mai veduto alcuno, sempre ho detto: “Va che Dio ti converta”»
Allora disse il frate: «Or mi dì, figliuol mio, che benedetto sia tu da Dio: hai tu mai testimonianza niuna falsa detta contro alcuno o detto mal d’altrui o tolte dell’altrui cose senza piacer di colui di cui sono?»
«Mai, messere sì», rispose ser Ciappelletto «che io ho detto male d’altrui; per ciò che io ebbi già un mio vicino che, al maggior torto del mondo, non faceva altro che battere la moglie, sì che io dissi una volta mal di lui alli parenti della moglie, sì gran pietà mi venne di quella cattivella, la quale egli, ogni volta che bevuto avea troppo, conciava come Dio vel dica».
Disse allora il frate: «Or bene, tu mi di’ che se’ stato mercatante: ingannasti tu mai persona così come fanno i mercatanti?»
«Gnaffe», disse ser Ciappelletto «messer sì; ma io non so chi egli si fu, se non che uno, avendomi recati danari che egli mi dovea dare di panno che io gli avea venduto, e io messogli in una mia cassa senza annoverare, ivi bene ad un mese trovai ch’egli erano quattro piccioli più che essere non doveano; per che, non rivedendo colui e avendogli serbati bene uno anno per rendergliele, io gli diedi per l’amor di Dio».
Disse il frate: «Cotesta fu piccola cosa; e facesti bene a farne quello che ne facesti».
E, oltre a questo, il domandò il santo frate di molte altre cose, delle quali di tutte rispose a questo modo. E volendo egli già procedere all’assoluzione, disse ser Ciappelletto: «Messere, io ho ancora alcun peccato che io non v’ho detto».
Il frate il domandò quale; ed egli disse: «Io mi ricordo che io feci al fante mio un sabato dopo nona spazzare la casa, e non ebbi alla santa domenica quella reverenza che io dovea».
«Oh!» disse il frate «figliuol mio, cotesta è leggier cosa».
«Non», disse ser Ciappelletto «non dite leggier cosa, ché la domenica è troppo da onorare, però che in così fatto dì risuscitò da morte a vita il nostro Signore».
Disse allora il frate: «O altro hai tu fatto?»
«Messer sì», rispose ser Ciappelletto «ché io, non avvedendomene, sputai una volta nella chiesa di Dio».
Il frate cominciò a sorridere e disse: «Figliuol mio, cotesta non è cosa da curarsene: noi, che siamo religiosi, tutto il dì vi sputiamo».
Disse allora ser Ciappelletto: «E voi fate gran villania, per ciò che niuna cosa si convien tener netta come il santo tempio, nel quale si rende sacrificio a Dio».
E in brieve de’ così fatti ne gli disse molti, e ultimamente cominciò a sospirare, e appresso a piagner forte, come colui che il sapeva troppo ben fare quando volea.
Disse il santo frate: «Figliuol mio, che hai tu?»
Rispose ser Ciappelletto: «Ohimè, messere, ché un peccato m’è rimaso, del quale io non mi confessai mai, sì gran vergogna ho di doverlo dire; e ogni volta ch’io me ne ricordo piango come voi vedete, e parmi essere molto certo che Iddio mai non avrà misericordia di me per questo peccato».
Allora il santo frate disse: «Va via, figliuol, che è ciò che tu dì? Se tutti i peccati che furon mai fatti da tutti gli uomini, o che si debbon fare da tutti gli uomini mentre che il mondo durerà, fosser tutti in uno uom solo, ed egli ne fosse pentuto e contrito come io veggio te, si è tanta la benignità e la misericordia di Dio che, confessandogli egli, gliele perdonerebbe liberamente; e per ciò dillo sicuramente».
Disse allora ser Ciappelletto, sempre piagnendo forte: «Ohimè, padre mio, il mio è troppo gran peccato, e appena posso credere, se i vostri prieghi non ci si adoperano, che egli mi debba mai da Dio esser perdonato».
A cui il frate disse: «Dillo sicuramente, ché io ti prometto di pregare Iddio per te».
Ser Ciappelletto pur piagnea e nol dicea, e il frate pur il confortava a dire. Ma poi che ser Ciappelletto piagnendo ebbe un grandissimo pezzo tenuto il frate così sospeso, ed egli gittò un gran sospiro e disse: «Padre mio, poscia che voi mi promettete di pregare Iddio per me, e io il vi dirò. Sappiate che, quando io era piccolino, io bestemmiai una volta la mamma mia»; e così detto ricominciò a piagnere forte.
Disse il frate: «O figliuol mio, or parti questo così grande peccato? Oh! gli uomini bestemmiano tutto ‘l giorno Iddio, e sì perdona egli volentieri a chi si pente d’averlo bestemmiato; e tu non credi che egli perdoni a te questo? Non piagner, confortati, ché fermamente, se tu fossi stato un di quegli che il posero in croce, avendo la contrizione ch’io ti veggio, sì ti perdonerebbe egli».
Disse allora ser Ciappelletto: «Ohimè, padre mio, che dite voi? La mamma mia dolce, che mi portò in corpo nove mesi il dì e la notte e portommi in collo più di cento volte! troppo feci male a bestemmiarla e troppo è gran peccato; e se voi non pregate Iddio per me, egli non mi sarà perdonato».
Veggendo il frate non essere altro restato a dire a ser Ciappelletto, gli fece l’assoluzione e diedegli la sua benedizione, avendolo per santissimo uomo, sì come colui che pienamente credeva esser vero ciò che ser Ciappelletto avea detto. E chi sarebbe colui che nol credesse, veggendo uno uomo in caso di morte dir così? E poi, dopo tutto questo, gli disse: «Ser Ciappelletto, coll’aiuto di Dio voi sarete tosto sano; ma se pure avvenisse che Iddio la vostra benedetta e ben disposta anima chiamasse a se’, piacev’egli che ‘l vostro corpo sia sepellito al nostro luogo?»
Al quale ser Ciappelletto rispose: «Messer sì; anzi non vorre’ io essere altrove, poscia che voi mi avete promesso di pregare Iddio per me; senza che io ho avuta sempre spezial divozione al vostro ordine. E per ciò vi priego che, come voi al vostro luogo sarete, facciate che a me vegna quel veracissimo corpo di Cristo, il qual voi la mattina sopra l’altare consecrate; per ciò che (come che io degno non ne sia) io intendo colla vostra licenzia di prenderlo, e appresso la santa e ultima unzione, acciò che io, se vivuto son come peccatore, almeno muoia come cristiano».
Il santo uomo disse che molto gli piacea e che egli dicea bene, e farebbe che di presente gli sarebbe apportato; e così fu. Li due fratelli, li quali dubitavan forte non ser Ciappelletto gl’ingannasse, s’eran posti appresso ad un tavolato, il quale la camera dove ser Ciappelletto giaceva divideva da un’altra, e ascoltando leggiermente udivano e intendevano ciò che ser Ciappelletto al frate diceva; e aveano alcuna volta sì gran voglia di ridere, udendo le cose le quali egli confessava d’aver fatte, che quasi scoppiavano, e fra se’ talora dicevano: «Che uomo è costui, il quale né vecchiezza né infermità né paura di morte alla qual si vede vicino, né ancora di Dio dinanzi al giudicio del quale di qui a picciola ora s’aspetta di dovere essere, dalla sua malvagità l’hanno potuto rimuovere, né far ch’egli così non voglia morire come egli è vivuto?»
Ma pur vedendo che sì aveva detto che egli sarebbe a sepoltura ricevuto in chiesa, niente del rimaso si curarono. Ser Ciappelletto poco appresso si comunicò, e peggiorando senza modo, ebbe l’ultima unzione; e poco passato vespro, quel dì stesso che la buona confessione fatta avea, si morì. Per la qual cosa li due fratelli, ordinato di quello di lui medesimo come egli fosse onorevolmente sepellito, e man datolo a dire al luogo de’ frati, e che essi vi venissero la sera a far la vigilia secondo l’usanza e la mattina per lo corpo, ogni cosa a ciò opportuna disposero.
Il santo frate che confessato l’avea, udendo che egli era trapassato, fu insieme col priore del luogo, e fatto sonare a capitolo, alli frati ragunati in quello mostrò ser Ciappelletto essere stato santo uomo, secondo che per la sua confessione conceputo avea; e sperando per lui Domenedio dover molti miracoli dimostrare, persuadette loro che con grandissima reverenzia e divozione quello corpo si dovesse ricevere. Alla qual cosa il priore e gli altri frati creduli s’accordarono; e la sera, andati tutti là dove il corpo di ser Ciappelletto giaceva, sopr’esso fecero una grande e solenne vigilia; e la mattina, tutti vestiti co’ camici e co’ pieviali, con libri in mano e con le croci innanzi, cantando, andaron per questo corpo e con grandissima festa e solennità il recarono alla lor chiesa, seguendo quasi tutto il popolo della città, uomini e donne. E nella chiesa postolo, il santo frate che confessato l’avea, salito in sul pergamo, di lui cominciò e della sua vita, de’ suoi digiuni, della sua virginità, della sua simplicità e innocenzia e santità maravigliose cose a predicare, tra l’altre cose narrando quello che ser Ciappelletto per lo suo maggior peccato piagnendo gli avea confessato, e come esso appena gli avea potuto mettere nel capo che Iddio gliele dovesse perdonare, da questo volgendosi a riprendere il popolo che ascoltava, dicendo: «E voi, maledetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi si volge tra’ piedi bestemmiate Iddio e la Madre, e tutta la corte di paradiso».
E oltre a queste, molte altre cose disse della sua lealtà e della sua purità; e in brieve colle sue parole, alle quali era dalla gente della contrada data intera fede, sì il mise nel capo e nella divozion di tutti coloro che v’erano che, poi che fornito fu l’uficio, colla maggior calca del mondo da tutti fu andato a baciargli i piedi e le mani, e tutti i panni gli furono in dosso stracciati, tenendosi beato chi pure un poco di quegli potesse avere; e convenne che tutto il giorno così fosse tenuto, acciò che da tutti potesse essere veduto e visitato. Poi, la vegnente notte, in una arca di marmo sepellito fu onorevolmente in una cappella, e a mano a mano il dì seguente vi cominciarono le genti ad andare e ad accender lumi e ad adorarlo, e per conseguente a botarsi e ad appiccarvi le imagini della cera secondo la promession fatta. E in tanto crebbe la fama della sua santità e divozione a lui, che quasi niuno era, che in alcuna avversità fosse, che ad altro santo che a lui si botasse, e chiamaronlo e chiamano san Ciappelletto; e affermano molti miracoli Iddio aver mostrati per lui e mostrare tutto giorno a chi divotamente si raccomanda a lui.
Così adunque visse e morì ser Cepperello da Prato e santo divenne come avete udito. Il quale negar non voglio essere possibile lui essere beato nella presenza di Dio, per ciò che, come che la sua vita fosse scelerata e malvagia, egli potè in su l’estremo aver sì fatta contrizione, che per avventura Iddio ebbe misericordia di lui e nel suo regno il ricevette; ma, per ciò che questo n’è occulto, secondo quello che ne può apparire ragiono, e dico costui più tosto dovere essere nelle mani del diavolo in perdizione che in paradiso. E se così è, grandissima si può la benignità di Dio cognoscere verso noi, la quale non al nostro errore, ma alla purità della fede riguardando, così faccendo noi nostro mezzano un suo nemico, amico credendolo, ci esaudisce, come se ad uno veramente santo per mezzano della sua grazia ricorressimo. E per ciò, acciò che noi per la sua grazia nelle presenti avversità e in questa compagnia così lieta siamo sani e salvi servati, lodando il suo nome nel quale cominciata l’abbiamo, lui in reverenza avendo, né nostri bisogni gli ci raccomandiamo, sicurissimi d’essere uditi.

Franco Citti nella parte di Ser Cepperello nel Decameron di Pasolini (1971)
Si racconta che Musciatto Franzesi, essendo diventato cavaliere in Francia da ricchissimo e potente mercante e dovendo venire a Firenze con Carlo di Valois, fratello del re Filippo il Bello, chiamato e sollecitato da papa Bonifacio VIII, sapendo che i suoi affari, come capita spesso ai mercanti, erano molto intricati di qua e di là e non potendoli risolvere facilmente, decise di affidarli a diverse persone e trovò quelle adatte ad ogni affare: solamente in dubbio gli rimase a chi sufficientemente affidare la riscossione dei suoi crediti fatti a diversi borgognoni. Il motivo della difficoltà della scelta era dovuto al fatto che gli abitanti di Borgogna erano litigiosi, malvagi e falsi; e a lui non veniva in mente chi fosse tanto malvagio, in cui porre grande fiducia da opporre alla loro malvagità. E avendo pensato a lungo, gli venne infine in mente un ser Cepparello di Siena, che a Parigi si era spesso ricoverato a casa sua, poiché era piccolino, ma ben sistemato, non sapendo i francesi cosa significasse Cepparello, credendo che volesse dire “cappello” o “copricapo”, nella loro lingua, non “Ciappello”, perché era piccolino, ma “Ciappelletto” lo chiamavano, e così per Ciappelletto tutti lo conoscevano, mentre per pochi ancora il suo nome era “Cepparello”. La vita di questo Ciappelletto era questa: essendo notaio, si vergognava moltissimo quando qualcuno dei suoi atti notarili fosse onesto, e tanti falsi ne avrebbe fatti quanti gliene avessero richiesti e questi li faceva gratuitamente più volentieri e che altri ben ricompensati. Diceva il falso con grande gioia, richiesto e non richiesto, e, prestando in quel tempo in Francia grandissima importanza ai giuramenti, non importandogli di giurare il falso, vinceva malvagiamente molte questioni sulle quali era chiamato a prestar fede. Provava gusto e molte volte anche provocava nello suscitare mali, inimicizie e scandali tra parenti e amici o qualsiasi altra persona, tra i quali quando più grandi mali vedeva seguire, quanto più trovava gioia. Invitato ad assistere ad un omicidio o a qualche altra azione delittuosa, senza mai negarsi, vi andava felicemente e molte volte si ritrovò volentieri a ferire o a uccidere con le proprie mani. Grande bestemmiatore di Dio e dei Santi, per ogni piccola cosa, così come colui che era estremamente iracondo. Non frequentava mai la Chiesa, e scherniva tutti i sacramenti come riti vigliacchi, mentre le taverne e i luoghi disonesti visitava volentieri e frequentava. Era così schifato dalle donne come sono i cani con i bastoni; con il sesso opposto si dilettava più di ogni altro uomo vizioso. Avrebbe commesso furti e rapimenti con la stessa coscienza con cui un sant’uomo offrirebbe l’elemosina. Golosissimo e grande bevitore, tanto che alcune volte vomitava sconciamente. Era un grandissimo giocatore con dadi falsi (baro): Ma perché mi dilungo in tante parole? Egli era il peggior uomo che fosse nato. La sua malizia sostenne per lungo tempo la condizione di Musciatto, per cui dalle persone private, a cui aveva fatto ingiuria, o alla pubblica corte, a cui continuamente le faceva, gli fu usato riguardo.
Venuto dunque in mente a messer Musciatto, che conosceva ottimamente la sua vita, pensò che la sua malignità dover esser adeguata a quella dei Borgognoni, perciò, fattolo chiamare, gli disse: «Ser Ciappelleto, come sai, io sto per allontanarmi da qui e, avendo tra le altre cose a fare con i borgognoni, uomini pieni d’inganni, non so a chi lasciare riscuotere i miei affari più adatta di te. E perciò, non facendo ora nulla e se mai lo desiderassi, laddove volessi, intendo farti avere la protezione della corte e di donarti una parte di ciò che riscuoterai che riterrai più opportuno.»
Ser Ciappelleto, che era senza lavoro e in cattive condizioni economiche e vedendo andar via chi per lui era stato per lungo tempo suo sostegno e protezione, accettò senza alcun indugio e quasi costretto dalla necessità, e disse che lo avrebbe fatto volentieri. Per cui, messosi d’accordo, ricevuta la procura e le lettere favorevoli del re, partito messer Musciatto, andò in Borgogna, dove non lo conosceva quasi nessuno e qui, fuori dalla sua indole, con fare benevole e cortese cominciò a voler riscuotere e a compiere il compito per cui era stato mandato, quasi si riversasse a fare esplodere la sua naturale ira alla fine.
E così facendo, mentre era ricoverato in casa di due fratelli fiorentini, usurai, e onorato molto da loro per amor di messer Musciatto, si ammalò. Allora i due fratelli fecero venir subito medici e servitori che lo servissero e ogni cosa opportuna affinché guarisse. Ma ogni aiuto era nullo, come dicevano i medici, per il fatto che il buon vecchio era vecchio e aveva vissuto in modo disordinato, e peggiorava di giorno in giorno, come se avesse una malattia inguaribile; di questa cosa i due fiorentini si lamentavano molto.
Un giorno, stando vicini alla camera in cui Ciappelletto giaceva malato, cominciarono così a parlare tra loro: «Che facciamo di lui? Noi a causa sua ci troviamo in una pessima situazione: perché sarebbe una grande vergogna ed una pazzia mandarlo via di casa così malato, dopo che la gente ci ha visto riceverlo e cercato di guarirlo ed ora, senza che egli ci abbia fatto alcun male, che dobbiamo mandarlo via così malato e verso una morte certa. D’altra parte egli è stato così malvagio che non vorrà confessarsi né prendere alcun sacramento; e morendo senza confessione, nessuna Chiesa vorrà ricevere il suo corpo, anzi sarà gettato nei fossi come un cane. E, se anche si dovesse confessare, i suoi peccati sono così orrendi, che accadrà la stessa cosa dal momento che nessun prete vorrà o potrà assolverlo per cui, non assolto, sarà ugualmente gettato ai fossi. E se ciò avvenisse, il popolo di questa terra, per il nostro mestiere, che a loro pare estremamente ingiusto e ci insultano ogni giorno a tal punto da volerci rubare, vedendo questo fatto si solleverà un tumulto e grideranno: “Questi cani lombardi, che la Chiesa si rifiuta di riceverli, non li vogliamo più tollerare” e correranno alle case e non solo ci porteranno via e cose, ma forse ci toglieranno anche la vita: per questo noi siamo nei guai, qualsiasi sia la nostra scelta, se costui muore».
Ser Ciappelletto, il quale, come già detto, giaceva vicino là dove i fratelli così ragionavano, avendo l’udito sottile, come spesso accade agli ammalati, udì ciò che loro di lui avevano detto; così li fece chiamare e disse loro: «Voglio che voi non dobbiate subire nulla per colpa mia né abbiate paura che io vi possa danneggiare. Ho sentito ciò che avete detto di me e sono sicurissimo che mi accadrebbe ciò che voi avete pronosticato, se le cose andassero così come pensate: ma andrà diversamente. Io, vivendo, ho fatto così tanti peccati verso Dio che, facendone una ora, sul punto di morte, non ne farà conto; e per questo fatemi venire un santo e valente frate, il più che potete, se qui ve n’è uno; e lasciatemi fare, che sicuramente sistemerò i fatti vostri e i miei in modo che risolverò la questione e ne sarete contenti»
I due fratelli, sebbene non riponessero molta speranza in questo, nondimeno andarono in un convento richiedendo un santo e saggio uomo che udisse la confessione di un lombardo malato in casa loro; e fu loro dato un vecchio frate, di vita santa e buona, gran maestro delle Sacre Scritture e molto venerabile, verso il quale tutti i cittadini avevano una speciale devozione, e glielo condussero. Questo, giunto nella camera dove ser Ciappelletto era infermo e postosi a sedere a fianco a lui, primo cominciò a confortarlo benignamente e in seguito gli domandò da quanto tempo non si confessasse. A lui ser Ciappelletto, che non si era mai confessato, rispose: «Padre mio, ho l’abitudine di confessarmi almeno una volta la settimana, anche se ci sono quelle in cui io mi confesso più volte; è pur vero che da quando mi sono ammalato, sono passati otto giorni, tanta è stata la sofferenza che la malattia mi ha procurato».
Gli disse il frate: «Figliolo, hai fatto bene; così bisogna fare d’ora in poi; e vedo che, dal momento che ti confessi così spesso, avrò poca fatica nell’ascoltarti e nel domandarti dei tuoi peccati».
Ser Ciappelleto disse: «Signor frate, non dite così: io non mi sono confessato tante volte, né così spesso, da non volermi confessare di tutti i peccati della mia vita da quando sono nato fino a questo giorno; e perciò vi prego padre mio buono, che in modo puntuale, mi poniate delle domande come se non mi fossi mai confessato, e non abbiate riguardo per la mia malattia, che preferisco di molto dispiacere al mio corpo perché, facendo cosa che fosse gradita loro, temo di entrare nella perdizione della mia anima, che il Signore riscattò col suo prezioso sangue».
Queste parole piacquero molto al venerando padre e gli sembrarono opportune per un uomo ben disposto verso la confessione; e dopo aver assai lodato questa sua abitudine, cominciò a chiedergli se mai avesse peccato in lussuria con le donne.
A lui sospirando Ciappelletto rispose: «Padre mio, di questo argomento mi vergogno di dirvi la verità, pensando d’essere vanaglorioso.
A cui il santo frate disse: «Parla sicuramente, che dicendo la verità non si pecca mai».
Allora disse ser Ciappelletto: «Poiché voi mi date sicurezza, ve lo dirò: io sono vergine come uscii dal corpo di mia madre».
«Oh, benedetto sia tu dal Dio», disse il frate «come hai fatto bene, e facendolo hai tanto meritato quanto, volendolo, avevi la facoltà che noi non abbiamo e che altri (non hanno) vincolati da una regola (religiosa)»
In seguito gli chiese se avesse commesso peccato di gola. Alla cui domanda, Ciappelletto, sospirando molto, rispose di sì e molte volte; per il fatto che, molte volte, dal momento che egli, oltre alle quaresime che si fanno durante l’anno dai devoti, ogni settimana fosse solito digiunare almeno tre giorni solo con pane e acqua e aveva bevuto l’acqua con gran gusto, specialmente dopo aver faticato o pregato o andato in pellegrinaggio, come coloro che bevono il vino; e molte volte aveva desiderato d’avere delle insalate di erbe, quelle che le donne raccolgono in campagna, e molte volte gli era sembrato migliore il mangiare di quanto avrebbe dovuto apparirgli a chi digiuna per devozione, come lui faceva».
A lui il frate rispose: «Figliolo mio, questi peccati sono naturali e molto veniali, e per questo voglio che la tua coscienza non sia da essi gravata più del necessario. Ad ogni uomo capita che dopo aver a lungo digiunato, per santissimo che sia, sembri il cibo e il bere un bene».
Disse Ciappelletto: «Oh, non deve dirmi questo per confortarmi, ben sapete che io so che le cose che si fanno al servizio di Dio, devono esser fatte in modo puro e senza macchia nell’anima e chiunque fa in modo diverso, pecca».
Il frate, contentissimo, disse: «Ed io sono felice che tu pensi questo e mi piace la tua coscienza pura e buona in questo. Ma, dimmi, in avarizia hai peccato, desiderando più del necessario e tenendo tu quello che non ti era dovuto?»
Al quale ser Ciappelletto disse: «Padre mio, io non vorrei che voi dubitaste perché io sono in casa di questi usurai: io non ho nulla a che fare con loro, anzi ero venuto per ammonirli e castigarli e toglierli da questo abominevole guadagno; e credo che ci sarei riuscito se Dio non mi avesse visitato. Ma voi dovete sapere che mio padre mi lasciò molto ricco, del cui avere, dopo la sua morte, gran parte diedi alla chiesa, poi per sostenere la mia vita e quella dei poveri di Cristo, ho fatto piccole mercanzie ed in quelle ho desiderato di guadagnare. E sempre con i poveri quello che ho guadagnato ho diviso; prendendo la metà per sostenermi e la metà per il loro sostegno e di questo mi ha favorito il Creatore che ho sempre garantito e difeso la mia vita».
«Ti sei comportato bene ed ora dimmi ti sei mai adirato?» disse il prete.
Rispose Ciappelletto: «Oh, vi dico chiaramente che mi sono arrabbiato spesso: e chi potrebbe trattenere l’ira, vedendo tutto il giorno gli uomini comportarsi in modo sconcio, non osservare i comandamenti di Dio e non temere il suo giudizio? Ci sono state volte che vorrei essere stato morto più che vivo, vedendo i giovani andare dietro le vanità e ascoltandoli giurare e spergiurare, andare alle taverne, non rispettare le feste e seguendo piuttosto le vie del mondo che quelle di Dio».
Disse allora il frate: «Figliolo mio, questa è buona ira, né io, per me, saprei importi una penitenza; ma qualche volta ha potuto l’ira spingerti ad un omicidio, a dire cattive parole verso qualcuno o fare qualsiasi atto ingiurioso?»
Al quale ser Ciappelleto rispose: «Oimè, signore, eppure mi sembrate uomo di Dio: come dite voi queste parole? Se io avessi avuto anche una piccolissima idea di fare qualcosa che voi dite, credete che Dio mi avrebbe sorretto? Queste sono cose che fanno gli assassini e i malvagi, dei quali, ogni volta che ne ho incontrato qualcuno, gli ho sempre detto “Va, che Dio ti converta”».
Allora disse il frate: «Ora dimmi, figlio mio, sia tu benedetto da Dio, hai tu mai detto una falsa testimonianza contro qualcuno, o sparlato di qualcuno o preso cose altrui senza che l’altro ne ricevesse piacere?»
Rispose Ciappelletto: «Certamente sì, che io ho parlato male di qualcuno: perché io ebbi tempo fa un vicino che, del tutto ingiustamente, non faceva altro che picchiare la moglie, tanto che io parlai male di lui ai genitori della donna, tanta fu la pietà che provai per quella poverella, che, ogni volta che lui tornava ubriaco, la conciava come solo Dio lo sa».
Disse il frate: «Orbene, tu mi hai detto che sei stato mercante: hai ingannato mai le persone così come fanno i mercanti?»
«In fede mia» disse Ciappelleto «sì, ma non so a chi. Senonché, dovendomi egli dare dei denari per dei panni che gli avevo venduto e messili in una mia cassa senza contarli, dopo un mese scoprii che vi erano quattro monete più di quelle dovute. Per cui, passato un anno e non vedendolo più per restituirglieli, li diedi in carità».
Disse il frate: «Questa è una piccola cosa e hai fatto bene a fare quello che hai fatto»
E, oltre a questo, il frate gli domandò molte altre cose, alle quali rispose al modo in cui abbiamo visto, e, volendo quindi procedere all’assoluzione, ser Ciappelletto disse: «Signore, io ancora qualche peccato che non v’ho detto».
Il frate domandò quale ed egli disse: «Io ricordo che feci spazzare un mio servo sabato sera, e non ebbi la reverenza, per la domenica, che dovevo».
«Oh,» disse il frate «figlio mio, questa è poca cosa»
Disse ser Ciappelleto: «Non dite poca cosa, che la domenica si deve adorare, per il fatto che in questo giorno resuscitò nostro Signore».
Disse allora il frate: «Hai fatto altro?»
«Signor sì» rispose «che io, non accorgendomene, sputai una volta nella chiesa di Dio»
Il frate cominciò a sorridere e disse: «Figliol mio, questo è da non prendere in considerazione; noi, che siamo religiosi, vi sputiamo tutto il giorno».
Disse allora ser Ciappelletto: «E fate un grande vigliaccheria, perché niente è da tebersi così pulito come il luogo in cui si svolge il sacrificio di Cristo».
E in poche parole aggiunse molti altri fatti e alla fine cominciò a sospirare e dopo a piangere forte, che lòui lo sapeva fare bene, quando voleva.
Disse il santo frate: «Figlio mio, che hai?»
Rispose ser Ciappelletto: «Oimè, signore, mi è rimasto un peccato, che non ho mai confessato, che ho grande vergogna nel ricordarlo oggi; ed ogni volta che ci ripenso mi vien da piangere, come vedete, e so per certyo che Dio non mi perdonerà per questo peccato».
Allora il Santo padre disse: «Ma va là!, figliolo, che dici? Se tutti i peccati che sono stati fatti dagli uomini o che saranno fatti finché durerà il mondo, fossero in un solo uomo ed egli ne fosse pentito e contrito come ti vedo, tanta è la bontà e la misericordia del Cielo che, confessandolo, glielo perdonerebbe con piacere ; per questo dillo con sicurezza.
Disse ser Ciappelletto, sempre piangendo: «Oimè, io mio peccato è troppo grave, e posso appena credere, se non ci fossero le vostre preghiere, di esser perdonato».
Disse il frate: «Dillo sicuramente, che io pregherò Dio per te».
Ser Ciappelletto piangeva ancora e non lo diceva, i il frate lo esortava a confessarlo; ma poi, dopo che Ciappelletto piangendo tenne a lungo il frate in attesa, dopo aver emesso un gran sospirato disse: «Padre mio, dal momento che avete promesso di pregare Dio per me, ve lo dirò: sappiate che una volta quando ero piccolino io maledissi mia madre»». E detto questo ricominciò a pianger forte.Disse il frate: «O figlio mio, ti sembra questo un così grande peccato? Gli uomini bestemmiano tutto il giorno Dio, eppure Egli perdona coloro a chi si pente d’averlo fatto: e tu credi che Egli non ti perdoni? Non piangere, confortati, che sicuramente, se tu fossi stato uno di quelli che lo posero in croce, mostrando il forte pentimento che io vedo in te, certamente Egli ti perdonerebbe.»
Disse allora ser Ciappelletto: «Oimè, frate mio, che dite mai? La mia dolce mamma che mi portò nel ventre per nove mesi e mi raccolse in petto durante la notte più di cento volte! Io ho fatto un gravissimo peccato a maledirla e se voi non pregate per me, Dio non perdonerà».
Il padre vedendo che non vi era nulla d’aggiungere alla confessione, gli diede l’assoluzione e la benedizione, credendolo un uomo santissimo, credendo certamente fosse vero ciò che Ciappelletto gli aveva detto: e chi non lo crederebbe vedendo un uomo in punto di morte dir così?
E poi, dopo, gli chiese: «Ser Ciappelletto, con l’aiuto di Dio voi sarete presto guarito, ma se pure avvenisse che Dio chiami la vostra benedetta e santa anima, vi farebbe piacere esser seppellito nel cimitero del Convento?»
A cui ser Ciappelletto rispose: «Si signore, anzi non vorrei essere altrove, dopo che voi avete promesso di pregare Dio per me, considerando inoltre la mia speciale devozione al vostro ordine. E vi prego di, appena sarete nel vostro luogo, fate in modo che a me venga quel corpo di Dio vero (attraverso l’ostia) che voi al mattino consacrate, dal momento che io, pur non essendone degno, con vostro permesso lo prenda, affinché se son vissuto nel peccato, almeno muoia da cristiano».
Il santo uomo affermò che molto gradiva la richiesta ben posta e avrebbe fatto in modo, che il giorno stesso, ricevesse l’eucarestia.
I due fratelli, che dubitavano fortemente che Ciappelletto li ingannasse, s’erano messi dietro un pannello che divideva la camera di Ciappelleto con l’altra, e ascoltando con facilità udirono tutto ciò che Ciappelletto diceva al frate, e veniva loro, alcune volte, tanto da ridere, ascoltando ciò che veniva confessato, che quasi scoppiavano; e talore si dicevano tra loro: «Che uomo è questo, che né vecchiaia, né malattia, né la paura della morte, che era a lui prossima, né addirittura di Dio, davanti al giudizio di cui in poco tempo avrebbe dovuto essere, l’hanno rimosso dalla sua malvagità, né fare in modo che egli morisse diversamente da come era vissuto. Ma come sentirono che sarebbe stato seppellito in Chiesa, non si preoccuparono di altro.
Ciappelleto ricevette la comunione e poco dopo si aggravò, e peggiorando in modo grave, ricevette l’estrema unzione e, passata la sera, il giorno stesso in cui aveva fatto la confessione, morì. Per cui i due fratelli, avendo disposto che egli, con il suo denaro, fosse onorevolmente seppellito e mandato a riferire della sua morte ai frati, e che essi stessi venissero quella stessa sera a prenderlo per far la veglia funebre secondo l’usanza e la mattina seguente per la sepoltura, disposero affinché fosse fatto tutto in modo opportuno.
Il frate che lo aveva confessato, saputo che Ciappelletto era morto, ebbe un colloquio con il priore luogo; e fatta suonare la campana, ai frati raccolti mostrò che ser Ciappelletto era stato un sant’uomo, così come aveva dedotto dalla sua confessione e sperando che il Signore, attraverso lui, dovesse dar vita a molti miracoli, convinse loro che si dovesse ricevere il suo corpo con somma reverenza e devozione. Sia il priore che i frati, credendo alle parole del confessore, accettarono e la sera stessa, andati nel luogo in cui Ciappelletto era spirato, fecero per lui una grande e solenne veglia di preghiera. Il mattino seguente, tutti vestiti con camici e piviali (abiti e mantelli indossati dagli ecclesiastici per le grandi solennità), con i libri sacri in mano e preceduti dalla croce, cantando in coro, andarono a prendere il corpo e a trasportarlo alla loro chiesa in modo festoso e solenne, seguiti da quasi tutto il popolo della città, uomini e donne. Messo il corpo di ser Ciappelletto in chiesa, il santo frate, che l’aveva confessato, salito sul pulpito cominciò a predicare, riferendo cose meravigliose di lui, della sua vita, dei suoi digiuni, della sua verginità, della sua semplicità, innocenza e santità; ed inoltre raccontando di cosa ser Ciappelletto, piangendo, gli aveva confessato come maggior peccato, e come avesse dovuto convincerlo, lui stesso, che Dio glielo avrebbe perdonato, e da ciò, prendendo lo spunto per rimproverare il popolo che lo ascoltava: «E voi, maledetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi s’impiglia tra i piedi, bestemmiate Dio, la Madonna e tutti i santi del Paradiso».
Oltre a queste, riferì molte altre cose sulla sua lealtà e purezza: in breve, con le sue parole, alle quali la gente della contrada aveva dato pienamente fede, che così mise in capo e nella devozione di tutti presenti che, finita la funzione, tutti con la maggior calca del mondo, volevano baciargli i piedi e le mani, e gli avevano strappato i panni che aveva indosso, ritenendosi beato chi avesse potuto averne anche soltanto un poco, e si ritenne di mantenerlo così all’interno della chiesa per tutto il giorno, affinché fosse visto e ricevesse la visita da tutti. Poi, la notte seguente, messo in un’arca marmorea fu seppellito onorevolmente in una cappella: dal giorno seguente cominciarono piano piano le visite della gente, chi ad accender lumi e adorarlo, e conseguentemente a far voti e a affiggere le immagini di cera (ex-voto) secondo la promessa richiesta. E a tal punto crebbe la fama della sua santità e della devozione a lui, che quasi nessuno che avesse qualche avversità, facesse voti ad altro santo che non fosse lui, e lo chiamarono e tuttora lo chiamano San Ciappelletto; e affermano che molti miracoli Dio fece attraverso lui, e tuttora fa a chi con devozione si raccomanda a lui.
Così dunque visse e morì ser Cepparello da Prato e come avete ascoltato, divenne santo. Non voglio negare che lui sia beato alla presenza di Dio e sebbene la sua vita fosse stata scellerata e malvagia, che abbia potuto all’ultimo aver fatto un così grande pentimento, che forse Dio abbia avuto misericordia di lui da riceverlo nel suo regno; ma siccome questo non è possibile da sapere, secondo quello che sappiamo, giudico e affermo che costui dovrebbe essere piuttosto nelle mani del diavolo in perdizione che in Paradiso. E se così fosse, si può riconoscere la grande benevolenza di Dio nei nostri confronti, la quale guardando la nostra fede e non l’errore, facendo noi da intercessore un suo nemico, credendolo un suo amico, allo stesso modo ci esaudisce, come se ad un vero santo, come intermediario, ci rivolgessimo. E per questo, dal momento che per sua grazia siamo stati conservati sani e salvi in questa avversità (della peste) e in così lieta compagnia, lodando il suo nome, con il quale l’abbiamo cominciata, avendo Lui in reverenza, ci raccomanderemo a Lui neli nostri bisogni, sicurissimi d’essere ascoltati.
 Il peccatore Ser Ciappelletto s’ammala in viaggio. Prima di morire si finge santo, il prete confessore ne beatifica la memoria”. Miniatura tratta dal ‘Decameron’ (codice del XV secolo)
Il peccatore Ser Ciappelletto s’ammala in viaggio. Prima di morire si finge santo, il prete confessore ne beatifica la memoria”. Miniatura tratta dal ‘Decameron’ (codice del XV secolo)
La novella di Ciappelletto, proprio perché è la prima ad essere raccontata, ha un protagonista malvagio, “il piggiore uomo forse che mai nascesse”. Tale figura viene inserita all’interno di un’etica mercantile, etica di cui lo stesso Boccaccio, come vedremo meglio, si farà estimatore. Infatti secondo la logica mercantile di Musciatto Franzesi per raggiungere l’obiettivo occorre un mezzo idoneo, ed essendo i borgognoni ladri ed infigardi, bisogna mandare chi è più ladro e più infingardo di loro. Moralmente criticabile, “commercialmente” emendabile.
Altra caratteristica della novella è certamente una doppia duplicazione:
- Ciappelletto è piccolo, minuto (lo stesso nome è un diminutivo), così come enormi, grandissimi sono i suoi peccati;
- La confessione è la duplicazione rovesciata dei suoi vizi.
Il fatto che venga sottolineata la piccolezza del protagonista, rende lo stesso più caricaturale proprio alla luce dell’enormità della sua vita viziosa, così come la descrizione a tutto tondo della sua vita rende più semplice ed efficace l’enormità della sua confessione. D’altra parte l’efficacia narrativa è nel tenere all’interno della stessa malvagità del protagonista l’atto della confessione (il narratore, così come il lettore sanno che essa è un’ulteriore falsità – per lo più compiuta in punto di morte -) e l’esaltazione virtuosa della stessa da parte del coprotagonista (il prete confessore, che non sa che è una falsità).
Vorremo in ultimo ricordare che la novella è strutturata secondo il modello degli exempla medioevali: teoria (Dio può operare il bene anche attraverso personaggi malvagi), novella esplicativa (narrazione della vita e della morte di Ciappelletto), conclusione in cui si afferma che a Dio non importa chi venga preso per intermediario, ma soltanto la fede di chi crede.
Sarà Filomena a raccontare la terza novella della prima giornata:

Melchisedech e il Saladino in un codice del XV sec.
MELCHISEDECH GIUDEO, CON UNA NOVELLA DI TRE ANELLA, CESSA UN GRAN PERICOLO DAL SALADINO APPARECCHIATOGLI.
(I, 3)
Il Saladino, il valore del qual fu tanto che non solamente di piccolo uomo il fe’ di Babillonia soldano, ma ancora molte vittorie sopra li re saracini e cristiani gli fece avere, avendo in diverse guerre e in grandissime sue magnificenze speso tutto il suo tesoro, e, per alcuno accidente sopravvenutogli bisognandogli una buona quantità di danari, né veggendo donde così prestamente come gli bisognavano aver gli potesse, gli venne a memoria un ricco giudeo, il cui nome era Melchisedech, il quale prestava ad usura in Alessandria, e pensossi costui avere da poterlo servire quando volesse; ma sì era avaro che di sua volontà non l’avrebbe mai fatto, e forza non gli voleva fare; per che, strignendolo il bisogno, rivoltosi tutto a dover trovar modo come il giudeo il servisse, s’avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata.
E fattolsi chiamare e familiarmente ricevutolo, seco il fece sedere e appresso gli disse: – Valente uomo, io ho da più persone inteso che tu se’ savissimo e nelle cose di Dio senti molto avanti; e per ciò io saprei volentieri da te quale delle tre leggi tu reputi la verace, o la giudaica o la saracina o la cristiana.
Il giudeo, il quale veramente era savio uomo, s’avvisò troppo bene che il Saladino guardava di pigliarlo nelle parole per dovergli muovere alcuna quistione, e pensò non potere alcuna di queste tre più l’una che l’altra lodare, che il Saladino non avesse la sua intenzione. Per che, come colui al qual pareva d’aver bisogno di risposta per la quale preso non potesse essere, aguzzato lo ‘ngegno, gli venne prestamente avanti quello che dir dovesse, e disse: – Signor mio, la quistione la qual voi mi fate è bella, e a volervene dire ciò che io ne sento, mi vi convien dire una novelletta, qual voi udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udito dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale, intra l’altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era uno anello bellissimo e prezioso; al quale per lo suo valore e per la sua bellezza volendo fare onore e in perpetuo lasciarlo né suoi discendenti, ordinò che colui de’ suoi figliuoli appo il quale, sì come lasciatogli da lui, fosse questo anello trovato, che colui s’intendesse essere il suo erede e dovesse da tutti gli altri essere come maggiore onorato e reverito. E colui al quale da costui fu lasciato il simigliante ordinò né suoi discendenti e così fece come fatto avea il suo predecessore; e in brieve andò questo anello di mano in mano a molti successori; e ultimamente pervenne alle mani ad uno, il quale avea tre figliuoli belli e virtuosi e molto al padre loro obedienti, per la qual cosa tutti e tre parimente gli amava. E i giovani, li quali la consuetudine dello anello sapevano, sì come vaghi d’essere ciascuno il più onorato tra’ suoi ciascuno per se’, come meglio sapeva, pregava il padre, il quale era già vecchio, che, quando a morte venisse, a lui quello anello lasciasse. Il valente uomo, che parimente tutti gli amava, né sapeva esso medesimo eleggere a qual più tosto lasciar lo dovesse, pensò, avendolo a ciascun promesso, di volergli tutti e tre sodisfare; e segretamente ad uno buono maestro ne fece fare due altri, li quali sì furono simiglianti al primiero, che esso medesimo che fatti gli avea fare appena conosceva qual si fosse il vero. E venendo a morte, segretamente diede il suo a ciascun de’ figliuoli. Li quali, dopo la morte del padre, volendo ciascuno la eredità e l’onore occupare, e l’uno negandolo all’altro, in testimonianza di dover ciò ragionevolmente fare ciascuno produsse fuori il suo anello. E trovatisi gli anelli sì simili l’uno all’altro che qual di costoro fosse il vero non si sapeva conoscere, si rimase la quistione, qual fosse il vero erede del padre, in pendente, e ancor pende. E così vi dico, signor mio, delle tre leggi alli tre popoli date da Dio padre, delle quali la quistion proponeste: ciascuno la sua eredità, la sua vera legge e i suoi comandamenti dirittamente si crede avere e fare; ma chi se l’abbia, come degli anelli, ancora ne pende la quistione.
Il Saladino conobbe costui ottimamente essere saputo uscire del laccio il quale davanti a’ piedi teso gli aveva; e per ciò dispose d’aprirgli il suo bisogno e vedere se servire il volesse; e così fece, aprendogli ciò che in animo avesse avuto di fare, se così discretamente, come fatto avea, non gli avesse risposto. Il giudeo liberamente d’ogni quantità che il Saladino richiese il servì; e il Saladino poi interamente il soddisfece; e oltre a ciò gli donò grandissimi doni e sempre per suo amico l’ebbe e in grande e onorevole stato appresso di sé il mantenne.
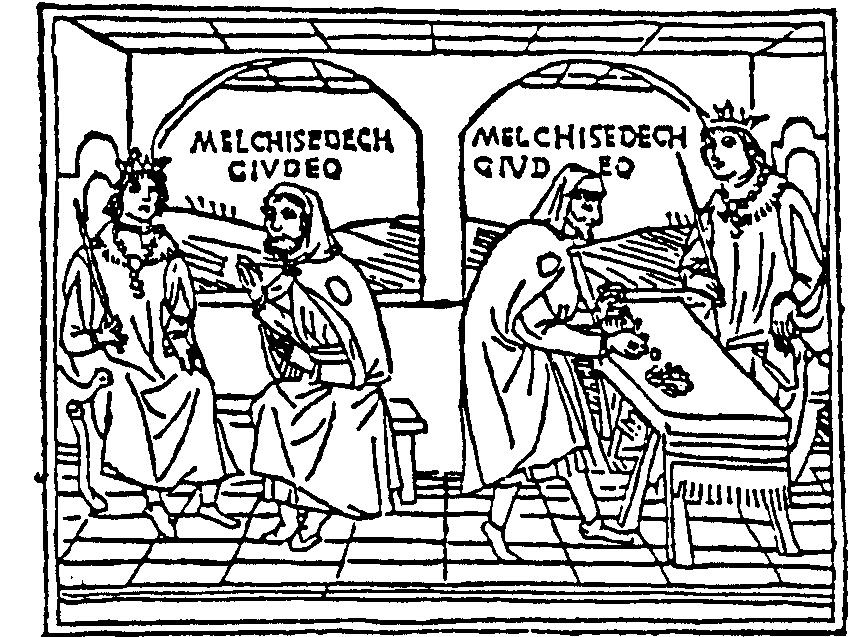
Un taglio di legno del XV secolo, che illustra la Storia dei tre anelli di Boccaccio
Il Saladino, il cui valore fu tanto grande che grazie ad esso, non soltanto egli passò dall’essere un uomo qualunque ad essere il sultano di Babilonia, ma per giunta ottenne innumerevoli vittorie contro i re cristiani e saraceni, aveva dato fondo all’intero suo patrimonio, a seguito di diverse guerre e di una serie di iniziative molto dispendiose; contemporaneamente, per un qualche avvenimento che gli era capitato, il Saladino si trovava ad aver bisogno di una grossa somma di denaro, e non aveva idea del modo in cui avrebbe potuto trovare quel denaro nel breve tempo che aveva a disposizione; così gli tornò alla memoria la figura di un ricco giudeo, il cui nome era Melchisedech, il quale esercitava l’attività di usuraio ad Alessandria d’Egitto; il Saladino ritenne che Melchisedech possedesse abbastanza denaro da soddisfare la sua necessità, qualora avesse voluto; ma il Saladino sapeva anche che Melchisedech era così avaro, che non avrebbe mai concesso i suoi soldi, a meno che non fosse stato costretto a farlo, ed egli non voleva ricorrere ai soprusi; alla fine il Saladino, tormentato dalla necessità di denaro, concentrò tutte le sue energie nella ricerca di un modo per farsi finanziare dal giudeo Melchisedech, ed escogitò di commettere un sopruso che apparisse giustificato da qualche parvenza di legalità.
Quindi mandò a chiamare Melchisedech e lo accolse con benevolenza, si sedette con lui e gli disse: «Saggio uomo, ho sentito dire da più persone che tu sei un uomo estremamente assennato e che hai molto approfondito le questioni religiose; per questa ragione io sarei molto interessato a sentire da te quale, tra le religioni monoteiste, tu ritieni quella autentica, se la religione giudaica, quella cristiana o quella islamica».
Il giudeo Melchisedech, che era per davvero un uomo molto assennato, si rese conto fin troppo bene che il Saladino stava cercando di farlo cadere in un tranello per potergli poi muovere qualche accusa, e pensò che l’unico modo per impedire al Saladino di riuscire nel suo intento, fosse non esprimersi a favore di nessuna delle tre religioni. così, dal momento che egli aveva l’assoluta necessità di trovare una risposta che non lo facesse cadere nella trappola, aguzzò il suo ingegno e subito ebbe davanti a sé ciò che avrebbe dovuto rispondere; allora disse: «Mio sultano, la domanda che voi mi ponete è molto interessante e per farvi capire quale sia il mio punto di vista, vi racconterò una breve novella, che adesso ascolterete. Se la memoria non m’inganna, io ricordo di aver sentito raccontare più volte che, molto tempo fa, visse un uomo illustre e ricco, il quale, tra i gioielli più preziosi che facevano parte del suo tesoro, aveva anche un anello bellissimo e raro; e poiché l’uomo voleva rendere onore al valore e alla bellezza di quell’anello e voleva che esso si tramandasse per sempre, di padre in figlio, lungo i rami della sua discendenza, stabilì questa regola: quello tra i suoi figli, che avesse ricevuto da lui l’anello, avrebbe dovuto essere considerato il suo legittimo erede, e avrebbe dovuto essere onorato e riverito dai suoi fratelli come il più importante. E il figlio che ricevette l’anello, adottò la medesima regola per i propri discendenti; e, per farla breve, questo anello passò di mano in mano, da una generazione all’altra, di successore in successore. E alla fine arrivò nelle mani di un padre, che aveva tre figli belli, valorosi e molto rispettosi del loro genitore; per queste regioni egli li amava alla stessa maniera tutti e tre. ora, dal momento che i tre giovani conoscevano l’usanza dell’anello e ciascuno ambiva ad essere il più apprezzato tra i suoi fratelli, ciascuno di loro supplicava quanto più poteva il padre, che era ormai anziano, affinché al momento della morte, lasciasse a lui l’anello. Il brav’uomo che amava tutti i suoi figli alla stesso modo e non era in grado di compiere la scelta di lasciare l’anello ad uno di loro in particolare, dopo aver promesso l’anello a ciascuno dei suoi figli pensò ad un sistema per non doversi rimangiare la parla.. In segreto l’uomo commissionò ad un valido fabbro la realizzazione di due copie dell’anello, le quali furono realizzate tanto somiglianti all’originale, che il fabbro stesso che le aveva confezionate faceva fatica a capire quale fosse il modello e quali le copie. E quando fu sul punto di morire, l’uomo consegnò in segreto a ciascuno dei suoi tre figli un esemplare dell’anello. Così, quando all’indomani della morte del padre, ciascuno dei tre figli tentò di succedergli e di impadronirsi dell’eredità e del titolo e ciascuno dei tre cercò di impedire agli altri due di realizzare il loro intento, ogni figlio tirò fuori, a garanzia della legittimità di ciò che stava facendo, la propria copia dell’anello. E poiché gli anelli furono riscontrati essere così simili uno all’altro, che non era possibile stabilire quale tei tre fosse l’originale, rimase aperta anche la questione di quale fosse l’autentico erede del padre. E quella questione è tuttora aperta. Mio sultano, la medesima cosa vi dico io in merito alle tre religioni che Dio padre ha dato ai popoli, riguardo alle quali mi avete interrogato: ogni popolo si crede nel giusto mentre mantiene e rispetta la sua eredità, la sua vera legge e i suoi comandamenti; tuttavia, come per gli anelli, la questione di chi sia il vero erede é ancora irrisolta.
Il Saladino si rese conto che Melchisedech aveva saputo magistralmente evitare la trappola che egli gli aveva teso davanti ai piedi; così decise di rivelargli con sincerità di aver bisogno di denaro, per poi stare a vedere se Melchisedech avrebbe accettato di finanziarlo; e così fece, svelandogli che cosa aveva pianificato di fare se lui non gli avesse risposto con quella capacità e saggezza. L’ebreo Melchisedech generosamente concesse al Saladino tutto il denaro di cui aveva bisogno e il Saladino successivamente gli restituì tutto il denaro che gli aveva prestato e, oltre a ciò, lo omaggiò di grandissimi doni, lo trattò sempre come un amico e lo fece restare nella propria corte tenendolo sempre in grande considerazione e grande stima.

Alberto Criscione: Melchisedech e il Saladino (2014)
L’analisi della terza novella della prima giornata presenta alcune caratteristiche che meritano di essere sottolineate:
- il narratore: se, nella parte omessa sarà Boccaccio (narratore di primo grado) a dirci che la parola viene data a Filomena per raccontarci una novella, la stessa la inizia (narratore di secondo grado) presentandoci il Saladino ed il motivo che lo spinge a rivolgersi all’usuraio ebreo Melchisedech. Per cercare di non ricevere un rifiuto, lo stesso Saladino escogita uno stratagemma che costringe Melchisedech a trovare un’immediata risposta che consiste nel raccontargli un’altra storia (narratore di terzo grado) che lo liberi dall’impasse tesagli.
- la cortesia: ambedue i protagonisti, sia il sultano che l’ebreo mostrano cortesia l’un l’altro: elemento fondamentale nell’etica boccacciana, il sapere riconoscere nell’altro una persona degna di rispetto.
- la religione: potremmo parlare di “democrazia” religiosa in questa novella, ma sarebbe forse più giusto notare come laddove vi sia vera fede, non vi sia da parte dell’autore nessun ostracismo
- intelligenza: qui forse più marcatamente l’intelligenza della parola. Sia il sultano mostra di saper usare l’intelligenza nel porre un quesito per non offendere l’usuraio, sia quella di quest’ultimo che con essa riesce a sviare il pericolo. E’ proprio l’intelligenza (saggezza) di entrambi a far sì che essi si stringano in un rapporto di amicizia.
SECONDA GIORNATA
La seconda giornata è posta sotto la reggenza di Filomena la quale propone alle giovani e ai giovani dell’allegra brigata di ragionare di chi, da diverse cose infestato, sia, oltre la speranza, riuscito a lieto fine.
La quarta novella è raccontata da Lauretta:
LANDOLFO RUFOLO, IMPOVERITO, DIVIEN CORSALE E DA’ GENOVESI PRESO, ROMPE IN MARE, E SOPRA UNA CASSETTA, DI GIOIE CARISSIME PIENA, SCAMPA, E IN GURFO RICEVUTO DA UNA FEMINA, RICCO SI TORNA A CASA SUA.
(II, 4)

Miniatura del XV secolo
Credesi che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole parte d’ltalia; nella quale assai presso a Salerno e una costa sopra ‘l mare riguardante, la quale gli abitanti chiamano la costa d’Amalfi, piena di picciole città, di giardini e di fontane, e d’uomini ricchi e procaccianti in atto di mercatantia sì come alcuni altri. Tra le quali città dette n’è una chiamata Ravello, nella quale, come che oggi v’abbia di ricchi uomini, ve n’ebbe già uno il quale fu ricchissimo, chiamato Landolfo Rufolo; al quale non bastando la sua ricchezza, disiderando di radoppiarla, venne presso che fatto di perder con tutta quella sé stesso. Costui adunque, sì come usanza suole essere de’ mercatanti, fatti suoi avvisi, comperò un grandissimo legno, e quello tutto di suoi denari caricò di varie mercatantie e andonne con esse in Cipri. Quivi, con quelle qualità medesime di mercatantie che egli aveva portate, trovò essere più altri legni venuti; per la qual cagione, non solamente gli convenne far gran mercato di ciò che portato avea, ma quasi, se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via; laonde egli fu vicino al disertarsi. E portando egli di questa cosa seco grandissima noia, non sappiendo che farsi e veggendosi di ricchissimo uomo in brieve tempo quasi povero divenuto, pensò o morire o rubando ristorare i danni suoi, acciò che la onde ricco partito s’era povero non tornasse. E, trovato comperatore del suo gran legno, con quegli denari e con gli altri che della sua mercatantia avuti avea, comperò un legnetto sottile da corseggiare, e quello d’ogni cosa opportuna a tal servigio armò e guernì ottimamente, e diessi a far sua della roba d’ogni uomo, e massimamente sopra i turchi.
Al qual servigio gli fu molto più la fortuna benivola che alla mercatantia stata non era. Egli, forse infra uno anno, rubò e prese tanti legni di turchi, che egli si trovò non solamente avere racquistato il suo che in mercatantia avea perduto, ma di gran lunga quello avere raddoppiato. Per la qual cosa, gastigato dal primo dolore della perdita, conoscendo che egli aveva assai per non incappar nel secondo, a sé medesimo dimostrò quello che aveva, senza voler più , dovergli bastare; e per ciò si dispose di tornarsi con esso a casa sua. E pauroso della mercatantia, non s’mpacciò d’investire altramenti i suoi denari, ma con quello legnetto col quale guadagnati gli avea, dato de’remi in acqua, si mise al ritornare. E già nello Arcipelago venuto, levandosi la sera uno scilocco, il quale non solamente era contrario al suo cammino, ma ancora faceva grossissimo il mare, il quale il suo picciol legno non avrebbe bene potuto comportare, in uno seno di mare, il quale una piccola isoletta faceva, da quello vento coperto, si raccolse, quivi proponendo d’aspettarlo migliore. Nel qual seno poco stante due gran cocche di genovesi, le quali venivano di Costantinopoli, per fuggire quello che Landolfo fuggito avea, con fatica pervennero. Le genti delle quali, veduto il legnetto e chiusagli la via da potersi partire, udendo di cui egli era e già per fama conoscendol ricchissimo, sì come uomini naturalmente vaghi di pecunia e rapaci, a doverlo avere si disposero. E messa in terra parte della lor gente con balestra e bene armata, in parte la fecero andare che del legnetto niuna persona, sé saettato esser non voleva, poteva discendere; ed essi, fattisi tirare a’paliscalmi e aiutati dal mare, s’accostarono al picciol legno di Landolfo, e quello con picciola fatica in picciolo spazio, con tutta la ciurma, senza perderne uomo, ebbero a man salva; e fatto venire sopra l’una delle lor cocche Landolfo e ogni cosa del legnetto tolta, quello sfondolarono, lui in un povero farsettino ritenendo.
Il dì seguente, mutatosi il vento, le cocche ver ponente venendo fer vela: e tutto quel dì prosperamente vennero al loro viaggio; ma nel far della sera si mise un vento tempestoso, il qual faccendo i mari altissimi, divise le due cocche l’una dall’altra. E per forza di questo vento addivenne che quella sopra la quale era il misero e povero Landolfo, con grandissimo impeto di sopra all’isola di Cifalonia percosse in una secca e, non altramenti che un vetro percosso ad un muro tutta s’aperse e si stritolò; di che i miseri dolenti che sopra quella erano, essendo già il mare tutto pieno di mercatantie che notavano e di casse e di tavole, come in così fatti casi suole avvenire, quantunque oscurissima notte fosse e il mare grossissimo e gonfiato, notando quelli che notar sapevano, s’incominciarono ad appiccare a quelle cose che per ventura loro si paravan davanti. Intra li quali il misero Landolfo, ancora che molte volte il dì davanti la morte chiamata avesse, seco eleggendo di volerla più tosto che di tornare a casa sua povero come si vedea, vedendola presta n’ebbe paura; e, come gli altri, venutagli alle mani una tavola, a quella s’appicco’, se forse Iddio, indugiando egli l’affogare, gli mandasse qualche aiuto allo scampo suo; e a cavallo a quella, come meglio poteva, veggendosi sospinto dal mare e dal vento ora in qua e ora in là, si sostenne infino al chiaro giorno. Il quale venuto, guardandosi egli d’attorno, niuna cosa altro che nuvoli e mare vedea, e una cassa la quale sopra l’onde del mare notando talvolta con grandissima paura di lui gli s’appressava, temendo non quella cassa forse il percotesse per modo che gli noiasse; e sempre che presso gli venia, quanto potea con mano, come che poca forza n’avesse, la lontanava.
Ma, come che il fatto s’andasse, avvenne che, solutosi subitamente nell’aere un groppo di vento e percosso nel mare, sì grande in questa cassa diede e la cassa nella tavola sopra la quale Landolfo era, che, riversata, per forza Landolfo lasciatola andò sotto l’onde e ritornò suso notando, più da paura che da forza aiutato, e vide da se molto dilungata la tavola; per che, temendo non potere ad essa pervenire, s’appressò alla cassa la quale gli era assai vicina, e sopra il coperchio di quella posto il petto, come meglio poteva, colle braccia la reggeva diritta. E in questa maniera, gittato dal mare ora in qua e ora in là, senza mangiare, sì come colui che non aveva che, e bevendo più che non avrebbe voluto, senza sapere ove si fosse o vedere altro che mare, dimorò tutto quel giorno e la notte vegnente.
Il dì seguente appresso, o piacer di Dio o forza di vento che ‘l facesse, costui divenuto quasi una spugna, tenendo forte con amendue le mani gli orli della cassa a quella guisa che far veggiamo a coloro che per affogar sono, quando prendono alcuna cosa, pervenne al lito dell’isola di Gurfo, dove una povera feminetta per ventura suoi stovigli con la rena e con l’acqua salsa lavava e facea belli. La quale, come vide costui avvicinarsi, non conoscendo in lui alcuna forma, dubitando e gridando si trasse indietro. Questi non potea favellare e poco vedea, e perciò niente le disse; ma pure, mandandolo verso la terra il mare, costei conobbe la forma della cassa, e più sottilmente guardando e vedendo, conobbe primieramente le braccia stese sopra la cassa, quindi appresso ravvisò la faccia e quello essere che era s’imaginò. Per che, da compassion mossa, fattasi alquanto per lo mare, che già era tranquillo, e per li capelli presolo, con tutta la cassa il tiro in terra, e quivi con fatica le mani dalla cassa sviluppatogli, e quella posta in capo ad una sua figlioletta che con lei era, lui come un picciol fanciullo ne portò nella terra, e in una stufa messolo, tanto lo stropicciò e con acqua calda lavo che in lui ritornò lo smarrito calore e alquante delle perdute forze; e quando tempo le parve trattonelo, con alquanto di buon vino e di confetto il riconforto, e alcun giorno, come potè il meglio, il tenne, tanto che esso, le forze recuperate, conobbe la dove era. Per che alla buona femina parve di dovergli la sua cassa rendere, la quale salvata gli avea, e di dirgli che omai procacciasse sua ventura, e così fece.
Costui, che di cassa non si ricordava, pur la prese, presentandogliele la buona femina, avvisando quella non potere sì poco valere che alcun dì non gli facesse le spese; e trovandola molto leggiera, assai manco della sua speranza. Nondimeno, non essendo la buona femina in casa, la sconficcò per vedere che dentro vi fosse, e trovò in quella molte preziose pietre, e legate e sciolte, delle quali egli alquanto s’intendea; le quali veggendo e di gran valore conoscendole, lodando Iddio che ancora abbandonare non l’avea voluto, tutto si riconfortò. Ma, si come colui che in picciol tempo fieramente era stato balestrato dalla fortuna due volte, dubitando della terza, pensò convenirgli molta cautela avere a voler quelle cose poter conducere a casa sua; per che in alcuni stracci, come meglio potè, ravvoltole, disse alla buona femina che più di cassa non avea bisogno, ma che, se le piacesse, un sacco gli donasse e avessesi quella.
La buona femina il fece volentieri; e costui, rendutele quelle grazie le quali poteva maggiori del beneficio da lei ricevuto, recatosi suo sacco in collo, da lei si partì , e montato sopra una barca, passò a Brandizio, e di quindi, marina marina, si condusse infino a Trani, dove trovati de’suoi cittadini li quali eran drappieri, quasi per l’amor di Dio fu da loro rivestito, avendo esso già loro tutti li suoi accidenti narrati, fuori che della cassa; e oltre a questo, prestatogli cavallo e datogli compagnia, infino a Ravello, dove del tutto diceva di voler tornare, il rimandarono. Quivi parendogli essere sicuro, ringraziando Iddio che condotto ve l’avea, sciolse il suo sacchetto, e con più diligenzia cercata ogni cosa che prima fatto non avea, trovò sé avere tante e sì fatte pietre che, a convenevole pregio vendendole e ancor meno, egli era il doppio più ricco che quando partito s’era. E trovato modo di spacciare le sue pietre, infino a Gurfo mandò una buona quantità di denari, per merito del servigio ricevuto, alla buona femina che di mare l’avea tratto, e il simigliante fece a Trani a coloro che rivestito l’aveano; e il rimanente, senza più volere mercatare, si ritenne e onorevolmente visse infino alla fine.

Alberto Criscione: Landolfo Rufolo (2014)
Si crede che il litorale che va da Reggio Calabria a Gaeta sia la parte più bella d’Italia; lungo di esso, nei pressi di Salerno, vi era una costiera che s’affaccia sul mare, chiamata dai suoi abitanti “costiera amalfitana”, piena di piccole città, di giardini, di fontane e di uomini industriosi nel commerciare come pochi altri. Tra queste cittadine, ve ne era una, chiamata Ravello, dove abitava un uomo di nome Landolfo Rufolo, ricchissimo, il quale, desiderando raddoppiare la sua ricchezza, corse il rischio di perdere la vita, insieme con le ricchezze.
Costui dunque, secondo l’usanza dei mercanti, fatti i suoi conti, comprò una grandissima nave che riempì completamente a sue spese con molte mercanzie e partì per Cipro. Lì giunto, trovò molte altre navi con le stesse mercanzie portate da lui e dovette dunque, per questa ragione vendere con un gran ribasso quanto aveva trasportato, ma quasi gettar via la sua merce, pur di liberarsene: per cui fu quasi arrivato al punto di rovinarsi. E avendogli arrecato, quanto era successo portato, un grandissimo dispiacere, non sapendo che fare, essendosi egli ritrovato da uomo ricchissimo ad indigente, pensò o di morire o di andare a rubare, affinché da dove era partito non tornasse povero essendo partito ricco. Trovato un compratore della sua grande nave e con i pochi ricavati dal commercio con i soldi avuti, comprò una navicella agile e snella da predone, la armò in maniera adeguata e si diede alla vita di corsaro, derubando soprattutto i turchi.
Questa attività fu favorita dalla fortuna, molto più che quella, precedente, di mercante. Dopo circa un anno rubò e catturò tante navi dei turchi, che non solo recuperò tutte le ricchezze che aveva perduto facendo il mercante, ma le raddoppiò completamente. per cui, reso prudente dalla prima perdita, misurando che con la nuova attività aveva ottenuto molto, per evitare un secondo dissesto finanziario, decise che quello che aveva gli doveva bastare e perciò deliberò di dover tornare a casa sua. Reso diffidente del commercio, non si dette pensiero d’investire i suoi denari, ma con la stessa piccola barca con la quale era ridiventato ricco, a forza di remi si pose sulla via del ritorno. Era già giunto nell’Arcipelago Egeo, quando, una sera, si alzò lo scirocco, che, non solo era contrario alla sua rotta, ma anche rendeva agitatissimo il mare; poiché la sua navicella non avrebbe potuto durare in un mare così grosso, si ritirò in un golfo protetto da un’isoletta e riparato dal vento; e qui si propose di attendere un vento migliore. In questa insenatura, poco distante, due cocche (navi da trasporto) genovesi, che venivano da Costantinopoli, giunsero a fatica, per ripararsi, come aveva fatto Landolfo. I naviganti, vista la piccola nave nel porticciolo e chiusale la via per uscire, udendo a chi apparteneva e sapendo, per fama, che il proprietario era ricchissimo, essendo ladri e desiderosi di danaro, decisero di appropriarsene. Fatta scendere una parte degli uomini armati di balestre ed altre armi, fecero circondare la navicella, in modo che nessuno potesse scendere da essa, se non voleva essere colpito dalle frecce; gli altri, trasportati dalle scialuppe e aiutati dal mare, si accostarono alla barchetta e se ne appropriarono, in breve tempo, con tutta la ciurma, senza colpo ferire, quindi fatto salire Landolfo su una delle loro cocche (navi con un solo albero), sfondarono la navicella e la affondarono, lasciandolo vestito solo con un miserevole farsetto.
Il giorno dopo, cambiato il vento, le cocche fecero vela verso ponente, viaggiando per tutta la giornata favorevolmente, ma sul far della sera, si levò un vento tempestoso che, creando altissimi marosi, divise le due navi. E a causa di ciò, la nave su cui si trovava il misero Landolfo, con grande violenza, fu sbattuta in una secca sull’isola di Cefalonia e, come un vetro che sbatteva contro un muro, si aprì tutta e si sgretolò. Gli sventurati che si trovavano sulla cocca, come suole avvenire in questi casi, essendo già il mare pieno di mercanzie, di casse e di tavole, in una notte nerissima, con un mare agitatissimo, nuotando al meglio che potevano, si cominciarono ad aggrappare alle cose che, per fortuna, si paravano davanti.
Tra questi il povero Landolfo, benché molte volte il giorno precedente avesse invocato la morte, scegliendo tra sé di voler morire piuttosto che tornare a casa povero come si trovava, vedendola sul serio davanti ne ebbe paura; e, come gli altri, aggrappatosi ad una tavola, a quella si attaccò, nella speranza che Dio, ritardando egli ad affogare, gli mandasse un qualche aiuto che gli permettesse di salvarsi e a cavallo di quella, come meglio poteva, spinto di qua e di là, si mantenne fino all’alba. Giunto il levar del sole, guardandosi intorno, non vedeva altro che nuvole e mare ed una cassa che sospesa nelle acque, mentre tentava di restare a galla, con sua grande paura, gli si avvicinava, sospinta dalle onde, e avendo paura che potesse colpirlo, recandogli danno, ogni volta che s’avvicinava nonostante avesse poca forza, quanto poteva con la mano la allontanava. Comunque il fatto avvenisse, successe che scoppiata nell’aria una raffica di vento che investì il mare, esso con tale forza spinse la cassa e la cassa con tale impeto percosse la tavola che si rovesciò e Landolfo, costretto a lasciare la presa, andò sott’acqua e riemerse nuotando, spinto più dalla paura che dalla forza e vide che la tavola s’era molto allontanata da lui e non potendola più raggiungere si avvicinò alla cassa e messosi sopra di essa come meglio poteva, la teneva dritta con le braccia. E così, sbattuto dal mare da una parte all’altra, senza mangiare, non avendo a disposizione nessun cibo e bevendo più di quanto avesse voluto, senza sapere dove fosse e vedere altro che mare, Landolfo passò tutto quel giorno e la notte seguente.
Il giorno dopo, come piacque a Dio o alla forza del vento che lo spingese, diventato quasi una spugna, attaccato con forza ai bordi della cassa, come ci si attacca per non affogare, giunse alla spiaggia dell’isola di Corfù, dove per caso una povera donnetta lavava i piatti con l’acqua salata e la sabbia. Come costei vide qualcosa che si avvicinava, non riconoscendo alcuna forma, temendo cominciò a gridare. Landolfo non poteva parlare e aveva la vista debolissima e non disse niente; nonostante ciò, avendolo il mare spinto in terra, costei riconobbe dapprima la forma di una cassa e, guardando più attentamente, vide due braccia sopra di essa, quindi scorse la faccia e capì che quello era un povero naufrago. Quindi, mossa a compassione, entrata un po’ nel mare, che, frattanto, si era calmato, afferratolo per i capelli, lo tirò a terra con tutta la cassa, che pose sulla testa della figlioletta che era con lei, e, presolo in braccio come un bambino, lo portò al villaggio; in seguito messolo in un bagno caldo, tanto lo strofinò e lavò con acqua calda che Landolfo riprese colore e recuperò in parte le perdute forze. Lo lasciò lì il tempo necessario, lo riconfortò con vino e dolci sostanziosi e lo trattenne con sé alcuni giorni, tanto che lui, rimessosi, seppe infine dove si trovava. Allora alla donna sembrò opportuno restituirgli la cassa, che aveva conservato e lo licenziò. Il giovane, che non se ne ricordava per niente, prese la cassa, pensando che potesse valere qualcosa, ma visto che pesava poco, non aveva molte speranze. Nonostante ciò, essendo solo in casa, la schiodò per vedere cosa ci fosse dentro e vi trovò molte pietre preziose sia unite in monili sia sciolte il cui valore egli sapeva riconoscere e ciò o confortò e gli fece ringraziare Dio che ancora non l’aveva abbandonato. Ma così come colui che in poco tempo e per ben due volte aveva subìto i colpi della fortuna, temendo che potesse essercene anche una terza, pensò di adoperare estrema prudenza nel voler condurre queste pietre a casa sua, per cui avvoltele in una tela, chiese alla donna un sacco, lasciandole in cambio la cassa.
La donna l’accontentò volentieri, egli la ringraziò caldamente e messosi il sacco in spalla, partì. Salito su una nave, arrivò a Brindisi e, di porto in porto, giunse fino a Trani, dove incontrò alcuni suoi concittadini, che commerciavano in stoffe, ai quali raccontò le sue vicissitudini, ma, prudentemente, non accennò alla cassa. Costoro lo rivestirono, gli prestarono un cavallo e con una compagnia lo rimandarono a Ravello, dove diceva di voler tornare.
Giunto finalmente nel suo paese, sentendosi al sicuro, ringraziando Iddio, sciolse il sacchetto e guardò, come non aveva avuto modo prima, le pietre con più attenzione e considerò che erano molte e di gran pregio e calcolò che vendendole anche a un prezzo inferiore al loro valore, sarebbe diventato ricco il doppio di quando era partito. Trovato il modo di farne commercio, mandò a Corfù una buona quantità di denari alla buona donna che l’aveva raccolto dal mare e lo stesso fece a Trani verso coloro che l’avevano rivestito e il rimanente, senza voler più fare il mercante, si tenne per sé e così visse onorevolmente fino alla fine.

Manoscritto con l’immagine di Landolfo Rufolo che scampa dal naufragio
Il motivo che spinge Landolfo è certamente economico ed egli perciò s’iscrive a quella categoria di mercanti verso cui Boccaccio mostra un’innata simpatia. Il personaggio, d’altra parte è caratterizzato da due elementi, posti all’inizio e alla fine del racconto, che lo caratterizzano: la ricerca di raddoppiare il denaro (non bastando la sua ricchezza, desiderando di radoppiarla) e l’ottenimento del fine (egli era il doppio più ricco che quando partito s’era).
Ma l’importanza è che in questo caso più che l’intelligenza poté la fortuna e quest’ultima viene metaforizzata attraverso il mare: Landolfo, infatti, non è un buon mercante, in quanto la situazione iniziale di una concorrenza spietata poteva essere prevista. Ma a determinare le sue azioni non è la sua preveggenza quanto la fortuna; essa infatti può modificare una situazione (in questo caso una tempesta, i pirati genovesi) e ciò che Landolfo impara è rinunciare all’azione, cioè mettersi al riparo dell’imprevedibilità del caso.

Ninetto Davoli nella parte di Andreuccio nel Decameron di Pasolini (1971)
ANDREUCCIO DA PERUGIA, VENUTO A NAPOLI A COMPERAR CAVALLI, IN UNA NOTTE DA TRE GRAVI ACCIDENTI SOPRAPRESO, DA TUTTI SCAMPATO CON UN RUBINO SI TORNA A CASA SUA.
(II, 5)
Fu, secondo che io già intesi, in Perugia un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro, cozzone di cavalli; il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messisi in borsa cinquecento fiorin d’oro, non essendo mai più fuori di casa stato, con altri mercatanti là se n’andò: dove giunto una domenica sera in sul vespro, dall’oste suo informato la seguente mattina fu in sul Mercato, e molti ne vide e assai ne gli piacquero e di più e più mercato tenne, né di niuno potendosi accordare, per mostrare che per comperar fosse, sì come rozzo e poco cauto più volte in presenza di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa de’ fiorini che aveva. E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane ciciliana bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito seco disse: «Chi starebbe meglio di me se quegli denari fosser miei?» e passò oltre.
Era con questa giovane una vecchia similmente ciciliana, la quale, come vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse a abbracciarlo: il che la giovane veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere. Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala, le fece gran festa, e promettendogli essa di venire a lui all’albergo, senza quivi tenere troppo lungo sermone, si partì: e Andreuccio si tornò a mercatare ma niente comperò la mattina. La giovane, che prima la borsa d’Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta, per tentare se modo alcuno trovar potesse a dovere aver quelli denari, o tutti o parte, cautamente incominciò a domandare chi colui fosse o donde e che quivi facesse e come il conoscesse. La quale ogni cosa così particularmente de’ fatti d’Andreuccio le disse come avrebbe per poco detto egli stesso, sì come colei che lungamente in Cicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era, e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse.
La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e de’ nomi, al suo appetito fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione, e a casa tornatasi, mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno acciò che a Andreuccio non potesse tornare; e presa una sua fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò all’albergo dove Andreuccio tornava. La qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo e solo trovò in su la porta e di lui stesso il domandò. Alla quale dicendole egli che era desso, essa, tiratolo da parte, disse: «Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria volentieri».
Il quale vedendola, tutto postosi mente e parendogli essere un bel fante della persona, s’avvisò questa donna dover di lui essere innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli, e prestamente rispose che era apparecchiato e domandolla dove e quando questa donna parlargli volesse. A cui la fanticella rispose: «Messere, quando di venir vi piaccia, ella v’attende in casa sua».
Andreuccio presto, senza alcuna cosa dir nell’albergo, disse: «Or via mettiti avanti, io ti verrò appresso».
Laonde la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale quanto sia onesta contrada il nome medesimo il dimostra. Ma esso, niente di ciò sappiendo né suspicando, credendosi in uno onestissimo luogo andare e a una cara donna, liberamente, andata la fanticella avanti, se n’entrò nella sua casa; e salendo su per le scale, avendo la fanticella già sua donna chiamata e detto «Ecco Andreuccio», la vide in capo della scala farsi a aspettarlo.
Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai orrevolemente; alla quale come Andreuccio fu presso, essa incontrogli da tre gradi discese con le braccia aperte, e avvinghiatogli il collo alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da soperchia tenerezza impedita; poi lagrimando gli basciò la fronte e con voce alquanto rotta disse: «O Andreuccio mio, tu sii il ben venuto!»
Esso, maravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto rispose: «Madonna, voi siate la ben trovata!»
Ella appresso, per la man presolo, suso nella sua sala il menò e di quella, senza alcuna cosa parlare, con lui nella sua camera se n’entrò, la quale di rose, di fiori d’aranci e d’altri odori tutta oliva, là dove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là , e altri assai belli e ricchi arnesi vide; per le quali cose, sì come nuovo, fermamente credette lei dovesse essere non men che gran donna.
E postisi a sedere insieme sopra una cassa che appiè del suo letto era, così gli cominciò a parlare: «Andreuccio, io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lagrime, sì come colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non m’udisti. Ma tu udirai tosto cosa la quale più ti farà forse maravigliare, sì come è che io sia tua sorella; e dicoti che, poi che Idio m’ha fatta tanta grazia che io anzi la mia morte ho veduto alcuno de’ miei fratelli, come che io disideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io tel vo’ dire. Pietro, mio padre e tuo, come io credo che tu abbi potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo, e per la sua bontà e piacevolezza vi fu e è ancora da quegli che il conobbero amato assai. Ma tra gli altri che molto l’amarono, mia madre, che gentil donna fu e allora era vedova, fu quella che più l’amò, tanto che, posta giù la paura del padre e de’ fratelli e il suo onore, in tal guisa con lui si dimesticò, che io ne nacqui e sonne qual tu mi vedi. Poi, sopravenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia madre piccola fanciulla lasciò, né mai, per quello che io sentissi, più né di me né di lei si ricordò: di che io, se mio padre stato non fosse, forte il riprenderei avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre mostrata (lasciamo stare allo amore che a me come a sua figliola non nata d’una fante né di vil femina dovea portare), la quale le sue cose e sé parimente, senza sapere altrimenti chi egli si fosse, da fedelissimo amor mossa rimise nelle sue mani. Ma che è? Le cose mal fatte e di gran tempo passate sono troppo più agevoli a riprendere che a emendare: la cosa andò pur così. Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta quasi come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno da Gergenti, gentile uomo e da bene, il quale per amor di mia madre e di me tornò a stare a Palermo; e quivi, come colui che è molto guelfo cominciò a avere alcuno trattato col nostro re Carlo. Il quale, sentito dal re Federigo prima che dare gli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di Cicilia quando io aspettava essere la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse; donde, prese quelle poche cose che prender potemmo (poche dico per rispetto alle molte le quali avavamo), lasciate le terre e li palazzi, in questa terra ne rifuggimmo, dove il re Carlo verso di noi trovammo sì grato che, ristoratici in parte li danni li quali per lui ricevuti avavamo, e possessioni e case ci ha date, e dà continuamente al mio marito, e tuo cognato che è, buona provisione, sì come tu potrai ancor vedere. E in questa maniera son qui, dove io, la buona mercé di Dio e non tua , fratel mio dolce, ti veggio».
E così detto, da capo il rabbracciò e ancora teneramente lagrimando gli basciò la fronte.
Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla quale in niuno atto moriva la parola tra’ denti né balbettava la lingua, e ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo e per se medesimo de’ giovani conoscendo i costumi, che volentieri amano nella giovanezza, e veggendo le tenere lagrime, gli abbracciari e gli onesti basci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero: e poscia che ella tacque, le rispose: «Madonna, egli non vi dee parer gran cosa se io mi maraviglio: per ciò che nel vero, o che mio padre, per che che egli sel facesse, di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che, se egli ne ragionò, a mia notizia venuto non sia, io per me niuna coscienza aveva di voi se non come se non foste; e emmi tanto più caro l’avervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo e meno questo sperava. E nel vero io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste esser cara, non che a me che un picciolo mercatante sono. Ma d’una cosa vi priego mi facciate chiaro: come sapeste voi che io qui fossi?»
Al quale ella rispose: «Questa mattina mel fè sapere una povera femina la qual molto meco si ritiene, per ciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica, lungamente e in Palermo e in Perugia stette, e se non fosse che più onesta cosa mi parea che tu a me venissi in casa tua che io a te nell’altrui, egli ha gran pezza che io a te venuta sarei».
Appresso queste parole ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti nominatamente, alla quale di tutti Andreuccio rispose, per questo ancora più credendo quello che meno di creder gli bisognava.
Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire greco e confetti e fè dar bere a Andreuccio; il quale dopo questo partir volendosi, per ciò che ora di cena era, in niuna guisa il sostenne, ma sembiante fatto di forte turbarsi abbracciandol disse: «Ahi lassa me, ché assai chiaro conosco come io ti sia poco cara! Che è a pensare che tu sii con una tua sorella mai più da te non veduta, e in casa sua, dove, qui venendo, smontato esser dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenare all’albergo? Di vero tu cenerai con esso meco: e perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene secondo donna fare un poco d’onore».
Alla quale Andreuccio, non sappiendo altro che rispondersi, disse: «Io v’ho cara quanto sorella si dee avere, ma se io non ne vado, io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania. Ed ella allora disse: «Lodato sia Idio, se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sii aspettato! benché tu faresti assai maggior cortesia, e tuo dovere, mandare a dire a’tuoi compagni che qui venissero a cenare, e poi, se pure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andar di brigata».
Andreuccio rispose che de’ suoi compagni non volea quella sera, ma, poi che pure a grado l’era, di lui facesse il piacer suo. Ella allora fè vista di mandare a dire all’albergo che egli non fosse atteso a cena; e poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena e splendidamente di più vivande serviti, astutamente quella menò per lunga infino alla notte obscura; ed essendo da tavola levati e Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in niuna guisa sofferrebbe , per ciò che Napoli non era terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere; e che come che egli a cena non fosse atteso aveva mandato a dire, così aveva dello albergo fatto il somigliante. Egli, questo credendo e dilettandogli, da falsa credenza ingannato, d’esser con costei, stette. Furono adunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi non senza cagione tenuti; e essendo della notte una parte passata, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla, con le sue femine in un’altra camera se n’andò.
Era il caldo grande: per la qual cosa Andreuccio, veggendosi solo rimasto, subitamente si spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba e al capo del letto gli si pose; e richiedendo il naturale uso di dovere diporre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse domandò quel fanciullo, il quale nell’uno de’ canti della camera gli mostrò uno uscio e disse: «Andate là entro». Andreuccio dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la quale dalla contraposta parte sconfitta dal travicello sopra il quale era ; per la qual cosa capolevando questa tavola con lui insieme se n’andò quindi giuso: e di tanto l’amò Idio, che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto, ma tutto della bruttura, della quale il luogo era pieno, s’imbrattò. Il quale luogo, acciò che meglio intendiate e quello che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò. Egli era in un chiassetto stretto, come spesso tra due case veggiamo: sopra due travicelli, tra l’una casa e l’altra posti, alcune tavole eran confitte e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde era l’una.
 Progetto di un libro con le più importanti novelle di Boccaccio illustrato per ragazzi, in via di realizzazione.
Progetto di un libro con le più importanti novelle di Boccaccio illustrato per ragazzi, in via di realizzazione.
Ritrovandosi adunque là giù nel chiassetto Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare il fanciullo; ma il fanciullo, come sentito l’ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna. La quale, corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni v’erano; e trovati i panni e con essi i denari, li quali esso non fidandosi mattamente sempre portava addosso, avendo quello a che ella di Palermo, sirocchia d’un perugin faccendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non curandosi prestamente andò a chiuder l’uscio del quale egli era uscito quando cadde.
Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare: ma ciò era niente. Per che egli, già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi a accorgere salito sopra un muretto che quello chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso, all’uscio della casa, il quale egli molto ben riconobbe, se n’andò, e quivi invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse. Di che egli piagnendo, come colui che chiara vedea la sua disavventura, cominciò a dire: «Oimè lasso, in come piccol tempo ho io perduti cinquecento fiorini e una sorella!»
E dopo molte altre parole, da capo cominciò a battere l’uscio e a gridare; e tanto fece così che molti de’circunstanti vicini, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono; e una delle servigiali della donna, in vista tutta sonnocchiosa, fattasi alla finestra proverbiosamente disse: «Chi picchia là giù?»
«Oh!» disse Andreuccio «o non mi conosci tu? Io sono Andreuccio, fratello di madama Fiordaliso».
Al quale ella rispose: «Buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va dormi e tornerai domattina; io non so che Andreuccio né che ciance son quelle che tu dì; va in buona ora e lasciaci dormir, se ti piace».
«Come» disse Andreuccio «non sai che io mi dico? Certo sì sai; ma se pur son così fatti i parentadi di Cicilia, che in sì piccol termine si dimentichino, rendimi almeno i panni miei li quali lasciati v’ho, e io m’andrò volentier con Dio».
Al quale ella quasi ridendo disse: «Buono uomo, e’ mi par che tu sogni», e il dir questo e il tornarsi dentro e chiuder la finestra fu una cosa. Di che Andreuccio, già certissimo de’ suoi danni, quasi per doglia fu presso a convertire in rabbia la sua grande ira e per ingiuria propose di rivolere quello che per parole riaver non potea; per che da capo, presa una gran pietra, con troppi maggior colpi che prima fieramente cominiciò a percuotere la porta. La qual cosa molti de’ vicini avanti destisi e levatisi, credendo lui essere alcuno spiacevole il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femina, recatosi a noia il picchiare il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altramenti che a un can forestiere tutti quegli della contrada abbaiano adosso, cominciarono a dire: «Questa è una gran villania a venire a questa ora a casa le buone femine e dire queste ciance; deh! va con Dio, buono uomo; lasciaci dormir, se ti piace; e se tu hai nulla a far con lei, tornerai domane, e non ci dar questa seccaggine stanotte».
Dalle quali parole forse assicurato uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femina, il quale egli né veduto né sentito avea, si fece alle finestre e con una boce grossa, orribile e fiera disse: «Chi è laggiù?»
Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender potè, mostrava di dovere essere un gran bacalare, con una barba nera e folta al volto, e come se del letto o da alto sonno si levasse sbadigliava e stropicciavasi gli occhi: a cui egli, non senza paura, rispose: «Io sono un fratello della donna di là entro».
Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi più rigido assai che prima disse: «Io non so a che io mi tegno che io non vegno là giù, e deati tante bastonate quante io ti vegga muovere, asino fastidioso e ebriaco che tu dei essere, che questa notte non ci lascerai dormire persona»; e tornatosi dentro serrò la finestra.
Alcuni de’ vicini, che meglio conoscieno la condizion di colui, umilmente parlando a Andreuccio dissono: «Per Dio, buono uomo, vatti con Dio, non volere stanotte essere ucciso costì : vattene per lo tuo migliore».
Laonde Andreuccio, spaventato dalla voce di colui e dalla vista e sospinto da’ conforti di coloro li quali gli pareva che da carità mossi parlassero, doloroso quanto mai alcuno altro e de’ suoi denar disperato, verso quella parte onde il dì aveva la fanticella seguita, senza sa per dove s’andasse, prese la via per tornarsi all’albergo. E a se medesimo dispiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva, disideroso di volgersi al mare per lavarsi, si torse a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga Catalana si mise. E verso l’alto della città andando, per ventura davanti si vide due che verso di lui con una lanterna in mano venieno li quali temendo non fosser della famiglia della corte o altri uomini a mal far disposti, per fuggirli, in un casolare, il qual si vide vicino, pianamente ricoverò. Ma costoro, quasi come a quello proprio luogo inviati andassero, in quel medesimo casolare se n’entrarono; e quivi l’un di loro, scaricati certi ferramenti che in collo avea, con l’altro insieme gl’incominciò a guardare, varie cose sopra quegli ragionando. E mentre parlavano, disse l’uno: «Che vuol dir questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire»; e questo detto alzata alquanto la lanterna, ebbe veduto il cattivel d’Andreuccio, e stupefatti domandar: «Chi è là?»
Andreuccio taceva, ma essi avvicinatiglisi con lume il domandarono che quivi così brutto facesse: alli quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. Costoro, imaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero fra sè: «Veramente in casa lo scarabone Buttafuoco fia stato questo».
E a lui rivolti, disse l’uno: «Buono uomo, come che tu abbi perduti i tuoi denari, tu molto a lodare Idio che quel caso ti venne che tu cadesti né potesti poi in casa rientrare: per ciò che, se caduto non fossi, vivi sicuro che, come prima adormentato ti fossi, saresti stato amazzato e co’ denari avresti la persona perduta. Ma che giova oggimai di piagnere? Tu ne potresti così riavere un denaio come avere delle stelle del cielo: ucciso ne potrai tu bene essere, se colui sente che tu mai ne facci parola». E detto questo, consigliatisi alquanto, gli dissero: «Vedi, a noi è presa compassion di te: e per ciò, dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa la quale a fare andiamo, egli ci pare esser molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai».
Andreuccio, sì come disperato, rispuose ch’era presto.
Era quel dì sepellito uno arcivescovo di Napoli, chiamato messer Filippo Minutolo, era stato sepellito con ricchissimi ornamenti e con uno rubino in dito il quale valeva oltre cinquecento fiorin d’oro, il quale costoro volevano andare a spogliare; e così a Andreuccio fecer veduto. Laonde Andreuccio, più cupido che consigliato, con loro si mise in via; e andando verso la chiesa maggiore, e Andreuccio putendo forte, disse l’uno: «Non potremmo noi trovar modo che costui si lavasse un poco dove che sia, che egli non putisse così fieramente?» Disse l’altro: «Sì , noi siam qui presso a un pozzo al quale suole sempre esser la carrucola e un gran secchione; andianne là e laverenlo spacciatamente». Giunti a questo pozzo trovarono che la fune v’era ma il secchione n’era stato levato: per che insieme diliberarono di legarlo alla fune e di collarlo nel pozzo, e egli là giù si lavasse e, come lavato fosse, crollasse la fune e essi il tirerebber suso; e così fecero.
Avvenne che, avendol costor nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali e per lo caldo e perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel pozzo venieno a bere: li quali come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire, li famigliari che quivi venivano a bere non avendogli veduti. Essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro assetati, posti giù lor tavolacci e loro armi e lor gonnelle, cominciarono la fune a tirare credendo a quella il secchion pien d’acqua essere appicato. Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino così, lasciata la fune, con le mani si gittò sopra quella. La qual cosa costoro vedendo, da subita paura presi, senza altro dir lasciaron la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire: di che Andreuccio si maravigliò forte, e se egli non si fosse bene attenuto, egli sarebbe infin nel fondo caduto forse non senza suo gran danno o morte; ma pure uscitone e queste arme trovate, le quali egli sapeva che i suoi compagni non avean portate, ancora più s’incominciò a maravigliare.
Ma dubitando e non sappiendo che, della sua fortuna dolendosi, senza alcuna cosa toccar quindi diliberò di partirsi: e andava senza saper dove. Così andando si venne scontrato in que’ due suoi compagni, li quali a trarlo del pozzo venivano; e come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono chi del pozzo l’avesse tratto. Andreuccio rispose che non sapea, e loro ordinatamente disse come era avvenuto e quello che trovato aveva fuori del pozzo. Di che costoro, avvisatisi come stato era, ridendo gli contarono perché s’eran fuggiti e chi stati eran coloro che su l’avean tirato. E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, n’andarono alla chiesa maggiore, e in quella assai leggiermente entrarono e furono all’arca, la quale era di marmo e molto grande; e con lor ferro il coperchio, ch’era gravissimo, sollevaron tanto quanto uno uomo vi potesse entrare, e puntellaronlo.
E fatto questo, cominciò l’uno a dire: «Chi entrerà dentro?»
A cui l’altro rispose: «Non io».
«Nè io» disse colui «ma entrivi Andreuccio».
«Questo non farò io» disse Andreuccio.
Verso il quale ammenduni costoro rivolti dissero: «Come non v’enterrai? In fè di Dio, se tu non v’entri, noi ti darem tante d’uno di questi pali di ferro sopra la testa, che noi ti farem cader morto».
Andreuccio temendo v’entrò, e entrandovi pensò seco: «Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi, per ciò che, come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscir dall’arca, essi se ne andranno pe’ fatti loro e io rimarrò senza cosa alcuna». E per ciò s’avisò di farsi innanzi tratto la parte sua; e ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire, come fu giù disceso così di dito il trasse all’arcivescovo e miselo a sè; e poi dato il pasturale e la mitra è guanti e spogliatolo infino alla camiscia, ogni cosa diè loro dicendo che più niente v’avea. Costoro, affermando che esser vi doveva l’anello, gli dissero che cercasse per tutto: ma esso rispondendo che non trovava e sembiante facendo di cercarne, alquanto li tenne ad aspettare. Costoro che d’altra parte eran sì come lui maliziosi, dicendo pur che ben cercasse preso tempo, tirarono via il puntello che il coperchio dell’arca sostenea, e fuggendosi lui dentro dall’arca lasciaron racchiuso. La qual cosa sentendo Andreuccio, qual egli allor divenisse ciascun sel può pensare.
Egli tentò più volte e col capo e con le spalle se alzare potesse il coperchio, ma invano si faticava: per che da grave dolor vinto, venendo meno cadde sopra il morto corpo dell’arcivescovo; e chi allora veduti gli avesse malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto, o l’arcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a piagnere, veggendosi quivi senza dubbio all’un de’ due fini dover pervenire: o in quella arca, non venendovi alcuni più a aprirla, di fame e di puzzo tra’ vermini del morto corpo convenirlo morire, o vegnendovi alcuni e trovandovi lui dentro, sì come ladro dovere essere appiccato. E in così fatti pensieri e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte persone, le quali sì come gli avvisava, quello andavano a fare che esso co’suoi compagni avean già fatto: di che la paura gli crebbe forte. Ma poi che costoro ebbero l’arca aperta e puntellata, in quistion caddero chi vi dovesse entrare, e niuno il voleva fare; pur dopo lunga tencione un prete disse: «Che paura avete voi? credete voi che egli vi manuchi? Li morti non mangian uomini: io v’entrerò dentro io». E così detto, posto il petto sopra l’orlo dell’arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giuso calare.
Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi prese il prete per l’una delle gambe e fè sembiante di volerlo giù tirare. La qual cosa sentendo il prete mise uno strido grandissimo e presto dell’arca si gittò fuori; della qual cosa tutti gli altri spaventati, lasciata l’arca aperta, non altramente a fuggir cominciarono che se da centomilia diavoli fosser perseguitati.
La qual cosa veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gittò fuori e per quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa; e già avvicinandosi al giorno, con quello anello in dito andando all’avventura, pervenne alla marina e quindi al suo albergo si abbattè ; dove li suoi compagni e l’albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine de’fatti suoi. A’ quali ciò che avvenuto gli era raccontato, parve per lo consiglio dell’oste loro che costui incontanente si dovesse di Napoli partire; la qual cosa egli fece prestamente e a Perugia tornossi, avendo il suo investito in uno anello, dove per comperare cavalli era andato.

Miniatura recante immagini riguardanti la novella di Andreuccio
Mi è stato raccontato che a Perugia visse un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro, sensale di cavalli che, avendo sentito che a Napoli si teneva un grande mercato di cavalli, si mise in borsa ben cinquecento fiorini d’oro e, pur non essendo mai uscito fuori di casa, vi andò insieme ad altri mercanti. Giunto là la domenica sera, informato dall’oste (dell’albergo), il giorno seguente si trovò al mercato; vide molti cavalli e molti gli piacquero e fece trattative su molti di essi, ma non si accordò con nessuno e, volendo mostrare che lui era lì per comperare, essendo inesperto ed incauto, spesse volte in presenza di chi andava e di chi veniva, faceva vedere questa borsa piena di fiorini.
E mentre faceva trattative, avendo più volte mostrato la borsa con dentro il denaro, accadde che una bellissima donna siciliana, ma disposta per poco prezzo a compiacere qualsiasi uomo, senza che Andreuccio la vedesse, passò vicino a lui vedendo la borsa con il denaro dentro e immediatamente disse fra sé: «Chi starebbe meglio di me se quei denari fossero i miei?» e andò oltre. Era con questa ragazza una vecchia, anche lei siciliana che appena vide Andreuccio lasciò che la ragazza andasse avanti e corse affettuosamente ad abbracciarlo: la giovane si accorse della situazione ma non disse niente e si mise ad aspettare. Andreuccio rivoltosi dapprima alla vecchia, ricambiò l’abbraccio e si mostrò molto contento (di averla rincontrata); lei gli promise che sarebbe andata all’albergo a salutarlo e se ne andò; Andreuccio continuò a trattare, ma quel giorno non comperò nulla. La giovane, che dapprima aveva visto la borsa e poi la familiarità della sua vecchia nei confronti di lui, per capire come fare ad entrar in possesso dei denari o tutti o solo una parte di essi, con accortezza cominciò a domandare chi fosse, da dove venisse e cosa fosse venuto a fare qui e come mai lo conoscesse. La donna anziana riferì particolarmente i fatti d’Andreuccio, come glieli avrebbe riferiti lui stesso, essendo lei stata per un lungo periodo in Sicilia col padre di lui e poi nella stessa Perugia. Inoltre gli disse in quale albergo dimorava ed il motivo per cui fosse a Napoli.
La giovane, pienamente informata sul parentado e sui nomi di Andreuccio, per soddisfare il suo desiderio (di denaro) con un inganno sottile, fondò il suo piano sulle informazioni ricevute: tornata a casa mandò la vecchia a sbrigare faccende che la tenessero lontana affinché non potesse tornare da lui e presa una servetta, abituata a prestare di questi servizi alla padrona, verso sera la mandò all’albergo dove Andreuccio aveva preso alloggio.
Costei, giunta all’albergo, per caso trovò lui solo sulla porta e gli chiese di Andreuccio. Rispondendo che era lui stesso, tiratolo da parte, le disse: «Signore, una gentil donna di questa terra, quando riterrete più opportuno, vi parlerebbe volentieri». Il quale, pur di vederla, considerando se stesso e ritenendo di essere un bel giovane, pensò che la donna si fosse innamorata di lui, come se non ci fosse altro bel giovane allora a Napoli al di fuori di lui, e subito rispose che era pronto e domandò dove e quando questa donna avesse intenzione di parlargli.
Al che la fanciulla rispose: «Signore, quando siete in grado di venire, ella v’aspetta casa sua».
Andreuccio subito, senza dir nulla all’oste dell’albergo, disse: «Dai, vai avanti che ti seguo».

Alberto Criscione: Andreuccio di Perugia (2014)
Quindi la fanticella la condusse a casa della donna, che dimorava in un luogo chiamato Malpertugio (luogo realmente esistente nella Napoli di allora, piuttosto malfamato, il cui nome deriva da buco – pertugio – nel muro della città che lo metteva in comunicazione direttamente con il porto) il cui nome stesso rivela quanto sia un poco onesto quartiere. Ma Andreuccio stesso, non sapendolo né sospettandolo, credendo d’andare in un luogo distinto e da una gentile e cara donna, ingenuamente, preceduto dalla fanciulla, entrò a casa della donna e salendo le scale, avendo la servetta chiamata già la padrona, annunciandole: «Ecco Andreuccio», egli la vide sulla cima della scala ad aspettarlo.
Lei era ancora molto giovane, alta e con un viso bellissimo, vestita e ornata onorevolmente e come Andreuccio le fu vicino, scese tre gradini con le braccia aperte e si avvinghiò al suo collo senza dire parola, come se fosse bloccata da eccessiva tenerezza, poi, lacrimando gli baciò la fronte e con voce alquanto tremante disse: «Oh Andreuccio, tu sei il benvenuto».
Egli, meravigliandosi di così tanta tenerezza, completamente stupefatto, rispose: «Signora, voi siete la ben trovata!»
Dopo lei lo prese per mano e lo condisse nella sala e continuando a non parlare, attraverso essa lo fece entrare nella sua camera che profumava di rose, fiori d’arancio e altro e là vide un bellissimo letto chiuso da cortine e molti abiti appesi alle pertiche, secondo l’abitudine di quei luoghi, e altre belle e ricche suppellettili per cui, inesperto com’era, sicuramente credette che lei fosse perlomeno una gran donna.
Si misero a sedere insieme su una cassapanca che era posta ai piedi del letto, e lei così cominciò a parlare: «Andreuccio, io sono sicura che tu ti sia meravigliato sia delle carezze che delle lacrime, dal momento che tu non mi conosci e forse non hai mai sentito parlare di me. Ma sentirai ben presto qualcosa che ti farà sicuramente meravigliare e cioè che io sono tua sorella; e ti dico che, dal momento che Dio mi ha fatto una così grande grazia che io, prima di morire, abbia conosciuto un mio fratello, sebbene io voglia vedervi tutti, quando arriverà la mia ora non potrò che morire consolata. E se tu di questo fatto non ne sai niente, te lo dirò io. Pietro, mio padre e tuo, come credo che tu abbia potuto sapere, stette per molti anni a Palermo e, per la sua benevolenza ed amabilità, ci fu, ed ancora vi è fra loro, chi lo apprezzò. Ma tra gli altri che molto lo apprezzarono mia madre, che era nobildonna e allora era vedova, fu quella che l’amò, tanto che, abbandonata la paura del padre, dei fratelli ed il suo onore, familiarizzò tanto con lui, così che nacqui io e sono diventata come tu vedi. Poi, sopraggiunto un motivo per cui Pietro dovette abbandonare la Sicilia, mi lasciò bambina con mia madre, né mai, per quanto io ne abbia saputo, si ricordò né di me né di lei: per cui io, se non fosse stato mio padre, lo rimprovererei duramente riguardo la sua ingratitudine verso mia madre (lasciamo stare l’amore che avrebbe dovuto mostrarmi, non essendo nata né da una fante né da una qualunque villana) la quale, spinta da un amore fortissimo, aveva messo se stessa e le proprie cose nelle sue mani, senza sapere altrimenti chi egli fosse. Ma che serve lamentarsi? Le cose mal fatte nel passato è tanto più semplice biasimarle che correggerle, quindi le cose avvennero in questo modo. Egli mi lasciò piccola a Palermo dove, cresciuta come mi vedi adesso, mia madre mi diede in moglie ad uno di Agrigento, nobile uomo e pieno di virtù che, per amor di mia madre si trasferì a Palermo; e qui, essendo egli un guelfo convinto, cominciò a tenere trattative segrete con Carlo (Angioino). La cosa, giunta all’orecchio di Federigo II d’Aragona (re di di Sicilia dal 1302 al 1337) prima che potesse essere messa in atto, fu il motivo che ci spinse ad abbandonare la Sicilia, proprio nel momento in cui io avrei potuto diventare la più gran dama, moglie di un cavaliere del regno, dell’isola; quindi, prese poche cose fra quelle che poterono esser prese, rispetto alle molte che laggiù possedevamo, lasciate le terre ed i palazzi, ci rifugiammo in questa terra, dove trovammo il re Carlo così riconoscente nei nostri confronti che, una volta che ci ebbe risarcito in parte delle perdite subite a causa sua, ha dato e continua a dare a mio marito, tuo cognato, case e terre ed un buon stipendio, come puoi vedere. E per questo sono qui, fratello mio dolce, dove io, grazie a Dio e non a causa tua, ti vedo (per la prima volta)».
E dopo aver detto questo, di nuovo l’abbracciò e ancora lacrimando gli baciò la fronte teneramente.
Andreuccio, sentendo questa favola raccontata in modo così acconcio e composto da lei che in nessuna parola aveva mostrato qualche incertezza o balbettato qualcosa e ricordando che il padre in gioventù era stato a Palermo, sapendo per esperienza personale che i giovani volentieri si lasciano andare all’amore, vedendo inoltre le lacrime, gli abbracci e i casti baci di lei, considerò che le cose che la donna diceva fossero più che vere e dopo che lei tacque disse: «Signora, non vi dovete sorprendere se io mi meraviglio, perché in verità, o perché mio padre, per qualunque motivo lo facesse, non parlava mai di vostra madre o di voi, o perché, se egli ne parlò, io non sia venuto a saperlo, io non avevo nessuna conoscenza di voi, come se non esisteste e mi è molto più caro l’aver trovata mia sorella qui, in quanto sono solo e tanto meno avrei sperato questo. In verità io non conosco uomo di così alto stato sociale al quale voi non dovreste esser così gradita e meno che a me che sono un piccolo mercante. Ma vi prego ditemi: come avete saputo che io ero qui?»
A lui lei rispose: «Questa mattina me lo fece sapere una povera donna che s’intrattiene con me, che stette con nostro padre, così mi ha detto, per molto tempo a Palermo e a Perugia, e se non fosse stata cosa più che onesta che tu venissi nella tua casa (in quanto mio fratello questa ti appartiene) che io venissi in un albergo, da molto tempo sarei venuta da te».
Dopo queste parole la donna cominciò dettagliatamente a domandare dei parenti, chiamandoli per nome, a cui Andreuccio rispose, sempre più confermandosi di ciò che di meno avrebbe dovuto confermarsi.
Avendo parlato a lungo e facendo molto caldo, la donna fece portare vino bianco e dolcetti e diede da bere ad Andreuccio; costui, dopo questo voleva andar via, perché era giunta l’ora di cena, ma lei in nessun modo accettò, anzi facendo finta di turbarsi, abbracciandolo disse: « Povera me, che ora capisco come poco ti sia cara! Come si può pensare che tu sia qui, con tua sorella che non hai mai visto, e in casa sua, dove, venendo qui, avresti dovuto fermarti, e tu voglia uscire per andare a cena all’albergo?» Tu cenerai con me e, sebbene mio marito non ci sia e di ciò mi dispiace molto, io saprò farti un poco d’onore, secondo quanto può fare una donna».
Alla quale Andreuccio, non sapendo cosa rispondere, disse: «Io vi ho cara, come dev’essere cara una sorella, me se non vado sarò aspettato tutta la sera per cena e farei un atto da villano».
E lei: «Lodato sia Dio se io non ho qualcuno da mandare a dire di non aspettarti! Sebbene tu facessi maggiore cortesia, nonché rispetto degli impegni, a dire ai tuoi compagni che venissero a cena qui e poi, se volessi andar via, ve ne potreste andare tutti insieme in compagnia».
Andreuccio rispose che non voleva compagni quella sera, ma poiché le era gradito, poteva disporre di lui come voleva. Lei fece finta di mandare qualcuno ad avvertire l’oste dell’albergo di non aspettare Andreuccio e poi, dopo aver parlato molto, si misero a cena e furono serviti splendidamente con più vivande; lei in modo astuto condusse il pasto fino a notte inoltrata ed essendosi alzati da tavola e volendo Andreuccio andar via, ella disse che non l’avrebbe sopportato, visto che Napoli non era una città da andare in giro di notte, soprattutto per un forestiere; e così come aveva fatto per la cena, l’oste era stato avvertito anche per il dormire. Lui credendo a ciò e facendogli piacere rimanere con lei, ingannato da una falsa verità, rimase. Ci furono molti e lunghi discorsi, condotti da lei non senza una ragione, ed essendo già passata parte della notte, lei, lasciato Andreuccio a dormire in compagnia di un bambino che lo servisse in caso di necessità, andò in un’altra camera in compagnia delle sue ancelle.
Faceva molto caldo, per cui Andreuccio si tolse subito il giubbetto e le brache, le mutande e le calze e posò tutto al capo del letto; poiché la naturale esigenza gli chiedeva di svuotare il peso del ventre, domandò al fanciullo dove fosse il luogo adibito a ciò, che gli fece vedere una porticina in un angolo della camera, dicendogli: «Andate là». Andreuccio, entrato senza sospetto, per caso posò il piede sopra un asse, la cui parte opposta era stata schiodata, per cui capovolgendosi, la tavola stessa con lui caddero in basso; e Dio lo amò talmente tanto che nel cadere non si fece male, ma s’imbrattò di escrementi, di cui il luogo era pieno. Questo luogo, affinché capiate ciò che ho detto e che dirò, vi mostrerò in che modo era. Quel luogo si trovava in uno stretto vicoletto, come spesso vediamo tra due case: c’erano alcune tavole confitte sopra due travicelli posti tra l’una e l’altra casa, sopra le quali tavole era posta la seduta; una di queste tavole era quella che cadde insieme a lui.
Andreuccio, ritrovandosi nel vicolo (che raccoglieva gli escrementi), sofferente per l’accaduto, cominciò a chiamare il bambino; ma il bambino, appena l’ebbe sentito cadere, corse a dirlo alla donna. Quest’ultima corse nella sua camera e velocemente cercò dove fossero i suoi vestiti e trovati e con essi i soldi, che lui pazzamente portava sempre addosso, ciò per cui gli aveva teso la trappola, fingendosi sorella palermitana di un perugino, non interessandosi più a lui, chiuse prontamente la porta da cui era entrato per cader giù.
Andreuccio, visto che il fanciullo non rispondeva, cominciò a chiamarlo più forte, ma non servì a niente. per cui lui, che già cominciava a sospettare e cominciando a capire l’inganno, salito su un muricciolo che divideva il vicoletto dalla strada, si mise in via e andò verso l’uscio della casa della donna che sapeva già riconoscere, e qui inutilmente lungamente chiamò, scosse e colpì la porta. Piangendo per la situazione, che ormai aveva già capito, cominciò a dire: «Povero me, come in breve tempo ho perduto cinquecento fiorini e una sorella!»
E dopo molti altri lamenti, di nuovo ricominciò a battere l’uscio e a chiamare, tanto che molti vicini svegliati, non sopportando più il chiasso, si alzarono e una delle serve della donna, in apparenza insonnolita, affacciatasi alla finestra con tono di rimprovero disse: «Chi picchia laggiù?»
«Oh», disse Andreuccio «non mi riconosci? Sono Andreuccio, fratello della signora Fiordaliso».
A lui rispose: «Buon uomo, se hai bevuto troppo, va a dormire e torna domani mattina; io non so chi sia Andreuccio né le frottole che tu dici; va alla buonora e, per favore, lasciaci dormire»
«Come», rispose Andreuccio «non sai che dico? Certo che lo sai; ma se sono così fatti i parenti siciliani, che in così poco tempo si dimenticano, restituiscimi perlomeno i vestiti, che ho lasciato dentro, e, con la volontà di Dio, me ne andrò.»
Al quale la donna, quasi ridendo, rispose: «Buon uomo, mi sembra che tu stia sognando» e dire questo, tornare dentro e chiudere la finestra, fu un tutt’uno.
Allora Andreuccio, già convinto dell’inganno, per il dolore si vide quasi a tramutare la sua ira in rabbia e con violenza propose di rivolere quello che non era riuscito ad ottenere con parole; per cui di nuovo, presa una grande pietra, con colpi più forti di prima ferocemente ricominciò a picchiare la porta. Per questo, molti dei vicini svegliatisi ed alzatisi, pensando essere lui un “delinquente” che dicesse bugie per disturbare la “buona donna”, infastiditi dal chiasso che egli stava facendo, affacciandosi alle finestre, non diversamente che un cane non della zona fosse circondato da un branco inferocito, cominciarono a dire: «E’ da gran maleducati venire a quest’ora a casa delle buone donne e dire queste fandonie. Dunque, va con Dio, lasciaci dormire, per favore; e se tu hai qualcosa da risolvere con lei, non ci dare questa seccatura stanotte».
Da queste parole, rassicurato forse uno che era dentro casa, protettore della buona donna, che Andreuccio non aveva visto né sentito, s’affacciò alla finestra e disse con voce grossa, terribile e minacciosa: «Chi è laggiù?»
Andreuccio, sollevata la testa nell’udire quella voce, vide uno il quale, per quel poco che poté capire, aveva l’aspetto di una persona importante, con una barba nera e folta che gl’incorniciava il volto, e come se si fosse appena svegliato da un grande sonno e alzato dal letto, sbadigliava e e si stropicciava gli occhi, a cui egli, anche con un po’ di paura, rispose: «Io sono un fratello della donna là dentro».
Ma l’uomo non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi, più burbero di prima, disse: «Io non so chi mi trattiene dallo scendere giù e darti tante bastonate finché continui a muoverti, asino fastidioso e ubriaco che non sei altro, che questa notte non permetterai a nessuno di dormire», e tornato dentro chiuse la finestra.
Alcuni dei vicini, che sapevano chi fosse e cosa abitualmente facesse, sottovoce si rivolsero ad Andreuccio e dissero: «Per Dio, buon uomo, va con Dio, non voler essere ammazzato qui, vattene per il tuo bene».
Per questo Andreuccio, spaventato dalla voce e dall’aspetto di quell’uomo e sospinto da coloro che sembravano aver avuto compassione di lui, pieno di dolori come nessuno e disperato per (aver perduto) tutti i soldi, verso quella parte dove il mattino aveva seguito la fanciulla, senza sapere dove andare, cercò la via dell’albergo. Ma vergognandosi per il puzzo che emanava, desideroso di andare verso il mare per lavarsi, girò verso sinistra e si ritrovò per una via chiamata Ruga Catalana. E camminando verso la parte alta della città, per caso si vide davanti due persone con una lanterna in mano che procedevano verso la sua direzione e temendo che fossero guardiani di corte o delinquenti disposti a far del male, per evitarli, si rifugiò senza far rumore in un casolare disabitato, che vide essere vicino. Ma quelli, come se avessero come meta lo stesso casolare vi entrarono e qui, uno di loro, scaricati certi strumenti di ferro che aveva appesi sul collo, con l’altro cominciarono a studiarli, parlando fra loro sul loro utilizzo.
Mentre parlavano, uno disse: «Ma che è? Io sento la peggior puzza che abbia mai sentito in vita mia» e detto questo, alzata la lanterna, videro il malcapitato Andreuccio e, meravigliati domandarono «Chi è là?»
Andreuccio non rispondeva, ma loro domandarono che cosa facesse lì così pieno di merda e allora Andreuccio raccontò tutto ciò che gli era capitato. Costoro, immaginando dove ciò potesse essere avvenuto, dissero tra loro: «Senz’altro questo dev’essere accaduto a casa del delinquente Buttafuoco».
Rivolgendosi a lui, uno di loro disse: «Buon uomo, benché tu abbia perduto i denari, devi lodare Dio che sei caduto dalla latrina e non sei rientrato in casa, perché se non fossi caduto, stai sicuro che appena ti fossi addormentato saresti stato ammazzato e avresti perso sia i denari che la vita. Ma che serve ora piangere? Tu così potresti avere un denaio (dodicesima parte di un fiorino) come tutte le stelle del cielo: sicuramente verrai ucciso, se parlerai con qualcuno di ciò che ti è accaduto».
Detto questo, parlando tra loro, gli dissero: «Vedi, ci è venuta la compassione per la tua situazione: e per ciò, quando tu voglia venire con noi per fare una cosa che stiamo andando a fare, siamo sicuri che in parte ti spetterà un valore (guadagno) maggiore di quanto hai perduto».
Andreuccio, vedendosi disperato, accettò.
Quel giorno si era celebrato il funerale dell’arcivescovo di Napoli, chiamato messer Filippo Minutolo, ed era stato seppellito con ricchissimi ornamenti e con un rubino nel dito, il quale valeva oltre cinquecento fiorini d’oro, che costoro volevano andare a rubare; e questo comunicarono ad Andreuccio.
Per questo Andreuccio, più avido che prudente, si mise in cammino con loro; andando verso la Chiesa Maggiore e poiché Andreuccio puzzava intensamente, disse uno dei due ladri: «Non potremmo noi fare in modo che costui si lavasse un po’ in un posto qualsiasi, affinché non puzzi così fortemente?»
Disse l’altro: «Sì, noi siamo qui vicino ad un pozzo che da sempre ha la carrucola ed un secchio; andiamo là e lo laveremo velocemente»
Giunti a questo pozzo videro che la fune c’era, ma il secchio era stato tolto, per cui pensarono di legarlo alla fune e di calarlo nel pozzo; una volta sceso, lui laggiù si lavasse, dopo scrollasse la fune e lo avrebbero riportato su; e così fecero.
Ma successe che, avendo calato Andreuccio, alcune guardie della Signoria che per il caldo o perché avevano inseguito qualcuno, avendo sete, s’avvicinarono a quel pozzo e come quei due li videro subito cominciarono a correre, poiché i gendarmi che qui venivano a bere non li avevano visti. Quest’ultimi, assetati, posero in terra gli scudi di legno, le armi e la sopravveste e cominciarono a tirare la fune credendo che alla fine di essa vi fosse il secchio pieno d’acqua. Non appena Andreuccio si vide vicino all’orlo del pozzo, si avvinghiò con le mani ad esso: i guardiani, vedendo ciò, presi da immediata paura, senza dire altro lasciarono la fune e cominciarono a fuggire: cosa di cui Andreuccio si meravigliò tantissimo.
Ma avendo paura e non sapendo cosa fare, lamentandosi della sua sorte, senza toccar nulla scelse di allontanarsi e andava senza sapere dove; così camminando gli capitò d’imbattersi in quei due compagni di prima, che lo stavano raggiungendo per liberarlo dal pozzo e come lo videro, con grande stupore, gli chiesero chi l’avesse tratto su dal pozzo. Andreuccio rispose che non lo sapeva e raccontò loro ordinatamente cosa era successo e cosa aveva visto fuori del pozzo. Della qual cosa costoro, avendo capito cos’era accaduto, glielo dissero e ridendo aggiunsero perché erano fuggiti e chi erano stati a tirarlo fuori. Senza dire più niente, perché era sopraggiunta la mezzanotte, andarono nella chiesa maggiore, entrarono facilmente e si avvicinarono al sepolcro, che era di marmo e molto grande; sollevarono con il ferro il coperchio, che era pesantissimo, quel tanto che un uomo ci potesse passare e misero un puntello.
Fatto questo uno dei due disse: «Chi entrerà là dentro?»
A cui l’altro rispose: «Non io».
«Nemmeno io», disse il primo, «ma vi entra Andreuccio»
«Questo non lo faccio» disse Andreuccio.
Verso di lui si rivolsero entrambi e dissero: «Come non vi entrerai? In verità se tu non entri, noi ti daremo tanti colpi in testa con questi pali di ferro che ti uccideremo».
Andreuccio per paura vi entrò e, mentre entrava, tra sé pensò: «Questi mi fanno entrare per ingannarmi, perciò, come io avrò dato loro ogni cosa, mentre faticherò per uscir dall’arca, se ne andranno per fatti loro ed io rimarrò senza niente» E perciò pensò per prima cosa di tenersi la parte propria e, ricordandosi del prezioso anello di cui avevano parlato, come fu nel sepolcro, lo tolse dal dito dell’arcivescovo e se lo mise addosso; e poi, dato il pastorale, la mitra e i guanti e spogliatolo fino a lasciarlo in camicia, diede tutto a loro, dicendo che non vi era più niente. Questi affermando che doveva esserci l’anello, gli intimarono di cercarlo dappertutto: ma lui, dicendo di non trovarlo e fingendo di cercare, li lasciò a lungo ad aspettare. Quei due, che erano maliziosi così come era diventato Andreuccio, dicendogli di continuare a cercare, al momento opportuno tolsero il puntello, che sosteneva l’apertura del sepolcro, e fuggendo lasciarono Andreuccio lì dentro. Ciascuno può immaginare come stesse.
Egli tentò più volte sia con la testa che con le spalle di sollevare il coperchio, ma i suoi tentativi erano vani; allora vinto da un gran dolore, cadde svenuto sopra il corpo dell’arcivescovo e chi allora li avesse visti, difficilmente avrebbe riconosciuto chi dei due era più morto, o lui o l’arcivescovo. Ma quando tornò in sé cominciò, cominciò a piangere in modo dirotto, vedendo se stesso giungere a due esiti finali: o morire di fame e ricoperto di vermi del corpo dell’arcivescovo in putrefazione in quell’arca, non venendo più nessuno ad aprirla, oppure, venendo qualcuno e trovando lui dentro, essere impiccato come ladro.
E mentre era molto addolorato, pensando tali cose, sentì gente camminare per la chiesa e parlare molte persone che, da come gli era sembrato di capire, andavano a fare ciò che lui, con i due compagni aveva fatto: per questo la sua paura aumentò. Ma dopo che costoro ebbero aperta l’arca e puntellata, incominciarono a discutere su chi dovesse entrare e nessuno lo voleva fare. Finalmente dopo una lunga discussione un prete disse: «Che paura avete? Credete che vi mangi? I morti non mangiano gli uomini. Entrerò io» E così detto, messo il petto sopra l’arca, volse la testa verso l’esterno e mandò all’interno le gambe per doversi calare giù. Andreuccio, vedendo questo, sollevatosi in piedi prese il prete per una delle gambe e cominciò a tirarlo. Il prete, sentendo ciò, emise un grandissimo urlo, e si gettò fuori; vedendo questo tutti gli altri spaventati cominciarono a fuggire come se fossero inseguiti dai diavoli, lasciando l’arca aperta.
La qual cosa vedendo Andreuccio, felice oltre ciò che sperava, subito si gettò verso l’esterno e, ripassando su quella strada attraverso cui era giunto in chiesa, ed essendo vicini all’alba, andato a caso con quell’anello al dito, giunse alla Marina e da lì giunse al suo albergo dove ritrovò i suoi compagni e l’albergatore tutti in ansia per lui. A loro raccontò ciò che gli era capitato e sembrò opportuno all’oste farlo partire immediatamente da Napoli; osa che lui fece subito e tornò a Perugia, avendo il suo denaro investito in un anello, quando era andato a comprare un cavallo.

Illustrazione della novella di Boccaccio
La novella di Andreuccio, come quella di Landolfo, tratta di fortuna, per meglio dire delle disavventure che possono capitare e di come, da esse, si possa uscire. Se in Landolfo il motore della fortuna è il mare, in Andreuccio è la città.
Se queste possono essere le similarità, di più sono le differenze che contraddistinguono le due narrazioni. In primo luogo il racconto di Andreuccio si struttura come un bildungsroman (romanzo di formazione) in quanto la vicenda del protagonista disegna un percorso in cui il giovane mercante “rozzo e poco cauto” arriva , non senza atteggiamenti di ribalderia e furbizia a possedere un anello di più alto valore del denaro perso. Tale acquisizione di consapevolezza viene da Boccaccio strutturato attraverso un percorso oppositivo che vede contrapposti l’alto ed il basso, il dentro e il fuori. Andreuccio dapprima viene accolto in casa (dentro: sicurezza) quindi cade nel pozzetto (basso/fuori). Le due opposizioni vogliono indicare lo stato di pericolo da cui riemerge con un grado di conoscenza superiore. Allo stesso modo la seconda opposizione: strada (alto: sicurezza) pozzo, (caduta, situazione di pericolo) ed anche la terza (arca: dentro) esterno e fuga (fuori: scioglimento).
Il tutto viene raccontato con una capacità realistica che ha dello straordinario, mostrando una Napoli labirintica che offre possibilità di “fortuna” come il mare. Il Boccaccio ottiene questo effetto grazie alla conoscenza di luoghi (Malpertugio, Ruga Catalana, Marina) e persone (Buttafuoco e Fiordaliso) che sono effettivamente reali e, come ci dicono i documenti dell’epoca, esistenti. In mezzo a tale realtà l’autore inserisce la casualità (“per ventura” ricorre piuttosto spesso nel racconto) che solo una città caotica come quella della città campana poteva offrire. Per questo possiamo concludere con la definizione di Mario Baratto che afferma come Boccaccio riesca a cogliere “il meraviglioso della realtà, il miracolo quotidiano” proponendosi come “il primo grande scrittore nel Medioevo, che abbia colto la natura avventurosa della città, il potenziale narrativo che essa contiene”.
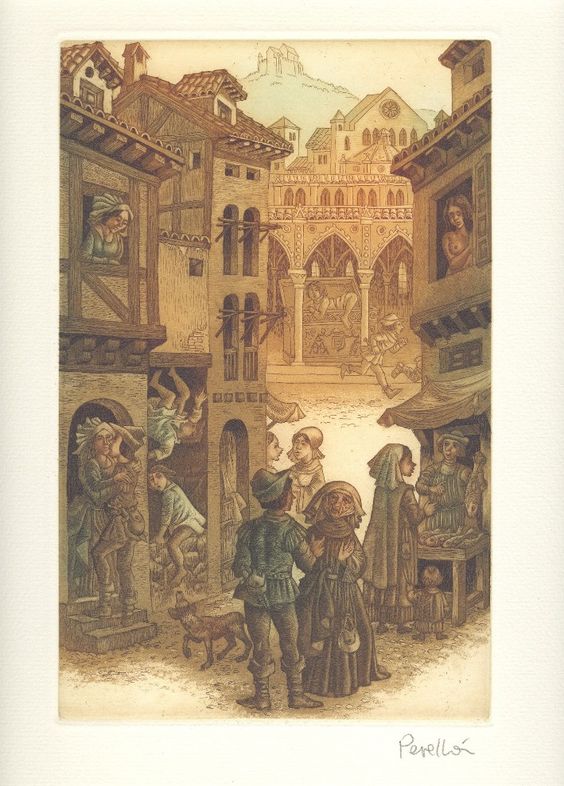
Celedonio Perellon: Illustrazione per l’edizione spagnola del Decameron (2009)
TERZA GIORNATA
La terza giornata è posta sotto la reggenza di Neifile in cui si racconta di chi alcuna cosa molto da lui disiderata con industria acquistasse o la perduta ricoverasse.
La prima novella della giornata è narrata da Filostrato, il quale vuol dimostrare come le religiose sono donne e quindi, come tali, naturalmente portate al piacere e allo stesso tempo come un uomo, pur di condizione umile e bassa, può raggiungere il piacere (sessuale) usando un po’ di furbizia ed intelligenza:
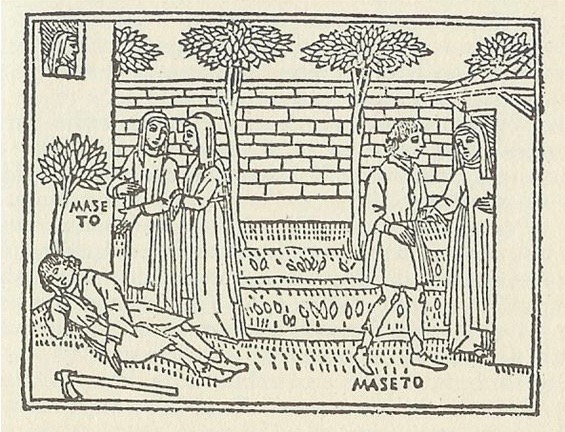
Manoscritto risalente al XIV che riproduce la novella di Masetto
MASETTO DA LAMPORECCHIO SI FA MUTOLO E DIVIENE ORTOLANO DI UNO MONISTERO DI DONNE, LE QUALI TUTTE CONCORRONO A GIACERSI CON LUI.
(III,1)
In queste nostre contrade fu, ed è ancora, un monistero di donne assai famoso di santità (il quale io non nomerò per non diminuire in parte alcuna la fama sua), nel quale, non ha gran tempo, non essendovi allora più che otto donne con una badessa, e tutte giovani, era un buono omicciuolo d’un loro bellissimo giardino ortolano, il quale, non contentandosi del salario, fatta la ragion sua col castaldo delle donne, a Lamporecchio, là ond’egli era, se ne tornò. Quivi, tra gli altri che lietamente il raccolsono, fu un giovane lavoratore forte e robusto e, secondo uom di villa, con bella persona e con viso assai piacevole, il cui nome era Masetto; e domandollo dove tanto tempo stato fosse. Il buono uomo, che Nuto avea nome, gliele disse. Il quale Masetto domandò, di che egli il monistero servisse.
A cui Nuto rispose: «Io lavorava un loro giardino bello e grande e, oltre a questo, andava alcuna volta al bosco per le legne, attigneva acqua e faceva cotali altri servigetti; ma le donne mi davano sì poco salaro, che io non ne potevo appena pure pagare i calzari. E, oltre a questo, elle son tutte giovani e parmi ch’elle abbiano il diavolo in corpo, ché non si può far cosa niuna al lor modo; anzi, quand’io lavorava alcuna volta l’orto, l’una diceva: “Pon qui questo”; e l’altra: “Pon qui quello”; e l’altra mi toglieva la zappa di mano e diceva: “Questo non sta bene”; e davanmi tanta seccaggine, che io lasciava stare il lavorio e uscivami dell’orto; sì che, tra per l’una cosa e per l’altra, io non vi volli star più e sonmene venuto. Anzi mi pregò il castaldo loro, quando io me ne venni, che, se io n’avessi alcuno alle mani che fosse da ciò, che io gliele mandassi, e io gliele promisi; ma tanto il faccia Dio san delle reni, quanto io o ne procaccerò o ne gli manderò niuno.
A Masetto, udendo egli le parole di Nuto, venne nell’animo un disidero sì grande d’esser con queste monache, che tutto se ne struggea, comprendendo per le parole di Nuto che a lui dovrebbe poter venir fatto di quello che egli disiderava. E avvisandosi che fatto non gli verrebbe se a Nuto ne dicesse niente, gli disse: «Deh come ben facesti a venirtene! Che è un uomo a star con femine? Egli sarebbe meglio a star con diavoli: elle non sanno delle sette volte le sei quello che elle si vogliono elleno stesse».
Ma poi, partito il lor ragionare, cominciò Masetto a pensare che via dovesse tenere a dovere potere esser con loro; e conoscendo che egli sapeva ben fare quegli servigi che Nuto diceva, non dubitò di perder per quello, ma temette di non dovervi esser ricevuto per ciò che troppo era giovane e appariscente. Per che, molte cose divisate seco, imaginò: «Il luogo è assai lontano di qui e niuno mi vi conosce; se io so far vista d’esser mutolo, per certo io vi sarò ricevuto».
E in questa imaginazione fermatosi, con una sua scure in collo, senza dire ad alcuno dove s’andasse, in guisa d’un povero uomo se n’andò al monistero; dove pervenuto, entrò dentro e trovò per ventura il castaldo nella corte; al quale faccendo suoi atti come i mutoli fanno, mostrò di domandargli mangiare per l’amor di Dio e che egli, se bisognasse, gli spezzerebbe delle legne. Il castaldo gli diè da mangiar volentieri, e appresso questo gli mise innanzi certi ceppi che Nuto non avea potuto spezzare, li quali costui, che fortissimo era, in poca d’ora ebbe tutti spezzati. Il castaldo, che bisogno avea d’andare al bosco, il menò seco, e quivi gli fece tagliate delle legne; poscia, messogli l’asino innanzi, con suoi cenni gli fece intendere che a casa ne le recasse. Costui il fece molto bene, per che il castaldo a far fare certe bisogne che gli eran luogo più giorni vel tenne. De quali avvenne che uno dì la badessa il vide, e domandò il castaldo chi egli fosse.
Il quale le disse: «Madonna, questi è un povero uomo mutolo e sordo, il quale un di questi dì ci venne per limosina, sì che io gli ho fatto bene, e hogli fatte fare assai cose che bisogno c’erano. Se egli sapesse lavorar l’orto e volesseci rimanere, io mi credo che noi n’avremmo buon servigio, per ciò che egli ci bisogna, ed egli è forte e potrebbene l’uom fare ciò che volesse; e, oltre a questo, non vi bisognerebbe d’aver pensiero che egli motteggiasse queste vostre giovani.»
A cui la badessa disse: «In fè di Dio tu di’il vero. Sappi se egli sa lavorare e ingegnati di ritenercelo; dagli qualche paio di scarpette qualche cappuccio vecchio, e lusingalo, fagli vezzi, dagli ben da mangiare».
Il castaldo disse di farlo. Masetto non era guari lontano, ma faccendo vista di spazzar la corte tutte queste parole udiva, e seco lieto diceva: «Se voi mi mettete costà entro, io vi lavorrò sì l’orto che mai non vi fu così lavorato».
Ora, avendo il castaldo veduto che egli ottimamente sapea lavorare e con cenni domandatolo se egli voleva star quivi, e costui con cenni rispostogli che far voleva ciò che egli volesse, avendolo ricevuto, gl’impose che egli l’orto lavorasse e mostrogli quello che a fare avesse; poi andò per altre bisogne del monistero, e lui lasciò. Il quale lavorando l’un dì appresso l’altro, le monache incominciarono a dargli noia e a metterlo in novelle, come spesse volte avviene che altri fa de’mutoli, e dicevangli le più scelerate parole del mondo, non credendo da lui essere intese; e la badessa, che forse estimava che egli così senza coda come senza favella fosse, di ciò poco o niente si curava.
Or pure avvenne che costui un dì avendo lavorato molto e riposandosi, due giovinette monache, che per lo giardino andavano, s’appressarono là dove egli era, e lui che sembiante facea di dormire cominciarono a riguardare. Per che l’una, che alquanto era più baldanzosa, disse all’altra: «Se io credessi che tu mi tenessi credenza, io ti direi un pensiero che io ho avuto più volte, il quale forse anche a te potrebbe giovare».
L’altra rispose: «Di’ sicuramente, ché per certo io nol dirò mai a persona».
Allora la baldanzosa incominciò: «Io non so se tu t’hai posto mente come noi siamo tenute strette, né che mai qua entro uomo alcuno osa entrare, se non il castaldo ch’è vecchio e questo mutolo; e io ho più volte a più donne, che a noi son venute, udito dire che tutte l’altre dolcezze del mondo sono una beffa a rispetto di quella quando la femina usa con l’uomo. Per che io m’ho più volte messo in animo, poiché con altrui non posso, di volere con questo mutolo provare se così è. Ed egli è il miglior del mondo da ciò costui; ché, perché egli pur volesse, egli nol potrebbe né saprebbe ridire. Tu vedi ch’egli è un cotal giovanaccio sciocco, cresciuto innanzi al senno; volentieri udirei quello che a te ne pare».
«Ohimè!» disse l’altra, «che è quello che tu di’? Non sai tu che noi abbiam promesso la virginità nostra a Dio?»
«Oh», disse colei, «quante cose gli si promettono tutto ‘l dì, che non se ne gli attiene niuna! Se noi gliele abbiam promessa, truovisi un’altra o dell’altre che gliele attengano».
A cui la compagna disse: «O se noi ingravidassimo, come andrebbe il fatto?»
Quella allora disse: «Tu cominci ad aver pensiero del mal prima che egli ti venga; quando cotesto avvenisse, allora si vorrà pensare; egli ci avrà mille modi da fare sì che mai non si saprà, pur che noi medesime nol diciamo».
Costei, udendo ciò, avendo già maggior voglia che l’altra di provare che bestia fosse l’uomo, disse: «Or bene, come faremo?»
A cui colei rispose: «Tu vedi ch’egli è in su la nona; io mi credo che le suore sien tutte a dormire, se non noi; guatiam per l’orto se persona ci è, e s’egli non ci è persona, che abbiam noi a fare se non a pigliarlo per mano e menarlo in questo capannetto, là dove egli fugge l’acqua; e quivi l’una si stea dentro con lui e l’altra faccia la guardia? Egli è sì sciocco, che egli s’acconcerà comunque noi vorremo».

Vincenzo Amato nella parte di Masetto nel Decameron di Pier Paolo Pasolini (1971)
Masetto udiva tutto questo ragionamento, e disposto ad ubidire, niuna cosa aspettava se non l’esser preso dall’una di loro. Queste, guardato ben per tutto e veggendo che da niuna parte potevano esser vedute, appressandosi quella che mosse avea le parole a Masetto, lui destò, ed egli incontanente si levò in piè. Per che costei con atti lusinghevoli presolo per la mano, ed egli faccendo cotali risa sciocche, il menò nel capannetto, dove Masetto senza farsi troppo invitare quel fece che ella volle. La quale, sì come leale compagna, avuto quel che volea, diede all’altra luogo, e Masetto, pur mostrandosi semplice, faceva il lor volere. Per che avanti che quindi si dipartissono, da una volta in su ciascuna provar volle come il mutolo sapea cavalcare; e poi, seco spesse volte ragionando, dicevano che bene era così dolce cosa, e più, come udito aveano; e prendendo a convenevoli ore tempo, col mutolo s’andavano a trastullare.
Avvenne un giorno che una lor compagna, da una finestretta della sua cella di questo fatto avvedutasi, a due altre il mostrò. E prima tennero ragionamento insieme di doverle accusare alla badessa; poi, mutato consiglio e con loro accordatesi, partefici divennero del podere di Masetto. Alle quali l’altre tre per diversi accidenti divenner compagne in vari tempi. Ultimamente la badessa, che ancora di queste cose non s’accorgea, andando un dì tutta sola per lo giardino, essendo il caldo grande, trovò Masetto (il qual di poca fatica il dì, per lo troppo cavalcar della notte, aveva assai) tutto disteso al l’ombra d’un mandorlo dormirsi, e avendogli il vento i panni dinanzi levati indietro, tutto stava scoperto. La qual cosa riguardando la donna, e sola vedendosi, in quel medesimo appetito cadde che cadute erano le sue monacelle; e, destato Masetto, seco nella sua camera nel menò, dove parecchi giorni, con gran querimonia dalle monache fatta che l’ortolano non venia a lavorar l’orto, il tenne, provando e riprovando quella dolcezza la qual essa prima all’altre solea biasimare.
Ultimamente della sua camera alla stanza di lui rimandatolne, e molto spesso rivolendolo, e oltre a ciò più che parte volendo da lui, non potendo Masetto sodisfare a tante, s’avvisò che il suo esser mutolo gli potrebbe, se più stesse, in troppo gran danno resultare. E perciò una notte colla badessa essendo, rotto lo scilinguagnolo, cominciò a dire: «Madonna, io ho inteso che un gallo basta assai bene a dieci galline, ma che dieci uomini possono male o con fatica una femina sodisfare, dove a me ne conviene servir nove, al che per cosa del mondo io non potrei durare; anzi son io, per quello che infino a qui ho fatto, a tal venuto che io non posso far né poco né molto; e perciò o voi mi lasciate andar con Dio, o voi a questa cosa trovate modo».
La donna udendo costui parlare, il quale ella teneva mutolo, tutta stordì, e disse: «Che è questo? Io credeva che tu fossi mutolo».
«Madonna», disse Masetto «io era ben così, ma non per natura, anzi per una infermità che la favella mi tolse, e solamente da prima questa notte la mi sento essere restituita, di che io lodo Iddio quant’io posso».

Un’altro fotogramma tratto dal Decameron di Pasolini (1971)
La donna sel credette, e domandollo che volesse dir ciò che egli a nove aveva a servire. Masetto le disse il fatto. Il che la badessa udendo, s’accorse che monaca non avea che molto più savia non fosse di lei; per che, come discreta, senza lasciar Masetto partire, dispose di voler colle sue monache trovar modo a questi fatti, acciò che da Masetto non fosse il monistero vituperato. Ed essendo di que’ dì morto il lor castaldo, di pari consenatimento, apertosi tra tutte ciò che per addietro da tutte era stato fatto, con piacer di Masetto ordinarono che le genti circustanti credettero che, per le loro orazioni e per gli meriti del santo in cui intitolato era il monistero, a Masetto, stato lungamente mutolo, la favella fosse restituita, e lui castaldo fecero; e per sì fatta maniera le sue fatiche partirono, che egli le poté comportare. Nelle quali, come che esso assai monachin generasse, pur sì discretamente procedette la cosa che niente se ne sentì se non dopo la morte della badessa, essendo già Masetto presso che vecchio e disideroso di tornarsi ricco a casa; la qual cosa saputa, di leggier gli fece venir fatto.
Così adunque Masetto vecchio, padre e ricco, senza aver fatica di nutricar figliuoli o spesa di quegli, per lo suo avvedimento avendo saputo la sua giovanezza bene adoperare, donde con una scure in collo partito s’era se ne tornò, affermando che così trattava Cristo chi gli poneva le corna sopra ‘l cappello.

Rockwell Kent: illustrazione per il Decameron (1934)
In queste nostre terre ci fu e c’è ancora un monastero femminile molto famoso per santità (che non nominerò per non intaccare la sua fama di santità), nel quale, non molto tempo fa, essendoci solo otto monache ed una badessa, tutte di età giovanile, vi lavorava un bravo ometto, ortolano in un loro bellissimo giardino che, non contentandosi più dello stipendio, fatti i conti con il fattore delle monache, tornò a Lamporecchio, da dove era partito. Qui tra i molti che l’accolsero, era presente un giovane, sebbene contadino, forte, robusto e bello, che si chiamava Masetto. Lui gli domandò dove fosse stato tutti quegli anni e il buon uomo, che si chiamava Nuto, glielo disse; Masetto gli chiese anche quali fossero i servizi che nel monastero prestava. Nuto gli rispose: «Coltivavo un loro giardino, bello e grande; talvolta andavo a far legna nel bosco; prendevo l’acqua e mi dedicavo anche ad altri lavoretti; ma le monache mi pagavano così poco da non potermi neanche comprare i calzari. Per di più le monache sono tutte giovani e sembra abbiano il diavolo in corpo, perché non si può fare nulla ce a loro vada bene. Quando io lavoravo l’orto, una diceva: “Metti questi qui”, l’altra “posa quello là”, un’altra mi toglieva la vanga dalle mani e diceva: “non si fa così” e mi davano tante seccature che io preferivo andare via dall’orto col lavoro a metà; così tra una cosa e l’altra, avevo deciso d’andarmene e sono rivenuto. Inoltre mi pregò il loro fattore, quando stavo andando via, se conoscessi qualcuno per sostituirmi e glielo promisi; ma possa Dio preservarmi i reni, se io gli procurerò o gli manderò qualcuno».
A Masetto, che aveva sentito le parole di Nuto, gli venne una voglia matta di stare con le monache che se ne moriva, capendo dalle parole dell’ortolano che gli sarebbe stato possibile ricevere qualcosa di quello che desiderava e, sapendo che non sarebbe riuscito se avesse rivelato il desiderio a Nuto, gli disse: «Dio come hai fatto bene ad andartene! A cosa si riduce un uomo a stare con le donne? Meglio stare con i diavoli: loro non sanno sette volte su sei cosa loro stesse vogliono».
Finita la loro conversazione, Masetto cominciò a pensare in che modo potesse rimanere con le monache e rendendosi conto che sapeva fare tutto ciò che serviva loro, temeva di non essere accettato perché era troppo giovane e avvenente. Pensate ed esaminate, riguardo a questo, molte cose, disse tra sé: “Il luogo e abbastanza lontano da qui e nessuno mi conosce. Se io faccio finta di essere muto, sono sicuro che mi riceveranno».
Convinto del suo pensiero, con una scure sulla spalle, senza dire niente a nessuno, come un povero uomo andò verso il monastero. Una volta entrato e trovò per caso nel cortile il castaldo verso il quale, facendo i segni come i muti, mostrò per amor di Dio di dargli da mangiare e che lui, se avesse avuto bisogno, gli avrebbe tagliato la legna. Il castaldo diede a lui volentieri da mangiare e gli mise di fronte alcuni ceppi che Nuto non aveva potuto tagliare, che lui, da uomo forte com’era, in breve tempo, spezzò. Quindi lo portò al bosco ed anche lì gli fece far legna: quindi gli mise l’asino davanti e con cenni gli disse di portarla al monastero. Egli fece il suo compito molto bene, per cui il fattore per più giorni gli fece fare dei lavori di cui aveva bisogno: in quei giorni capitò che la badessa lo vide e domandò al fattore chi fosse.
Il fattore rispose: «Signora, costui è un povero uomo muto e sordo, che, qualche giorno fa è venuto per elemosinare (qualcosa da mangiare), che io gli ho dato e gli ho fatto fare molte cose che erano necessarie. Se lui sapesse lavorare l’orto e volesse rimanere, io credo faremo un bell’affare, perché un uomo come lui ci serve, è forte, e si potrebbe fargli fare ciò che lei desidera; inoltre non dovreste preoccuparvi perché non infastidirebbe con parole le giovani monache».
A lui la badessa rispose: «In nome di Dio, tu dici il vero! Fa in modo di sapere se egli sappia lavorare la terra e cerca di trattenerlo: dagli un paio di scarpe, un vecchio cappuccio e soddisfalo, sii affettuoso e nutrilo bene».
Il fattore lo fece. Masetto che non era lontano, ma facendo finta di spazzare il cortile, sentiva tutto e fra sé diceva: «Se voi mi mettete dentro il monastero, lavorerò l’orto così come nessuno prima di me l’ha mai lavorato!»
Il castaldo avendo visto che sapeva lavorare molto bene, gli fece capire a cenni se lui volesse rimanere a cui lui con gesti disse di sì e quindi, avendolo assunto, gli comandò di lavorare l’orto e gli fece vedere ciò che doveva fare. Quindi andò per altri suoi impegni e lo lasciò solo. Masetto lavorava da più giorni e le monache cominciarono ad infastidirlo e a prenderlo in giro, come spesso si fa con i sordomuti, dicendogli le peggiori parole, pensando che lui non le sentisse; e la badessa che pensava che così senza “coda”, come senza parola fosse, di ciò non si dava pensiero.
Un giorno avvenne, avendo Masetto lavorato molto ed essendosi messo a riposare, che due giovani monache che passeggiavano per il giardino, s’avvicinarono dove lui fingeva di dormire e cominciarono a guardarlo; e allora una, che era più spigliata, disse all’altra: «Se io sapessi che tu sai mantenere un segreto, io ti confesserei un’idea che mi è venuta spesso in testa, che potrebbe essere gradita anche a te».
«Parla con tranquillità, che io non lo dirò a nessuno»
Allora la più sfacciata cominciò a dire: «Io non se ti sei mai accorta su come siamo chiuse in regole rigide, che mai in questo monastero alcun uomo osa entrare se non il fattore, che è vecchio e questo muto. Io sentito dire spesso e a più di una donna che è venuta qui che tutte le altre dolcezze sono uno scherzo rispetto a quella di far l’amore con uomo; per questo mi sono messa in testa, dal momento che non ho altre occasioni, di voler provare con questo muto se questo è vero; e lui è io migliore del mondo per far ciò dal momento che, pur volendolo, non potrebbe ridirlo. Tu vedi che è un tale giovinaccio scemo, che è cresciuto prima lui del suo cervello. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi».
«Ohimé!» disse l’altra «Cosa dici! Non sai che abbiamo promesso la verginità a Dio?»
«Oh», le rispose «quante cose gli si promettono tutto il giorno e non se mantiene nessuna! Se gliela abbiamo promessa, ne troveremo un’altra o delle altre che gli attengono»
E ancora l’altra: «E se rimanessimo incinta, come faremo?»
Le disse: «Tu cominci a preoccuparti del danno prima che avvenga: se dovesse accadere, ci penseremo; ci sarà pure io modo di non farlo sapere, se noi non lo diciamo (a nessuno)».
Quella, sentito ciò e che aveva maggior voglia dell’altra di provare che animale fosse il maschio, disse: «Come faremo?»
Allora rispose: «Tu vedi che è circa la nona (tra le due e le tre del pomeriggio): credo che le suore siano tutte a dormire, eccetto noi; guardiamo se c’è qualcuno nell’orto e se non c’è nessuno che dobbiamo fare se non prenderlo per mano e portarlo a questo capanno, dove si rifugia quando piove, e qui, mentre una sta dentro con lui, l’altra fa da guardia? Egli è talmente scemo, che farà tutto quello che noi vorremo».
Masetto ascoltava tutto quello che dicevano ed era pronto ad obbedirle aspettando che una di loro lo prendesse. Queste, guardando intorno e considerando che non erano vedibili da alcuno, avvicinandosi quella che aveva parlato per prima a Masetto, lo svegliò e lui, immediatamente, si alzò; e quindi con atti lusinghieri preso per mano, mentre lui rideva in modo scemo, lo condusse nel capanno, dove Masetto senza farsi invitare, fece quello che lei desiderava. Uscita dopo aver fatto ciò che voleva, come compagna leale lasciò il posto all’altra; Masetto, sebbene si mostrasse sempliciotto, esaudiva il loro piacere; per cui, prima di andarsene da lì, più di una volta, vollero riprovare come il muto sapeva cavalcare; in seguito, parlando tra loro, dicevano che era una cosa più bella di come l’avevano sentita e sfruttando il tempo favorevole, col muto andavano a divertirsi.
Capitò un giorno che una loro compagna dalla finestra della sua cella si accorse di questo fatto e lo mostrò ad altre due; e prima ragionarono se dovessero dirlo alla badessa, poi, cambiato parere e messosi d’accordo con le prima, cominciarono a frequentare l’orto di Masetto; ad esse per diverse vicissitudini le altre tre divennero compagne in tempi diversi.
Da ultimo la badessa, che ancora non si era accorta di nulla, andando un giorno tutta sola per il giardino, poiché era molto caldo trovò Masetto, che durante il giorno si stancava anche per un piccolo sforzo, per l’eccessiva attività notturna, steso e addormentato sotto un albero di mandorlo; e avendo il vento spinto all’indietro i panni con cui era coperto, stava completamente scoperto. La donna, vedendolo così, cadde nello stesso appetito nel quale erano cadute le sue monachelle e, svegliato Masetto se lo portò in camera, dove per molti giorni e con grande lamentela delle monache che non vedevano più l’ortolano, lo tenne con sé provando e riprovando il piacere che lei stessa prima condannava alle altre.Rimandandolo ultimamente dalla sua camera a quella di Masetto, rivolendolo spesso e soprattutto non volendolo spartire con le altre, non potendo Masetto soddisfarle tutte, risolse che il suo essere muto, se avesse continuato, si sarebbe potuto tramutare in danno; perciò una notte, essendo con la badessa, cominciando a parlare disse: «Signora, so che un gallo può servire dieci galline, ma che dieci maschi possono soddisfare malamente o con fatica una donna, quando a me tocca soddisfarne nove; perciò non ce la posso fare, anzi sono io, per tutto quello che fino ad adesso ho fatto, arrivato al punto di non poter fare né molto né poco e perciò o mi lasciate andar con Dio o per questa cosa trovate il modo».
La donna, sentendo costui parlare, credendolo muto, si turbò e disse: «Che cosa è questa novità? Pensavo tu fossi muto».
«Signora», rispose Masetto «io ero così non per natura, ma per una malattia che mi tolse la voce, e solamente da questa notte, per la prima volta, sento che sia tornata, della qual cosa lodo il Signore per quanto posso».
La donna gli credette e gli chiese che cosa intendesse dire che lui dovesse servire a nove. Masetto glielo spiegò, il che, la badessa udendo, si rese conto che tutte le sue monache erano più avvedute di lei; per questo, discretamente, senza lasciare che Masetto partisse, decise di trovare un accordo con le monache, affinché il monastero non fosse infamato dallo stesso ortolano. Essendo quei giorni molto il fattore, di comune accordo, girata la voce cosa tutte avevano fatto, con il consenso di Masetto ordinarono che la gente del luogo doveva credere che, per le preghiere da lor fatte al santo cui era intitolato il monastero, a Masetto, per lungo tempo muto, fosse tornata la parola e fecero lui fattore; quindi si divisero le sue fatiche in modo tale che egli le potesse sopportare. E in queste cose, sebbene grazie a lui venissero al mondo molti monachini, tutto procedette con discrezione che non se ne seppe nulla, se non dopo la morte della badessa, quando ormai Masetto vicino alla vecchiaia, mostrò il desiderio di tornare a casa, che gli fu concesso.
Così infine Masetto vecchio, ricco e padre, senza darsi il pensiero di mantenere figli, avendo saputo passare bene la giovinezza, che lo aveva visto partire con una vanga in spalla, se ne tornò, affermando che così trattava Cristo chi gli metteva le corna sul cappello.

Carlo Romiti: Masetto e le monache (2013)
La novella presenta come protagonisti un lavoratore della terra e nove monache: ciò che li caratterizza è l’identità del numero tra i protagonisti della novella e i novellatori che la raccontano. Ma vi è una sostanziale differenza che emerge sia nella concezione spaziale che culturale:
- i dieci novellatori appartengono alla classe alta, vivono in un locus amoenus e, in quanto “cortesi” vivono nell’idealità di una purezza non scalfibile;
- i dieci protagonisti (nove donne e un uomo) pur vivendo anch’essi in un locus amoenus vengono esclusi da ogni altro sguardo oltre le mure conventuali e vivono una realtà “naturale” in contrasto con l’ideale religioso.
A questo punto bisogna sottolineare meglio tale concetto: infatti quello che qui si vuol dire è che se i dieci novellatori si aprono al mondo attraverso la parola, qui il mondo è chiuso, introiettato su stesso, attraverso un processo di regressione animale (sesso senza comunicazione) che vede l’istinto prevalere sulla ragione.
Ma non è tutto così: non per niente l’azione parte con la parola e si chiude con la parola: Masetto dapprima ascolta la parola, mette quindi in atto un processo intellettivo di tipo mercantilistico (ricerca di un mezzo per un ottenimento di un bene) e scioglie l’avvenuto ottenimento con la parola stessa.

Bottega degli Zavattari: Agilulfo e Teodolinda si incontrano a Lomello (1441-1446)
UN PALLAFRENIER GIACE CON LA MOGLIE D’AGIFUL RE, DI CHE AGIFUL TACITAMENTE S’ACCORGE; TRUOVALO E TONDALO; IL TONDUTO TUTTI GLI ALTRI TONDE, E COSI’ CAMPA DELLA MALA VENTURA.
(III,2)
Agilulf re de’ longobardi, sì come i suoi predecessori avevan fatto, in Pavia città di Lombardia fermò il solio del suo regno, avendo presa per moglie Teudelinga, rimasa vedova d’Autari re stato similmente de’ longobardi, la quale fu bellissima donna, savia e onesta molto, ma male avventurata in amadore. Ed essendo alquanto per la virtù e per lo senno di questo re Agilulf le cose de’ longobardi prospere e in quiete, avvenne che un pallafreniere della detta reina, uomo quanto a nazione di vilissima condizione, ma per altro da troppo più che da così vil mestiere, e della persona bello e grande così come il re fosse, senza misura della reina s’innamorò. E per ciò che il suo basso stato non gli avea tolto che egli non conoscesse questo suo amore esser fuor d’ogni convenienza, sì come savio, a niuna persona il palesava, né eziandio a lei con gli occhi ardiva di scoprirlo. E quantunque senza alcuna speranza vivesse di dover mai a lei piacere, pur seco si gloriava che in alta parte avesse allogati i suoi pensieri; e, come colui che tutto ardeva in amoroso fuoco, studiosamente faceva, oltre ad ogn’altro de’ suoi compagni, ogni cosa la qual credeva che alla reina dovesse piacere. Per che interveniva che la reina, dovendo cavalcare, più volentieri il palla freno da costui guardato cavalcava che alcuno altro; il che quando avveniva, costui in grandissima grazia sel reputava; e mai dalla staffa non le si partiva, beato tenendosi qualora pure i panni toccar le poteva.
Ma, come noi veggiamo assai sovente avvenire, quanto la speranza diventa minore tanto l’amor maggior farsi, così in questo povero pallafreniere avvenia, in tanto che gravissimo gli era il poter comportare il gran disio così nascoso come facea, non essendo da alcuna speranza atato; e più volte seco, da questo amor non potendo disciogliersi, diliberò di morire. E pensando seco del modo, prese per partito di voler questa morte per cosa per la quale apparisse lui morire per lo amore che alla reina aveva portato e portava; e questa cosa propose di voler che tal fosse, che egli in essa tentasse la sua fortuna in potere o tutto o parte aver del suo disidero. Né si fece a voler dir parole alla reina o a voler per lettere far sentire il suo amore, ché sapeva che in vano o direbbe o scriverrebbe; ma a voler provare se per ingegno colla reina giacer potesse. Né altro ingegno né via c’era se non trovar modo come egli in persona del re, il quale sapea che del continuo con lei non giacea, potesse a lei pervenire e nella sua camera entrare.
Per che, acciò che vedesse in che maniera e in che abito il re, quando a lei andava, andasse, più volte di notte in una gran sala del palagio del re, la quale in mezzo era tra la camera del re e quella della reina, si nascose; e in tra l’altre una notte vide il re uscire della sua camera inviluppato in un gran mantello e aver dall’una mano un torchietto acceso e dall’altra una bacchetta, e andare alla camera della reina e senza dire alcuna cosa percuotere una volta o due l’uscio della camera con quella bacchetta, e incontanente essergli aperto e toltogli di mano il torchietto.
La qual cosa venuta, e similmente vedutolo ritornare, pensò di così dover fare egli altressì; e trovato modo d’avere un mantello simile a quello che al re veduto avea e un torchietto e una mazzuola, e prima in una stufa lavatosi bene, acciò che non forse l’odore del letame la reina noiasse o la facesse accorgere dello inganno, con queste cose, come usato era, nella gran sala si nascose. E sentendo che già per tutto si dormia, e tempo parendogli o di dovere al suo disiderio dare effetto o di far via con alta cagione alla bramata morte, fatto colla pietra e collo acciaio che seco portato avea un poco di fuoco, il suo torchietto accese, e chiuso e avviluppato nel mantello se n’andò all’uscio della camera e due volte il percosse colla bacchetta. La camera da una cameriera tutta sonnochiosa fu aperta, e il lume preso e occultato; laonde egli, senza alcuna cosa dire, dentro alla cortina trapassato e posato il mantello, se n’entrò nel letto nel quale la reina dormiva. Egli disiderosamente in braccio recatalasi, mostrandosi turbato (per ciò che costume del re esser sapea che quando turbato era niuna cosa voleva udire), senza dire alcuna cosa o senza essere a lui detta, più volte carnalmente la reina cognobbe. E come che grave gli paresse il partire, pur temendo non la troppa stanza gli fosse cagione di volgere l’avuto diletto in tristizia, si levò, e ripreso il suo mantello e il lume, senza alcuna cosa dire se n’andò, e come più tosto potè si tornò al letto suo.
Nel quale appena ancora esser poteva, quando il re, levatosi, alla camera andò della reina, di che ella si maravigliò forte; ed essendo egli nel letto entrato e lietamente salutatala, ella, dalla sua letizia preso ardire, disse: «O signor mio, questa che novità è stanotte? Voi vi partite pur testé da me; e oltre l’usato modo di me avete preso piacere, e così tosto da capo ritornate? Guardate ciò che voi fate».
Il re, udendo queste parole, subitamente presunse la reina da similitudine di costumi e di persona essere stata ingannata; ma, come savio, subitamente pensò, poi vide la reina accorta non se n’era né alcuno altro, di non volernela fare accorgere. Il che molti sciocchi non avrebbon fatto, ma avrebbon detto: «Io non ci fu’ io, chi fu colui che ci fu? come andò? chi ci venne?» Di che molte cose nate sarebbono, per le quali egli avrebbe a torto contristata la donna e datole materia di disiderare altra volta quello che già sentito avea; e quello che tacendo niuna vergogna gli poteva tornare, parlando s’arebbe vitupero recato.
Risposele adunque il re, più nella mente che nel viso o che nelle parole turbato: «Donna, non vi sembro io uomo da poterci altra volta essere stato e ancora appresso questa tornarci?»
A cui la donna rispose: «Signor mio, sì; ma tuttavia io vi priego che voi guardiate alla vostra salute».
Allora il re disse: «Ed egli mi piace di seguire il vostro consiglio; e questa volta senza darvi più impaccio me ne vo’ tornare».
E avendo l’animo già pieno d’ira e di mal talento, per quello che vedeva gli era stato fatto, ripreso il suo mantello, s’uscì della camera e pensò di voler chetamente trovare chi questo avesse fatto, imaginando lui della casa dovere essere, e qualunque si fosse, non esser potuto di quella uscire. Preso adunque un picciolissimo lume in una lanternetta, se n’andò in una lunghissima casa che nel suo palagio era sopra le stalle de’ cavalli, nella quale quasi tutta la sua famiglia in diversi letti dormiva; ed estimando che, qualunque fosse colui che ciò fatto avesse che la donna diceva, non gli fosse ancora il polso e ‘1 battimento del cuore per lo durato affanno potuto riposare, tacitamente, cominciato dall’uno de’ capi della casa, a tutti cominciò ad andare toccando il petto per sapere se gli battesse.
Come che ciascuno altro dormisse forte, colui che colla reina stato era non dormiva ancora; per la qual cosa, vedendo venire il re e avvisandosi ciò che esso cercando andava, forte cominciò a temere tanto che sopra il battimento della fatica avuta la paura n’aggiunse un maggiore; e avvisossi fermamente che, se il re di ciò s’avvedesse, senza indugio il facesse morire. E come che varie cose gli andasser per lo pensiero di doversi fare, pur vedendo il re senza alcuna arme, diliberò di far vista di dormire e d’attender quello che il re far dovesse.
Avendone adunque il re molti cerchi né alcuno trovandone il quale giudicasse essere stato desso, pervenne a costui, e trovandogli batter forte il cuore, seco disse: «Questi è desso». Ma, sì come colui che di ciò che fare intendeva niuna cosa voleva che si sentisse, niuna altra cosa gli fece se non che con un paio di forficette, le quali portate avea, gli tondè alquanto dal l’una delle parti i capelli, li quali essi a quel tempo portavano lunghissimi, acciò che a quel segnale la mattina seguente il riconoscesse; e questo fatto, si dipartì, e tornossi alla camera sua. Costui, che tutto ciò sentito avea, sì come colui che malizioso era, chiaramente s’avvisò per che così segnato era stato; là onde egli senza alcuno aspettar si levò, e trovato un paio di forficette, delle quali per avventura v’erano alcun paio per la stalla per lo servigio de’ cavalli, pianamente andando a quanti in quella casa ne giacevano, a tutti in simil maniera sopra l’orecchie tagliò i capelli; e ciò fatto, senza essere stato sentito, se ne tornò a dormire.
Il re levato la mattina, comandò che avanti che le porti del palagio s’aprissono tutta la sua famiglia gli venisse davanti; e così fu fatto. Li quali tutti, senza alcuna cosa in capo davanti standogli, esso cominciò a guardare per riconoscere il tonduto da lui; e veggendo la maggior parte di loro co’ capelli ad un medesimo modo tagliati, si maravigliò, e disse seco stesso: «Costui, il quale io vo cercando, quantunque di bassa condizion sia, assai ben mostra d’essere d’alto senno». Poi, veggendo che senza romore non poteva avere quel ch’egli cercava, disposto a non volere per piccola vendetta acquistar gran vergogna, con una sola parola d’ammonirlo e dimostrargli che avveduto se ne fosse gli piacque; e a tutti rivolto disse: «Chi ‘l fece nol faccia mai più, e andatevi con Dio».
Un altro gli averebbe voluti far collare, martoriare, esaminare, e domandare; e ciò facendo, avrebbe scoperto quello che ciascun dee andar cercando di ricoprire; ed essendosi scoperto, ancora che intera vendetta n’avesse presa, non scemata ma molto cresciuta n’avrebbe la sua vergogna, e contaminata l’onestà della donna sua. Coloro che quella parola udirono si maravigliarono e lungamente fra sé esaminarono che avesse il re voluto per quella dire; ma niuno ve ne fu che la ‘ntendesse se non colui solo a cui toccava. Il quale, sì come savio, mai, vivente il re, non la scoperse, né più la sua vita in sì fatto atto commise alla fortuna.

Miniature delle Cronache di Norimberga: Agilulfo e Teodolinda
Agilulfo, re dei longobardi, pose il trono reale, come i suoi predecessori, a Pavia, città della Lombardia, dopo aver sposato Teodolinda, vedova di Autari, donna bellissima, saggia, onesta, ma sfortunata in amore. Mentre il regno longobardo prosperava, grazie alla virtù e al senno del re Agifulfo, un palafreniere (scudiero), di umilissima condizione, ma per tutto il resto assai superiore al suo modesto mestiere, e nell’aspetto bello e possente come un re, si innamorò perdutamente della regina. E sebbene che la sua vile condizione non gli impediva di comprendere che il suo amore era del tutto sconveniente, impossibile a realizzarsi, saggiamente non svelava il suo amore, neppure osava farlo comprendere con un semplice sguardo neppure all’amata. E sebbene vivesse senza alcuna speranza di poterle piacere, tuttavia si gloriava fra sé e sé di aver posto i pensieri così in alto e ardendo di fuoco d’amore faceva con passione più di tutti i suoi compagni ogni cosa che sembrava dovesse arrecare piacere alla regina. Quando accadeva che la regina doveva cavalcare, si serviva del cavallo da costui guardato piuttosto che quello di qualcun altro e quando questo capitava costui si reputava in grandissima grazia e non si allontanava dalle staffe , ritenendosi beato se poteva toccarle la stoffa.
Ma, come sempre avviene, l’amore si fa sempre più forte ogni qual volta la speranza diminuisce e così capitava per questo povero stalliere, tanto che gli era difficilissimo sopportare in silenzio il proprio desiderio, non essendo aiutato da alcuna speranza e più volte dunque pensò di morire, non avendo alcuna possibilità di soddisfarlo. E pensando in quale modo decise di procurasi la morte per la qual cosa fosse chiaro che moriva per l’amore che aveva provato e provava per la regina: e decise che ciò accadesse tentando la sorte, cercando di realizzare in tutto o in parte il proprio desiderio. Non accennò con parole alla regina né le comunicò nulla per lettera il suo amore, poiché sapeva che lo avrebbe detto o scritto inutilmente, ma volle provare se, con l’inganno, gli riuscisse di dormire con la regina. Altro modo non c’era se non prender il posto del re, che sapeva non dormire con lei, giungere da lei ed entrare nella sua camera. Affinché vedesse il che modo e con quale abito il re andasse a trovarla, si nascose più volte di notte in una sala che stava tra la camera del re e quella della regina; in una di queste notti vide il re uscire dalla sua camera avvolto in un lungo mantello che aveva in una mano una piccola torcia e nell’altra una bacchetta; andava nella camera della regina e senza dire niente colpiva con la bacchetta l’uscio con uno o due colpetti, allora gli veniva aperto e gli veniva tolta la piccola torcia dalla mano.
Veduto questo e accorgendosi che lo stesso avveniva quando il re tornava, pensò di fare lo stesso e trovato il modo di possedere un mantello simile a quello del re una piccola torcia e una piccola mazza, essendosi lavato bene perché l’odore di letame non infastidisse e non svelasse l’inganno alla regina, e si nascose nella sala. La notte, sentendo che tutti dormivano, desiderando possedere la regina o morire, accese con la pietra focaia e l’acciarino la torcia, indossò il mantello e si avviò. Giunto davanti alla camera della sovrana, colpì due volte la porta con la bacchetta. La camera fu aperta da una cameriera assonnata, che prese la torcia e la spense. Egli in silenzio, posato il mantello, entrò nel letto della regina che dormiva. Con immenso desiderio la presala in braccio e poiché sapeva che il re faceva l’amore in silenzio, senza dire alcuna cosa e senza che alcuna cosa gli fosse detta, più volte conobbe carnalmente la regina. Poi, sebbene gli risultasse gravoso il dover andare via, temendo che l’indugiare convertisse il diletto in danno, si alzò, riprese il mantello e la torcia e tornò nel suo letto.
In questo letto lui avrebbe potuto appena essersi levato quando il re, alzatosi, andò nella camera della regina, cosa di cui lei si stupì alquanto; ed essendo lui entrato nel suo letto e salutatala lietamente, lei, preso coraggio dalla sua disponibilità, disse: «Signor mio, che novità è questa di stanotte? Mi avete appena lasciato e avete fatto l’amore con più intensità e già siete di nuovo qua? State attento a quel che fate».
Il re, ascoltando tali parole, comprese che la regina era stata ingannata da una persona che aveva preso il suo posto, ma, saggiamente pensò che né la regina né alcun altro se ne fossero accorti e non volle che se ne accorgesse. Molti altri sciocchi avrebbero detto: «Non ero io, chi c’era al posto mio, come è arrivato qui, quando se ne andato?» da cui sarebbero partite infinite inquisizioni per le quali avrebbe rattristato ingiustamente la regina o avrebbe spinto la stessa a desiderare un’altra volta un amore diverso dal suo; si sarebbe procurato infamia e disonore rivelando quello che invece, tacendo, non gli avrebbe procurato alcuna vergogna.
Rispose dunque il re, turbato più nella mente che nel viso o nelle parole: «Donna, non vi sembro io un uomo che, dopo aver avuto dei rapporti amorosi con voi, non possa averne subito dopo altri?»
A cui la donna rispose: « Signor mio sì, ma tuttavia vi prego di stare più attento alla vostra salute»
Il re allora: «Oggi voglio seguire il vostro consiglio e senza darvi più impaccio, me ne torno in camera».
Essendo adirato e già pieno di sdegno per ciò che gli era successo, riprese il suo mantello e uscì dalla camera ma decise di scoprire, di nascosto, chi era stato, sicuro che doveva trattarsi di uno che era nella casa e chiunque fosse stato da quella non poteva scappare. Preso dunque un piccola lanterna e se ne andò in un lungo casamento che nel suo palazzo era posto sopra le stalle, nel quale in diversi letti dormiva tutta la sua servitù e credendo che chiunque avesse fatto ciò che la moglie gli aveva detto non avesse ancora il polso e il battito del cuore acquietato per l’affanno sopportato, in silenzio, cominciando dall’inizio del casamento a tutti toccava il petto per sapere se il cuore battesse con più forza.
Mentre ogni altro dormiva profondamente, colui che era stato con la regina non riusciva a prender sonno e accorgendosi che il re s’avvicinava e sapendo cosa cercava, cominciò ad avere tanta paura che il cuore che già per la fatica, ora anche per la timore aumentò di molto il battito; si rese conto fermamente che se il re se ne fosse accorto, senza aspettare un momento, lo avrebbe ucciso. E sebbene pensasse come scampare, vedendo il re senz’armi, fece finta di dormire, rimandando quello che dovesse fare. Avendone il re toccati molti e non trovandone nessuno che giudicasse colpevole, giunse a lui e trovando che il cuore gli batteva forte tra sé disse: “E’ lui”; ma non volendo fare nessun atto che fosse manifesto a tutti, non fece altro se non tagliargli con una forbicetta che aveva portato con sé, da una delle due parti i capelli, che a quel tempo portavano lunghi, affinché potesse essere riconosciuto il mattino seguente e fatto questo se ne tornò in camera.
Alzatosi la mattina il re comandò che prima che s’aprissero le porte del palazzo, venissero al suo cospetto tutti i suoi familiari e così avvenne. Tutti, senza alcun copricapo gli stavano davanti e il re cominciò a guardare per riconoscere quello a cui aveva tagliato i capelli e vedendo che davanti a lui molti avevano i capelli tagliati allo stesso modo in cui li aveva tagliati lui dapprima si stupì e poi disse tra sé: “Quello che sto cercando, sebbene di bassa condizione, mostra di essere di grande intelligenza». Poi vedendo che senza destare scalpore e scandalo non poteva trovare colui che cercava e deciso a non volersi procurare una grande vergogna per compiere una piccola vendetta, decise d’ammonirlo con la sola parola, mostrandogli che lui si era accorto di quanto successo e, rivolgendosi a tutti, disse: Chi lo ha fatto non lo faccia più e ora andate con la grazia di Dio».
Un altro li avrebbe potuti torturare, procurar loro tremendi dolori, sottoporli ad interrogatorio e così facendolo avrebbe reso palese quello che ciascuno deve cercare di tenere nascosto e rendendola palese, sebbene avesse ottenuto l’intera vendetta, non diminuita ma molto aumentata sarebbe stata la sua vergogna e rovinata l’onestà della sua donna. Quelli che sentirono la sua risposta si meravigliarono e a lungo si chiesero cosa il re avesse voluto dire, ma nessuno riuscì a capirlo ad eccezione di colui a cui era indirizzato. Lui, saggiamente, mai finché il re visse, rivelò l’accaduto, ne mise più con un simile atto la propria vita in balia della sorte.

Miniatura recante immagini riguardanti la novella di Agilulf e il palafreniere
Una delle protagoniste di questa novella è la saggezza. Qui infatti si vuole rappresentare in un tempo lontano, quello longobardo, un classico triangolo amoroso i cui vertici, tradizionalmente parlando sono costituiti da lui (il re), lei (la regina) l’altro (lo stalliere). Già così la novella avrebbe difficilmente potuto raggiungere l’idea del beffato e gabbato che è solito di un lui (un marito, in questo caso il re) in un personaggio così altocolato, così non avrebbe potuto fare della di lui moglie una donna facile alle attenzioni altrui. Per Boccaccio il triangolo amoroso deve essere riportato, in quanto coinvolgente le figure regali – oltreché reali – sul piano della non sfacciata corporeità. La differenza è nel lessico: se Masetto “cavalcava”, lo stalliere “disiderosamente in braccio recatalasi (la regina), mostrandosi turbato, senza dire alcuna cosa o senza essere a lui detta, più volte carnalmente la reina cognobbe“. L’atto sessuale è in un rigo e mezzo, senza alcun riferimento animale.
Si potrà obiettare che il fine del Boccaccio non era quello di rappresentare l’amore dello stalliere, ma di vedere in che modo l’ottenesse sfruttando l’intelligenza. Ma non è forse lo stesso per Masetto, il quale intelligentemente si finge muto per divertirsi carnalmente con nove suore?
Forse si potrebbe giustamente dire che qui Boccaccio ha voluto “democratizzare” l’intelligenza: “sì come savio” dice dello stalliere perché non rileva a nessuno l’amore per la regina; “ma come savio” dice del re quando lo stesso decide di non dire alla moglie che non è stato lui nell’amarla. Alla “democrazia” dell’intelligenza corrisponde a sua volta la “democrazia” dell’amore; d’altra parte la regina non si è accorta di nulla; forse se un pericolo vi era (suggerisce la novellatrice) è che lo stalliere fosse più focoso del re, ma ci piace pensare che lei, ignara dell’amante, ritenesse il marito capace di esserlo.
QUARTA GIORNATA
La quarta giornata vede come re Filostrato che come tema propone che si ragioni di coloro i cui amori ebbero infelice fine, in linea direi col suo nome che, come già visto, secondo l’etimologia di Boccaccio significa “vinto, sconfitto dall’amore”. Non bisogna tuttavia dimenticare che tale giornata è preceduta da un’introduzione nella quale Boccaccio parla della “naturalità dell’amore”, in risposta alle critiche che aveva ricevuto rispetto a questo argomento. La novelletta, ricordo, utilizza un registro comico, cui fa da contrasto il tema scelto dal re, soprattuto la prima novella, raccontata da Fiammetta, ce ci porta in un ambiente abitato da principi e da gran dame:
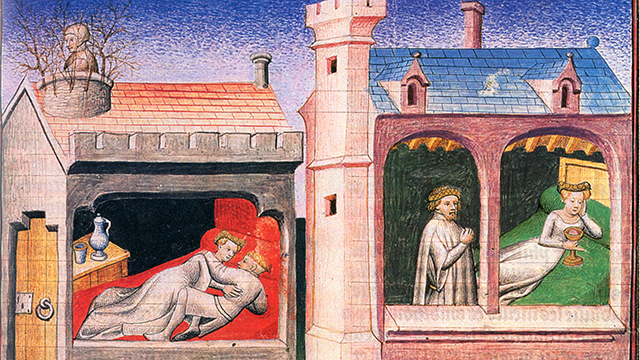
Miniatura francese per la novella di Tancredi e Ghismonda
TANCREDI PRENZE DI SALERNO UCCIDE L’AMANTE DELLA FIGLIUOLA E MANDALE IL CUORE IN UNA COPPA D’ORO; LA QUALE, MESSA SOPR’ESSO ACQUA AVVELENATA, QUELLA SI BEE, E COSI’ MUORE.
(IV,1)
Tancredi principe di Salerno fu signore assai umano e di benigno ingegno; se egli nello amoroso sangue nella sua vecchiezza non s’avesse le mani bruttate; il quale in tutto lo spazio della sua vita non ebbe che una figliuola, e più felice sarebbe stato se quella avuta non avesse.
Costei fu dal padre tanto teneramente amata, quanto alcuna altra figliuola da padre fosse giammai; e per questo tenero amore, avendo ella di molti anni avanzata l’età del dovere avere avuto marito, non sappiendola da sé partire, non la maritava; poi alla fine ad un figliuolo del duca di Capova datala, poco tempo dimorata con lui, rimase vedova e al padre tornossi. Era costei bellissima del corpo e del viso quanto alcun’altra femina fosse mai, e giovane e gagliarda e savia più che a donna per avventura non si richiedea. E dimorando col tenero padre, sì come gran donna, in molte dilicatezze, e veggendo che il padre, per l’amor che egli le portava, poca cura si dava di più maritarla, né a lei onesta cosa pareva il richiedernelo, si pensò di volere avere, se esser potesse, occultamente un valoroso amante.
E veggendo molti uomini nella corte del padre usare, gentili e altri, sì come noi veggiamo nelle corti, e considerate le maniere e i costumi di molti, tra gli altri un giovane valletto del padre, il cui nome era Guiscardo, uom di nazione assai umile ma per virtù e per costumi nobile, più che altro le piacque, e di lui tacitamente, spesso vedendolo, fieramente s’accese, ogn’ora più lodando i modi suoi. E il giovane, il quale ancora non era poco avveduto, essendosi di lei accorto, l’aveva per sì fatta maniera nel cuore ricevuta, che da ogni altra cosa quasi che da amar lei aveva la mente rimossa. In cotal guisa adunque amando l’un l’altro segretamente, niuna altra cosa tanto disiderando la giovane quanto di ritrovarsi con lui, né volendosi di questo amore in alcuna persona fidare, a dovergli significare il modo seco pensò una nuova malizia. Essa scrisse una lettera, e in quella ciò che a fare il dì seguente avesse per esser con lei gli mostrò; e poi quella messa in un bucciuol di canna, sollazzando la diede a Guiscardo, dicendo: – Fara’ ne questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella raccenda il fuoco.
Guiscardo il prese, e avvisando costei non senza cagione dovergliele aver donato e così detto, partitosi, con esso se ne tornò alla sua casa, e guardando la canna e quella veggendo fessa, l’aperse, e dentro trovata la lettera di lei e lettala, e ben compreso ciò che a fare avea, il più contento uom fu che fosse giammai, e diedesi a dare opera di dovere a lei andare, secondo il modo da lei dimostratogli.
Era allato al palagio del prenze una grotta cavata nel monte, di lunghissimi tempi davanti fatta, nella qual grotta dava alquanto lume uno spiraglio fatto per forza nel monte, il quale, per ciò che abbandonata era la grotta, quasi da pruni e da erbe di sopra natevi era riturato; e in questa grotta per una segreta scala, la quale era in una delle camere terrene del palagio, la quale la donna teneva, si poteva andare, come che da un fortissimo uscio serrata fosse. Ed era sì fuori delle menti di tutti questa scala, per ciò che di grandissimi tempi davanti usata non s’era, che quasi niuno che ella vi fosse si ricordava; ma Amore, agli occhi del quale niuna cosa è sì segreta che non pervenga, l’aveva nella memoria tornata alla innamorata donna. La quale, acciò che niuno di ciò accorger si potesse, molti dì con suoi ingegni penato avea, anzi che venir fatto le potesse d’aprir quell’uscio; il quale aperto, e sola nella grotta discesa e lo spiraglio veduto, per quello aveva a Guiscardo mandato a dire che di venire s’ingegnasse, avendogli disegnata l’altezza che da quello infino in terra esser poteva. Alla qual cosa fornire Guiscardo, prestamente ordinata una fune con certi nodi e cappi da potere scendere e salire per essa, e sè vestito d’un cuoio che da’ pruni il difendesse, senza farne alcuna cosa sentire ad alcuno, la seguente notte allo spiraglio n’andò, e accomandato ben l’uno de’ capi della fune ad un forte bronco che nella bocca dello spiraglio era nato, per quello si collò nella grotta ed attese la donna.
 Kasia Smutniak e Michele Riondino (Guiscardo e Ghismunda) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)
Kasia Smutniak e Michele Riondino (Guiscardo e Ghismunda) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)
La quale il seguente dì, faccendo sembianti di voler dormire, mandate via le sue damigelle e sola serratasi nella camera, aperto l’uscio, nella grotta discese, dove trovato Guiscardo, insieme maravigliosa festa si fecero; e nella sua camera insieme venutine, con grandissimo piacere gran parte di quel giorno si dimorarono; e, dato discreto ordine alli loro amori acciò che segreti fossero, tornatosi nella grotta Guiscardo ed ella serrato l’uscio, alle sue damigelle se ne venne fuori. Guiscardo poi, la notte vegnente su per la sua fune salendo, per lo spiraglio donde era entrato se n’uscì fuori e tornossi a casa. E avendo questo cammino appreso, più volte poi in processo di tempo vi ritornò.
Ma la fortuna, invidiosa di così lungo e di così gran diletto, con doloroso avvenimento la letizia dei due amanti rivolse in tristo pianto. Era usato Tancredi di venirsene alcuna volta tutto solo nella camera della figliuola, e quivi con lei dimorarsi e ragionare alquanto, e poi partirsi. Il quale un giorno dietro mangiare laggiù venutone essendo la donna, la quale Ghismonda aveva nome, in un suo giardino con tutte le sue damigelle, in quella, senza essere stato da alcuno veduto o sentito, entratosene, non volendo lei torre dal suo diletto, trovando le finestre della camera chiuse e le cortine del letto abbattute, a piè di quello in un canto sopra un carello si pose a sedere; e appoggiato il capo al letto e tirata sopra sè la cortina quasi come se studiosamente si fosse nascoso quivi, s’addormentò.
E così dormendo egli, Ghismonda, che per isventura quel dì fatto aveva venir Guiscardo, lasciate le sue damigelle nel giardino, pianamente se n’entrò nella camera, e quella serrata, senza accorgersi che alcuna persona vi fosse, aperto l’uscio a Guiscardo che l’attendeva e andatisene in su ‘l letto, sì come usati erano, e insieme scherzando e sollazzandosi, avvenne che Tancredi si svegliò e sentì e vide ciò che Guiscardo e la figliuola facevano; e dolente di ciò oltre modo, prima gli volle sgridare, poi prese partito di tacersi e di starsi nascoso, se egli potesse, per potere più cautamente fare e con minore sua vergogna quello che già gli era caduto nell’animo di dover fare. I due amanti stettero per lungo spazio insieme, sì come usati erano, senza accorgersi di Tancredi; e quando tempo lor parve, discesi del letto, Guiscardo se ne tornò nella grotta ed ella s’uscì della camera. Della quale Tancredi, ancora che vecchio fosse, da una finestra di quella si calò nel giardino, e senza essere da alcuno veduto, dolente a morte, alla sua camera si tornò.
E per ordine da lui dato, all’uscir dello spiraglio la seguente notte in su ‘l primo sonno, Guiscardo, così come era nel vestimento del cuoio impacciato, fu preso da due, e segretamente a Tancredi menato. Il quale, come il vide, quasi piagnendo disse: «Guiscardo, la mia benignità verso te non avea meritato l’oltraggio e la vergogna la quale nelle mie cose fatta m’hai, sì come io oggi vidi con gli occhi miei».
Al quale Guiscardo niuna altra cosa disse se non questo: «Amor può troppo più che né voi né io possiamo».
Comandò adunque Tancredi che egli chetamente in alcuna camera di là entro guardato fosse, e così fu fatto. Venuto il dì seguente, non sappiendo Ghismonda nulla di queste cose, avendo seco Tancredi varie e diverse novità pensate, appresso mangiare, secondo la sua usanza, nella camera n’andò della figliuola, dove fattalasi chiamare e serratosi dentro con lei, piagnendo le cominciò a dire: «Ghismonda, parendomi conoscere la tua virtù e la tua onestà, mai non mi sarebbe potuto cader nell’animo, quantunque mi fosse stato detto, se io co’ miei occhi non lo avessi veduto, che tu di sottoporti ad alcuno uomo, se tuo marito stato non fosse, avessi, non che fatto, ma pur pensato; di che io in questo poco di rimanente di vita che la mia vecchiezza mi serba sempre sarò dolente, di ciò ricordandomi. E or volesse Iddio che, poi che a tanta disonestà conducere ti dovevi avessi preso uomo che alla tua nobiltà decevole fosse stato; ma tra tanti che nella mia corte n’usano, eleggesti Guiscardo, giovane di vilissima condizione, nella nostra corte quasi come per Dio da picciol fanciullo infino a questo dì allevato; di che tu in grandissimo affanno d’animo messo m’hai, non sappiendo io che partito di te mi pigliare. Di Guiscardo, il quale io feci stanotte prendere quando dello spiraglio usciva, e hollo in prigione, ho io già meco preso partito che farne; ma di te, sallo Iddio che io non so che farmi. Dall’una parte mi trae l’amore, il quale io t’ho sempre più portato che alcun padre portasse a figliuola, e d’altra mi trae giustissimo sdegno, preso per la tua gran follia; quegli vuole che io ti perdoni, e questi vuole che contro a mia natura in te incrudelisca; ma prima che io partito prenda, disidero d’udire quello che tu a questo dei dire». E questo detto bassò il viso, piagnendo sì forte come farebbe un fanciul ben battuto.

Kasia Smutniak e Lello Arena (Tancredi e Ghismunda) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)
Ghismonda, udendo il padre e conoscendo non solamente il suo segreto amore esser discoperto, ma ancora esser preso Guiscardo, dolore inestimabile sentì, e a mostrarlo con romore e con lagrime, come il più le femine fanno, fu assai volte vicina; ma pur, questa viltà vincendo il suo animo altiero, il viso suo con maravigliosa forza fermò, e seco, avanti che a dovere alcun priego per sè porgere, di più non stare in vita dispose, avvisando già esser morto il suo Guiscardo. Per che, non come dolente femina o ripresa del suo fallo, ma come non curante e valorosa, con asciutto viso e aperto e da niuna parte turbato, così al padre disse: «Tancredi, né a negare né a pregare son disposta, per ciò che né l’un mi varrebbe né l’altro voglio che mi vaglia; e oltre a ciò in niuno atto intendo di rendermi benivola la tua mansuetudine e ‘l tuo amore; ma, il ver confessando, prima con vere ragioni difender la fama mia e poi con fatti fortissimamente seguire la grandezza dello animo mio. Egli è il vero che io ho amato e amo Guiscardo, e quanto io viverò, che sarà poco, l’amerò; e se appresso la morte s’ama, non mi rimarrò d’amarlo; ma a questo non mi indusse tanto la mia feminile fragilità, quanto la tua poca sollecitudine del maritarmi e la virtù di lui. Esser ti dovea, Tancredi, manifesto, essendo tu di carne, aver generata figliuola di carne e non di pietra o di ferro; e ricordarti dovevi e dei, quantunque tu ora sia vecchio, chenti e quali e con che forza vengano le leggi della giovanezza; e, come che tu uomo in parte ne’ tuoi migliori anni nell’armi esercitato ti sii, non dovevi di meno conoscere quello che gli ozi e le dilicatezze possano ne’ vecchi non che ne’ giovani. Sono adunque, sì come da te generata, di carne, e sì poco vivuta, che ancor son giovane; e per l’una cosa e per l’altra piena di concupiscibile disidero, al quale maravigliosissime forze hanno date l’aver già, per essere stata maritata, conosciuto qual piacer sia a così fatto disidero dar compimento. Alle quali forze non potendo io resistere, a seguir quello a che elle mi tiravano, sì come giovane e femina, mi disposi e innamora’mi. E certo in questo opposi ogni mia virtù di non volere né a te né a me di quello a che natural peccato mi tirava, in quanto per me si potesse operare, vergogna fare. Alla qual cosa e pietoso Amore e benigna Fortuna assai occulta via m’avean trovata e mostrata, per la quale, senza sentirlo alcuno, io a’ miei disideri perveniva; e questo, chi che ti se l’abbi mostrato o come che tu il sappi, io nol nego. Guiscardo non per accidente tolsi, come molte fanno, ma con diliberato consiglio elessi innanzi ad ogn’altro, e con avveduto pensiero a me lo ‘ntrodussi, e con savia perseveranza di me e di lui lungamente goduta sono del mio disio. Di che egli pare, oltre allo amorosamente aver peccato, che tu, più la volgare oppinione che la verità seguitando, con più amaritudine mi riprenda, dicendo (quasi turbato esser non ti dovessi, se io nobile uomo avessi a questo eletto) che io con uom di bassa condizione mi son posta. In che non ti accorgi che non il mio peccato ma quello della Fortuna riprendi, la quale assai sovente li non degni ad alto leva, a basso lasciando i dignissimi. Ma lasciamo or questo, e riguarda alquanto a’ principii delle cose: tu vedrai noi d’una massa di carne tutti la carne avere, e da uno medesimo creatore tutte l’anime con iguali forze, con iguali potenzie, con iguali virtù create. La virtù primieramente noi, che tutti nascemmo e nasciamo iguali, ne distinse; e quegli che di lei maggior parte avevano e adoperavano nobili furon detti, e il rimanente rimase non nobile. E benché contraria usanza poi abbia questa legge nascosa, ella non è ancor tolta via né guasta dalla natura né da’ buon costumi; e per ciò colui che virtuosamente adopera apertamente si mostra gentile, e chi altramenti il chiama, non colui che è chiamato ma colui che chiama, commette difetto. Raguarda tra tutti i tuoi nobili uomini ed esamina la lor virtù, i lor costumi e le loro maniere, e d’altra parte quelle di Guiscardo raguarda: se tu vorrai senza animosità giudicare, tu dirai lui nobilissimo e questi tuoi nobili tutti esser villani. Delle virtù e del valore di Guiscardo io non credetti al giudicio d’alcuna altra persona che a quello delle tue parole e de’ miei occhi. Chi il commendò mai tanto, quanto tu ‘l commendavi in tutte quelle cose laudevoli che valoroso uomo dee essere commendato? E certo non a torto; ché se i miei occhi non m’ingannarono, niuna laude da te data gli fu, che io lui operarla, e più mirabilmente che le tue parole non potevano esprimere, non vedessi; e se pure in ciò alcuno inganno ricevuto avessi, da te sarei stata ingannata. Dirai dunque che io con uomo di bassa condizione mi sia posta? Tu non dirai il vero; ma per avventura, se tu dicessi con povero, con tua vergogna si potrebbe concedere, che così hai saputo un valente uomo tuo servidore mettere in buono stato; ma la povertà non toglie gentilezza ad alcuno, ma sì avere. Molti re, molti gran principi furon già poveri; e molti di quegli che la terra zappano e guardan le pecore già ricchissimi furono e sonne. L’ultimo dubbio che tu movevi, cioè che di me far ti dovessi, caccial del tutto via. Se tu nella tua estrema vecchiezza a far quello che giovane non usasti, cioè ad incrudelir, se’ disposto, usa in me la tua crudeltà, la quale ad alcun priego porgerti disposta non sono, sì come in prima cagion di questo peccato, se peccato è; per ciò che io t’accerto che quello che di Guiscardo fatto avrai o farai, se di me non fai il simigliante, le mie mani medesime il faranno. Or via, va con le femine a spander le tue lagrime, e incrudelendo con un medesimo colpo altrui e me, se così ti par che meritato abbiamo, uccidi».
Conobbe il prenze la grandezza dell’animo della sua figliuola; ma non credette per ciò in tutto lei sì fortemente disposta a quello che le parole sue sonavano, come diceva. Per che, da lei partitosi e da sè rimosso di volere in alcuna cosa nella persona di lei incrudelire, pensò con gli altrui danni raffreddare il suo fervente amore, e comandò a’ due che Guiscardo guardavano che senza alcun romore lui la seguente notte strangolassono, e, trattogli il cuore, a lui il recassero; li quali, così come loro era stato comandato, così operarono. Laonde, venuto il dì seguente, fattasi il prenze venire una grande e bella coppa d’oro e messo in quella il cuor di Guiscardo, per un suo segretissimo famigliare il mandò alla figliuola e imposegli che, quando gliele desse, dicesse: «Il tuo padre ti manda questo, per consolarti di quella cosa che tu più ami, come tu hai lui consolato di ciò che egli più amava».
Ghismonda, non smossa dal suo fiero proponimento, fattesi venire erbe e radici velenose, poi che partito fu il padre, quelle stillò e in acqua ridusse, per presta averla se quello di che elle temeva avvenisse. Alla quale venuto il famigliare e col presente e con le parole del prenze, con forte viso la coppa prese, e quella scoperchiata, come il cuor vide e le parole intese, così ebbe per certissimo quello essere il cuor di Guiscardo.
Per che, levato il viso verso il famigliare, disse: «Non si conveniva sepoltura men degna che d’oro a così fatto cuore chente questo è; discretamente in ciò ha il mio padre adoperato».
E così detto, appressatoselo alla bocca, il baciò, e poi disse: «In ogni cosa sempre e infino a questo estremo della vita mia ho verso me trovato tenerissimo del mio padre l’amore, ma ora più che giammai; e per ciò l’ultime grazie, le quali render gli debbo giammai, di così gran presente da mia parte gli renderai».
Questo detto, rivolta sopra la coppa la quale stretta teneva, il cuor riguardando disse: «Ahi! dolcissimo albergo di tutti i miei piaceri, mala detta sia la crudeltà di colui che con gli occhi della fronte or mi ti fa vedere! Assai m’era con quegli della mente riguardarti a ciascuna ora. Tu hai il tuo corso fornito, e di tale chente la fortuna tel concedette ti se’ spacciato; venuto se’ alla fine alla qual ciascun corre; lasciate hai le miserie del mondo e le fatiche, e dal tuo nemico medesimo quella sepoltura hai che il tuo valore ha meritata. Niuna cosa ti mancava ad aver compiute esequie, se non le lagrime di colei la qual tu vivendo cotanto amasti; le quali acciò che tu l’avessi, pose Iddio nel l’animo al mio dispietato padre che a me ti mandasse, e io le ti darò, come che di morire con gli occhi asciutti e con viso da niuna cosa spaventato proposto avessi; e dateleti, senza alcuno indugio farò che la mia anima si congiugnerà con quella, adoperandol tu, che tu già cotanto cara guardasti. E con qual compagnia ne potre’ io andar più contenta o meglio si cura ai luoghi non conosciuti che con lei? Io son certa che ella è ancora quincentro e riguarda i luoghi de’ suoi diletti e de’ miei; e come colei che ancor son certa che m’ama, aspetta la mia, dalla quale sommamente è amata».
E così detto, non altramenti che se una fonte d’acqua nella testa avuta avesse, senza fare alcun feminil romore, sopra la coppa chinatasi, piagnendo cominciò a versare tante lagrime, che mirabile cosa furono a riguardare, baciando infinite volte il morto cuore. Le sue damigelle, che dattorno le stavano, che cuore questo si fosse o che volesson dire le parole di lei non intendevano; ma da compassion vinte tutte piagnevano e lei pietosamente della cagion del suo pianto domandavano invano, e molto più, come meglio sapevano e potevano, s’ingegnavano di confortarla.

Lavennia Illustratrice canadese: Ghismunda mette la pozione avvelenata nella coppa (2017)
La qual, poi che quanto le parve ebbe pianto, alzato il capo e rasciuttosi gli occhi, disse: «O molto amato cuore, ogni mio uficio verso te è fornito; né più altro mi resta a fare se non di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia». E questo detto, si fe’ dare l’orcioletto nel quale era l’acqua che il dì avanti aveva fatta, la qual mise nella coppa ove il cuore era da molte delle sue lagrime lavato, e senza alcuna paura postavi la bocca, tutta la bevve, e bevutala, con la coppa in mano se ne salì sopra il suo letto, e quanto più onestamente seppe compose il corpo suo sopra quello, e al suo cuore accostò quello del morto amante, e senza dire alcuna cosa aspettava la morte.
 Lavennia Illustratrice canadese: Ghismunda sdraiata col cuore di Guiscardo (2017)
Lavennia Illustratrice canadese: Ghismunda sdraiata col cuore di Guiscardo (2017)
Le damigelle sue, avendo queste cose e vedute e udite, come che esse non sapessero che acqua quella fosse la quale ella bevuta aveva, a Tancredi ogni cosa avean mandata a dire; il quale, temendo di quello che sopravvenne, presto nella camera scese della figliuola, nella qual giunse in quella ora che essa sopra il suo letto si pose; e tardi con dolci parole levatosi a suo conforto, veggendo i termini ne’quali era, cominciò dolorosamente a piagnere.
Al quale la donna disse: «Tancredi, serbati coteste lagrime a meno disiderata fortuna che questa, né a me le dare, che non le disidero. Chi vide mai alcuno, altro che te, piagnere di quello che egli ha voluto? Ma pure, se niente di quello amore che già mi portasti ancora in te vive, per ultimo dono mi concedi che, poi che a grado non ti fu che io tacitamente e di nascoso con Guiscardo vivessi, che ‘l mio corpo col suo, dove che tu te l’abbi fatto gittar morto, palese stea».
L’angoscia del pianto non lasciò rispondere al prenze. Laonde la giovane, al suo fine esser venuta sentendosi strignendosi al petto il morto cuore, disse: «Rimanete con Dio, ché io mi parto».
E velati gli occhi, e ogni senso perduto, di questa dolente vita si dipartì.
Così doloroso fine ebbe l’amor di Guiscardo e di Ghismonda, come udito avete; li quali Tancredi dopo molto pianto, e tardi pentuto della sua crudeltà, con general dolore di tutti i salernetani, onorevolmente amenduni in un medesimo sepolcro gli fe’ sepellire.
Tancredi, principe di Salerno, fu un signore pieno di umanità e di indole buona, se lui, in vecchiaia, non si fosse sporcate le mani col sangue di due amanti; egli nella sua vita non ebbe che una figliola e sarebbe stato più felice se non l’avesse avuta. Quest’ultima fu teneramente amata dal padre, quanto nessun altro padre mai e per questo tenero amore, avendo lei già da tempo passata l’età del matrimonio, ma non sapendone separarsi, non la sposava; infine la fece unire con il figlio del duca di Capua, ma fu per poco tempo moglie, perché rimase presto vedova e tornò dal padre.
Era d’aspetto e di viso bellissima più di ogni altra femmina, giovane, d’animo forte e saggia più di quanto normalmente non si richiedesse ad una donna. Vivendo con il padre in molte raffinatezze come una gran dama e vedendo che per l’amore ce le portava non aveva nessuna intenzione di rimaritarla, nè credendo cosa opportuna il chiederlo, pensò vi voler avere, laddove se ne fosse presentata l’opportunità, un amante di valore. Essendo circondata dalla presenza di molti uomini nella corte del padre, nobili e non nobili, così come è d’abitudine, e presi in considerazione i modi e le abitudini di ciascuno, tra tutti le piacque un giovane valletto del padre, di nome Guiscardo, uomo per nascita assai umile ma nobile per virtù e costumi nobile e, osservandolo spesso, silenziosamente s’innamorò intensamente di lui, apprezzando sempre di più il suo modo di fare. Il giovane, a cui non mancava l’intuito, essendosi accorto delle attenzioni di lei, si era a tal punto innamorato di lei che aveva allontanato dalla mente ogni pensiero, se non quello dell’amore per lei.
Così amandosi segretamente, non desiderando altro la giovane che di ritrovarsi insieme e non fidandosi di nessuno a cui svelare il suo sentimento e dovendogli comunicare il modo in cui incontrarsi, tra sé pensò un nuovo ed inusitato stratagemma. Scrisse na lettera e in essa gli descrisse cosa fare il giorno dopo per essere con lei; poi la mise in un pezzo di canna vuoto e scherzando lo diede a Guiscardo dicendogli: «Lo darai alla tua servitrice stasera con il quale alimenterà il fuoco».

Adrien Van der Werff: Tancredi offre la coppa a Ghismonda (1675)
Guiscardo lo prese e pensando che non senza ragione costei dovesse averglielo donato e aver parlato in quel modo, allontanatosi, con questo pezzo di canna tornò a casa sua. Guardandolo con attenzione vide che era forato, l’aprì e vi trovò dentro la lettera e avendo capito ciò che dovesse fare, si riempì di felicità e cominciò a pensare affinché potesse raggiungere lei secondo il modo che la stessa gli aveva indicato.
Il palazzo del principe di fianco aveva una grotta, scavata nel monte, prodottasi molto tempo prima, che riceveva un po’ di luce da uno spiraglio fatto artificialmente che, poiché era stata abbandonata da anni, era ricoperto da cespugli spinosi ed erba nata spontaneamente; questa grotta era raggiungibile da una scalinata segreta che partiva da una delle camere terrene abitate dalla donna, sebbene fosse separata da una porta pesantissima. E tutti si erano dimenticati di questa scala, non essendo stata più utilizzata al punto che quasi nessuno si ricordava che essa esistesse, ma l’Amore al quale nessun segreto può rimanere nascosto che lui non scopra, aveva permesso che fosse tornata in mente alla donna innamorata. Lei, per fare in modo che nessuno la scoprisse aveva penato molti giorni prima con i suoi arnesi per poter aprire quella porta. Una volta aperta e scesa sola nella grotta, riscoprendo lo spiraglio, attraverso quello aveva detto per lettera a Guiscardo che trovasse il modo di raggiungerla, avendogli indicata l’altezza da quello sino a terra. Quindi per portare a termine l’impresa Guiscardo si procurò una fune con nodi e appigli con cui salire e scendere ed un vestito di cuoio per difendersi dai rovi. Senza farsene accorgere la sera seguente raggiunse la grotta e dopo aver legato la fune ad un forte sterpo, nato alla bocca dello spiraglio, per quello scese nella grotta e aspettò la donna.Lo stesso giorno seguente, lei facendo finta di volere dormire, licenziò le sue ancelle e chiusasi in camera, aprì la porta e scese nella grotta dove trovò Guiscardo mostrando entrambi grande felicità, poi raggiunsero la camera vi rimasero gran parte del giorno tra i piaceri e, data una precisa regola ai loro incontri d’amore, affinché rimanessero segreti, dopo averlo licenziato, Guiscardo tornò nella grotta e lei, chiusa la porta, raggiunse le sue ancelle. Al calar della notte Guiscardo salendo attraverso la fune passò nello spiraglio da cui era entrato e così tornò a casa. Avendo imparato il percorso più volte in seguito vi tornò.
Ma il destino, invidioso di un così lungo e grande piacere, con un doloroso incidente trasformò la felicità dei due amanti in pianto.
Tancredi aveva l’abitudine di andare solo nella camera della figlia e qui rimanere con lei, parlare per un po’ di tempo e poi andarsene. Un giorno, dopo pranzo, andò dalla figlia ma lei, il cui nome era Ghismonda, stava insieme con le sua damigelle in un giardino. Per non disturbare non si fece vedere né sentire; entrò nella camera e trovò le finestre chiuse e le cortine del letto abbassate; quindi si mise su una cassapanca ai piedi del letto, poggiò la testa sul letto e copertosi con la cortina, quasi si fosse nascosto apposta, s’addormentò. Per sfortuna quel giorno Ghismonda, dopo aver lasciato le sue damigelle in giardino, fece venire Guiscardo che tranquillamente entrò nella stanza e quella chiusa, senza accorgersi che dentro vi fosse qualcuno, lo fece entrare e, come succedeva da tempo, andarono a letto e insieme si divertirono e presero piacere l’un l’altra; accadde però che Tancredi si svegli, sentì e vide ciò che Guiscardo faceva con la figlia. Addolorato, prima volle loro sgridare, poi decise di star zitto e rimanere nascosto per poter con più calma e con meno vergogna quello che già aveva deciso di fare. I due amanti stettero insieme per un bel po’, com’erano abituati, senza accorgersi di Tancredi e quando decisero di alzarsi dal letto, Guiscardo tornò nella grotta e lei uscì dalla camera. Tancredi. sebbene fosse vecchio, uscì calandosi nel giardino dalla finestra e estremamente turbato, tornò in camera sua.
Guiscardo, essendo impacciato dall’abito di cuoio, nelle prime ore della notte all’uscir dallo spiraglio, per ordine di Tancredi fu catturato da due guardie e, nascostamente, fu portato di fronte al principe che, appena lo vide, quasi piangendo disse: «Guiscardo, la generosità che ti ho mostrata non merita l’offesa e la vergogna che hai arrecato nelle faccende della mia famiglia, così come oggi ho potuto constatare»
Guiscardo, non disse niente se non: «L’amore può molto di più di quanto lei ed io possiamo»
Comandò quindi il principe che lui segretamente fosse condotto in una camera tenuto in prigionia e così accadde.
Il giorno dopo, non sapendo Ghismonda nulla di quanto fosse successo, Tancredi pensò diverse e inusitate mostruosità e si avviò, come era ormai solito, nella camera della figlia: fattala chiamare e chiusosi con lei, tra le lacrime cominciò a dirle: «Ghismonda, mi era sembrato di conoscere la tua virtù e onestà e mai mi sarebbe venuto in mente, anche se mi fosse stato detto, se non l’avessi visto con i miei occhi, che tu di concederti ad altro uomo che non fosse tuo marito, non solo non lo avresti fatto, ma neppure pensato, fatto del quale, per quanto poco mi rimanga da vivere, sempre ricordandolo mi dorrò. Abbia perlomeno voluto il cielo che poi, dovendoti condurre a tanta disonestà, avessi scelto un uomo conveniente al tuo essere nobile, ma fra tanti che frequentano la mia casa hai scelto Guiscardo, di umilissima condizione, cresciuto per carità nella nostra corte sin da bambino; per questo mi hai messo in grande difficoltà non sapendo che decisione prendere nei tuoi confronti. Ho già deciso di cosa fare di Guiscardo, che ho ordinato di prelevare quando è uscito dallo spiraglio e che adesso tengo in prigione, ma di te lo sa Dio che cosa ho deciso di fare. Da una parte mi tira l’amore che ti ho sempre portato, più di ogni altro padre verso la figlia, dall’altra mi tira un giustificabilissimo sdegno derivato da questa tua follia: la prima vorrebbe che io ti perdoni , l’altra che io contro la mia natura infierisca contro di te: ma prima di decidere, vorrei sentire quello che tu a questo proposito vuoi dirmi». Detto questo abbassò il viso e cominciò a piangere come un bambino picchiato ben bene.
Ghismonda dopo aver sentito il padre e aver saputo che il suo segreto amore era stato scoperto, ma ancor più che Guiscardo era stato tratto in prigione, sentì un fortissimo dolore e fu molto vicina a mostrarlo con grida e pianti, così come capita spesso alle donne, ma il suo forte animo questa volta vinse questa debolezza e con forza straordinaria compose con fermezza il viso e prima di dover rivolgere qualche supplica per sé, decise fra sé di togliersi la vita, ritenendo che il suo Guiscardo fosse già morto.
Per cui, non come femmina addolorata o rimproverata per un suo errore, ma come incurante e coraggiosa, con viso asciutto e franco e per niente turbato, così disse al padre: «Tancredi, non sono disposta né a negare né a pregare, perché né la proma varrebbe qualcosa, né la seconda voglio che mi valga; e oltre a ciò non intendo rendere la tua mansuetudine e il tuo amore favoreli per me; ma, dicendoti la verità, per prima cosa intendo difendere il mio onore e con i comportamenti mantendermi del tutto coerente con la mia grandezza d’animo. E’ vero che ho amato e amo ancora Guiscardo e per quanto vivrò l’amerò, e se dopo la morte si continua ad amare, non smetterò d’amarlo; ma a questo amore non mi ha spinto la mia femminile fragilità, quanto la tua poca sollecitudine di darmi in moglie e la virtù dell’uomo. Tancredi, avresti dovuto sapere, essendo fatto di carne, di aver messo al mondo una figlia di carne, non di pietra o di ferro; avresti dovuto e devi inoltre ricordare, sebbene abbia raggiunto la vecchiaia, quante e di che tipo e con che forza vengono gli istinti derivanti dalla giovinezza e sebbene tu abbia passato i migliori anni della tua vita nell’esercizio delle armi, nondimeno non dovevi disconoscere ciò che l’ozio e il vivere nella raffinatezza possono sia nei vecchi che nei giovani. Sono dunque da te nata così di carne che ancora di giovane età, e per ambedue queste condizioni pienamente vogliosa di appagamento carnale a cui ha dato una forza straordinaria il fatto che io ho conosciuto quale piacere si provi nel consumarlo, siccome già sono stata sposata. Non potendo resistere a ciò, dal momento che le forze della natura mi spingevano, come giovane e femmina, decisi di innamorarmi. Sicuramente misi in atto ogni mia virtù, per quanto potessi fare, nel non voler a te né a me procurare vergogna a cui quel naturale peccato mi conduceva. A ciò l’Amore e la buona fortuna mi avevano mostrato una via segreta, attraverso cui, senza che nessuno lo venisse a sapere, riuscivo a realizzare i miei piaceri: e questo, chiunque te l’abbia mostrato o come tu sia venuto a saperlo, non lo nego. Guiscardo non lo scelsi per caso, come fanno molte altre, ma lo elessi con deliberata volontà e con saggia costanza mia e sua ho goduto a lungo del mio desiderio. E sembra che, riguardo a questo fatto, tu, seguendo le dicerie altrui piuttosto che la verità, mi rimproveri più aspramente, non solo il peccato d’amore; ma dici che mi sono andata a mettere con un uomo di bassa condizione, quasi che fosse stato per te possibile non sdegnarti se io avessi scelto per dar sfogo al mio desiderio un uomo nobile e in questo non ti rendi conto di riprendere non il mio peccato ma la stessa fortuna che spesso mette in alto gli indegni lasciando in basso i degnissimi. Ma lasciamo perdere ora questo e andiamo alla essenza delle cose: vedrai che tutti siamo nati da un corpo e un corpo abbiamo tutti e da un unico Creatore creati con uguali forze, capacità e virtù. Dapprima distinse noi, uguali per nascita, la virtù e quelli che la possedevano e la mettevano in atto furono definiti nobili, tutti gli altri non nobili. E benché abitudini di vita contrarie a questa legge l’abbiano spesso offuscata, non è stata ancora cancellata, né rovinata dalla natura né dal buon costume; per questo colui che opera in modo virtuoso, mostra apertamente di essere nobile e chi lo chiama in modo diverso è lui che sbaglia non colui che è chiamato. Considera tutti i tuoi nobili ed esamina la loro vita, i loro costumi, il modo in cui agiscono e, viceversa, considera quelli di Guiscardo. Se osserverai senza animosità diresti lui nobilissimo e i tuoi nobili tutti villani. Delle virtù e del valore di Guiscardo non mi sono riferita al giudizio di un’altra persona, ma alle tue parole e ai miei occhi. Chi mai lo elogiò tanto quanto tu lo lodavi in tutte quelle cose per cui un uomo valoroso dev’essere ricoperto di lodi? E certo non a torto, perché, se i miei occhi non m’ingannarono, nessuna lode gli fu da te attribuita che io non vedessi metterla in atto in modo migliore di quanto le tue parole potessero esprimere, e se mai mi fossi ingannata, l’inganno sarebbe partito da te. Dirai ora che io mi dia messa con un uomo di bassa condizione? Diresti una bugia: ma se per caso dicessi povero ti si potrebbe concedere con vergogna, perché così hai saputo ripagare un tuo valevole servitore; ma la povertà non toglie gentilezza d’animo, ma solo la ricchezza. Molti re e molti principi furono poverissimi e molti di coloro che zappano la terra e pascolano pecore furono e sono ricchissimi. L’ultimo dubbio che avevi, cioè cosa fare di me, scaccialo: se tu nell’avanzata vecchiaia sei disposto a fare ciò che in gioventù non hai osato fare, cioè a incrudelire, rivolgi contro me la tua crudeltà, che non sono disposta a pregarti in nessun modo, poichè sei la prima causa di questo peccato, se peccato è; perciò t’assicuro che quello che hai fatto o farai a Guiscardo, se non dovessi farlo anche me, saranno le mie mani a compierlo. Ora via, vattene con le femmine a piagnucolare e se credi che abbiamo meritato di morire, uccidici con uno stesso colpo».
Il principe riconobbe la grandezza d’animo della figlia ma non per questo credette che lei fosse così fermamente disposta a fare tutto ciò che affermava a parole; per cui allontanatosi da lei e scacciando da sé il proposito d’infierire in qualche modo contro di lei, pensò con il colpire Guiscardo di riuscire a farle passare il forte amore e ordinò ai due guardiani di Guiscardo che durante la notte in modo silenzioso lo strangolassero e strappatogli il cuore glielo portassero. Essi fecero ciò che venne loro comandato.
Il giorno seguente, il principre, fattosi recapitare una grande e bella coppa d’oro e messo al suo interno il cuore di Guiscardo, tramite un fidatissimo servo lo mandò alla figlia e gli ordinò quando lo consegnava di dirle: «Tuo padre ti manda questo per consolarti di ciò che tu più ami, come tu lo hai consolato di ciò che lui amava di più».
Ghismonda, non allontanatasi del suo proponimento, si fece venire erbe e radici velenose, poi, andato via il padre, le distillò e le sciolse in acqua, per averla pronta se avvenisse quello che lei temeva. Giunto a lei il familiare con la coppa e le parole del padre, con coraggio la prese e dopo averla scoperchiata e aver sentito le parole del padre, fu assolutamente certa che quello era il cuore di Guiscardo; per cui rivolta verso il familiare, disse: «Non sarebbe stato conveniente una sepoltura meno degna di questa d’oro per un cuore come questo: almeno in questo mio padre ha operato in modo saggio»
E detto questo, avvicinando il cuore alla bocca lo baciò e poi disse: «Ho sempre trovato fino alla fine della mia vita l’amore di mio padre nei miei confronti tenerissimo, ma ora più che mai e per questo da parte mia gli renderai le ultime grazie che gli devo per un così grande regalo».
Detto questo, rivolta verso la coppa che stringeva a sé, guardando il cuore disse: «Ahi! docissimo rifugio di tutti i miei piaceri; maledetta sia la crudeltà di Tancredi che ora mi fa veder con gli occhi come sei! Quanto valeva di più viverti nel ricordo. Tu hai portato a compimento la vita e ti sei liberato di quel tale corso che la fortuna ti aveva concesso: sei arrivato dove corrono tutti (la morte) e hai abbandonato le miserie e le fatiche del mondo e hai ottenuto dal tuo nemico quella sepoltura che la tua virtù meritava. Non ti mancava niente per avere le esequie complete, se non le lacrime di quella che durante la vita hai amato tanto; e affinché tu le avessi, Dio pose nell’animo del padre crudele di mandarti a me e io te le darò, sebbene avessi deciso di morire con occhi asciutti e viso sereno; e te le darò e farò in modo, con il tuo aiuto, di congiungere la tua anima con la mia, che tu hai custodito tanto caramente. E con quale compagnia potrei andare più felice e sicura nell’aldilà che con lei (la tua anima)? Sono sicura che essa è ancora qui e osserva i luoghi del nostro piacere e, dal momento che mi ama ancora, ne sono certa, sta aspettando la mia, da cui è amata moltissimo».E detto questo senza emettere alcun gemito, come se avesse una fonte d’acqua negli occhi, chinatasi sopra la coppa cominciò a piangere e a versare un mondo di lacrime, straordinario a vedersi, baciando innumerevoli volte il morto cuore. Le damigelle, che le stavano intorno, non sapevano di chi fosse il cuore e cosa volesse dire, ma vinte da compassione, piangevano tutte e le domandavano inutilmente il motivo del pianto e come meglio potevano e sapevano cercavano di confortarla.
Dopo aver pianto quanto voleva, alzato il viso e asciugati gli occhi, disse: «O cuore molto amato, ho compiuto ogni dovere nei tuoi confronti, non mi resta altro da fare se non di raggiungerti con la mia anima per far compagnia alla tua»
Detto questo si fece dare il piccolo recipiente pieno dell’acqua che aveva preparato, che mise nella coppa con dentro il cuore lavato dalle molte lacrime e senza alcun timore lo bevve e quindi, con la coppa in mano, salì nel letto e quanto più compostamente mise il suo corpo sopra quello e accostò il suo core a quello dell’amante: aspettava la morte senza dire nulla.
Le sue damigelle, avendo visto e ascoltato tutto, sebbene non sapessero che acqua fosse quella che aveva bevuto, avevavo mandato a chiamare Tancredi, che temendo di quello che potesse succedere era corso in camera della figlia, in cui giunse mentre lei si stava sdraiando e solo allora cercò di confortarla con dolci parole, ma vedendo le condizioni in cui si trovava, cominciò a piangere dolorosamente.
A lui la donna disse:«Tancredi, conserva queste lacrime per una sorte che hai desiderato meno di questa, non darle a me, che non le desidero. Chi vide mai qualcuno piangere per quello che ha voluto? Ma pure se qualcosa di quell’amore che mi hai portato ancora vive, per ultimo signore concedimi che, dal momento che non hai voluto che io in silenzio e di nascosto amassi Guiscardo, il mio corpo riposi visibile a tutti accanto al suo, dove tu lo hai fatto gettare».
L’angoscia del principe non gli permise di rispondere; in ultimo la giovane, sentendosi morire, stringendo al petto il morto cuore, disse: «Rimanete con dio, che io muoio». E chiusi gli occhi e perduto ogni sentimento partì da questa dolente vita.
Così ebbe una dolorosa fine la storia d’amore di Guiscardo e Ghismonda, come avete ascoltato, i quali Tancredi dopo aver pianto molto ed essersi pentito della sua crudeltà, con il dolore di tutti i salernitani, fece seppellire tutti e due in uno stesso sepolcro con tutti gli onori.

Bernardino Mei: Ghismonda con il cuore di Guiscardo (1659)
La novella sembra essere costruita al fine di farla convergere nello scontro ideologico tra padre e figlia; pare che l’inizio e la sua fine costituiscano una “cornice” nel quale inserire l’elemento tragico tra lo scontro tra i due protagonisti. Ad analizzarlo attentamente, infatti, vediamo che sebbene i protagonisti della storia d’amore siano Ghismonda e Guiscardo, quest’ultimo sia sacrificato a strumento per arrivare al momento chiarificatore dei rapporti tra Tancredi padre e Ghismonda figlia.
Probabilmente non ci bastano gli strumenti della realtà storica: affinché la tragedia abbia luogo occorrono alcuni elementi che potremmo definire “fiabeschi” ad iniziare da come tutto venga tenuto in segreto e nascosto, dalle prove a cui lui si deve sottoporre per raggiungerla e al suo “strano abbigliamento”, all’inspiegabile non accorgersi della presenza paterna in camera quando la sua testa era sopra il letto, dal uscire di Tancredi dalla finestra, perché? Perché tutto deve convergere allo scontro finale che vede il capovolgimento dei due antagonisti: il vecchio e saggio Tancredi comportarsi come un bambino piangente per i colpi ricevuti; la giovane e bella Ghismonda fiera e coraggiosa che rimprovera la fragilità nonché la mancanza di virtù paterna.
Il discorso di Ghismonda, d’altra parte, non costituisce una novità da un punto di vista contenutistico, a partire proprio dal concetto di amore/nobiltà (di ascendenza guinizzelliana); semmai risulta nuovo, ma non nelle novelle precedenti del Boccaccio stesso, la rivendicazione, in questo caso femminile, dell’amore sensuale, soprattutto in giovane età.
Ma l’accento può cambiare se proviamo a formulare, in modo se si vuole anche veloce, una lettura psicoanalitica: Tancredi è rimasto vedovo in giovane età e riversa tutto il suo amore verso la figlia. Tale amore, che da parte sua non può essere esplicitato, dev’essere tuttavia negato alla figlia, affinché lei possa rimanere sua e di nessun altro; in altre parole l’elaborazione del lutto da parte di Tancredi avviene maturando un rapporto d’amore incestuoso verso la figlia. Come può superare tale difficoltà psicologica? con l’annullamento degli amanti e quindi la rimozione della sua contraddittorietà.

Miniatura per la novella di Lisabetta da Messina
I FRATELLI DELL’ELISABETTA UCCIDON L’AMANTE DI LEI; EGLI L’APPARISCE IN SOGNO E MOSTRALE DOVE SIA SOTTERRATO. ELLA OCCULTAMENTE DISOTERRA LA TESTA E METTELA IN UN TESTO DI BASSILICO; E QUIVI SU PIAGNENDO OGNI DI’ PER UNA GRANDE ORA, I FRATELLI GLIELE TOLGONO, ED ELLA SE NE MUORE DI DOLOR POCO APPRESSO.
(IV,5)
Erano adunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il qual fu da San Gimignano, e avevano una lor sorella chiamata Lisabetta, giovane assai bella e costumata, la quale, che che se ne fosse cagione, ancora maritata non aveano. E avevano oltre a ciò questi tre fratelli in uno lor fondaco un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte l’Isabetta guatato, avvenne che egli le ‘ncominciò stranamente a piacere. Di che Lorenzo accortosi e una volta e altra, similmente, lasciati suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l’animo a lei; e sì andò la bisogna che, piacendo l’uno all’altro igualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più disiderava ciascuno.
E in questo continuando e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare che una notte, andando l’Isabetta là dove Lorenzo dormiva, che il maggior de’ fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse. Il quale, per ciò che savio giovane era, quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo intorno a questo fatto, infino alla mattina seguente trapassò. Poi, venuto il giorno, a’ suoi fratelli ciò che veduto avea la passata notte dell’Elisabetta e di Lorenzo raccontò, e con loro insieme, dopo lungo consiglio, diliberò di questa cosa, acciò che né a loro né alla sirocchia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente e d’infignersi del tutto d’averne alcuna cosa veduta o saputa infino a tanto che tempo venisse nel qua le essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi, si potessero torre dal viso.
E in tal disposizion dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano avvenne che, sembianti faccendo d’andare fuori della città a diletto tutti e tre, seco menarono Lorenzo; e pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto, veggendosi il destro, Lorenzo, che di ciò niuna guardia prendeva, uccisono e sotterrarono in guisa che niuna persona se ne accorse. E in Messina tornati dieder voce d’averlo per lor bisogne mandato in alcun luogo; il che leggiermente creduto fu, per ciò che spesse volte eran di mandarlo attorno usati. Non tornando Lorenzo, e Lisabetta molto spesso e sollicitamente i fratei domandandone, sì come colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che, domandandone ella molto instantemente, che l’uno de’ fratelli le disse: «Che vuol dir questo? Che hai tu a fare di Lorenzo, ché tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene».

Lisabetta nel Decameron di Pasolini (1971)
Per che la giovane dolente e trista, temendo e non sappiendo che, senza più domandarne si stava, e assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse, e alcuna volta con molte lagrime della sua lunga dimora si doleva e, senza punto rallegrarsi, sempre aspettando si stava.
Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava, ed essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l’apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato e con panni tutti stracciati e fracidi indosso, e parvele che egli dicesse: «O Lisabetta, tu non mi fai altro che chiamare e della mia lunga dimora t’attristi, e me con le tue lagrime fieramente accusi; e per ciò sappi che io non posso più ritornarci, per ciò che l’ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m’uccisono». E disegnatole il luogo dove sotterrato l’aveano, le disse che più nol chiamasse né l’aspettasse, e disparve.
La giovane destatasi, e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi la mattina levata, non avendo ardire di dire al cuna cosa a’ fratelli, propose di volere andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero che nel sonno l’era paruto. E avuta la licenza d’andare alquanto fuor della terra a diporto, in compagnia d’una che altra volta con loro era stata e tutti i suoi fatti sapeva, quanto più tosto potè là se n’andò; e tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove men dura le parve la terra quivi cavò; né ebbe guari cavato, che ella trovò il corpo del suo misero amante in niuna cosa ancora guasto né corrotto; per che manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piagnere, se avesse potuto volentieri tutto il corpo n’avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura; ma, veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il meglio che potè gli spiccò dallo ‘mbusto la testa, e quella in uno asciugatoio inviluppata e la terra sopra l’altro corpo gittata, messala in grembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si partì e tornossene a casa sua.
Quivi con questa testa nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, mille baci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e un bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il bassilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo, e poi messovi su la terra, su vi piantò parecchi piedi di bellissimo bassilico salernetano, e quegli di niuna altra acqua che o rosata o di fior d’aranci o delle sue lagrime non inaffiava giammai; e per usanza avea preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il suo disidero vagheggiare, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascoso; e poi che molto vagheggiato l’avea, sopr’esso andatasene, cominciava a piagnere, e per lungo spazio, tanto che tutto il bassilico bagnava, piagnea.
Il bassilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra procedente dalla testa corrotta che dentro v’era, divenne bellissimo e odorifero molto. E servando la giovane questa maniera del continuo, più volte da’suoi vicini fu veduta. Li quali, maravigliandosi i fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano della testa fuggiti, il disser loro: «Noi ci siamo accorti, che ella ogni dì tiene la cotal maniera».
Il che udendo i fratelli e accorgendosene, avendonela alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecer portar via questo testo. Il quale, non ritrovandolo ella, con grandissima instanzia molte volte richiese; e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lagrime, infermò, né altro che il testo suo nella infermità domandava. I giovani si maravigliavan forte di questo addimandare e per ciò vollero vedere che dentro vi fosse; e versata la terra, videro il drappo e in quello la testa non ancor sì consumata che essi alla capellatura crespa non conoscessero lei esser quella di Lorenzo. Di che essi si maravigliaron forte e temettero non questa cosa si risapesse; e sotterrata quella, senza altro dire, cautamente di Messina uscitisi e ordinato come di quindi si ritraessono, se n’andarono a Napoli. La giovane non restando di piagnere e pure il suo testo addimandando, piagnendo si morì; e così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi a certo tempo divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcuno che compuose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè:
Quale esso fu lo malo cristiano;
che mi furò la grasta, ecc.

Alberto Criscione: Lisabetta da Messina (2014)
A Messina vivevano tre giovani fratelli, tutti mercanti, che dopo la morte del padre, originario di San Gimignano, erano diventati ricchissimi; avevano anche una sorella, chiamata Elisabetta, assai bella ed educata, che, non si sa per quale motivo, non avevano ancora sposata. Avevano anche in una loro bottega un ragazzetto di Pisa di nome Lorenzo, che si occupava di tutti i loro affari, che essendo bello nella persona ed raffinato nei modi, avendolo più volte Lisabetta guardato infine accadde che cominciò a piacerle. Lorenzo, accortosi più di una volta di questo, lasciate da parte le altre donne, cominciò a pensare a lei; così andò la faccenda che piacendosi vicendevolmente, non passò molto tempo, che fecero insieme l’amore, dopo aver preso le dovute precauzioni.
Continuando e prendendo spesso piacere l’un l’altra, non seppero agire con discrezione tale che una notte, essendo andata nella camera di Lorenzo, il maggiore dei suoi fratelli non si accorgesse del fatto, senza che lei si rendesse conto d’essere stata scoperta. Quest’ultimo, essendo un uomo saggio, sebbene fosse per lui molto doloroso venire a sapere ciò, mosso da un cauto pensiero, senza dar modo che con atti o parole mostrasse di esserne accorto, pensando a lungo all’accaduto, attese fino alla mattina seguente. In seguito, quando ritenne opportuno, raccontò ciò che aveva visto fare tra Lisabetta e Lorenzo ai suoi fratelli, e insieme a loro, dopo lungo parlare, stabilì in merito a questa vicenda, affinché non ne derivasse alcuna infamia né a loro né alla sorella, di passarla sotto silenzio e di fingere di non aver visto o saputo nulla fono a che non si presentasse l’occasione in cui senza danno né fastidio per loro, potessero lavare questa vergogna, prima che progredisse troppo. Mantenendo questo patto, e parlando e ridendo con Lorenzo come erano soliti fare, successe che facendo finta di andare a divertirsi tutti e tre fuori città, con loro portarono Lorenzo e arrivati in un luogo solitario e lontano dalla città, vedendo che si offriva loro l’occasione favorevole, uccisero Lorenzo che in nessun modo si proteggeva da una simile evenienza e lo sotterrarono di modo che nessuno se ne potesse accorgere. Quando tornarono a Messina, sparsero la voce di averlo mandato in qualche luogo per fare loro un servizio, il che fu creduto facilmente perché spesso lo mandavano fuori città.
Non vedendo tornare Lorenzo, Elisabetta continuava a chiedere spiegazioni ai fratelli, pesandole molto la sua lunga assenza; un giorno chiedendo ad uno di essi con insistenza egli le disse: «Questo che vuol dire? ciò? Che te ne importa di Lorenzo? E come mai chiedi di lui cosi spesso? Se tu continuerai a chiedere di lui, noi ti daremo la risposta che cerchi». La giovane dolente e triste non sapendo più cosa fare o dire, non chiese più nulla ai fratelli ma la notte lo chiamava e pregava perché tornasse, e qualche volta piangendo intensamente per il sua lunga assenza si lamentava, senza mai rallegrarsi e lo aspettava.
Una notte accadde che, continuando lei a piangerlo molto perché non tornava ed essendosi, mentre lacrimava addormentata Lorenzo le apparve nel sonno, pallido e scarmigliato, con i vestiti fradici e stracciati e le parve che le dicesse: “O Lisabetta tu non fai altro che chiamarmi e allolorati per il mio ritardo e di questo mi accusi; ma sappi che non potrò più tornare perché lo stesso giorno che mi hai visto per l’ultima volta i tuoi fratelli mi uccisero», e indicatole il posto in cui era sotterrato le disse di non chiamarlo e di non aspettarlo più, poi sparì.
La giovane, svegliatasi e credendo nella visione, pianse amaramente; poi la mattina seguente, non avendo il coraggio di dire niente ai suoi fratelli, si ripropose di andare nel luogo mostratole (da Lorenzo) per vedere se ciò che gli era apparso nel sonno fosse vero. Avuto il permesso di uscire da Messina per svago, in compagnia di una donna che era stataa servizio di loro servizio in un momento passato, e che conosceva le tribolazioni di Lisabetta, quanto più velocemente vi andò. Tolse le foglie secche che c’erano sul luogo e dove la terra le sembrava più morbida scavò, e non scavando molto, trovò il corpo del suo misero amante non ancora corrotto e putrefatto, capì allora che la visione era giusta. Per questo era molto addolorata quanto ogni donna mai, ma sapeva che quello non era il tempo di piangere. Se avesse potuto volentieri avrebbe portato con sé tutto il corpo per dargli una sepoltura migliore, ma vedendo che ciò era impossibile, con un coltello gli tagliò la testa, la mise in un asciugatoio e la mise in braccio alla signora, poi ricoprì il corpo con la terra e quindi senza essere vista partì da quel luogo e tornò a casa.
Giunta a casa si rinchiuse in camera sua con la testa di Lorenzo e sopra essa pianse amaramente e a lungo, tanto da lavarla completamente con le lacrime, e la riempì di mille baci da ogni parte. Prese poi un grande e bel vaso di quelli che si usava per piantarci la maggiorana o il basilico e vi ripose la testa fasciata in un lenzuolo, la ricoprì poi di terra e vi piantò molti semi del bellissimo basilico salernitano che innaffiava solo con acqua di rose o di fiori d’arancio e con le sue lacrime. Aveva preso l’abitudine di sedersi vicino al vaso e di vegheggiare il suo desiderio accanto ad esso, dal momento che esso conteneva la testa del suo Lorenzo; quanto aveva finito piangeva a lungo e in questo modo bagnava il basilico.
Il basilico sia per le continue attenzioni che per la terra molto grassa, grazie al fatto di contenere la testa putrefatta, divenne bellissimo e molto profumato e dal momento che Lisabetta si comportava continuamente così, fu notata dai vicini che, meravigliandosi, parlarono ai fratelli del viso sfatto e degli occhi gonfi e dissero loro: «Noi ci siamo accorti che lei ogni giorno fa la stessa cosa». Sentito questo i fratelli e essendosene accorti, dopo averla rimproverata qualche volta, senza risultato, senza che lei se ne accorgesse le sottrassero il vaso; lei lo richiese con molta insistenza, ma non essendole reso, non smettendo di piangere, alla fine si ammalò e, durante la malattia, non faceva che domandare del suo vaso. I tre giovani si meravigliarono di queste continue domande e perciò vollero controllare cosa ci fosse nel vaso; lo svuotarono e trovato il lenzuolo lo aprirono e videro la testa non ancora consumata, ma la riconobbero come quella di Lorenzo a causa della capigliatura crespa.
Di ciò essi si meravigliarono tantissimo e temettero che questa cosa si risapesse in giro e sotterrata la testa, senza dire nulla, senza farsene accorgere andarono via da Messina, dopo aver trovato il modo di trasferire i loro affari lontani da lì e se andarono a Napoli.
La giovane non smettendo di piangere e continuamente domandando il suo vaso, morì tra le lacrime e così finì il suo sventurato amore: ma in seguito la faccenda fu conosciuta da molti e ci fu qualcuno che compose quella canzone che ancora oggi si canta:chi fu l’uomo malvagio / che mi rubò il vaso di fiori, ecc…
La novella a prima vista potrebbe avere un impianto simile a quella di Guiscardo e Ghismunda: un triangolo i cui vertici sono rappresentati nel primo caso dal padre e la figlia, nel secondo da tre fratelli (supplenti del padre e la sorella) e la sorella; per entrambi l’oggetto del desiderio è l’eros “naturale” che infrange le regole. nella novella precedente quella della nobiltà, in questa quella della mercatura.
 William Holman Hunt: Isabella e il vaso di basilico (1876)
William Holman Hunt: Isabella e il vaso di basilico (1876)
Vi sono altre due specularità:
- in ambedue vince la donna (pur morendo, vanifica i progetti delle figure maschili);
- ambedue hanno un andamento si potrebbe dire quasi favolistico (in questo caso il sogno, la pianta di basilico).
E’ importante notare come nel primo i riferimenti culturali erano altissimi, a partire dalla tragedia classica nonché dal romanzo cortese e dalla storia, in specifico del “Tristano e Isotta” che giustifica in qualche modo quella perorazione, oserei quasi dall’impianto logico di Ghismonda verso il padre; qui invece è come se la narratrice partisse da una canzone popolare, messa in coda al racconto e ne spiegasse il motivo. Ciò permette al racconto di Lisabetta di vertere più sul piano dell’elegia, in cui a prevalere non è la parola ma il pianto (piange perché il fratello non le dice dov’è Lorenzo; piange perché l’uccidono; piange sulla sua testa “vegheggiando il desiderio”). Il pianto sembra il filo conduttore delle tre sequenze:
- l’amore clandestino di Lisabetta e Lorenzo;
- L’uccisione di lui; il sogno e il prelevamento della testa;
- Il ritorno il pianto, lo svelamento della verità e la fuga.
Se tuttavia ci sembra “giustificabile” da un punto di vista feudale, il comportamento di Tancredi, meno comprensibile è quello dei fratelli: cos’hanno da perdere, per il loro commercio, da un matrimonio tra Lisabetta e Lorenzo?
Le risposte potrebbero essere due:
- L’autorità che, pure nel mondo borghese, un padre o chi per lui aveva su una donna, tanto da decidere il suo destino sentimentale (nonché sessuale);
- l’impossibilità, essendo Lorenzo un sottoposto, di contrarre un matrimonio di “convenienza”
Pensiamo invece che quello che agisce possa essere sia una identica lettura psicoanalitica, che ripeterebbe lo schema di Tancredi e Ghisunda, quanto, invece socialmente, tale fatto avrebbe creato “vergogna” tra i commercianti che non avrebbero saputo contrarre un matrimonio vergognoso e si sarebbero piegati alla libertà femminile.
QUINTA GIORNATA
La quinta giornata è presieduta dalla regina Fiammetta la quale vuole che si parli di ciò che a alcuno amante, dopo alcuni fieri e sventurati accidenti, felicemente avvenisse. Dopo le tragedie delle novelle narrate la giornata precedente, si torna a parlare di “amori a lieto fine”.
Su questo argomento scegliamo la novella di Nastagio degli Onesti presentataci da Filomena:
NASTAGIO DEGLI ONESTI, AMANDO UNA DE’ TRAVERSARI, SPENDE LE SUE RICCHEZZE SENZA ESSERE AMATO. VASSENE, PREFATO DA’ SUOI, A CHIASSI; QUIVI DEVE CACCIARE AD UN CAVALIERE UNA GIOVANE E UCCIDERLA E DIVORARLA DA DUE CANI. INVITA I PARENTI SUOI E QUELLA DONNA AMATA DA LUI SD UN DESINARE, LA QUALE VEDE QUESTA MEDESIMA GIOVANE SBRANARE; E TEMENDO DI SIMILE AVVENIMENTO PRENDE PER MARITO NASTAGIO.
(V, 8)
In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già assai nobili e ricchi uomini, tra’ quali un giovane chiamato Nastagio degli Onesti, per la morte del padre di lui e d’un suo zio, senza stima rimaso ricchissimo. Il quale, sì come de’ giovani avviene, essendo senza moglie, s’innamorò d’una figliuola di messer Paolo Traversaro, giovane troppo più nobile che esso non era, prendendo speranza con le sue opere di doverla trarre ad amar lui; le quali, quantunque grandissime, belle e laudevoli fossero, non solamente non gli giovavano, anzi pareva che gli nocessero, tanto cruda e dura e salvatica gli si mostrava la giovinetta amata, forse per la sua singular bellezza o per la sua nobiltà sì altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa che gli piacesse le piaceva.
La qual cosa era tanto a Nastagio gravosa a comportare, che per dolore più volte, dopo molto essersi doluto, gli venne in disidero d’uccidersi. Poi, pur tenendosene, molte volte si mise in cuore di doverla del tutto lasciare stare, o, se potesse, d’averla in odio come ella aveva lui. Ma invano tal proponimento prendeva, per ciò che pareva che quanto più la speranza mancava, tanto più moltiplicasse il suo amore. Perseverando adunque il giovane e nello amare e nello spendere smisuratamente, parve a certi suoi amici e parenti che egli sé e ‘l suo avere parimente fosse per consumare; per la qual cosa più volte il pregarono e consigliarono che si dovesse di Ravenna partire e in alcuno altro luogo per alquanto tempo andare a dimorare; per ciò che, così faccendo, scemerebbe l’amore e le spese. Di questo consiglio più volte fece beffe Nastagio; ma pure, essendo da loro sollicitato, non potendo tanto dir di no, disse di farlo; e fatto fare un grande apparecchiamento, come se in Francia o in Ispagna o in alcuno altro luogo lontano andar volesse, montato a cavallo e da suoi molti amici accompagnato di Ravenna uscì e andossene ad un luogo forse tre miglia fuor di Ravenna, che si chiama Chiassi; e quivi, fatti venir padiglioni e trabacche disse a coloro che accompagnato l’aveano che star si volea e che essi a Ravenna se ne tornassono. Attendatosi adunque quivi Nastagio, cominciò a fare la più bella vita e la più magnifica che mai si facesse, or questi e or quegli altri invitando a cena e a desinare, come usato s’era.
Ora avvenne che uno venerdì quasi all’entrata di maggio essendo un bellissimo tempo, ed egli entrato in pensier della sua crudel donna, comandato a tutta la sua famiglia che solo il lasciassero, per più potere pensare a suo piacere, piede innanzi piè sé medesimo trasportò, pensando, infino nella pigneta. Ed essendo già passata presso che la quinta ora del giorno, ed esso bene un mezzo miglio per la pigneta entrato, non ricordandosi di mangiare né d’altra cosa, subitamente gli parve udire un grandissimo pianto e guai altissimi messi da una donna; per che, rotto il suo dolce pensiero, alzò il capo per veder che fosse, e maravigliossi nella pigneta veggendosi; e oltre a ciò, davanti guardandosi vide venire per un boschetto assai folto d’albuscelli e di pruni, correndo verso il luogo dove egli era, una bellissima giovane ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche e dà pruni, piagnendo e gridando forte mercé; e oltre a questo le vide a’ fianchi due grandi e fieri mastini, li quali duramente appresso correndole, spesse volte crudelmente dove la giugnevano la mordevano, e dietro a lei vide venire sopra un corsiere nero un cavalier bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano, lei di morte con parole spaventevoli e villane minacciando. Questa cosa ad una ora maraviglia e spavento gli mise nell’animo, e ultimamente compassione della sventurata donna, dalla qual nacque disidero di liberarla da sì fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma, senza arme trovandosi, ricorse a prendere un ramo d’albero in luogo di bastone, e cominciò a farsi incontro a’cani e contro al cavaliere.

Sandro Botticelli: 1° pannello
Ma il cavalier che questo vide, gli gridò di lontano: «Nastagio, non t’impacciare, lascia fare a’ cani e a me quello che questa malvagia femina ha meritato.»
E così dicendo, i cani, presa forte la giovane né fianchi, la fermarono, e il cavaliere sopraggiunto smontò da cavallo.
Al quale Nastagio avvicinatosi disse: «Io non so chi tu ti sé, che me così cognosci; ma tanto ti dico che gran viltà è d’un cavaliere armato volere uccidere una femina ignuda, e averle i cani alle coste messi come se ella fosse una fiera salvatica; io per certo la difenderò quant’io potrò».
Il cavaliere allora disse: «Nastagio, io fui d’una medesima terra teco, ed eri tu ancora piccol fanciullo quando io, il quale fui chiamato messer Guido degli Anastagi, era troppo più innamorato di costei, che tu ora non sé di quella de’ Traversari, e per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un dì con questo stocco, il quale tu mi vedi in mano, come disperato m’uccisi, e sono alle pene etternali dannato. Né stette poi guari tempo che costei, la qual della mia morte fu lieta oltre misura, morì, e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta de’ miei tormenti, non pentendosene, come colei che non credeva in ciò aver peccato ma meritato, similmente fu ed è dannata alle pene del ninferno. Nel quale come ella discese, così ne fu e a lei e a me per pena dato, a lei di fuggirmi davanti e a me, che già cotanto l’amai, di seguitarla come mortal nimica, non come amata donna; e quante volte io la giungo, tante con questo stocco, col quale io uccisi me, uccido lei e aprola per ischiena, e quel cuor duro e freddo, nel qual mai né amor né pietà poterono entrare, con l’altre interiora insieme, sì come tu vedrai incontanente, le caccia di corpo, e dolle mangiare a questi cani. Né sta poi grande spazio che ella, sì come la giustizia e la potenzia d’Iddio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da capo incomincia la dolorosa fugga, e i cani e io a seguitarla; e avviene che ogni venerdì in su questa ora io la giungo qui, e qui ne fo lo strazio che vedrai; e gli altri dì non creder che noi riposiamo, ma giungola in altri luoghi né quali ella crudelmente contro a me pensò o operò; ed essendole d’amante divenuto nimico, come tu vedi, me la conviene in questa guisa tanti anni seguitare quanti mesi ella fu contro a me crudele. Adunque lasciami la divina giustizia mandare ad esecuzione, né ti volere opporre a quello che tu non potresti contrastare».
Nastagio, udendo queste parole, tutto timido divenuto e quasi non avendo pelo addosso che arricciato non fosse, tirandosi addietro e riguardando alla misera giovane, cominciò pauroso ad aspettare quello che facesse il cavaliere. Il quale, finito il suo ragionare, a guisa d’un cane rabbioso, con lo stocco in mano corse addosso alla giovane, la quale inginocchiata e da’ due mastini tenuta forte gli gridava mercè; e a quella con tutta sua forza diede per mezzo il petto e passolla dall’altra parte. Il qual colpo come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone, sempre piagnendo e gridando; e il cavaliere, messo mano ad un coltello, quella aprì nelle reni, e fuori trattone il cuore e ogni altra cosa d’attorno, a’ due mastini il gittò, li quali affamatissimi incontanente il mangiarono. Né stette guari che la giovane, quasi niuna di queste cose stata fosse, subitamente si levò in piè e cominciò a fuggire verso il mare, e i cani appresso di lei sempre lacerandola; e il cavaliere, rimontato a cavallo e ripreso il suo stocco, la cominciò a seguitare, e in picciola ora si dileguarono in maniera che più Nastagio non gli potè vedere.
Il quale, avendo queste cose vedute, gran pezza stette tra pietoso e pauroso, e dopo alquanto gli venne nella mente questa cosa dovergli molto poter valere, poi che ogni venerdì avvenia; per che, segnato il luogo, a’ suoi famigli se ne tornò, e appresso, quando gli parve, mandato per più suoi parenti e amici, disse loro: «Voi m’avete lungo tempo stimolato che io d’amare questa mia nemica mi rimanga e ponga fine al mio spendere, e io son presto di farlo dove voi una grazia m’impetriate, la quale è questa: che venerdì che viene voi facciate sì che messer Paolo Traversaro e la moglie e la figliuola e tutte le donne lor parenti, e altre chi vi piacerà, qui sieno a desinar meco. Quello per che io questo voglia, voi il vedrete allora».
A costor parve questa assai piccola cosa a dover fare e promissongliele; e a Ravenna tornati, quando tempo fu, coloro invitarono li quali Nastagio voleva, e come che dura cosa fosse il potervi menare la giovane da Nastagio amata, pur v’andò con gli altri insieme. Nastagio fece magnificamente apprestare da mangiare, e fece le tavole mettere sotto i pini d’intorno a quel luogo dove veduto aveva lo strazio della crudel donna; e fatti mettere gli uomini e le donne a tavola, sì ordinò, che appunto la giovane amata da lui fu posta a sedere dirimpetto al luogo dove doveva il fatto intervenire.
Essendo adunque già venuta l’ultima vivanda, e il romore disperato della cacciata giovane da tutti fu cominciato ad udire. Di che maravigliandosi forte ciascuno e domandando che ciò fosse, e niun sappiendol dire, levatisi tutti diritti e riguardando che ciò potesse essere, videro la dolente giovane e ‘l cavaliere e’ cani; ne guari stette che essi tutti furon quivi tra loro.

Sandro Botticelli: 2° pannello
Il romore fu fatto grande e a’ cani e al cavaliere, e molti per aiutare la giovane si fecero innanzi; ma il cavaliere, parlando loro come a Nastagio aveva parlato, non solamente gli fece indietro tirare, ma tutti gli spaventò e riempiè di maraviglia; e faccendo quello che altra volta aveva fatto, quante donne v’avea (ché ve ne avea assai che parenti erano state e della dolente giovane e del cavaliere e che si ricordavano e dell’amore e della morte di lui) tutte così miseramente piagnevano come se a sé medesime quello avesser veduto fare.
La qual cosa al suo termine fornita, e andata via la donna e ‘l cavaliere, mise costoro che ciò veduto aveano in molti e vari ragionamenti; ma tra gli altri che più di spavento ebbero, fu la crudel giovane da Nastagio amata, la quale ogni cosa distintamente veduta avea e udita, e conosciuto che a sé più che ad altra persona che vi fosse queste cose toccavano, ricordandosi della crudeltà sempre da lei usata verso Nastagio; per che già le parea fuggir dinanzi da lui adirato e avere i mastini a’ fianchi. E tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò che questo a lei non avvenisse, prima tempo non si vide (il quale quella medesima sera prestato le fu) che ella, avendo l’odio in amore tramutato, una sua fida cameriera segretamente a Nastagio mandò, la quale da parte di lei il pregò che gli dovesse piacer d’andare a lei, per ciò ch’ella era presta di far tutto ciò che fosse piacer di lui. Alla qual Nastagio fece rispondere che questo gli era a grado molto, ma che, dove piacesse, con onor di lei voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie.
La giovane, la qual sapeva che da altrui che da lei rimaso non era che moglie di Nastagio stata non fosse, gli fece risponder che le piacea. Per che, essendo ella medesima la messaggera, al padre e alla madre disse che era contenta d’esser sposa di Nastagio, di che essi furon contenti molto; e la domenica seguente Nastagio sposatala e fatte le sue nozze, con lei più tempo lietamente visse. E non fu questa paura cagione solamente di questo bene, anzi sì tutte le ravignane donne paurose ne divennero, che sempre poi troppo più arrendevoli a’ piaceri degli uomini furono, che prima state non erano.

Sandro Botticelli: 3° pannello
A Ravenna, antichissima città della Romagna, vissero uomini nobili e ricchi, tra i quali un giovane chiamato Nastagio degli Onesti, che aveva ereditato un’immensa eredità, in seguito alla morte del padre e dello zio. Egli, come di solito capita ai giovani, essendi scapolo, s’innamorò di una delle figlie di messer Paolo Traversaro, una giovane molto più nobile di lui, sperando di farla innamorare con grandi cortesie. Sebbene esse furono grandi, belle e degne di lode, non solo non gli giovarono, ma sembravano produrre l’effetto contrario; tanto la giovane amata gli si mostrava crudele, scontrosa e scortese, forse a causa della sua bellezza e nobiltà ed era diventata così altezzosa e superba, che non le piaceva né lui né le cose che lui apprezzava. Tutto questo era per Nastagio difficile a sopportare, che, dopo essersi doluto, spesso pensò di uccidersi; poi, pur trattenendosi dal farlo, tante volte cercò di convincersi di lasciarla stare o, se avesse potuto, odiarla allo stesso modo in cui lei odiava lui. ma inutilmente, però, perché quanto più sembrava svanisse ogni speranza tanto lui moltiplicava l’amore.
Continuando il giovane ad amarla e allo spendere in modo smisurato, ai suoi amici e ai suoi parenti sembrò che lui fosse in procinto di perdere se stessi e i suoi beni; per cui più volte lo pregarono e lo consigliarono di partire da Ravenna per andare a stare per qualche tempo in un altro posto, in modo che, facendo così, facesse diminuire l’amore e le spese. Nastagio più spesso si prese gioco di questo consiglio, ma essendo da loro sollecitato (a farlo) non potendo più rifiutarsi, lo promise e fatti imponenti preparativi, come se dovesse andare in Francia o in Spagna o in un altro lontano paese, montato a cavallo e con molti compagni uscì da Ravenna per andare in un posto che distava circa tre miglia da Ravenna, Classe. Qui Nastagio si fece portare padiglioni e tende e disse ai suoi amici che voleva rimanere lì e li invitò a rientrare in città. Accampatosi lì Nastagio cominciò a condurre la più bella e magnifica vita che mai avesse fatto, invitando a cena or questi o quelli, come era solito fare.
All’inizio di maggio, in una giornata bellissima, pensando alla donna crudele, chiedendo a tutti i suoi familiari di lasciarlo solo per immergersi più semplicemente nei suoi pensieri e camminando lentamente giunse all’interno di una pineta. Era quasi mezzogiorno quando, entrato per mezzo miglio all’interno della pineta, dimentico di mangiare, sentì improvvisamente una donna emettere un grandissimo pianto ed altissimi lamenti; per cui, interrotto il pensiero della donna, alzò la testa per vedere e si meravigliò del posto in cui si trovava, tanto era stato immerso nella sua immaginazione. Guardò quindi davanti a sé e vide venire attraverso il bosco ricco di arbusti e rovi, una bella giovane nuda, scapigliata e graffiata da rami e cespugli che piangeva ed urlava pietà. A fianco a lei vide due grandi e feroci mastini che rabbiosamente la inseguivano e, quando la raggiungevano la mordevano; e dietro di lei vide un cavallo nero con sopra un cavaliere vestito di nero, molto crudele nel volto, con uno spadino in mano, minacciandola di morte con parole spaventose e insolenti. Dapprima Nastagio fu colto da stupore e paura nello stesso tempo, poi da compassione per la donna sfortunata, e quindi nacque la voglia di liberarla da una così crudele angoscia e certa morte, se fosse possibile riuscirci. Ma trovandosi senza armi, si adattò a raccogliere un ramo d’albero da utilizzare come bastone e andò verso i cani e il cavalieri.
Ma il cavaliere, vedendolo, da lontano gli disse: «Nastagio, non ti intromettere, lascia fare a me e ai cani ciò che questa malvagia donna ha meritato».
Mentre diceva ciò i cani raggiunsero la donna e la bloccarono e il cavaliere smontò da cavallo per raggiungerla, ma Nastagio, avvicinandolo, disse: «Non chi tu sia e come mai conosci il mio nome, ma intanto ti dico che è un gesto di gran villania per un cavaliere voler uccidere una donna nuda e di averle messo dei cani alle costole come fosse un animale selvatico: certamente, per quanto potrò, la difenderò.
Gli rispose il cavaliere: «Nastagio, io fui della tua stessa terra, e tu eri ancora un piccolo bambino quando io, messer Guido degli Anastagi, ero molto più innamorato di questa donna di quanto tu oggi lo sia di quella della famiglia dei Traversari e a causa della sua superbia e crudeltà, il mio stato infelice crebbe tanto, che un giorno con questo spadino, che tu mi vedi in mano, poiché ero giunto alla disperazione, mi uccisi. Non passò molto che costei, che mostrò di essere estremamente felice per la mia morte, morì e per il peccato della sua crudeltà e della sua contentezza per le mie disgrazie, poiché non si pentì, ma credeva con il suo atteggiamento di non aver peccato, anzi di aver fatto un atto meritorio, come me è dannsta alle pene dell’Inferno. Lì ci fu dato come pena a lei di fuggirmi e a me, che l’amai tanto, di inseguirla come un mortale nemico e non come donna desiderata, e ogni volta che la raggiungo tante volte la colpisco con la spada con la quale mi uccisi. Quindi le apro uno squarcio sulla schiena e le strappo le interiora ed il cuore, che non permise entrassero amore e pietà per me, e li do ai cani. Non trascorre poi tanto tempo che lei, secondo la giustizia e la potenza di Dio, come se non fosse stata uccisa, risorge e di nuovo ricomincia la dolorosa fuga, l’inseguimento dei cani e il mio. E accade che ogni venerdì, più o meno a quest’ora, io arrivo qui e faccio strazio del suo corpo come vedrai, e non credere che gli altri giorni ci riposiamo, ma la raggiungo in altri luoghi dove lei pensò e mise in atto atteggiamenti rivolti contro di me. Ora essendole diventato da amante a nemico sono condannato ad inseguirla tanti anni quanti furono i mesi che ella fu crudele nei miei confronti. Dunque lasciami eseguire la giustizia divina e non opporti a ciò che Dio non ti permetterebbe di contrastare».
Nastagio, dopo aver udito ciò, pieno di paura e con i peli rizzati sulla pelle, indietreggiò e, guardando alla povera giovane, aspettò timoroso di vedere che cosa le facesse il cavaliere che, finito di parlare, come un cane rabbioso con la spada in mano corse contro la ragazza che in ginocchio, ma trattenuta dai mastini, gli chiedeva pietà ma con tutta la forza la colpì in mezzo al petto e la trapassò. Appena ricevuto il colpo, la giovane cadde bocconi, continuando a piangere e a gridare: il cavaliere, preso un coltello la squarciò all’altezza delle reni e tirato fuori il cuore e le altre interiora le gettò ai cani che, affamati, le divorarono. Ma non passò molto tempo che la giovane, come se non gli fosse accaduto nulla, improvvisamente si sollevò in piedi e ricominciò a correre verso il mare con i cani ad inseguirla per morderla e il cavaliere, ripreso lo spadino, rimontò in sella a rincorrerla e in brevissimo tempo di dileguarono tanto che Nastagio non poté più vederli.
Lui, dopo aver visto questa cose rimase per molto tempo in una condizione commista tra pietà e paura; in seguito pensò di poter trarre vantaggio da questo avvenimento, dal momento che si ripeteva in modo uguale ogni venerdì. Quindi, segnato il luogo, tornò dai suoi servitori e in seguito, quando gli sembrò opportuno, convocata la maggior parte di parenti e amici, disse loro: «Voi mi avete spinto a smettere di amare questa mia nemica e ponga fine al gettare il mio denaro per lei, ed io lo farò certamente nel caso voi otteniate una grazia per me, che è la seguente: venerdì prossimo fate in modo che messer Traversari con moglie, figlia e tutto il parentado femminile e chiunque altro vi piacerà, siano qui a mangiare con me. Quello che io voglio ottenere con questo, lo vedrete in quel momento».
A coloro cui tale richiesta fu rivolta parve piccola cosa da eseguire e, tornati a Ravenna e quando fu il momento invitarono coloro che Nastagio aveva chiesto e sebbene non fu facile convincere la ragazza che lui amava, alla fine vi andò insieme ad altre donne. Nastagio fece preparare un pasto sontuoso, mettendo i tavoli sotto i pini, intorno a quel luogo in cui aveva visto lo strazio della donne crudele, e ordinò ai servi di mettere gli uomini e le donne a tavola e che la donna fosse messa a sedere di fronte al luogo dove sarebbe accaduta la scena.
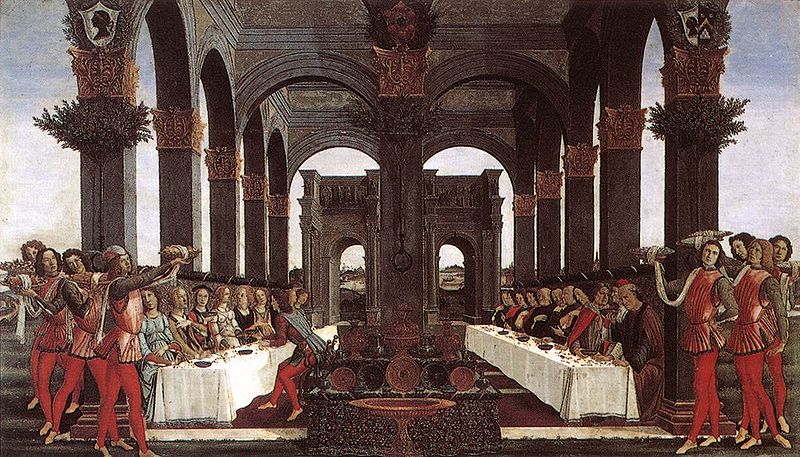
Sandro Botticelli: 4° pannello
Giunti all’ultima portata si cominciò a percepire il rumore della giovane inseguita. Tutti si meravigliarono molto e si domandarono cosa fosse, ma non sapendolo nessuno si sollevarono in piedi per guardare e videro la donna dolorosa, i cani e il cavaliere. Si levarono molte grida contro di loro e moti avanzarono per aiutare la giovane, ma il cavaliere, parlando loro come aveva parlato a Nastagio non solo li fece indietreggiare ma li spaventò e li riempì di meraviglia e facendo quello che il venerdì precedente aveva fatto, quante donne erano presenti (ce n’erano molte che erano state congiunte della giovane donna o del cavaliere e che ricordavano l’amore e la morte di lui) tutte piangevano come se avessero subito loro stesse la punizione inflitta alla donna. La visione dell’inseguimento e del supplizio, non appena fu giunta al termine e la donna e il cavaliere se nje furono andati via, indusse coloro che vi avevano assistito a molti e diversi discorsi: Ma tra coloro che si spaventarono di più, ci fu la donna crudele amata da Nastagio, che, vista ogni cosa, aveva capito che riguardavano se stessa più degli altri presenti, ripensando alla crudeltà avita sin da allora verso Nastagio, tanto che già si vedeva scappare di fronte a lui adirato e inseguita da cani.
Tanta fu la paura che quello che vide le procurò che, affinché non avvenisse, non appena ebbe l’occasione – ciò fu la sera di quel medesimo giorno – ella, avendo mutato l’odio in amore, mandò in gran segreto una sua cameriera da Nastagio e lo pregò, da parte della sua padrona, di voler andare da lei, perché ella era pronta a fare tutto ciò che egli desiderasse: Nastaglio gli risposte che ciò che gli aveva riferito le era molto gradito, ma che nel caso lei fosse stata d’accordo, desiderava portare a compimento il suo desiderio, e questo era possibile prendendola in moglie. La giovane sapeva che non era dipeso da altri se non da lei il fatto di non essere diventava la moglie di Nastaglio, gli fece rispondere che acconsentiva. Per cui, presentando lei stessa la richiesta di matrimonio, disse di voler diventare la sposa di Nastagio ai suoi genitori, che furono, per questo, molto soddisfatti.
La domenica seguente, celebrate le nozze, Nastastagio visse molto tempo felicemente con lei; e la paura non fu solamente il motivo di questo avvenimento lieto, anzi tutte le ravennate divennero donne timorose che in seguito furono molto più arrendevoli ai corteggiamenti degli uomini di quanto lo fossero state prima.

Alberto Criscione: Nastagio degli Onesti (2014)
La novella qui presentata mette a fuoco tre nuclei tematici estremamente interessanti:
- ambiente feudale, con elementi tratti dalla cultura cortese (la dedizione totale dell’uomo verso la donna, sino al depauperamento del suo patrimonio). E’ evidente che tale ambiente si presenti come “lontano nel tempo” e “raffinato”;
- La caccia infernale di dantesca memoria (canto XIII, pena degli scialacquatori, inseguiti e lacerati da morsi di cani rabbiosi); elemento religioso, infatti, con il castigo di Dio che ritiene una “villania” l’amor che a nullo amato amar perdona;
- L’elogio dell’intelligenza: Nastagio, dopo un primo momento di smarrimento, sfrutta a suo vantaggio la visione infernale, piegando alla sua volontà la ritrosia della donna.
La novella si chiude con un sorriso, invitando le donne ad essere meno scontrose e riservate alle richieste d’amore; d’altra parte non sempre tali richieste nascono solo per soddisfacimenti carnali, ed è lo stesso Nastagio a mostrarlo: quando la giovane avrebbe acconsentito a qualsiasi richiesta dell’uomo, quest’ultimo le chiede di sposarlo, rientrando così in una richiesta che, forse non più feudale, strizza l’occhio all’etica borghese.
La novella è anche famosa perché nel 1483 Lorenzo il Magnifico ne commissionò la resa pittorica a Sandro Botticelli, per donarla al matrimonio di Giannozzo Pucci. Essa è divisa in quattro pannelli, tre conservati attualmente al Prado (Madrid), il quarto a Palazzo Pucci, a Firenze.
La penultima famosissima novella della quinta giornata è raccontata da Fiammetta, che pur essendo regina, racconterà la storia di Federigo degli Alberighi, lasciando così al decimo narratore, Dioneo, la possibilità data lui di raccontare in piena libertà.
FEDERIGO DEGLI ALBERIGHI AMA E NON E’ AMATO E IN CORTESIA SPENDENDO SI CONSUMA E RIMANGLI UN SOL FALCONE, IL QUALE, NON AVENDO ALTRO DA’ A MANGIARE ALLA SUA DONNA VENUTAGLI A CASA; LA QUALE, CIO’ SAPPIENDO, MUTATA D’ANIMO, IL PRENDE PER MARITO E FALLO RICCO.
(V,9)

Josafat Vagni (Federigo degli Alberighi) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)
Dovete adunque sapere che Coppo di Borghese Domenichi, il quale fu nella nostra città, e forse ancora è, uomo di grande e di reverenda autorità né dì nostri, e per costumi e per vertù molto più che per nobiltà di sangue chiarissimo e degno d’eterna fama, essendo già d’anni peno, spesso volte delle cose passate co’ suoi vicini e con altri si dilettava di ragionare: la qual cosa egli meglio e con più ordine e con maggior memoria e ornato parlare che altro uomo seppe fare. Era usato di dire, tra l’altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federigo di messer Filippo Alberighi, in opera d’arme e in cortesia pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana. Il quale, sì come il più de’ gentili uomini avviene, d’una gentil donna chiamata monna Giovanna s’innamorò, né suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze fossero; e acciò che egli l’amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava, e il suo senza alcun ritegno spendeva; ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte né di colui si curava che le faceva.
Spendendo adunque Federigo oltre a ogni suo potere molto e niente acquistando, sì come di leggiere adiviene, le ricchezze mancarono e esso rimase povero, senza altra cosa che un suo poderetto piccolo essergli rimasa, delle rendite del quale strettissimamente vivea, e oltre a questo un suo falcone de’ miglior del mondo. Per che, amando più che mai né parendo gli più potere essere cittadino come disiderava, a Campi, là dove il suo poderetto era, se n’andò a stare. Quivi, quando poteva uccellando e senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà comportava.
Ora avvenne un dì che, essendo così Federigo divenuto allo stremo, che il marito di monna Giovanna infermò, e veggendosi alla morte venire fece testamento, e essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo già grandicello e appresso questo, avendo molto amata monna Giovanna, lei, se avvenisse che il figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede substituì, e morissi. Rimasa adunque vedova monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l’anno di state con questo suo figliuolo se n’andava in contado a una sua possessione assai vicina a quella di Federigo. Per che avvenne che questo garzoncello s’incominciò a dimesticare con Federigo e a dilettarsi d’uccelli e di cani; e avendo veduto molte volte il falcon di Federigo volare e stranamente piacendogli, forte disiderava d’averlo ma pure non s’attentava di domandarlo, veggendolo a lui esser cotanto caro. E così stando la cosa, avvenne che il garzoncello infermò: di che la madre dolorosa molto, come colei che più non n’avea e lui amava quanto più si poteva, tutto il dì standogli dintorno non restava di confortarlo e spesse volte il domandava se alcuna cosa era la quale egli disiderasse, pregandolo gliele dicesse, che per certo, se possibile fosse a avere, procaccerebbe come l’avesse.

Josafat Vagni (Federigo degli Alberighi) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)
Il giovanetto, udite molte volte queste proferte, disse: «Madre mia, se voi fa che io abbia il falcone di Federigo, io mi credo prestamente guerire.»
La donna, udendo questo, alquanto sopra sé stette e cominciò a pensar quello che far dovesse. Ella sapeva che Federigo lungamente l’aveva amata, né mai da lei una sola guatatura aveva avuta, per che ella diceva: «Come manderò io o andrò a domandargli questo falcone che è, per quel che io oda, il migliore che mai volasse e oltre a ciò il mantien nel mondo? E come sarò io sì sconoscente, che a un gentile uomo al quale niuno altro diletto è più rimaso, io questo gli voglia torre?»
E in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima d’averlo se ‘l domandasse, senza sapere che dover dire, non rispondeva al figliuolo ma si stava. Ultimamente tanto la vinse l’amor del figliuolo, che ella seco dispose, per contentarlo che che esser ne dovesse, di non mandare ma d’andare ella medesima per esso e di recargliele e risposegli: «Figliuol mio, confortati e pensa di guerire di forza, ché io ti prometto che la prima cosa che io farò domattina, io andrò per esso e sì il ti recherò.»
Di che il fanciullo lieto il dì medesimo mostrò alcun miglioramento. La donna la mattina seguente, presa un’altra donna in compagnia, per modo di diporto se n’andò alla piccola casetta di Federigo e fecelo adimandare. Egli, per ciò che non era tempo, né era stato a quei dì, d’uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavorietti acconciare; il quale, udendo che monna Giovanna il domandava alla porta, maravigliandosi forte, lieto là corse.
La quale vedendol venire, con una donnesca piacevolezza levataglisi incontrò, avendola già Federigo reverentemente salutata, disse: «Bene stea Federigo!» e seguitò: «Io sono venuta a ristorarti de’ danni li quali tu hai già avuti per me amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno: e il ristoro è cotale che io intendo con questa mia compagna insieme destinar teco dimesticamente stamane».
Alla qual Federigo umilmente rispose: «Madonna, niun danno mi ricorda mai avere ricevuto per voi ma tanto di bene che, se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valore e per l’amore che portato v’ho adivenne. E per certo questa vostra liberale venuta m’è troppo più cara che non sarebbe se da capo mi fosse dato da spendere quanto per adietro ho già speso, come che a povero oste siate venuta».
E così detto, vergognosamente dentro alla sua casa la ricevette e di quella nel suo giardino la condusse, e quivi non avendo a cui farle tenere compagnia a altrui, disse: «Madonna, poi che altri non c’è, questa buona donna moglie di questo lavoratore vi terrà compagnia tanto che io vada a far metter la tavola».
Egli, con tutto che la sua povertà fosse strema, non s’era ancor tanto avveduto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d’ordine spese le sue ricchezze, ma questa mattina niuna cosa trovandosi di che potere onorar la donna, per amor della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fé ravedere. E oltre modo angoscioso, seco stesso maledicendo la sua fortuna, come uomo che fuor di sé fosse or qua e or là trascorrendo, né denari né pegno trovandosi, essendo l’ora tarda e il disiderio grande di pure onorar d’alcuna cosa la gentil donna e non volendo, non che altrui, ma il lavorator suo stesso richiedere gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la stanga per che, non avendo a che altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui esser degna vivanda di cotal donna. E però, senza più pensare, tiratogli il collo, a una sua fanticella il fé prestamente, pelato e acconcio, mettere in uno schedone e arrostir diligentemente; e messa la tavola con tovaglie bianchissime, delle quali alcuna ancora avea, con lieto viso ritornò alla donna nel suo giardino e il desinare, che per lui far si potea, disse essere apparecchiato.
Laonde la donna con la sua compagna levatasi andarono a tavola e, senza saper che si mangiassero, insieme con Federigo, il quale con somma fede le serviva, mangiarono il buon falcone. E levate da tavola e alquanto con piacevoli ragionamenti con lui dimorate, parendo alla donna tempo di dire quello per che andata era, così benignamente verso Federigo cominciò a parlare: «Federigo, ricordandoti tu della tua preterita vita e della mia onestà, la quale per avventura tu hai reputata durezza e crudeltà, io non dubito punto che tu non ti debbi maravigliare della mia presunzione sentendo quello per che principalmente qui venuta sono; ma se figliuoli avessi o avessi avuti, per li quali potessi conoscere di quanta forza sia l’amor che lor si porta, mi parrebbe esser certa che in parte m’avresti per iscusata. Ma come che tu non n’abbia, io che n’ho uno, non posso però le leggi comuni d’altre madri fuggire; le cui forze seguir convenendomi, mi conviene, oltre al piacer mio e oltre a ogni convenevolezza e dovere, chiederti un dono il quale io so che sommamente t’è caro: e è ragione, per ciò che niuno altro diletto, niuno altro diporto, niuna consolazione lasciata t’ha la sua strema fortuna, e questo dono è il falcon tuo, del quale il fanciul mio è sì forte invaghito, che, se io non gliene porto, io temo che egli non aggravi tanto nella infermità la quale ha, che poi ne segua cosa per la quale io il perda. E per ciò ti priego, non per l’amore che tu mi porti, al quale tu di niente sé tenuto, ma per la tua nobiltà, la quale in usar cortesia s’è maggiore che in alcuno altro mostrata, che ti debba piacere di donarlomi, acciò che io per questo dono possa dire d’avere ritenuto in vita il mio figliuolo e per quello averloti sempre obligato».
Federigo, udendo ciò che la donna adomandava e sentendo che servir non ne la potea per ciò che mangiar gliele avea dato, cominciò in presenza di lei a piagnere anzi che alcuna parola risponder potesse. Il quale pianto la donna prima credette che da dolore di dover da sé di partire il buon falcone divenisse più che d’altro, e quasi fu per dire che nol volesse; ma pur sostenutasi, aspettò dopo il pianto la risposta di Federigo, il qual così disse: «Madonna poscia che a Dio piacque che io in voi ponessi il mio amore, in assai cose m’ho reputata la fortuna contraria e sonmi di lei doluto; ma tutte sono state leggieri a rispetto di quello che ella mi fa al presente, di che io mai pace con lei aver non debbo, pensando che voi qui alla mia povera casa venuta siete, dove, mentre che ricca fu, venir non degnaste, e da me un picciol don vogliate, e ella abbia sì fatto, che io donar nol vi possa: e perché questo esser non possa vi dirò brievemente. Come io udii che voi, la vostra mercé, meco desinar volavate, avendo riguardo alla vostra eccellenzia e al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda secondo la mia possibilità io vi dovessi onorare, che con quelle che generalmente per l’altre persone s’usano: per che, ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà, degno cibo da voi il reputai, e questa mattina arrostito l’avete avuto in sul tagliere, il quale io per ottimamente allogato avea; ma vedendo ora che in altra maniera il disideravate, m’è sì gran duolo che servire non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare».
E questo detto, le penne e i piedi e ‘l becco le fe’ in testimonianza di ciò gittare davanti. La qual cosa la donna vedendo e udendo, prima il biasimò d’aver per dar mangiare a una femina ucciso un tal falcone, e poi la grandezza dell’animo suo, la quale la povertà non avea potuto né potea rintuzzare, molto seco medesima commendò. Poi, rimasa fuori dalla speranza d’avere il falcone e per quello della salute del figliuolo entrata in forse, tutta malinconosa si dipartì e tornossi al figliuolo. Il quale, o per malinconia che il falcone aver non potea o per la ‘nfermità che pure a ciò il dovesse aver condotto, non trapassar molti giorni che egli con grandissimo dolor della madre di questa vita passò.
La quale, poi che piena di lagrime e d’amaritudine fu stata alquanto, essendo rimasa ricchissima e ancora giovane, più volte fu da’ fratelli costretta a rimaritarsi. La quale, come che voluto non avesse, pur veggendosi infestare, ricordatasi del valore di Federigo e della sua magnificenzia ultima, cioè d’avere ucciso un così fatto falcone per onorarla, disse a’ fratelli: «Io volentieri, quando vi piacesse, mi starei; ma se a voi pur piace che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcuno altro, se io non ho Federigo degli Alberighi».
Alla quale i fratelli, faccendosi beffe di lei, dissero: «Sciocca, che è ciò che tu dì? come vuoi tu lui che non ha cosa al mondo?»
A’ quali ella rispose: «Fratelli miei, io so bene che così è come voi dite, ma io voglio avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza che ricchezza che abbia bisogno d’uomo.»
Li fratelli, udendo l’animo di lei e conoscendo Federigo da molto, quantunque povero fosse, sì come ella volle, lei con tutte le sue ricchezze gli donarono. Il quale così fatta donna e cui egli cotanto amata avea per moglie vedendosi, e oltre a ciò ricchissima, in letizia con lei, miglior massaio fatto, terminò gli anni suoi.

Josafat Vagni e Jasmine Trinca (Federigo degli Alberighi e Monna Giovanna) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)
Dovete sapere che Coppo Borghese Dominichi, che è vissuto nella nostra città e forse ancora vi vive (se non è morto per la pestilenza), uomo di grande e rispettabile autorità ai giorni nostri, illustre per i costumi e la virtù più che per la nobiltà di sangue, degno di essere ricordato lungamente, essendo già in là con gli anni, spesse volte si divertiva a parlare del passato con i suoi vicini ed altri cittadini, cosa che lui sapeva fare meglio e con maggior chiarezza, memoria ed eleganza di chiunque altro. Egli, tra le cose piacevoli, era solito raccontare che a Firenze visse un giovane di nome Federigo degli Alberighi, notevole più di ogni altro giovane della Toscana per l’esercizio delle armi e per la cortesia. Costui, così come avviene agli uomini nobili, s’innamorò di una giovane nobildonna di nome Giovanna, ritenuta ai suoi tempi una delle più belle e costumate donne di Firenze, e affinché lui potesse conquistarne l’amore, faceva giostre, si esibiva nell’uso delle armi, organizzava feste e mostrava grande generosità; ma lei non meno onesta che bella, non si curava di queste cose fatte per lei né chi le faceva.
Federigo, avendo speso più della sua possibilità e non ottenendo nulla, così come naturalmente avviene, le ricchezze sfumarono e cadde in povertà, poiché non gli era rimasto che un piccolo poderetto, delle rendite del quale viveva in grandi ristrettezze ed un falcone, uno dei migliori del mondo. Per questo, amando (madonna Giovanna) sempre più intensamente, ma non potendo vivere in città nel modo in cui desiderava farlo, andò a stabilirsi a Campi dove aveva il piccolo podere. Qui, quando poteva, andando a caccia di uccelli e non chiedendo aiuto a nessuno, sopportava con mirabile pazienza la sua povertà.
Un giorno avvenne che, mentre Federigo era arrivato allo stremo dell’indigenza, il marito di Giovanna si ammalò ed essendo molto ricco, all’apprestarsi della morte, fece il testamento di cui erede fece l’unico figlio e dove questo morisse, ne usufruisse la stessa Giovanna. Stabilito questo, morì.
Rimasta vedova monna Giovanna, com’è di abitudine per le nostre donne, ogni anno d’estate andava con questo figlio in campagna, in un suo possedimento non lontano dal piccolo podere di Federigo. Ora avvenne che questo ragazzo prese a familiarizzare con Federigo e a divertirsi con gli uccelli e con i cani; avendo inoltre visto il falcone di Federigo e piacendogli straordinariamente, lo desiderava fortemente , ma pur non osava richiederglielo, vedendo l’attaccamento che Federigo aveva per lui. Stando le così le cose, capitò che il figlio di Giovanna si ammalò; per questo la madre essendo molto addolorata, non avendo che lui solo e amandolo quanto più poteva, stando intorno a lui cercava di recargli conforto e spesso lo interrogava chiedendogli che se desiderava qualcosa, pregandolo di dirglielo, perché certamente avrebbe trovato il modo di fargliela avere, se fosse possibile ottenerla. Il giovane, dopo aver udito più volte le richieste materne disse: «Madre mia, se fate in modo che io possa avere il falcone di Federigo, guarirò certamente».
La donna, dopo averlo ascoltato, rimase incerta, pensando a come fare. Sapeva che Federigo l’aveva amata per molto tempo, ma non aveva ricevuto da lei nemmeno uno sguardo, per cui si diceva: «Come manderò qualcuno o come andrò io stessa a richiedergli questo falcone che, per quanto ne sappia, è il migliore tra tutti e oltre a ciò lo tiene in vita? E come sarò io così ingrata da volerlo togliere ad un uomo così gentile cui nessuna altra gioia gli è rimasta?» E trattenuta da questo pensiero, sebbene sapesse che se glielo avesse domandato gliel’avrebbe dato, senza sapere cosa fare, indugiava.
Alla fine tanto vinse l’amore che portava al figlio che fra sé decise di non inviare un servitore, ma di andare lei stessa a chiedere il falcone e di portarglielo, e gli disse: «Figlio mio, rasserenati e pensa di guarire con tutte le forze che ti prometto che la prima cosa che farò domani mattina sarà di andare a prendere il falcone e te lo porterò». Il fanciullo, felice, il giorno stesso mostrò un certo miglioramento.
Il mattino seguente, Giovanna con una compagna, come se vi andasse per piacere, raggiunse la piccola casa di Federigo e domandò di lui. Il giovane, che a causa del tempo non favorevole in quei giorni non era andato a caccia, stava in un piccolo orto e vi faceva eseguire alcuni lavoretti. Egli, avendo sentito che la signora Giovanna, era alla sua porta, con grande meraviglia ma felice, la raggiunse.
Lei, vedendolo arrivare, con il suo fascino femminile gli andò incontro e avendola già Federigo salutata con riguardo, gli disse: «Stia bene, Federigo» e continuò «sono venuta a risarcirti dei danni che hai subito a causa mia, amandomi più di quanto avresti dovuto fare; e il conforto è tale che io ho piacere oggi di mangiare in modo famigliare con te insieme alla mia compagna».
A cui Federigo rispose: «Non ricordo di aver mai ricevuto alcun danno a causa vostra, ma tanto di quel bene che, se ho mai avuto dei meriti, è stato solo grazie alla vostra virtù e all’amore che ho nutrito per voi; e certamente questa vostra generosa visita mi è molto più gradita di quanto lo sarebbe riavere e il poter spendere tutto ciò che ho già speso in passato, sebbene siate venuta da un ospite povero». Detto ciò le accolse con timidezza nella sua casa e quindi le condusse in giardino e qui non avendo nessuno per far loro compagnia, disse: «Madonna, dal momento che non c’è nessuno (pari alla vostra altezza), questa donna, moglie di questo mio contadino vi terrà compagnia quel tanto che io vada a preparare la tavola».
Egli, con tutto che la sua povertà fosse estrema, non si era ancora accorto quanto avrebbe dovuto, di aver dissipato tutte le sue ricchezze; ma questa mattina non avendo alcuna cosa con cui poter onorare la donna, per amor della quale egli aveva mostrato generosità ad infiniti uomini, glielo fece comprendere. Pieno d’angoscia, maledicendo la sua sorte, andando da una parte all’altra, non avendo denaro né alcuna cosa da impegnare, essendo già tardi e dovendo pur trovare qualcosa che gli permettesse di onorare la donna e non volendo chiedere nulla non solo a uno estraneo, ma neppure al suo stesso contadino, gli venne sotto gli occhi il falcone, che stava appollaiato sopra la stanga, per cui, non avendo altro cui ricorrere, preso e vedendolo grasso, pensò potesse essere degna vivanda per la donna. Perciò, senza più pensarci, gli tirò il collo e lo fece mettere da una fanciulla, dopo averlo spennato e preparato, sullo spiedo affinché arrostisse a dovere; preparata quindi la tavola con tovaglie bianchissime di cui ne conservava ancora qualcuna, con volto felice tornò dalla donna in giardino e il pranzo, per quello che poteva fare lui, era pronto. Quindi la donna con la sua compagna si alzarono e andarono a tavola e, senza sapere che tipo di carne stessero mangiando, insieme con Federigo, che le serviva con estrema devozione, finirono il falcone.
Alzatesi da tavola e dopo aver trascorso piacevolmente il tempo con vari discorsi, sembrando giunto il tempo per la donna di dire il perché era andata da lui, così benevolmente cominciò a parlare a Federigo: «Federigo, ricordandoti la vita passata e la mia onestà, che tu, per caso, avrai reputato durezza e crudeltà, sono certa che ti meraviglierai della mia audacia, sentendo il motivo per cui io sia venuta qui da te; ma se avessi avuti o avessi figli, se potessi conoscere di quanta forza sia l’amore che noi portiamo verso loro, mi parrebbe certamente che in parte mi avresti perdonata. E sebbene tu non ne abbia, mentre io ne ho uno, non posso venir meno alle leggi di tutte le madri, e dovendola seguire, mi è necessario, contro il mio desiderio e contro ogni regola di convenienza e di dovere, chiederti un dono che ti so immensamente caro; ed è giusto, per il fatto che nessun altra gioia, nessun altro svago, nessuna altra consolazione ti ha lasciato la tua misera condizione; e questo dono è il tuo falcone, di cui il mio bambino si è talmente invaghito, che, se non dovessi portarglielo, ho paura che possa aggravarsi così tanto nella sua malattia, da cui ne deriverebbe la morte. Perciò ti prego, non per l’amore che mi porti, per il quale non sei obbligato in nulla, ma per la tua nobiltà, la quale si è mostrata nell’usare generosità più di qualunque altro, perciò ti prego di donarmelo, affinché io possa dire d’aver tenuto in vita mio figlio grazie a questo dono e mio figlio, per questo, ti sia sempre riconoscente».
Federigo, ascoltando ciò che la donna domandava e sentendo di non poterla accontentare, per quello che gli aveva preparato da mangiare, cominciò in sua presenza a piangere senza riuscire a pronunciare alcuna parola. La donna pensò che il pianto fosse dovuto dal doversi separare dal falcone e fu quasi sul punto di dirgli di non volerlo più; ma, trattenutasi, aspetto che, smesso il pianto, Federigo le rispondesse, che così le disse: «Madonna, dopo che Dio ha voluto che io ponessi il mio amore su di voi, in molte cose ho reputata la sorte contraria a me e mi sono lamentato di lei, ma tutte le cose contrarie capitatemi sono nulla rispetto a oggi, per cui io non avrò mai pace con lei, pensando che voi siete venuta qui alla mia povera casa e quando essa era ricca non veniste mai e che vogliate da me un piccolo dono e che io non possa donarvelo e perché non possa, ve lo dirò. Come ho sentito che voi, per vostra bontà, volevate mangiare con me, avendo rispetto per la vostra eleganza e virtù, reputai cosa degna e convenevole onorarvi con la vivanda più preziosa secondo la mia possibilità, rispetto a quelle che sono solito offrire ad altre persone; per cui, ricordandomi del falcone che mi state chiedendo e della sua bontà, lo reputai cibo degno per voi e questa mattina lo avete avuto arrostito sul piatto, e ritenevo di averlo impiegato nel modo migliore; ma vedendo ora che voi lo desideravate in altro modo, mi provoca gran dolore perché non posso servirvi, e credo di non poter mai trovare pace per questo».
Detto questo le pose davanti, in segno di fede, le penne, i piedi ed il becco: La donna, vedendo ed udendo ciò, dapprima lo rimproverò per aver dato in pasto ad una donna un falcone di grande valore ma poi la grandezza d’animo dell’uomo, che la povertà non aveva potuto far diminuire, molto tra sé e sé apprezzò. Poi, non avendo più la speranza di avere il falcone e cominciando a dubitare sulla salute del figlio, estremamente malinconica tornò a casa dal suo ragazzo. Costui o per il dolore di non poter avere il falcone o per la malattia che l’avrebbe comunque ridotto in quello stato, non passarono molti giorni che, con l’immenso strazio della madre, morì.
La donna, dopo esser stata lungo tempo a piangere e a lamentarsi, essendo tuttavia ricchissima e ancora giovane, fu più volte dai fratelli sollecitata a risposarsi. Lei, sebbene non lo volesse, vedendosi continuamente infastidire, ricordando delle virtù di Federigo, soprattutto l’ultima, cioè quella d’aver ucciso un falcone per onorarla, disse ai fratelli: «Volentieri, se vi piacesse, farei a meno di sposarmi; ma se volete che io prenda marito, siate sicuri che non ne prenderò alcuno che non sia Federigo degli Alberighi».
A cui i fratelli, prendendola in giro, dissero: «Stupida, che dici? Come mai vuoi lui che non ha più nulla?»
Ai quali rispose: «Fratelli, ciò che dite è vero; ma preferisco un uomo senza ricchezze che un uomo ricco privo di valore».
I fratelli, sentendo la sua volontà e conoscendo da tempo il valore di Federigo, sebbene lui fosse povero, come lei volle, gli donarono lei con tutte le ricchezze; e vedendo una cotal donna, da lui da sempre amata, diventargli moglie e, oltre a questo, diventando ricchissimo, fattosi miglior amministratore, terminò con lei i suoi anni.

Nerina Sam: Federigo degli Alberighi (2015)
La novella nell’impianto e tematica può somigliare a quella di Nastagio. Anche qui un uomo innamorato spende tutti i suoi averi per conquistare la donna del desiderio. La differenza, laddove vi può essere, e nell’ambientazione: se la precedente si può dire della Romagna contemporanea e quindi “maggiormente borghese” vi è naturale il bisogno di atemporalizzarla attraverso l’elemento fantastico; la seconda invece è a Firenze e il tempo è già di per sé favoloso. La storia infatti è raccontata da Coppo di Borghese Domenichi, personaggio realmente esistente (ce lo fa capire la stessa Fiammetta, quando ne mette in forse l’essere ancora in vita per via della peste) quando era già anziano e parlava di un periodo da lui già lontano: ne è spia un linguaggio “arcaico” che definisce Federigo “donzel” giovane nobile. Da tale assunto tutto dipende, a lui è dovuto l’onore, la cortesia e la generosità. Secondo l’insegnamento della letteratura precedente l’omaggio verso la donna è totale. La cancellazione del sé avviene sia in Nastagio che in Federigo: ma potremo dire che nella prima è momentanea per più potere pensare a suo piacere, piede innanzi piè sé medesimo trasportò, pensando, infino nella pigneta, con la mente occupata dal pensiero della figlia dei Traversari, in Federigo è essenziale: Egli, con tutto che la sua povertà fosse strema, non s’era ancor tanto avveduto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d’ordine spese le sue ricchezze, in quanto l’arrivo di Giovanna gli fa rendere conto d’essere in miseria.

Il falcone di Federigo
In questo mondo arcaico, pieno di virtù e cortesia Boccaccio punta il suo sguardo di uomo borghese. Quel mondo così straordinario non è più possibile: l’economia entra in esso e ne stravolge le regole. Il ricco Federigo cade in miseria, solo il soccorso di un amore “borghese” lo può salvare (Giovanna lo sceglie, con l’approvazione dei fratelli) e renderlo da uomo feudale a uomo contemporaneo, trasformandolo da “donzel” a “massaio”. Sembra che Boccaccio ci voglia dire che il mondo da lui sognato sia il figlio delle visioni di entrambi, cioè Federigo marito di Giovanni.
SESTA GIORNATA
La sesta giornata è dedicata a chi con alcun leggiadro motto, tentato, si riscotesse, o con pronta risposta o avvedimento fuggì perdita o pericolo o scorno ed è sotto il reggimento d’Elissa. E’ evidente che tale argomento, basato sulla parola, metta in luce l’intelligenza.
La prima novella che leggiamo è quella di Cisti fornaio ed è raccontata da Pampinea.
CISTI FORNAIO CON UNA SOLA PAROLA FA RAVEDER MESSER GERI SPINA D’UNA SUA TRASCURATA DOMANDA.
(VI, 2)
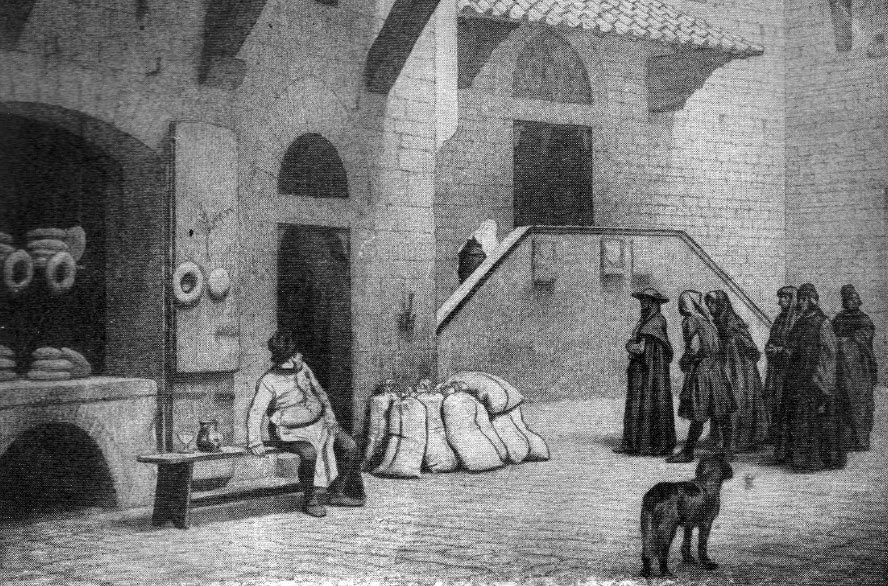
La novella di Cisti illustrata
Dico adunque che, avendo Bonifazio papa, appo il quale messer Geri Spina fu in grandissimo stato, mandati in Firenze certi suoi nobili ambasciadori per certe sue gran bisogne, essendo essi in casa di messer Geri smontati, e egli con loro insieme i fatti del Papa trattando, avvenne che, che se ne fosse cagione, messer Geri con questi ambasciadori del Papa tutti a piè quasi ogni mattina davanti a Santa Maria Ughi passavano, dove Cisti fornaio il suo forno aveva e personalmente la sua arte esserceva. Al quale quantunque la fortuna arte assai umile data avesse, tanto in quella gli era stata benigna, che egli n’era ricchissimo divenuto, e senza volerla mai per alcuna altra abbandonare splendidissimamente vivea, avendo tra l’altre sue buone cose sempre i migliori vini bianchi e vermigli che in Firenze si trovassero o nel contado. Il quale, veggendo ogni mattina davanti all’uscio suo passar messer Geri e gli ambasciadori del Papa, e essendo il caldo grande, s’avisò che gran cortesia sarebbe il dar lor bere del suo buon vin bianco; ma avendo riguardo alla sua condizione e a quella di messer Geri, non gli pareva onesta cosa il presummere d’invitarlo ma pensossi di tener modo il quale inducesse messer Geri medesimo a invitarsi. E avendo un farsetto bianchissimo indosso e un grembiule di bucato innanzi sempre, li quali più tosto mugnaio che fornaio il dimostravano, ogni mattina in su l’ora che egli avvisava che messer Geri con gli ambasciadori dover passare si faceva davanti all’uscio suo recare una secchia nuova e stagnata d’acqua fresca e un picciolo orcioletto bolognese nuovo del suo buon vin bianco e due bicchieri che parevano d’ariento, sì eran chiari: e a seder postosi, come essi passavano, e egli, poi che una volta o due spurgato s’era, cominciava a ber sì saporitamente questo suo vino, che egli n’avrebbe fatta venir voglia a’ morti.
La qual cosa avendo messer Geri una e due mattine veduta, disse la terza: «Chente è, Cisti? è buono?»
Cisti, levato prestamente in piè, rispose: «Messer sì, ma quanto non vi potre’ io dare a intendere, se voi non assaggiaste».
Messer Geri, al quale o la qualità o affanno più che l’usato avuto o forse il saporito bere, che a Cisti vedeva fare, sete avea generata, volto agli ambasciadori sorridendo disse: «Signori, egli è buono che noi assaggiamo del vino di questo valente uomo: forse che è egli tale, che noi non ce ne penteremo»; e con loro insieme se n’andò verso Cisti.
Il quale, fatta di presente una bella panca venire di fuori dal forno, gli pregò che sedessero; e alli lor famigliari, che già per lavare i bicchieri si facevano innanzi, disse: «Compagni, tiratevi indietro e lasciate questo servigio fare a me, ché io so non meno ben mescere che io sappia infornare; e non aspettaste voi d’assaggiarne gocciola!»
E così detto, esso stesso, lavati quatro bicchieri belli e nuovi e fatto venire un piccolo orcioletto del suo buon vino diligentemente diede bere a messer Geri e a’ compagni, alli quali il vino parve il migliore che essi avessero gran tempo davanti bevuto; per che, commendatol molto, mentre gli ambasciador vi stettero, quasi ogni mattina con loro insieme n’andò a ber messer Geri. A’ quali, essendo espediti e partir dovendosi, messer Geri fece un magnifico convito al quale invitò una parte de’ più orrevoli cittadini, e fecevi invitare Cisti, il quale per niuna condizione andar vi volle. Impose adunque messer Geri a uno de’ suoi famigliari che per un fiasco andasse del vin di Cisti e di quello un mezzo bicchier per uomo desse alle prime mense.
Il famigliare, forse sdegnato perché niuna volta bere aveva potuto del vino, tolse un gran fiasco. Il quale come Cisti vide, disse: «Figliuolo, messer Geri non ti manda a me».
Il che raffermando più volte il famigliare né potendo altra risposta avere, tornò a messer Geri e sì gliele disse; a cui messer Geri disse: «Tornavi e digli che sì fo: e se egli più così ti risponde, domandalo a cui io ti mando».
Il famigliare tornato disse: «Cisti, per certo messer Geri mi manda pure a te».
Al quale Cisti rispose: «Per certo, figliuol, non fa».
«Adunque», disse il famigliare «a cui mi manda?»
Rispose Cisti: «Ad Arno».
Il che rapportando il famigliare a messer Geri, subito gli occhi gli s’apersero dello ‘ntelletto e disse al famigliare: «Lasciami vedere che fiasco tu vi porti»; e vedutol disse: «Cisti dice vero»; e dettagli villania gli fece torre un fiasco convenevole.
Il quale Cisti vedendo disse: «Ora so io bene che egli ti manda a me», e lietamente glielo impiè.
E poi quel medesimo dì fatto il botticello riempiere d’un simil vino e fattolo soavemente portare a casa di messer Geri, andò appresso, e trovatolo gli disse: «Messere, io non vorrei che voi credeste che il gran fiasco stamane m’avesse spaventato; ma, parendomi che vi fosse uscito di mente ciò che io a questi dì co’ miei piccoli orcioletti v’ho dimostrato, ciò questo non sia vin da famiglia, vel volli staman raccordare. Ora, per ciò che io non intendo d’esservene più guardiano tutto ve l’ho fatto venire: fatene per innanzi come vi piace».
Messer Geri ebbe il dono di Cisti carissimo e quelle grazie gli rendè che a ciò credette si convenissero, e sempre poi per da molto l’ebbero e per amico.

Manoscritto con l’episodio di Cisti illustrato
Racconto dunque che, avendo papa Bonifacio VIII, presso il quale messer Geri Spina fu tenuto in grandissima considerazione, inviati a Firenze alcuni suoi ambasciatori per trattative di notevole importanza, ed essendo gli ambasciatori alloggiati in casa di Geri Spina, dal momento che a lui toccava discutere con loro gli interessi del pontefice, accadde che, qualunque fosse il motivo, Geri e gli ambasciatori papali passassero quasi ogni mattina, a piedi, davanti alla chiesa di Santa Maria degli Ughi, dove il fornaio Cisti aveva il suo forno ed esercitava il suo mestiere. E benché la sorte avesse riservato a Cisti un mestiere assai modesto, tuttavia gli era stata tanto propizia nella sua professione, che egli era diventato ricchissimo, e viveva in modo elegante e agiato, senza che mai gli venisse la tentazione di rinunziare al suo mestiere per qualche altro lavoro, avendo nella sua bottega, tra varie altre bontà, sempre i migliori vini bianchi e rossi che si potessero trovare a Firenze o nelle campagne circostanti. Cisti, vedendo ogni mattina passare davanti alla porta della sua bottega messer Geri e gli ambasciatori papali, facendo molto caldo, considerò che sarebbe stato un bel gesto cortese l’offrire loro un buon vino bianco, ma pensando che alla sua condizione sociale e a quella di messer Geri, non gli sembrava cortese avere la presunzione di invitarlo, e dunque pensò tra sé e sé, di fare in modo da indurre lo stesso Geri a invitarsi.
Indossando sempre un corpetto bianchissimo e, sul davanti, un grembiule fresco di bucato che lo facevano sembrare un proprietario di un mulino piuttosto che un fornaio, ogni mattina nell’ora in cui sapeva che messer Geri e gli ambasciatori sarebbero passati, si faceva portare davanti all’uscio della sua bottega un secchio nuovo di stagno d’acqua fresca e una brocca di terracotta, di fabbricazione bolognese, con il suo squisito vino bianco e due bicchieri, che erano tanto lucidi da sembrare d’argento; quindi si sedeva fuori e non appena essi passavano, dopo aver espettorato più volte per richiamare l’attenzione, cominciava a bere con tale gusto questo vino, che ne avrebbe fatto venir voglia ai morti.
Questa cosa fu vista una o due volte da messer Geri, il terzo giorno gli disse: «Com’è Cisti? E’ buono?»
Cisti, alzatosi prontamente in piedi, gli rispose: «Signor sì, ma quanto non ve lo potrei far capire, a meno che voi non lo assaggiaste».
Messer Geri, a cui il caldo della stagione o la preoccupazione (del compito da svolgere) o forse la gustosa bevuta che aveva visto fare a Cisti, avevano fatto venire sete, sorridendo, rivolto agli ambasciatori disse: «Signori, è cosa opportuna che noi assaggiamo il vino di questo uomo gentile, forse e così buono come dice che non ce ne pentiremo», e insieme a loro s’avvicinò alla bottega di Cisti. Questo, fatta arrivare subito una panca dall’interno, pregò loro di sedersi e ai suoi operai, che già si preparavano a lavare i bicchieri, disse. «Compagni, lasciate fare a me, fatevi da parte perché io so versare il vino non meno bene di quanto sappia infornare il pane; e non crediate di assaggiarne una goccia».
Ciò detto, lui stesso, lavati quattro bicchieri belli e nuovi, e fatto venire una piccola fiaschetta di buon vino, con accortezza diede da bere a messer Geri e ai suoi compagni. A loro il vino parve il migliore che da molto tempo essi ebbero bevuto, per cui, lodatolo molto, per tutto il tempo che gli ambasciatori rimasero a Firenze insieme a messer Geri, quasi ogni mattina andarono a berlo.
Avendo gli ambasciatori terminato il loro lavoro e dovendo ripartire, messer Geri ritenne opportuno offrire un magnifico banchetto, al quale invitò i cittadini più importanti ed anche Cisti, che tuttavia a nessuna condizione ci volle andare. Messer Geri allora comandò ad un suo servitore di andare a chiedere a Cisti un fiasco del suo vino e che di quello si servisse mezzo bicchiere a ciascuno con la prima portata. Il servitore, forse arrabbiato perché mai aveva potuto assaggiare quel vino, prese un fiasco grande, che, appena Cisti, vide, gli disse: «Figliolo, messer Geri non ti manda da me».
Più volte il servitore gli disse che così era, ma non potendo avere altra risposta da Cisti, tornò da Geri e gliela riferì.
A cui messer Geri: «Torna da lui e digli che ti mando io e se egli ti dovesse rispondere come prima, domandagli da chi altri ti debba mandare».
Tornando il servitore da Cisti: «Cisti, è sicuro che messer Geri mi manda da te»
A cui Cisti rispose: «Figliolo, e certo che non è così»
Ed il servitore: «Da chi mi deve mandare?»
Rispose Cisti: «All’Arno»
Riportando il servitore questo, Cisti capì immediatamente il senso della risposta e gli disse: «Fammi vedere il fiasco che gli hai portato» e dopo averlo visto, aggiunse: «Cisti dice la verità» e rimproveratolo, gli fece portare un fiasco della misura giusta.
Cisti vedendo il nuovo fiasco disse: «Ora sono sicuro che ti manda da me» e, con gioia, lo riempì.
E poi, quello stesso giorno, fatta riempire una piccola botte con un vino della stessa qualità, e fattala portare con attenzione a casa di Geri, dopo se ne andò lì, e, trovando messer Geri gli disse: «Signore, io non vorrei che lei credesse che il gran fiasco di stamane mi abbia spaventato, ma, sembrandomi che vi foste dimenticato che io in questi giorni con dei piccoli contenitori via abbia mostrato che questo non è vino di poco valore, volli stamattina ricordarvelo. Ora non ho più intenzione di esserne geloso e ve l’ho mandato tutto, fatene, per il futuro, ciò che volete.
Messer Geri considerò il vino di Cisti un dono graditissimo e lo ringraziò nel modo che gli sembrò adatto a simile dono; e da quel momento in avanti lo considerò uomo di grande valore e degno della sua amicizia.
La novella di Cisti è sintomatica dell’intera giornata: risulta infatti evidente come essa sia stata costruita intorno alla battuta dello stesso fornaio e come, molto probabilmente, tale battuta fosse patrimonio comune di modi di dire del popolo fiorentino.
Essa tuttavia costituisce un valido esempio per riaffrontare quel dibattito forse allora ancora molto acceso che appare come argomentazione su cui Pampinea costruisce in seguito la sua narrazione: si tratta appunto d’individuare cosa sia la cortesia (con tutti i suoi attributi) e dove essa risieda; la risposta è appunto Cisti fornaio, uomo della Arti minori a cui la sorte ha attribuito un animo nobile.

Manoscritto francese con l’episodio di Cisti illustrato
Tuttavia tanta “luminosità” nell’illustrare il carattere del protagonista lascia qualche ombra di dubbio: certamente egli è cortese, ma la sua cortesia e quindi generosità, mira ad uno scopo, quello di essere considerato e quindi apprezzato dalla classe nobiliare; non è un caso che tale “generosità” non venga elargita ai sottoposti, a cui nega recisamente fosse anche solo una goccia del suo prezioso vino.
Nella piccola novella sembra quindi riaffiorare il disegno politico/sociale al quale Boccaccio fa riferimento: così Cisti può raffigurare il borghese che, con la sua industriosità si fa ricchissimo, nel contempo mostra la volontà di non superare i limiti, cioè di non volersi confondere con la classe sociale superiore; ma ciò viene anche ribadito nel momento in cui nega questa possibilità ai suoi sottoposti, lasciando il “proletariato” al suo posto, affinché anch’esso non si confonda con la borghesia arricchita.
La novella che vede protagonista Guido Cavalcanti viene narrata dalla regina stessa, Elissa:
GUIDO CAVALCANTI DICE CON UN MOTO ONESTAMENTE VILLANIA A CERTI CAVALIER FIORENTINI LI QUALI SOPRAPPRESO L’AVEANO.
(VI, 9)

Manoscritto francese che illustra la novella di Cavalcanti
Dovete adunque sapere che né tempi passati furono nella nostra città assai belle e laudevoli usanze, delle quali oggi niuna ve n’è rimasa, mercé dell’avarizia che in quella con le ricchezze è cresciuta, la quale tutte l’ha discacciate. Tra le quali n’era una cotale, che in diversi luoghi per Firenze si ragunavano insieme i gentili uomini delle contrade e facevano lor brigate di certo numero, guardando di mettervi tali che comportar potessono acconciamente le spese, e oggi l’uno, doman l’altro, e così per ordine tutti mettevan tavola, ciascuno il suo dì, a tutta la brigata; e in quella spesse volte onoravano e gentili uomini forestieri, quando ve ne capitavano, e ancora de’cittadini; e similmente si vestivano insieme almeno una volta l’anno, e insieme i dì più notabili cavalcavano per la città, e talora armeggiavano, e massimamente per le feste principali o quando alcuna lieta novella di vittoria o d’altro fosse venuta nella città.
Tra le quali brigate n’era una di messer Betto Brunelleschi, nella quale messer Betto è compagni s’eran molto ingegnati di tirare Guido di messer Cavalcante de’Cavalcanti, e non senza cagione; per ciò che, oltre a quello che egli fu un de’migliori loici che avesse il mondo e ottimo filosofo naturale (delle quali cose poco la brigata curava, sì fu egli leggiadrissimo e costumato e parlante uomo molto, e ogni cosa che far volle e a gentile uom pertenente, seppe meglio che altro uom fare; e con questo era ricchissimo, e a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell’animo gli capeva che il valesse. Ma a messer Betto non era mai potuto venir fatto d’averlo, e credeva egli co’suoi compagni che ciò avvenisse per ciò che Guido alcuna volta speculando molto astratto dagli uomini diveniva. E per ciò che egli alquanto tenea della oppinione degli epicuri, si diceva tra la gente volgare che queste sue speculazioni eran solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse.
Ora avvenne un giorno che, essendo Guido partito d’Orto San Michele e venutosene per lo corso degli Adimari infino a San Giovanni, il quale spesse volte era suo cammino, essendo quelle arche grandi di marmo, che oggi sono in Santa Reparata, e molte altre dintorno a San Giovanni, ed egli essendo tra le colonne del porfido che vi sono e quelle arche e la porta di San Giovanni, che serrata era, messer Betto con sua brigata a caval venendo su per la piazza di Santa Reparata, veggendo Guido là tra quelle sepolture, dissero: «Andiamo a dargli briga»; e spronati i cavalli a guisa d’uno assalto sollazzevole gli furono, quasi prima che egli se ne avvedesse, sopra, e cominciarongli a dire: «Guido tu rifiuti d’esser di nostra brigata; ma ecco, quando tu arai trovato che Iddio non sia, che avrai fatto?»
A’ quali Guido, da lor veggendosi chiuso, prestamente disse: «Signori, voi mi potete dire a casa vostra ciò che vi piace»; e posta la mano sopra una di quelle arche, che grandi erano, sì come colui che leggerissimo era, prese un salto e fussi gittato dall’altra parte, e sviluppatosi da loro se n’andò.
Costoro rimaser tutti guatando l’un l’altro, e cominciarono a dire che egli era uno smemorato e che quello che egli aveva risposto non veniva a dir nulla, con ciò fosse cosa che quivi dove erano non avevano essi a far più che tutti gli altri cittadini, né Guido meno che alcun di loro.
Alli quali messer Betto rivolto disse: «Gli smemorati siete voi, se voi non l’avete inteso. Egli ci ha detta onestamente in poche parole la maggior villania del mondo; per ciò che, se voi riguardate bene, queste arche sono le case de’ morti, per ciò che in esse si pongono e dimorano i morti; le quali egli dice che sono nostra casa, a dimostrarci che noi e gli altri uomini idioti e non litterati siamo, a comparazion di lui e degli altri uomini scienziati, peggio che uomini morti, e per ciò, qui essendo, noi siamo a casa nostra».
Allora ciascuno intese quello che Guido aveva voluto dire e vergognossi né mai più gli diedero briga, e tennero per innanzi messer Betto sottile e intendente cavaliere.
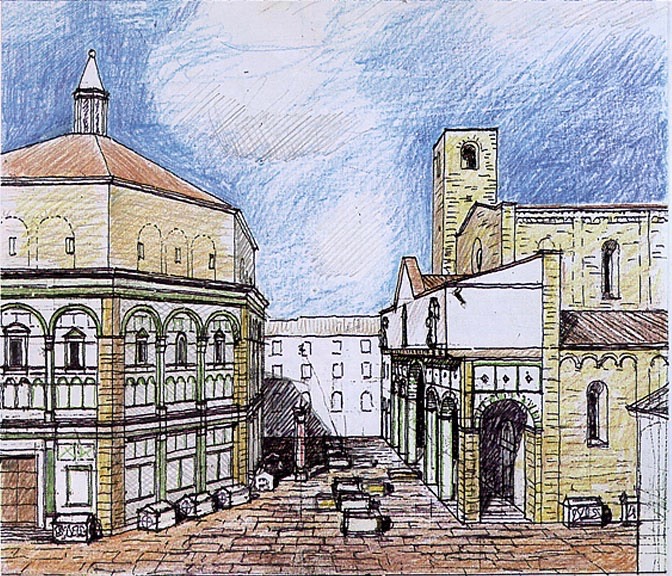
La piazza cimitero interposta tra Battistero e Basilica alla fine del XIII secolo, descritta nella novella su Guido Cavalcanti
Dovete sapere che in passato nella nostra città ci furono delle usanze bellissime e molto lodevoli, di cui oggi non ne è rimasta neppure una, grazie al fatto che l’avarizia, naturalmente insieme all’aumentata ricchezza, le ha bandite. Tra queste ve n’era una per cui in diversi luoghi si radunavano un certo numero di uomini nobili delle varie contrade cittadine e si univano in gruppi di un certo numero di persone, preoccupandosi di accogliervi solo quanti potessero sostenere agevolmente le spese, e una volta per uno offrivano il pranzo, ognuno nel suo giorno stabilito, a tutta la brigata. E in essa spesso invitavano nobili forestieri, quando per caso si trovavano a Firenze, ed anche altri rispettabili concittadini: gli appartenenti a questi gruppi si vestivano in modo simile almeno una volta l’anno, e insieme durante le feste cavalcavano per la città, duellavano e si esercitavano con le armi, soprattutto nelle festività più importanti o quando giungeva in città una lieta notizia di una vittoria militare o altro di notevole riguardante la città.
Tra queste brigate vi era quella di Betto Brunelleschi, nella quale lo stesso Betto ed i suoi compagni s’erano ingegnati di farvi partecipare Guido, figlio di messer Cavalcante de’ Cavalcanti, e non senza motivo: infatti egli era uno dei maggiori pensatori del mondo e un ottimo filosofo naturalista (di queste virtù la brigata poco si interessava), inoltre fu persona molto eloquente nel parlare e ogni cosa che volesse fare adatta ad un nobile egli la seppe fare in modo migliore di ogni altro; oltre a ciò era ricchissimo e quanto più si può richiedere sapeva onorare chi riteneva ne fosse degno. Ma messer Betto non era mai riuscito ad averlo nella propria compagnia, e pensava, insieme ai suoi compagni, che ciò fosse dovuto per il fatto che Guido, spesso dedicandosi a profonde riflessioni, si allontanasse molto dagli altri uomini, e siccome protendeva molto per le teorie degli epicurei, si chiacchierava tra il popolino che tutti i suoi pensieri tendessero a cercare di provare l’inesistenza di Dio.
Un giorno Guido, partito da Orto San Michele e camminando per il corso degli Adimari, era giunto al Battistero di San Giovanni, percorso abituale per lui; intorno a San Giovanni c’erano grandi sarcofagi di marmo, che oggi sono a Santa Reparata, e molti altri; mentre Guido si trovava tra le colonne di porfido, i sarcofagi e la porta del Battistero chiusa, passarono per piazza Santa Reparata messer Betto e i suoi compagni che vedendo Guido tra quei sarcofagi dissero: «Andiamo a dargli fastidio» e, dato lo sprone ai cavalli, come in un assalto scherzoso, gli furono addosso prima che lo stesso se ne accorgesse e gli cominciarono a dire: «Guido, tu ti rifiuti di esser parte della nostra compagnia; ma una volta che hai dimostrato l’inesistenza di Dio cosa ci guadagni?»
A loro Guido, vedendo da loro chiuso, subito rispose: «Signori, voi a casa vostra mi potete dire tutto quello che volete» e messa la mano sopra un’arca, poiché era leggerissimo, con un balzo si gettò dall’altra parte e, liberatosi di loro, se ne andò.
Questi rimasero attoniti, guardandosi l’un con l’altro e cominciarono a considerarlo pazzo e che la sua risposta non significava nulla, poiché là dov’erano non era di più di loro di quanto non fosse dello stesso Guido:
A loro rispose messer Betto: «I pazzi siete voi, che non l’avete capito: egli in modo garbato e in poche parole ci ha recato un’offesa più grande del mondo perché, se poneste bene attenzione, questi sarcofagi sono le case dei morti, in quanto in essi riposano i morti, e ci dice che sono la nostra casa, dimostrandoci che noi e gli altri uomini siamo ignoranti e non colti a differenza di lui e degli altri intellettuali, e quindi peggio dei morti e perciò, in mezzo ai sarcofagi, siamo a casa nostra».
Allora tutti capirono cosa Guido intendesse dire e si vergognarono e non gli diedero più fastidio e considerarono da quel momento in poi messer Betto un cavaliere intelligente ed acuto.
La novella ha certamente come antecedente il canto X dell’Inferno dantesco: ne sono spia la presenza delle arche e quella dell’epicureo Cavalcanti; ma nondimeno il Boccaccio tiene presente anche il Villani, autore di una cronaca della città di Firenze in cui il poeta fiorentino appare sdegnoso e solitario, ma innamorato profondamente degli studi filosofici.
Con questi elementi Boccaccio costruisce la sua novella che possiamo analizzare a partire dal rimpianto del bel tempo antico, impossibile al presente a causa della ricchezza e dell’avarizia (topos della cultura trecentesca fiorentina), dove vi regnava una allegra socialità fatta di nobili giovani che dominavano con la cortesia la vita raffinata di Firenze. Quindi la presentazione di Betto (Benedetto) Brunelleschi, uno dei più eminenti rappresentanti del partito guelfo, il quale, da giovane nobile, dedito a divertimenti cavallereschi, ma anche da fine intellettuale, vorrebbe inserire nella sua compagnia il maggiore intellettuale allora esistente, appunto Cavalcanti ma, sottolinea Boccaccio, come forma di prestigio, più che per le sue qualità.

Manoscritto del Decameron dove viene rappresentato l’incontro di Betto Brunelleschi e Guido Cavalcanti
Qui entra in gioco Dante a dar forma all’idea boccacciana di Cavalcanti: riprende il paesaggio infernale delle tombe infuocate e le pone realisticamente sul suolo, tra l’Orto di San Giovanni ed il Battistero, dove effettivamente erano; gli dà l’appellativo di epicureo ed è proprio nel girone degli epicurei che Dante inserisce il papà di Guido, ma per parlare del figlio. Ma a Boccaccio serve anche Villani, che lo disegna come un asociale che sdegna i divertimenti dei suoi coetanei.
La battuta criptica che guido fa alla brigata di Betto diventa una vera e propria sfida all’intelligenza e se l’autore del Decameron si astiene dal giudicare l’uomo, non può fare a meno di ammirare (per meglio dire farci ammirare attraverso il suo scritto) la profonda capacità di “giocare con le parole” attraverso la metafora della mancanza di cultura come morte.
SETTIMA GIORNATA
La settima giornata viene affidata a Dioneo, il più irriverente tra i dieci novellatori: infatti spetta a lui la libertà di poter uscire dal tema proposto, e, quasi sempre, ogni suo racconto presenta il tema dell’eros, come fattore di libertà e di piacevolezza. Non vi è nella sua figura alcuna cosa che lo allontani dall’idealizzazione della brigata, viceversa, il suo novellare, spesso, porta equilibrio tra i ragazzi (si pensi alla quarta giornata, dove il senso del pathos domina, e Dioneo che narra una storia divertente di un amante nascosto in una tomba, rubata da due ladri). D’altra parte è lo stesso suo nome a portare questa ventata di naturalità sessuale, infatti Dioneo sembra derivi da Dioniso, dio dell’ebbrezza e dell’eccesso. Il tema da lui scelto è in linea con quanto detto: delle beffe, le quali, o per amore o per salvamento di loro, le donne hanno già fatte à lor mariti, senza esserne avveduti o sì.
La novella che segue ci è raccontata da Filostrato, che la premette da una considerazione generale: se si sa che gli uomini si fanno gioco delle mogli, può anche accadere che qualche donna si faccia beffe del marito: di questo le donne dovrebbero essere contente non solo nel saperlo, ma anche nel ridirlo, tanto che infine si sappia, da entrambi le parti, che tutti conoscono tutti, tanto da far sì che ci sia più attenzione (e forse rispetto) da parte di tutti.
PERONELLA METTE UN SUO AMANTE IN UN DOGLIO, TORNANDO IL MARITO A CASA; IL QUALE AVENDO IL MARITO VENDUTO, ELLA DICE CHE VENDUTO L’HA AD UNO CHE DENTRO V’E’ A VEDERE SE SALDO GLI PARE. IL QUALE SALTATONE FUORI, IL FA RADERE AL MARITO, E POI PORTARSENELO A CASA SUA.
(VII, 2)

Illustrazione in un codice del Decameron
Egli non è ancora guari che in Napoli un povero uomo prese per moglie una bella e vaga giovinetta chiamata Peronella, ed esso con l’arte sua, che era muratore, ed ella filando, guadagnando assai sottilmente, la lor vita reggevano come potevano il meglio. Avvenne che un giovane de’ leggiadri, veggendo un giorno questa Peronella e piacendogli molto, s’innamorò di lei, e tanto in un modo e in uno altro la sollicitò, che con esso lei si dimesticò. E a potere essere insieme presero tra sé questo ordine: che, con ciò fosse cosa che il marito di lei si levasse ogni mattina per tempo per andare a lavorare o a trovar lavorio, che il giovane fosse in parte che uscir lo vedesse fuori; ed essendo la contrada, che Avorio si chiama, molto solitaria, dove stava, uscito lui, egli in casa di lei se n’entrasse; e così molte volte fecero.

Angela Luce nelle vesti di Peronella nel Decameron di Pasolini (1971)
Ma pur tra l’altre avvenne una mattina che, essendo il buono uomo fuori uscito, e Giannello Scrignario, ché così aveva nome il giovane, entratogli in casa e standosi con Peronella, dopo alquanto, dove in tutto il dì tornar non soleva, a casa se ne tornò, e trovato l’uscio serrato dentro, picchiò, e dopo il picchiare cominciò seco a dire: «O Iddio, lodato sia tu sempre; ché, benché tu m’abbi fatto povero, almeno m’hai tu consolato di buona e onesta giovane di moglie. Vedi come ella tosto serrò l’uscio dentro, come io ci uscii, acciò che alcuna persona entrar non ci potesse che noia le desse».
Peronella, sentito il marito, ché al modo del picchiare il conobbe, disse: «Ohimè, Giannel mio, io son morta, ché ecco il marito mio, che tristo il faccia Iddio, che ci tornò, e non so che questo si voglia dire, ché egli non ci tornò mai più a questa otta; forse che ti vide egli quando tu c’entrasti. Ma, per l’amore di Dio, come che il fatto sia, entra in cotesto doglio che tu vedi costì, e io gli andrò ad aprire, e veggiamo quello che questo vuol dire di tornare stamane così tosto a casa».
Giannello prestamente entrò nel doglio, e Peronella andata all’uscio aprì al marito, e con un malviso disse: «Ora questa che novella è, che tu così tosto torni a casa stamane? Per quello che mi paia vedere, tu non vuogli oggi far nulla, ché io ti veggio tornare co’ ferri tuoi in mano; e, se tu fai così, di che viverem noi? Onde avrem noi del pane? Credi tu che io sofferi che tu m’impegni la gonnelluccia e gli altri miei pannicelli? che non fo il dì e la notte altro che filare, tanto che la carne mi s’è spiccata dall’unghia, per potere almeno aver tanto olio che n’arda la nostra lucerna. Marito, marito, egli non ci ha vicina che non se ne maravigli e che non facci beffe di me di tanta fatica quanta è quella che io duro; e tu mi torni a casa con le mani spenzolate, quando tu dovresti esser a lavorare».
E così detto, incominciò a piagnere e a dir da capo: «Ohimè, lassa me, dolente me, in che mal’ora nacqui, in che mal punto ci venni! ché avrei potuto avere un giovane così da bene e nol volli, per venire a costui che non pensa cui egli s’ha recata a casa. L’altre si danno buon tempo con gli amanti loro, e non ce n’ha niuna che non n’abbia chi due e chi tre, e godono e mostrano a’ mariti la luna per lo sole; e io, misera me!, perché son buona e non attendo a così fatte novelle, ho male e mala ventura; io non so perché io non mi pigli di questi amanti come fanno l’altre. Intendi sanamente, marito mio, che se io volessi far male, io troverrei ben con cui, ché egli ci son de’ ben leggiadri che m’amano e voglionmi bene e hannomi mandato proferendo di molti denari, o voglio io robe o gioie, né mai mel sofferse il cuore, per ciò che io non fui figliuola di donna da ciò; e tu mi torni a casa quando tu dei essere a lavorare».
Disse il marito: «Deh donna, non ti dar malinconia, per Dio; tu dei credere che io conosco chi tu se’, e pure stamane me ne sono in parte avveduto. Egli è il vero ch’io andai per lavorare, ma egli mostra che tu nol sappi, come io medesimo nol sapeva: egli è oggi la festa di santo Galeone, e non si lavora, e per ciò mi sono tornato a questa ora a casa; ma io ho nondimeno proveduto e trovato modo che noi avremo del pane per più d’un mese, ché io ho venduto a costui, che tu vedi qui con meco, il doglio, il quale tu sai che, già è cotanto, ha tenuta la casa impacciata, e dammene cinque gigliati».
Disse allora Peronella: «E tutto questo è del dolor mio: tu che se’ uomo e vai attorno, e dovresti sapere delle cose del mondo, hai venduto un doglio cinque gigliati, il quale io feminella che non fu’ mai appena fuor dell’uscio, veggendo lo ‘mpaccio che in casa ci dava, l’ho venduto sette ad un buono uomo, il quale, come tu qui tornasti, v’entrò dentro per vedere se saldo era».
Quando il marito udì questo, fu più che contento, e disse a colui che venuto era per esso: «Buon uomo, vatti con Dio; ché tu odi che mia mogliere l’ha venduto sette, dove tu non me ne davi altro che cinque».
Il buono uomo disse: «In buona ora sia»; e andossene.
E Peronella disse al marito: «Vien su tu, poscia che tu ci se’, e vedi con lui insieme i fatti nostri».
Giannello, il quale stava con gli orecchi levati per vedere se di nulla gli bisognasse temere o provvedersi, udite le parole di Peronella, prestamente si gittò fuor del doglio, e quasi niente sentito avesse della tornata del marito, cominciò a dire: «Dove se’, buona donna?» Al quale il marito, che già veniva, disse: «Eccomi, che domandi tu?»
Disse Giannello: «Qual se’ tu? Io vorrei la donna con la quale io feci il mercato di questo doglio».
Disse il buono uomo: «Fate sicuramente meco, ché io son suo marito».
Disse allora Giannello: «Il doglio mi par ben saldo, ma egli mi pare che voi ci abbiate tenuta entro feccia, ché egli è tutto impiastricciato di non so che cosa sì secca, che io non ne posso levar con l’unghie, e però nol torrei se io nol vedessi prima netto».
Disse allora Peronella: «No, per quello non rimarrà il mercato; mio marito il netterà tutto».
E il marito disse: «Sì bene»; e posti giù i ferri suoi, e ispogliatosi in camicione, si fece accendere un lume e dare una radimadia, e fuvvi entrato dentro e cominciò a radere. E Peronella, quasi veder volesse ciò che facesse, messo il capo per la bocca del doglio, che molto grande non era, e oltre a questo l’un de’ bracci con tutta la spalla, cominciò a dire: – «Radi quivi, e quivi, e anche colà»; e: «Vedine qui rimaso un micolino».
E mentre che così stava e al marito insegnava e ricordava, Giannello, il quale appieno non aveva quella mattina il suo disidero ancor fornito quando il marito venne, veggendo che come volea non potea, s’argomentò di fornirlo come potesse; e a lei accostatosi, che tutta chiusa teneva la bocca del doglio, e in quella guisa che negli ampi campi gli sfrenati cavalli e d’amor caldi le cavalle di Partia assaliscono, ad effetto recò il giovinil desiderio, il quale quasi in un medesimo punto ebbe perfezione e fu raso il doglio, ed egli scostatosi, e la Peronella tratto il capo del doglio, e il marito uscitone fuori.
Per che Peronella disse a Giannello: «Te’ questo lume, buono uomo, e guata se egli è netto a tuo modo».
Giannello, guardatovi dentro, disse che stava bene, e che egli era contento; e datigli sette gigliati, a casa sel fece portare.
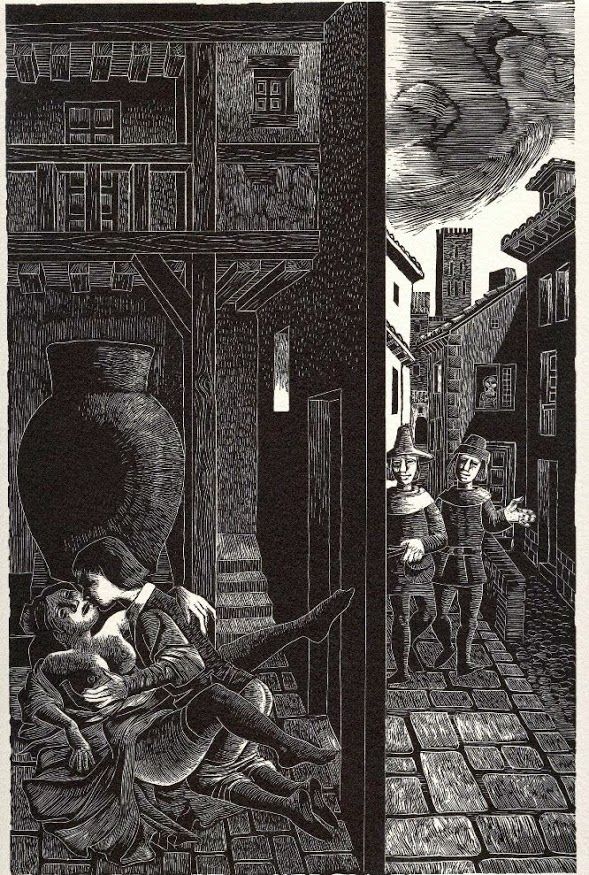
Celedonio Perellón: Peronella (2005)
Non è passato molto tempo da quando a Napoli un povero uomo prese per moglie una bella e amabile giovinetta il cui nome era Peronella. Essi, ognuno con il proprio lavoro, lui il muratore, lei la filatrice, guadagnando assai poco, cercavano di tirare al meglio la loro vita. Un giorno avvenne che un giovane tra i più galanti, vedendo Peronella e piacendogli molto, se ne innamorò e ora in un modo ora in un altro tanto la corteggiò che infine prese dimestichezza con lei. Per poter stare insieme i due decisero che, dal momento che il marito per andare a lavorare si alzava ogni mattina piuttosto presto, il giovane si mettesse in una parte per vederlo senza essere a sua volta visto ed essendo la strada, chiamata via Arborio, piuttosto isolata, una volta uscito lui entrasse in casa di Peronella e così più volte fecero.
Tuttavia un giorno accadde che, essendo il buon uomo uscito e Giannello Scrignario, questo era il nome del giovane amante, stando in casa insieme a Peronella, dopo un po’ tornò a casa, cosa che di solito non succedeva mai. Trovata la porta chiusa e dopo aver bussato tra sé disse: «O Signore, sii sempre tu lodato! Sebbene mi abbia fatto povero, almeno mi hai consolato con una bella e onesta moglie! Guarda come si è chiusa dentro non appena sono uscito, affinché non potesse entrare nessuno che le desse noia».
Peronella, sentendo il marito, riconosciuto dal suo modo di bussare, disse: «Povera me! Giannello mio, sono morta che è tornato mio marito, gli venga un accidente e non so che cosa dire, visto che non è mai arrivato a quest’ora, forse ti ha visto quando sei entrato! Ma, per amor di Dio, comunque stiano le cose, entra in questa botte qui, che vado ad aprirgli, e vediamo cosa a dire per essere tornato così presto questa stamattina.»
Giannello entrò subito nella botte e Peronella, raggiunta la porta aprì e con voce adirata disse al marito: «Che novità è questa di tornare così presto a casa? Da quello che mi sembra di capire, tu oggi non vuoi lavorare, che ti vedo con i ferri in mano; se fai così, di cosa vivremo? come avremo noi il pane? credi che io non soffra a vederti impegnare la gonna e altri miei vestiti, che non faccio che filare notte e giorno, tanto che mi è staccata la carne dall’unghia, per poter avere almeno dell’olio per la nostra lanterna? Marito, marito, non c’è nessuna che non si meravigli e si faccia beffe di me, per tutta la fatica che mi tocca sopportare, che tu mi torni con le braccia penzoloni quando dovresti essere a lavorare». Detto questo cominciò a piangere e aggiunse: «Povera me! Disgraziata! Che tempi mi tocca vivere, sotto quale cattiva stella sono nata! Che avrei potuto avere un giovane a posto e non l’ho voluto, per prendere costui che non pensa a chi si è portato in casa! Le altre si divertono con gli amanti e non ce n’è nessuna che non ne abbia almeno due o tre, e godono e fanno scambiano ai loro mariti la luna per il sole; ed io, poiché sono onesta, e non faccio tali storie, mi capitano disgrazie e sfortuna, non so perché non mi prenda anch’io degli amanti come tutte l’altre! Capisci bene, marito mio, che se volessi far del male, lo troverei e so anche con chi, perché ci sono dei galanti che mi amano e mi hanno promesso molti soldi o vestiti e gioielli; ma non ho mai ceduto, che non sono nata da una donna volgare; e tu che, torni a casa quando dovresti lavorare!»
Disse il marito: «Su, donna mia, non rattristarti, per Dio! E’ pur vero che io ero andato a lavorare, ma è evidente che tu non lo sapevi, come io non sapevo. Oggi è la festa di San Galeone e non si lavora e per questo sono tornato a casa; ma io ci ho pensato e trovato il modo di avere il pane per più di un mese, perché io venduto a quest’uomo, che tu vedi qui con me, la botte, che sai che è d’impiccio nella nostra casa, e me ne dà cinque gigliati».
Disse allora Peronella: «Anche tutto ciò è causa del dolore mio: tu che sei un uomo e che dovresti sapere quali siano i prezzi del mercato, hai venduto una botte per cinque gigliati, che io povera donna che non sono mai stata fuori di casa mia, l’ho venduto a sette gigliati a un buon uomo che, quando stavi per tornare, vi entrò dentro per vedere se fosse resistente.
Quando il marito sentì questo, fu più contento che mai e disse a colui che era venuto a comprarlo: «Buon uomo, va con Dio, che hai sentito che mia moglie l’ha venduto per sette, mentre tu non me ne volevi dare che cinque».
Rispose il buon uomo: «Sta bene» e andò via.
E Peronella disse al marito: «Dai vieni dentro, visto che ci sei, e vedi con lui i soldi che ti deve dare».
Giannetto, che stava con le orecchie rizzate per capire se dovesse temere qualcosa o prendere dei provvedimenti adatti alla situazione, sentite le parole di Peronella, subito si gettò fuori dalla botte e come se non avesse sentito affatto il ritorno del marito, cominciò a dire: «Dove sei, buona donna?»
A lui il marito, che si avvicinava, disse: «Eccomi, che mi dici?»
Giannello: «Chi sei tu? vorrei la donna con la quale stavo contrattando questa botte»
Disse il buon uomo: «Trattate sicuramente con me, che sono suo marito».
Disse allora Giannello: «La botte mi sembra abbastanza resistente, ma mi sembra che dentro voi ci abbiate tenuto della melma, che è tutto impiastricciato di non so che di secco, che non riesco a scalfire con le unghie, e perciò non lo voglio se prima non risulterà pulito».
Disse allora Peronella: «No, per questo non rimarrà invenduto, mio marito lo pulirà tutto».
E il marito: «Bene», e poggiati gli attrezzi di lavoro in terra e messosi in maniche di camicia, si fece accendere una lanterna e dare un raschiatoio e, entrato dentro, cominciò a raschiare. E Peronella, quasi volesse vedere ciò che il marito facesse, messa la testa e un braccio con tutta la spalla sulla bocca della botte che molto grande non era, cominciò a dire: «Raschia qui e qui e là» e «Guarda qui, ce n’è un pochino anche qui».
E mentre che da quella posizione Peronella indicava e sottolineava al marito (dove operare) Giannello, che in quella mattina non aveva portato a termine il suo piacere, essendo arrivato il marito e considerando che non poteva esaudirlo nel modo desiderato, si adoperò di raggiungerlo come avrebbe potuto e, avvicinatosi a lei, che copriva con il corpo la testa della botte, in quel modo con cui cavalli in calore e pronti all’atto sessuale assalgono le cavalle di Partia, portò a compimento il giovanile piacere, che quasi nello stesso momento terminò mentre la botte fu pulita e il marito venne fuori.
Allora Peronella disse a Giannello: «Buon uomo, prendi questa lucerna e guarda se è pulita come la desideravi».
Giannello, guardato dentro, disse che andava bene e che rimaneva soddisfatto; e datigli sette gligliati si fece portare la botte a casa.

Alexander Daniloff: la novella di Peronella
La novella presenta il lato che nella fantasia popolare viene detto boccaccesco, o meglio quello dove l’eros viene esplicitato apertamente; ma anche qui il riferimento è classico, lo stesso episodio, infatti, lo ritroviamo nell’Asino d’oro o Metamorfosi di Apuleio. Esiste infatti nella letteratura greca e conosciuti da noi da quella latina (Petronio e appunto Apuleio) la fabula milesia la cui caratteristica è quella di essere un po’ lasciva, o meglio d’avere degli argomenti il cui riferimento sessuale è abbastanza diretto.
La capacità e l’originalità dell’autore toscano è quella di averla ambientata a Napoli, in un ambiente popolare i cui protagonisti emergono con forza con quelle caratteristiche care a Boccaccio: la stupidità del marito, infatti viene vinta dalla prontezza di Peronella che, con meno aulicità e capacità argomentativa, fa un’arringa al marito alla stregua di quella di Ghismunda al padre cui segue la capacità di Giannello di raggiungere il piacere interrotto. Arte delle parola ed eros, ambedue ottenuti grazie all’intelligenza, basta questo a Boccaccio per farne personaggi vincenti.
DUE SANESI AMANO UNA DONNA COMARE DELL’ALTRO; MUORE IL COMPARE E TORNA AL COMPAGNO SECONDO LA PROMESSA FATTAGLI, E RACCONTAGLI COME DI LA’ SI DIMORI.
(VII, 10)

Miniatura che ci illustra la novella di Tingoccio e Meuccio
Furono adunque in Siena due giovani popolari, de’ quali l’uno ebbe nome Tingoccio Mini e l’altro fu chiamato Meuccio di Tura, e abitavano in porta Salaia, e quasi mai non usavano se non l’un con l’altro, e per quello che paresse s’amavan molto; e andando, come gli uomini vanno, alle chiese e alle prediche, più volte udito avevano della gloria e della miseria che all’anime di coloro che morivano era, secondo li lor meriti, conceduta nell’altro mondo. Delle quali cose disiderando di saper certa novella, né trovando il modo, insieme si promisero che qual prima di lor morisse, a colui che vivo fosse rimaso, se potesse, ritornerebbe, e direbbegli novelle di quello che egli desiderava; e questo fermarono con giuramento.
Avendosi adunque questa promession fatta, e insieme continuamente usando, come è detto, avvenne che Tingoccio divenne compare d’uno Ambruogio Anselmini, che stava in Camporeggi, il qual d’una sua donna chiamata monna Mita aveva avuto un figliuolo. Il qual Tingoccio, insieme con Meuccio visitando alcuna volta questa sua comare, la quale era una bellissima e vaga donna, non ostante il comparatico, s’innamorò di lei; e Meuccio similmente, piacendogli ella molto e molto udendola commendare a Tingoccio, se ne innamorò. E di questo amore l’un si guardava dall’altro, ma non per una medesima cagione: Tingoccio si guardava di scoprirlo a Meuccio per la cattività che a lui medesimo pareva fare d’amare la comare, e sarebbesi vergognato che alcun l’avesse saputo; Meuccio non se ne guardava per questo, ma perché già avveduto s’era che ella piaceva a Tingoccio. Laonde egli diceva: «Se io questo gli discuopro, egli prenderà gelosia di me; e potendole ad ogni suo piacere parlare, sì come compare, in ciò che egli potrà le mi metterà in odio, e così mai cosa che mi piaccia di lei io non avrò».
Ora, amando questi due giovani, come detto è, avvenne che Tingoccio, al quale era più destro il potere alla donna aprire ogni suo disiderio, tanto seppe fare, e con atti e con parole, che egli ebbe di lei il piacere suo; di che Meuccio s’accorse bene; e quantunque molto gli dispiacesse, pure, sperando di dovere alcuna volta pervenire al fine del suo disidero, acciò che Tingoccio non avesse materia né cagione di guastargli o d’impedirgli alcun suo fatto, faceva pur vista di non avvedersene.
Così amando i due compagni, l’uno più felicemente che l’altro, avvenne che, trovando Tingoccio nelle possessioni della comare il terren dolce, tanto vangò e tanto lavorò che una infermità ne gli sopravenne, la quale dopo alquanti dì sì l’aggravò forte che, non potendola sostenere, trapassò di questa vita. E trapassato, il terzo dì appresso (ché forse prima non aveva potuto) se ne venne, secondo la promession fatta, una notte nella camera di Meuccio, e lui, il qual forte dormiva, chiamò.
Meuccio destatosi disse: «Qual se’ tu?»
A cui egli rispose: «Io son Tingoccio, il qual, secondo la promession che io ti feci, sono a te tornato a dirti novelle dell’altro mondo».
Alquanto si spaventò Meuccio veggendolo, ma pure rassicurato disse: «Tu sia il ben venuto, fratel mio»; e poi il domandò se egli era perduto.
Al qual Tingoccio rispose: «Perdute son le cose che non si ritruovano; e come sarei io in mei chi, se io fossi perduto?»
«Deh,» disse Meuccio «io non dico così ; ma io ti domando se tu se’ tra l’anime dannate nel fuoco pennace di ninferno».
A cui Tingoccio rispose: «Costetto no, ma io son bene, per li peccati da me commessi, in gravissime pene e angosciose molto».
Domandò allora Meuccio particularmente Tingoccio che pene si dessero di là per ciascun de’ peccati che di qua si commettono; e Tingoccio gliele disse tutte. Poi gli domandò Meuccio s’egli avesse di qua per lui a fare alcuna cosa. A cui Tingoccio rispose di sì, e ciò era che egli facesse per lui dir delle messe e delle orazioni e fare delle limosine per ciò che queste cose molto giovavano a quei di là, a cui Meuccio disse di farlo volentieri.
E partendosi Tingoccio da lui, Meuccio si ricordò della comare, e sollevato alquanto il capo disse: «Ben che mi ricorda, o Tingoccio: della comare, con la quale tu giacevi quando eri di qua, che pena t’è di là data?»
A cui Tingoccio rispose: «Fratel mio, come io giunsi di là, sì fu uno, il qual pareva che tutti i miei peccati sapesse a mente, il quale mi comandò che io andassi in quel luogo nel quale io purgo in grandissima pena le colpe mie, dove io trovai molti compagni a quella medesima pena condennati che io; e stando io tra loro, e ricordandomi di ciò che già fatto avea con la comare e aspettando per quello troppo maggior pena che quella che data m’era, quantunque io fossi in un gran fuoco e molto ardente, tutto di paura tremava. Il che sentendo un che m’era dal lato, mi disse: “Che hai tu più che gli altri che qui sono, che triemi stando nel fuoco?” “Oh,” diss’io “amico mio, io ho gran paura del giudicio che io aspetto d’un gran peccato che io feci già”. Quegli allora mi domandò che peccato quel fosse. A cui io dissi: “Il peccato fu cotale, che io mi giaceva con una mia comare, e giacquivi tanto che io me ne scorticai”. Ed egli allora, faccendosi beffe di ciò, mi disse: “Va, sciocco, non dubitare; ché di qua non si tiene ragione alcuna delle comari; il che io udendo tutto mi rassicurai”.
E detto questo, appressandosi il giorno, disse: «Meuccio, fatti con Dio, ché io non posso più esser con teco»; e subitamente andò via.
Meuccio, avendo udito che di là niuna ragione si teneva delle comari, cominciò a far beffe della sua sciocchezza, per ciò che già parecchie n’avea risparmiate; per che, lasciata andar la sua ignoranza, in ciò per innanzi divenne savio.

Tingoccio nel Decameron di Pasolini (1971)
A Siena vissero due giovani popolani, uno dei quali si chiamò Tingoccio Mini, l’altro Meuccio di Tura, e abitavano entrambi a Porta Salaia, e non si frequentavano che fra di loro e sembra si volessero molto bene. E poiché andavano, come fanno tutti gli uomini, in chiesa a sentire le prediche, più volte avevano sentito della gloria e delle pene che era concessa alle anime di coloro che morivano, sulla base dei loro peccati. Di questo fatto, volendo esser sicuri né potendo trovare altro modo, promisero fra di loro che chi dei due prima morisse, se gli fosse stato possibile, sarebbe tornato e gli avrebbe riferito quello che l’altro desiderava sapere; e stabilirono questo con un giuramento.
Dopo aver fatto questa promessa, continuando a frequentarsi, successe che Tingoggio divenne compare di Ambrogio Anselmini, che abitava nella contrada di Camporeggi, che aveva avuto un figlio da sua moglie, chiamata monna Mita. Tingoccio, visitando insieme a Meuccio questa comare, che era bellissima e molto desiderabile, nonostante il rapporto di parentela, s’innamorò; lo stesso capitò a Meuccio, piacendogli molto e sentendo tutte le lodi che Tangoccio le rivolgeva. E questo amore lo tenevano segreto anche fra loro, ma non per lo stesso motivo: Tingoccio si guardava di dirlo a Meuccio per il grave peccato che lui stesso reputava per sé amando la comare e si sarebbe vergognato se qualcuno l’avesse scoperto; Meuccio non per questo, ma perché si era già accorto che lei piaceva a Tingoccio, per cui fra sé diceva: «Se io gli rivelo che so (che lui la desidera), s’ingelosirà di me e potendole parlare a suo piacimento, essendole compare, farà in modo che lei mi odii, tanto da non avere più alcuna cosa che mi piaccia di lei».
Così come detto, essendo i due amici innamorati, successe che Tingoccio, al quale era più semplice svelare il proprio desiderio alla donna, tanto seppe fare che sia con gesti che con parole riuscì a conquistarla. Di questo s’accorse Meuccio e sebbene provasse molto dispiacere, pure, sperando che un giorno potesse anche lui raggiungere il suo desiderio, affinché Tingoccio non avesse né ragione né motivo di guastargli o impedirgli qualcosa, fece finta di non sapere nulla.
Così essendo innamorati entrambi, sebbene uno con più soddisfazioni, successe che Tingoccio, trovando nella comare un terreno estremamente fertile, tanto infilò la zappa e tanto la dissodò che ne cadde malato, e tale infermità si aggravò molto che non potendola più combattere, nel giro di tre giorni morì. Dopo altri tre giorni, poiché forse non aveva potuto prima, come aveva promesso una notte giunse nella camera di Meuccio, che dormiva profondamente, e lo chiamò.
Meuccio svegliatosi disse: «Chi sei?»
A cui rispose: «Sono Tingocco e secondo la promessa che ti ho fatto, sono tornato a darti notizie dell’aldilà»
Meuccio, vedendolo, dapprima si spaventò molto, ma dopo essersi rassicurato disse: «Tu sei il benvenuto, fratello mio!» e poi gli chiese se fosse perduto (nel senso di dannato).
A cui Tingoccio rispose: «Perdute sono le cose che non si trovano più, e come sarei in me stesso se fossi perduto?»
«Ah», disse Meuccio, «ma io non intendevo in quel senso, ma ti chiedo se tu sei tra le anime dannate nel fuoco eterno dell’inferno».
A cui Tingoccio rispose: «Questo no, ma io, per i molti peccati da me commessi, mi trovo giustamente in pene grandissime e piene d’angoscia».
Meuccio gli domandò più precisamente quali fossero queste pene per i peccati commessi in terra e Tingoccio glieli disse tutti. Poi gli chiese se poteva fare qualcosa per lui e Tingoccio gli disse di sì, e cioè di far fare delle messe in suo suffragio, e pregare e fare l’elemosina, perché questi gesti erano molto considerati da quelli di lassù, e Meuccio gli rispose che avrebbe fatto tutto ciò volentieri.
Quando Tingoccio stava per andarsene, Meuccio si ricordò della comare e, sollevata la testa gli disse: «Bene, ora che mi ricordo, Tingoccio: per la comare con la quali facevi l’amore, che pena ti hanno assegnata?»
A cui Tingoccio: «Fratello mio, come arrivai di là, c’era uno che sembrava conoscesse tutti i miei peccati, che mi comandò d’andare in un luogo in cui, con grandissima pena, piansi tutti i miei peccati e dove trovai molti compagni con la medesima pena che mi era stata attribuita; mentre stavo con loro, ricordandomi della comare e aspettandomi per questo una pena maggiore di quella che stavo scontando, sebbene fossi in un gran fuoco e molto bruciato, tremavo completamente per paura. Vedendo questo, uno che mi era a fianco, mi disse: “Che hai tu di più di questi qua, che stai tremando in mezzo al fuoco?”, “Oh”, gli risposi “amico mio, io ho una gran paura del giudizio che mi attende per un peccato che io ho fatto”. Mi domandò allora che peccato fosse, a cui risposi: «Il peccato fu questo: che io facevo l’amore con mia comare e lo feci in modo talmente spesso da rimanerci” E lui, prendendomi in giro per questo, mi disse: «Va, stupido, non preoccuparti che qui non gliene frega niente delle comari!” e io, sentendolo, mi tranquillizzai». E detto questo, facendosi già quasi mattino, disse: «Meuccio, va’ con Dio, che io non posso più rimanere con te» e immediatamente sparì.
Meuccio, dopo aver sentito che non si dava alcuna importanza alle comari. cominciò a pensare alla sua dabbenaggine, dal momento in cui ne aveva risparmiate tante (di comari). Perciò, messa da parte l’ignoranza, si comportò saggiamente.

Meuccio nel Decameron di Pasolini (1971)
La novella, ambientata a Siena, ci mostra un ambiente popolare, con protagonisti due amici ed uno stesso oggetto del desiderio. Il triangolo costruito qui da Boccaccio ha una forma un po’ particolare: non si tratta di un marito beffato, o di un padre (o fratelli) traditi dall’intemperanza della figura femminile, ma di un rapporto, all’inizio quasi paritario, verso lo stesso oggetto del desiderio, lasciato sullo sfondo.
L’etica vincente non è quella erotica, ma quella amicale, con aspetti interessanti di gelosia: Tingoccio riesce a farsi monna Mita, ma non dice niente all’amico, perché? Forse non vuole offenderlo nell’apparire “più bravo di lui”; Meuccio sa quello che Tingoccio fa con la comare, ma non lo svela: perché? Forse ne è geloso, e aspetta l’occasione buona per fregarlo. C’è insomma qualcosa di torbido in questa amicizia virile, che si dissolve nella scena del sogno. Forse per leggere la sequenza dovremo ricorrere alla psicologia e vedere in essa la proiezione di Meuccio verso l’esuberanza erotica dell’amico e quindi la stessa possibilità, ora che non c’è più, di emularlo.
OTTAVA GIORNATA
L’ottava giornata è governata da Lauretta, la quale ha dettato come tema il seguente: si ragiona di quelle beffe che tutto il giorno o donna ad uomo o uomo a donna o l’uno uomo all’altro di fanno.
La prima novella che si racconta sulla figura di Calandrino è di Elissa:
CALANBRINO, BRUNO E BUFFALMACCO GIU’ PER LO MUGNONE VANNO CERCANDO DI TROVAR L’ELITROPIA, E CALANDRINO SE LA CREDE AVER TROVATA; TORNASI A CASA CARICO DI PIETRE; LA MOGLIE IL PROVERBIA, ED EGLI TURBATO LA BATTE, E A’ SUOI COMPAGNI RACCONTA CIO’ CHE ESSI SANNO MEGLIO DI LUI.
(VIII,3)

Alberto Cascione: Calandrino e l’elitropia (2016)
Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di nuove genti è stata abondevole, fu, ancora non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino, uom semplice e di nuovi costumi. Il quale il più del tempo con due altri dipintori usava, chiamati l’un Bruno e l’altro Buffalmacco, uomini sollazzevoli molto, ma per altro avveduti e sagaci, li quali con Calandrino usavan per ciò che de’ modi suoi e della sua simplicità sovente gran festa prendevano. Era similmente allora in Firenze un giovane di maravigliosa piacevolezza, in ciascuna cosa che far voleva astuto e avvenevole, chiamato Maso del Saggio; il quale, udendo alcune cose della simplicità di Calandrino, propose di voler prender diletto de’ fatti suoi col fargli alcuna beffa, o fargli credere alcuna nuova cosa.
E per avventura trovandolo un dì nella chiesa di San Giovanni, e vedendolo stare attento a riguardar le dipinture e gl’intagli del tabernacolo il quale è sopra l’altare della detta chiesa, non molto tempo davanti postovi, pensò essergli dato luogo e tempo alla sua intenzione; e informato un suo compagno di ciò che fare intendeva, insieme s’accostarono là dove Calandrino solo si sedeva, e faccendo vista di non vederlo, insieme cominciarono a ragionare delle virtù di diverse pietre, delle quali Maso così efficacemente parlava come se stato fosse un solenne e gran lapidario. A’ quali ragionamenti Calandrino posto orecchie, e dopo alquanto levatosi in pié, sentendo che non era credenza, si congiunse con loro; il che forte piacque a Maso; il quale, seguendo le sue parole, fu da Calandrin domandato dove queste pietre così virtuose si trovassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de’ baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce, e avevasi un’oca a denaio e un papero giunta, ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva; e ivi presso correva un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi entro gocciol d’acqua.
«Oh», disse Calandrino «cotesto è buon paese; ma dimmi, che si fa de’ capponi che cuocon coloro?»
Rispose Maso: «Mangiansegli i baschi tutti».
Disse allora Calandrino: «Fostivi tu mai»?
A cui Maso rispose: «Di’ tu se io vi fu’ mai? Sì vi sono stato così una volta come mille».
Disse allora Calandrino: «E quante miglia ci ha?»
Maso rispose: «Haccene più di millanta, che tutta notte canta».
Disse Calandrino: «Dunque dee egli essere più là che Abruzzi».
«Sì bene», rispose Maso «si è cavelle».
Calandrino semplice, veggendo Maso dir queste parole con un viso fermo e senza ridere, quella fede vi dava che dar si può a qualunque verità più manifesta, e così l’aveva per vere, e disse: «Troppo ci è di lungi a’ fatti miei, ma se più presso ci fosse, ben ti dico che io vi verrei una volta con essoteco, pur per veder fare il tomo a quei maccheroni, e tormene una satolla. Ma dimmi, che lieto sie tu, in queste contrade non se ne truova niuna di queste pietre cosė virtuose?»
A cui Maso rispose: «Sì, due maniere di pietre ci si truovano di grandissima virtù: l’una sono i macigni da Settignano e da Montisci, per virtù de’ quali, quando son macine fatti, se ne fa la farina; e per ciò si dice egli in que’ paesi di là, che da Dio vengon le grazie e da Montisci le macine; ma ècci di questi macigni sì gran quantità, che appo noi è poco prezzata, come appo loro gli smeraldi, de’ quali v’ha maggior montagne che Monte Morello, che rilucon di mezza notte vatti con Dio; e sappi che chi facesse le macine belle e fatte legare in anella prima che elle si forassero e portassele al soldano, n’avrebbe ciò che volesse. L’altra si è una pietra, la quale noi altri lapidarii appelliamo elitropia, pietra di troppo gran vertù, per ciò che qualunque persona la porta sopra di sé, mentre la tiene, non è da alcuna altra persona veduto dove non è».
Allora Calandrin disse: «Gran virtù son queste; ma questa seconda dove si truova?»
A cui Maso rispose, che nel Mugnone se ne solevan trovare.
Disse Calandrino: «Di che grossezza è questa pietra? o che colore è il suo?»
Rispose Maso: «Ella è di varie grossezze, ché alcuna n’è più e alcuna meno, ma tutte son di colore quasi come nero».

Calandrino, avendo tutte queste cose seco notate, fatto sembianti d’avere altro a fare, si partì da Maso e seco propose di volere cercare di questa pietra; ma diliberò di non volerlo fare senza saputa di Bruno e di Buffalmacco, li quali spezialissimamente amava. Diessi adunque a cercar di costoro, acciò che senza indugio e prima che alcuno altro n’andassero a cercare, e tutto il rimanente di quella mattina consumò in cercargli.
Ultimamente, essendo già l’ora della nona passata, ricordandosi egli che essi lavoravano nel monistero delle donne di Faenza, quantunque il caldo fosse grandissimo, lasciata ogni altra sua faccenda, quasi correndo n’andò a costoro, e chiamatigli, così disse loro: «Compagni, quando voi vogliate credermi, noi possiamo divenire i più ricchi uomini di Firenze: per ciò che io ho inteso da uomo degno di fede che in Mugnone si truova una pietra, la qual chi la porta sopra non è veduto da niun’altra persona; per che a me parrebbe che noi senza alcuno indugio, prima che altra persona v’andasse, v’andassimo a cercare. Noi la troveremo per certo, per ciò che io la conosco; e trovata che noi l’avremo, che avrem noi a fare altro se non mettercela nella scarsella e andare alle tavole de’ cambiatori, le quali sapete che stanno sempre cariche di grossi e di fiorini, e torcene quanti noi ne vorremo? Niuno ci vedrà; e così potremo arricchire subitamente, senza avere tutto dì a schiccherare le mura a modo che fa la lumaca».
Bruno e Buffalmacco, udendo costui, fra se medesimi cominciarono a ridere, e guatando l’un verso l’altro fecer sembianti di maravigliarsi forte e lodarono il consiglio di Calandrino; ma domandò Buffalmacco, come questa pietra avesse nome.
A Calandrino, che era di grossa pasta, era già il nome uscito di mente, per che egli rispose: «Che abbiam noi a far del nome, poi che noi sappiam la virtù? A me parrebbe che noi andassomo a cercare senza star più».
«Or ben», disse Bruno «come è ella fatta?»
Calandrin disse: «Egli ne son d’ogni fatta, ma tutte son quasi nere; per che a me pare che noi abbiamo a ricogliere tutte quelle che noi vederem nere, tanto che noi ci abbattiamo ad essa; e per ciò non perdiamo tempo, andiamo».
A cui Bruno disse: «Or t’aspetta»; e volto a Buffalmacco disse: «A me pare che Calandrino dica bene; ma non mi pare che questa sia ora da ciò, per ciò che il sole è alto e dà per lo Mugnone entro e ha tutte le pietre rasciutte, per che tali paion testé bianche delle pietre che vi sono, che la mattina, anzi che il sole l’abbia rasciutte, paion nere; e oltre a ciò molta gente per diverse cagioni è oggi, che è dì di lavorare, per lo Mugnone, li quali vedendoci si potrebbono indovinare quello che noi andassimo faccendo, e forse farlo essi altressì, e potrebbe venire alle mani a loro, e noi avremmo perduto il trotto per l’ambiadura. A me pare, se pare a voi, che questa sia opera da dover fare da mattina, che si conoscon meglio le nere dalle bianche, e in dì di festa, che non vi sarà persona che ci vegga».
Buffalmacco lodò il consiglio di Bruno, e Calandrino vi s’accordò, e ordinarono che la domenica mattina vegnente tutti e tre fossero insieme a cercar di questa pietra; ma sopra ogn’altra cosa gli pregò Calandrino che essi non dovesser questa cosa con persona del mondo ragionare, per ciò che a lui era stata posta in credenza. E ragionato questo, disse loro ciò che udito avea della contrada di Bengodi, con saramenti affermando che così era. Partito Calandrino da loro, essi quello che intorno a questo avessero a fare ordinarono fra sé medesimi.
Calandrino con disidero aspettò la domenica mattina; la qual venuta, in sul far del dì si levò. E chiamati i compagni, per la porta a San Gallo usciti e nel Mugnon discesi cominciarono ad andare in giù, della pietra cercando. Calandrino andava, come più volenteroso, avanti, e prestamente or qua e or là saltando, dovunque alcuna pietra nera vedeva, si gittava, e quella ricogliendo si metteva in seno. I compagni andavano appresso, e quando una e quando un’altra ne ricoglievano; ma Calandrino non fu guari di via andato, che egli il seno se n’ebbe pieno; per che, alzandosi i gheroni della gonnella, che all’analda non era, e faccendo di quegli ampio grembo, bene avendogli alla correggia attaccati d’ogni parte, non dopo molto gli empié, e similmente, dopo alquanto spazio, fatto del mantello grembo, quello di pietre empié. Per che, veggendo Buffalmacco e Bruno che Calandrino era carico e l’ora del mangiare s’avvicinava, secondo l’ordine da sé posto, disse Bruno a Buffalmacco: «Calandrino dove è?»
Buffalmacco, che ivi presso sel vedeva, volgendosi intorno e or qua e or là riguardando, rispose: «Io non so, ma egli era pur poco fa qui dinanzi da noi».
Disse Bruno: «Ben che fa poco! a me par egli esser certo che egli è ora a casa a desinare, e noi ha lasciati nel farnetico d’andar cercando le pietre nere giù per lo Mugnone».
«Deh come egli ha ben fatto», disse allora Buffalmacco «d’averci beffati e lasciati qui, poscia che noi fummo sì sciocchi che noi gli credemmo. Sappi! chi sarebbe stato sì stolto che avesse creduto che in Mugnone si dovesse trovare una così virtuosa pietra, altri che noi?»
Calandrino, queste parole udendo, imaginò che quella pietra alle mani gli fosse venuta e che per la virtù d’essa coloro, ancor che lor fosse presente, nol vedessero. Lieto adunque oltre modo di tal ventura, senza dir loro alcuna cosa, pensò di tornarsi a casa; e volti i passi indietro, se ne cominciò a venire.

Kim Rossi Stuart nella parte di Calandrino in Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2001)
Vedendo ciò, Buffalmacco disse a Bruno: «Noi che faremo? Ché non ce ne andiam noi?»
A cui Bruno rispose: «Andianne; ma io giuro a Dio che mai Calandrino non me ne farā più niuna; e se io gli fossi presso, come stato sono tutta mattina, io gli darei tale di questo ciotto nelle calcagna, che egli si ricorderebbe forse un mese di questa beffa»; e il dir le parole e l’aprirsi e ‘l dar del ciotto nel calcagna a Calandrino fu tutto uno. Calandrino, sentendo il duolo, levò alto il piè e cominciò a soffiare, ma pur si tacque e andò oltre.
Buffalmacco, recatosi in mano uno de’ ciottoli che raccolti avea, disse a Bruno: «Deh! vedi bel codolo, così giugnesse egli testé nelle reni a Calandrino!» e lasciato andare, gli diè con esso nelle reni una gran percossa. E in brieve in cotal guisa or con una parola, e or con una altra su per lo Mugnone infino alla porta a San Gallo il vennero lapidando. Quindi, in terra gittate le pietre che ricolte aveano, alquanto con le guardie de’ gabellieri si ristettero; le quali, prima da loro informate, faccendo vista di non vedere, lasciarono andar Calandrino con le maggior risa del mondo.
Il quale senza arrestarsi se ne venne a casa sua, la quale era vicina al Canto alla Macina; e in tanto fu la fortuna piacevole alla beffa, che, mentre Calandrino per lo fiume ne venne e poi per la cittā, niuna persona gli fece motto, come che pochi ne scontrasse, per ciō che quasi a desinare era ciascuno.
Entrossene adunque Calandrino così carico in casa sua.
Era per avventura la moglie di lui, la quale ebbe nome monna Tessa, bella e valente donna, in capo della scala; e alquanto turbata della sua lunga dimora, veggendol venire, cominciò proverbiando a dire: «Mai, frate, il diavol ti ci reca! ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare».
Il che udendo Calandrino, e veggendo che veduto era, pieno di cruccio e di dolore cominciò a gridare: «Ohimè, malvagia femina, o eri tu costì? Tu m’hai diserto; ma in fé di Dio io te ne pagherò»; e salito in una sua saletta e quivi scaricate le molte pietre che recate avea, niquitoso corse verso la moglie, e presala per le treccie la si gittò a’piedi, e quivi, quanto egli poté menar le braccia e’ piedi, tanto le diè per tutta la persona pugna e calci, senza lasciarle in capo capello o osso addosso che macero non fosse, niuna cosa valendole il chieder mercé con le mani in croce.
Buffalmacco e Bruno, poi che co’ guardiani della porta ebbero alquanto riso, con lento passo cominciarono alquanto lontani a seguitar Calandrino, e giunti a piè dell’uscio di lui, sentirono la fiera battitura la quale alla moglie dava, e faccendo vista di giugnere pure allora, il chiamarono. Calandrino tutto sudato, rosso e affannato si fece alla finestra, e pregogli che suso a lui dovessero andare. Essi, mostrandosi alquanto turbati, andaron suso e videro la sala piena di pietre, e nell’un de’ canti la donna scapigliata, stracciata, tutta livida e rotta nel viso dolorosamente piagnere, e d’altra parte Calandrino scinto e ansando a guisa d’uom lasso sedersi.
Dove come alquanto ebbero riguardato, dissero: «Che è questo, Calandrino? Vuoi tu murare, che noi veggiamo qui tante pietre?» E oltre a questo soggiunsero: «E monna Tessa che ha? E’ par che tu l’abbi battuta; che novelle son queste?»
Calandrino, faticato dal peso delle pietre e dalla rabbia con la quale la donna aveva battuta, e dal dolore della ventura la quale perduta gli pareva avere, non poteva raccogliere lo spirito a formare intera la parola alla risposta. Per che soprastando, Buffalmacco ricominciò: «Calandrino, se tu aveva altra ira, tu non ci dovevi perciò straziare come fatto hai; ché, poi sodotti ci avesti a cercar teco della pietra preziosa, senza dirci a Dio né a diavolo, a guisa di due becconi nel Mugnon ci lasciasti, e venistitene, il che noi abbiamo forte per male; ma per certo questa fia la sezzaia che tu ci farai mai».
A queste parole Calandrino sforzandosi rispose: «Compagni, non vi turbate, l’opera sta altramenti che voi non pensate. Io, sventurato! avea quella pietra trovata; e volete udire se io dico il vero? Quando voi primieramente di me domandaste l’un l’altro, io v’era presso a men di diece braccia; e veggendo che voi ve ne venavate e non mi vedavate, v’entrai innanzi, e continuamente poco innanzi a voi me ne son venuto».
E, cominciandosi dall’un de’ capi, infino la fine raccontò loro ciò che essi fatto e detto aveano, e mostrò loro il dosso e le calcagna come i ciotti conci gliel’avessero, e poi seguitò: «E dicovi che, entrando alla porta con tutte queste pietre in seno che voi vedete qui, niuna cosa mi fu detta, ché sapete quanto esser sogliano spiacevoli e noiosi que’ guardiani a volere ogni cosa vedere; e oltre a questo ho trovati per la via più miei compari e amici, li quali sempre mi soglion far motto e invitarmi a bere, né alcun fu che parola mi dicesse né mezza, sė come quegli che non mi vedeano. Alla fine, giunto qui a casa, questo diavolo di questa femina maladetta mi si parò dinanzi ed ebbemi veduto, per ciò che, come voi sapete, le femine fanno perder la virtù ad ogni cosa: di che io, che mi poteva dire il più avventurato uom di Firenze, sono rimaso il più sventurato; e per questo l’ho tanto battuta quant’io ho potuto menar le mani, e non so a quello che io mi tengo che io non le sego le veni; che maladetta sia l’ora che io prima la vidi e quand’ella mi venne in questa casa!»
E raccesosi nell’ira, si voleva levar. per tornare a batterla da capo.
Buffalmacco e Bruno, queste cose udendo, facevan vista di maravigliarsi forte e spesso affermavano quello che Calandrino diceva, e avevano sė gran voglia di ridere che quasi scoppiavano; ma, vedendolo furioso levare per battere un’altra volta la moglie, levatiglisi allo ‘ncontro il ritennero, dicendo di queste cose niuna colpa aver la donna, ma egli che sapeva che le femine facevano perdere la virtù alle cose e non le aveva detto che ella si guardasse d’apparirgli innanzi quel giorno: il quale avvedimento Iddio gli aveva tolto o per ciò che la ventura non doveva esser sua, o perch’egli aveva in animo d’ingannare i suoi compagni, a’ quali, come s’avvedeva d’averla trovata, il doveva palesare.
E dopo molte parole, non senza gran fatica, la dolente donna riconciliata con essolui, e lasciandol malinconoso colla casa piena di pietre, si partirono.

Kim Rossi Stuart nella parte di Calandrino in Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2001)
La nostra città che è sempre stata ricca di varie usanze e gente strana, è vissuto un tempo, non da molto, un pittore di nome Calandrino, semplice e d’insolite maniere. Egli passava molto tempo con altri due pittori, chiamati uno Bruno, l’altro Buffalmacco, uomini cui piaceva il divertimento, ma molto avveduti ed intelligenti, che frequentavano spesso Calandrino perché si burlavano dei sui modi e della sua ingenuità. Nello stesso tempo viveva a Firenze un uomo di straordinaria capacità in qualunque cosa decidesse di fare, intelligente e fortunato, chiamato Maso del Saggio, che, avendo sentito parlare della ingenuità di Calandrino, decise di burlarsi di lui e di fargli credere qualcosa d’impossibile.
Per caso un giorno, trovandolo seduto nella chiesa di San Giovanni, davanti al tabernacolo sopra l’altare attento ad osservare i disegni e i bassorilievi , pensò che quello era il momento di mettere in pratica la sua intenzione. Dopo aver informato un suo compagno di ciò che aveva in mente di fare, si avvicinarono entrambi dov’era seduto Calandrino e facendo finta di non averlo visto cominciarono a parlare della virtù di diverse pietre, argomento sul quale Maso parlava così efficacemente da apparire un importante e saggio studioso di lapidari. Ad un certo punto Calandrino, dopo aver aguzzato le orecchie, avendo capito che ciò di cui argomentavano i due non era segreto, si unì a loro, mettendo così ad effetto l’idea di Maso. Calandrino gli domandò dove queste pietre fossero e Maso rispose che la maggior parte si trovavano a Berlinzone, terra dei baschi, in un paese che si chiamava Bengodi, in cui si legano le vigne con le salsicce, si comprava un’oca con l’aggiunta di un papero per una moneta e c’era una intera montagna di parmigiano grattugiato, sopra la quale stavano alcune persone che non facevano altro che fare gnocchi e ravioli per poi cuocerli in un brodo di capponi; poi li buttavano giù e chi ne prendeva di più, più ne aveva; e lì vicino vi era un fiumiciattolo di vernaccia, della migliore che si bevve mai, senza l’aggiunta di alcun goccio d’acqua.
«Oh», disse Calandrino, «dev’essere un bel paese; ma dimmi, che ci fanno dei capponi che si mettono a cuocere?»
Rispose Maso: «Se li mangiano i baschi».
Disse ancora Calandrino: «Ci sei mai stato?»
A cui Maso: «Mi chiedi se ci sono stato? Sì sono stato qui una volta come mille»
Disse ancora Calandrino: «E quante miglia dista?»
Maso rispose: «Ce ne sono più di millanta che tutta la notte canta».
Calandrino: «Quindi dev’essere più lontana degli Abruzzi»
«Si è così», rispose Maso, «è niente».
L’ingenuo Calandrino, vedendo che Maso diceva queste parole con viso serio e senza ridere, diede ad esse fede come si fa per una verità ben più evidente e così le riteneva vere; e aggiunse: «E’ troppo lontana, ma se fosse più vicina ti dico che verrei una volta con te per vedere rotolare gli gnocchi e farmene una scorpacciata. Ma dimmi, che tu sia felice, in questi posti si trova qualcuna di quelle pietre piene di virtù?»
A cui Maso rispose: «Sì, si trovano due tipi di pietre di grandissima virtù. La prima sono i macigni che si stanno a Settignano e Montisci, per virtù dei quali, quando diventano macine, ne nasci la farina, perciò si dice in quei paesi che Da uno vengono le grazie dall’altro le macine; ma ce ne sono talmente tante che da noi sono poco pregiate, come presso loro gli smeraldi, di cui vi sono montagne più alte di Monte Morello, che brillano a mezzanotte e non ti dico di più. E aggiungo che formasse una collana le macine prima di forarle e le portasse dal sultano potrebbe chiedergli qualsiasi cosa che l’otterrebbe. L’altra è una pietra, che noi nei lapidari chiamiamo elitropia, di grande virtù, perché chiunque l’indossi , per tutto il tempo che la tiene, non è veduto là dove non è».
Disse Calandrino: «Gran virtù son queste; ma questa dove si trova?»
Maso rispose che ve n’erano alcune nel Mugnone.
Chiese ancora Calandrino: «Di che grandezza sono? Qual è il loro colore?»
Rispose Maso: «Ve ne sono di varie grandezze, più o meno grandi e il loro colore è grigio scuro, quasi nero».
Calandrino, avendo annotato tra sé e sé, facendo finta di avere altro da fare, si allontanò da Maso e decise di andare a cercare questa pietra, ma non voleva farlo senza dirlo prima a Bruno e Buffalmacco, con cui era molto legato. Cominciò dunque a cercarli, prima che qualcuno li trovasse, e passò tutta la mattina a vedere dove fossero. Alla fine, essendo già tra le due e le tre del pomeriggio, ricordandosi che loro lavoravano in un monastero di Faenza, sebbene facesse un gran caldo, cominciò a correre e chiamatili, così disse: «Compagni, se volete credermi, noi possiamo diventare gli uomini più ricchi di Firenze: infatti ho saputo da un uomo degno di fede che a Mugnone c’è una pietra che chi la indossa diventa invisibile da chiunque, per cui mi sembrerebbe giusto che noi, senza aspettare oltre, prima che vi andasse qualcun’altro, andassimo a cercarla. Sicuramente la troveremo, dal momento che io so com’è fatta e, una volta trovata, che dovremo fare se non metterla nel borsello e andare dai banchieri, che, com’è sapete, sono sempre pieni di piccole monete d’argento e di fiorini e prenderne quanti ne vorremmo? Nessuno ci vedrà, così arricchiremo in un sol attimo, senza stare tutto il giorno a imbrattare le mura come fa la lumaca».
Bruno e Buffalmacco, mentre lo ascoltavano, cominciarono a ridere tra se stessi e guardandosi reciprocamente gli mostrarono di meravigliarsi molto e di approvare totalmente il consiglio di Calandrino e Buffalmacco gli chiese quale fosse il nome di questa pietra.
A Calandrino, che era piuttosto stupido, già non ricordava il nome della pietra, per cui gli rispose: «A che ci serve dal momento che ne conosciamo le virtù? Mi sembra più opportuno a andare a cercarla senza indugiare oltre».
«Bene», aggiunse Bruno, «com’è fatta?»
Calandrino: «Ce ne sono d’ogni forma, ma sono quasi tutte nere; per cui a me pare che noi dobbiamo raccogliere tutte quelle di questo colore, finché non ci imbattiamo in essa, e perciò, non perdiamo tempo, andiamo».
A cui Bruno disse: «Aspetta»; e rivolto a Buffalmacco aggiunse. «A me sembra che Calandrino dica il giusto, ma non mi pare che adesso sia il momento, perché il sole è alto e illumina la vallata del Mugnone all’interno, che ha tutte le pietre asciutte che sembrano ora più bianche delle pietre che ci sono e che invece la mattina, prima che il sole le abbia inaridite, sembrano diventare nere; e oltre a questo ci sono oggi, per diversi motivi, molte persone per la vallata, in quanto è giorno di lavoro, i quali, vedendoci, potrebbero indovinare che cosa noi fossimo andati a fare e lo farebbero anche loro; finiremo quindi per litigare, cosicché per voler troppo si perde l’essenziale. A me sembra, se siete d’accordo, che questa cosa si faccia domani mattina, perché così si distingueranno le pietre nere da quelle bianche, ed essendo un giorno di festa non ci sarà nessuno».
Buffalmacco approvò il consiglio di Bruno e Calandrino vi si associò e stabilirono che la domenica mattina successiva si ritrovassero tutti e tre per cercare questa pietra; ma Calandrino soprattutto pregò loro di non dover parlare con persona alcuna di questa cosa perché a lui era stata riferita in gran segreto. E dopo aver detto questo, riferì loro con giuramenti ciò che aveva ascoltato sul paese di Bengodi, affermando che era la verità. Essi si misero d’accordo su quello che dovessero fare intorno a questo fatto, dopo che Calandrino si era allontanato.
Calandrino aspettò la domenica mattina con ansia e arrivato il tempo si alzò all’alba. Chiamati i compagni, usciti a San Gallo attraverso la porta e scesi dal declivio del Mugnone iniziarono a cercare la pietra. Calandrino andava come quello che aveva più voglia degli altri di trovarla, camminando avanti e saltando con velocità ora qui e ora là, e dovunque vedeva una pietra nera l’afferrava e, raccogliendola, se la metteva in grembo. I compagni lo seguivano e ne raccoglievano quando una quando un’altra; ma Calandrino non era andato molto avanti che ne aveva il grembo pieno, per cui alzandosi i lembi della veste che era capace ed ampia e facendo con la veste un ampio contenitore, attaccata bene alla cintura, non dopo molto lo riempì, e allo stesso modo dopo un bel po’ di tempo, fatto un altro contenitore con il mantello, lo riempì di pietre. Vedendo Buffalmacco e Bruno che Calandrino era carico e si avvicinava l’ora di mangiare, secondo il piano che avevano ordito tra loro, Bruno disse a Buffalmacco: «Calandrino dov’è?». Buffalmacco, che lo aveva vicino, girando il volto da una parte e dall’altra e guardando con attenzione, rispose: «Non lo so, ma prima egli era poco davanti a noi».
Disse Bruno: « Altro che poco fa! Sono certo che egli ora è a casa a mangiare e ci ha lasciato in questo impiccio di andare a cercare le pietre nere giù per il Mugnone».
«Ahimè, come è riuscito bene», disse allora Buffalmacco «a imbrogliarci e a lasciarci qui dal momento in cui siamo stati così stupidi da credergli. Figurati! Chi sarebbe stato così scemo da credere che nel Mugnone ci fosse una pietra così virtuosa, oltre che noi!»
Calandrino, sentendo queste parole, immaginò di aver preso quella pietra e che per la virtù di essa gli amici, sebbene lui fosse presente, non lo vedessero. Contentissimo per questo fatto, senza dir niente pensò di andare a casa e tornato sui suoi passi cominciò ad andare verso casa.
Vedendo ciò, Buffalmacco disse a Bruno: « Che facciamo? Perché non ce ne andiamo?».
A cui Bruno rispose: «Andiamocene; ma giuro di fronte a Dio che Calandrino non me ne farà più nessuna; e se io adesso gli fossi vicino come ci sono stato per tutta la mattina, lo colpirei con questa pietra sui calcagni che egli si ricorderebbe per un intero mese di questa beffa»; e nel dire queste parole, allargare il braccio e a lanciarlo sui calcagni di Calandrino, fu un momento e Calandrino, sentendo il dolore, alzò il piede, cominciò a soffiare, ma non disse parola e camminò oltre.
Buffalmacco, presa in mano una pietra che aveva raccolto, disse a Bruno: «Guarda che bella pietra, potesse giungere in questo momento sulle reni di Calandrino!» e lanciatala lo colse nelle reni con un gran colpo; e per dirla in breve, in questo modo ora con una parola ora con un’altra, risalendo sul Mugnone fino alla porta di San Gallo, continuarono a lapidarlo. In seguito, gettate in terra le pietre che avevano raccolto, si fermarono per un po’ di tempo con i gabellieri; questi, informati prima, fecero finta di non vedere Calandrino, divertendosi molto. Costui, senza fermarsi, raggiunse casa, che era vicino al Canto alla macina; e tanto fu la sorte favorevole alla beffa, che, mentre Calandrino attraversando il fiume giungeva in città, nessuno gli rivolse la parola perché incontrò poche persone, in quanto erano quasi tutti a pranzo.
Dunque Calandrino entrò estremamente carico (di pietre) in casa sua. Per caso vi era la moglie di lui, monna Tessa, bella e amorevole donna, in cima alle scale e, alquanto preoccupata per la lunga assenza (del marito), vedendolo venire cominciò, rimproverandolo, a dire: «Alla buon’ora, fratello, il diavolo ti porta a casa! Tutti hanno già mangiato quando tu torni a pranzo».
Calandrino, ascoltando e vedendo che era visto, pieno di rabbia e di dolore, cominciò a gridare: «Oimè, malvagia donna, tu eri qui? Mi hai rovinato, ma in fede di Dio te la farò pagare!» e salito in una piccola camera e gettate in terra le molte pietre che aveva con sé, infuriato corse verso la moglie e presala per le trecce la gettò in terra e qui con tutte le sue forze la colpi su tutto il corpo con le mani e con le braccia: pugni e calci, senza lasciarle in testa capello o osso che non rimase pesto, non valendo per lei nulla il chiedere pietà con le mani giunte sul petto.
Buffalmacco e Bruno, dopo che ebbero riso molto con i guardiani della porta, cominciarono a seguire da lontano Calandrino molto lentamente; giunti alla soglia della sua porta, sentirono l’atroce pestaggio che Calandrino dava alla moglie e, facendo finta di arrivare solo ora, lo chiamarono. Calandrino, tutto sudato, rosso e affannato, si affacciò alla finestra e li pregò che andassero immediatamente da lui. Loro, mostrandosi alquanto arrabbiati, andarono su e videro la sala piena di pietre e in un angolo la donna scapigliata, con le vesti stracciate, tutta livida e ferita nel volto piangere dolorosamente; e dall’altra parte, Calandrino con gli abiti slacciati e ansando come un uomo stanco, sedersi.
Qui, quando ebbero guardato tutto, dissero:« Che è questo Calandrino? vuoi tu costruire un muro che qui vediamo tante pietre?» e oltre a questo aggiunsero:« E che è successo a monna Tessa? Sembra che tu l’abbia picchiata: che novità son queste?». Calandrino, stanco dal peso delle pietre e per la rabbia con la quale aveva colpito la moglie e dal dolore della fortuna che gli sembrava aver perso, non riusciva a riprendere fiato per pronunciare una parola in risposta; per cui, poiché indugiava, Buffalmacco ricominciò: «Calandrino, se tu avevi un altro motivo di rabbia, tu non avresti dovuto fare di noi lo strazio che hai fatto; perché ingannati ci hai portato con te a cercare la pietra preziosa, e senza considerarci, a guisa di due bestioni, ci hai lasciato e sei andato via dal mugnone, al che noi ci siamo rimasti molto male; ma per certo questa sarà l’ultima che ci farai».
A queste parole Calandrino rispose sforzandosi: «Compagni, non vi arrabbiate, la faccenda sta in altro modo di come la pensate. Io, sfortunato me!, avevo trovato quella pietra e volete sentire se vi dico la verità? Quando voi all’inizio mi cercaste io ero vicino a voi, meno di dieci metri, e vedendo che voi ve ne stavate andando e non mi vedevate mi incamminai davanti e sempre avanzato rispetto a voi, arrivai a casa». E cominciando dall’inizio fino alla fine disse loro ciò che gli avevano fatto e mostrò il colpo ai calcagni e come i sassi glieli avessero ridotti; e poi continuò: « E vi dico che, entrando dalla porta con tutte queste pietre in grembo che voi vede qui, nessuno mi ha detto niente, e sapete quanto sono solitamente impiccioni e noiosi quei guardiani che vogliono vedere sempre tutto; e oltre a questo ho incrociato per via diversi compagni e amici, i quali sempre sono soliti rivolgermi la parola e invitarmi a bere, ma non c’è stato nessuno che mi dicesse nè una nè mezza parola, come se non mi vedessero. Infine, arrivato a casa, questo diavolo di femmina maledetta mi si mise davanti e mi vide, perciò che come sapete, le femmine fanno perdere la virtù ad ogni cosa: perciò io, che mi potevo considerare il più fortunato uomo di Firenze, mi sono ritrovato ad essere il più sfortunato; per questo l’ho picchiata tanto per quanto io abbia potuto menar le mani e non so che cosa mi trattenga dall’ammazzarla, che maledetta sia l’ora che io la vidi per la prima volta e che mi venne in questa casa!» e riaccesosi d’ira si voleva rialzare per tornare a picchiarla di nuovo.
Buffalmacco e Bruno, ascoltando queste cose, facevano finta di meravigliarsi molto e spesso confermavano quello che Calandrino affermava, e avevano una così gran voglia di ridere da scoppiare; ma, vedendolo furioso alzarsi per picchiare un’altra volta la moglie, gli andarono incontro e lo trattennero, dicendo che di questo fatto la donna non aveva nessuna colpa, ma lui, che sapeva che le donne fanno perdere la virtù alle cose, e non glielo aveva detto, non l’aveva avvertita di non apparirgli quel giorno: di quella cautela Dio lo aveva privato o perché la fortuna non doveva esser sua o perché egli aveva pensato di ingannare i suoi amici, ai quali, come si era accorto di averla trovata, avrebbe dovuto rivelarlo. E dopo molti discorsi, non senza una grande fatica, facendo riconciliare la donna dolente con lui, e lasciandolo triste con la casa piena di pietre, se ne andarono.

Calandrino a teatro
La novella è la prima che ha come protagonista Calandrino, personaggio che sembra sia realmente esistito, cui il Boccaccio dedica altre tre novelle.
Nella sua figura possiamo individuare alcune caratteristiche che fanno di lui un antieroe. Tali caratteristiche le potremmo individuare nelle sequenze attraverso le quali la stessa narrazione è suddivisa:
- dapprincipio egli ci è presentato come un sempliciotto, che, molto presumibilmente fa male il suo lavoro di pittore in quanto privo d’intelligenza e quindi facile oggetto dello scherno altrui. Di questo ci dà dimostrazione la credulità con cui assorbe tutto il nonsenso delle parole di Maso il quale, sebbene estremamente intelligente, si fa beffe della sua ignoranza creando un mondo “altro” con la parola, cioè mostrando che la realtà può esistere anche se non è, se vi è la parola che la traduce e se ne fa testimone. E’ chiaro che tale gioco può essere paritario se vi è stessa padronanza verbale, altrimenti diventa potere contro debolezza. Per questo un po’ sorridendo e un po’ impietosendoci, all’inizio del racconto siamo tutti per Calandrino;
- lo stesso dicasi quando Calandrino si rivolge a Bruno e Buffalmacco, i quali, se fossero stati veri amici, può darsi che l’avrebbero messo in guardia rispetto a ciò che Maso aveva detto; tuttavia un primo, sebbene appena accennato, segnale che Calandrino non è quell’ingenuo e sempliciotto che all’inizio della novella ci aveva quasi fatto pena, ce lo dà la motivazione per cui vuole diventare “invisibile”: rubare senza essere visto;
- in questa sequenza vediamo i tre amici in opera: il protagonista, stupido com’è cerca veramente, Bruno e Buffalmacco fingono e sempre dall’alto della loro intelligenza colpiscono l’ingenuo Calandrino, prendendolo a sassate. Ma in fondo, questa volta, il lettore è d’accordo con loro: credendo di aver preso la pietra miracolosa, Calandrino cerca di svignarsela, per non condividerla con nessuno; bel concetto, anche per lui, d’amicizia!
- l’ultima sequenza ce lo svela: violento e misogino; credendo che sia stata la moglie ad interrompere l’incantesimo la picchia con rabbia furiosa, mostrando un sottofondo di cattiveria quale all’inizio non ci saremo aspettati.
Per riassumere si potrebbe dire che Calandrino sia tutto quello che Boccaccio non vuole ci sia in un uomo, sembra gli manchino tutte le virtù necessarie: infatti egli non è cortese, non è intelligente né tantomeno astuto, non ricerca il guadagno attraverso l’intelligenza, ma con la frode e non rispetta le donne.
L’altra novella di Calandrino, sempre con i coprotagonisti Bruno e Buffalmaccio, ci è raccontata da Filomena:
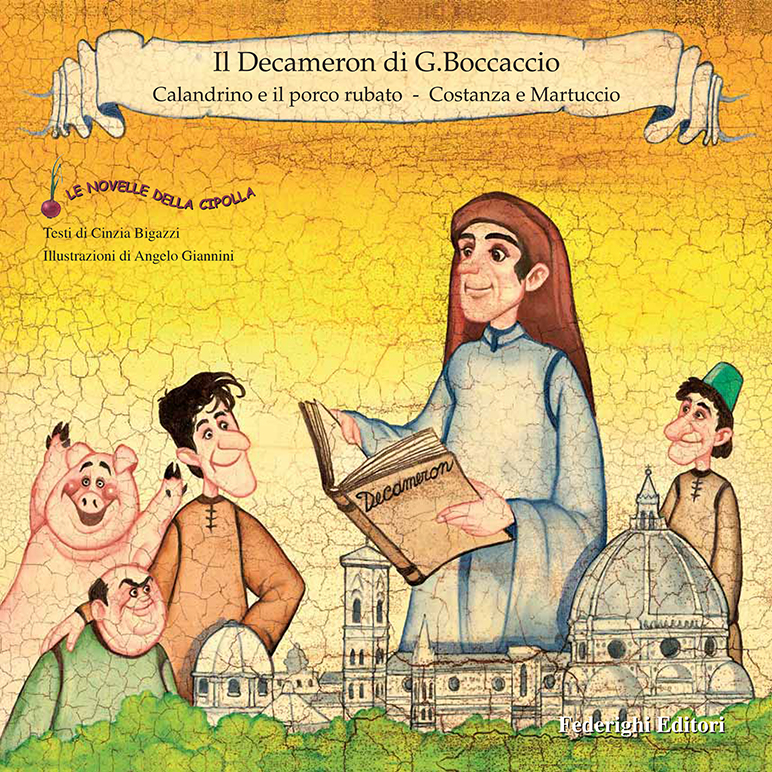
Copertina per un’edizione dedicata ai bambini della novella di Calandrino e il porco rubato
BRUNO E BUFFALMACCO IMBOLANO UN PORCO A CALANDRINO; FANNOGLI FARE LA SPERIENZA DA RITROVARLO CON GALLE DI GENGIOVO E CON VERNACCIA, E A LUI NE DANNO DUE, L’UNA DOPO L’ALTRA, DI QUELLE CONFETTATE IN ALOE’, E PARE CHE L’ABBIA AVUTO EGLI STESSO, FANNOLO RICOMPERARE, SE EGLI NON VUOLE CHE ALLA MOGLIE IL DICANO.
(VIII, 6)
Chi Calandrino, Bruno e Buffalmacco fossero non bisogna che io vi mostri, ché assai l’avete di sopra udito; e per ciò, più avanti faccendomi, dico che Calandrino aveva un suo poderetto non guari lontano da Firenze, che in dote aveva avuto della moglie, del quale tra l’altre cose che su vi ricoglieva, n’aveva ogn’anno un porco, ed era sua usanza sempre colà di dicembre d’andarsene la moglie ed egli in villa, e ucciderlo e quivi farlo salare.
Ora avvenne una volta tra l’altre che, non essendo la moglie ben sana, Calandrino andò egli solo ad uccidere il porco; la qual cosa sentendo Bruno e Buffalmacco, e sappiendo che la moglie di lui non v’andava, se n’andarono ad un prete loro grandissimo amico, vicino di Calandrino, a starsi con lui alcun dì. Aveva Calandrino, la mattina che costor giunsero il dì, ucciso il porco, e vedendogli col prete, gli chiamò e disse: «Voi siate i ben venuti. Io voglio che voi veggiate che massaio io sono; e menatigli in casa, mostrò loro questo porco».
Videro costoro il porco esser bellissimo, e da Calandrino intesero che per la famiglia sua il voleva salare. A cui Brun disse: «Deh! come tu se’ grosso! Vendilo, e godianci i denari; e a mogliata dì che ti sia stato imbolato».
Calandrino disse: «No, ella nol crederrebbe, e caccerebbemi fuor di casa; non v’impacciate, ché io nol farei mai».
Le parole furono assai, ma niente montarono. Calandrino gl’invitò a cena cotale alla trista, sì che costoro non vi vollon cenare, e partirsi da lui.
Disse Bruno a Buffalmacco: «Vogliangli noi imbolare stanotte quel porco?»
Disse Buffalmacco: «O come potremmo noi?»
Disse Bruno: «Il come ho io ben veduto, se egli nol muta di là ove egli era testé».
«Adunque», disse Buffalmacco «faccianlo; perché nol faremo noi? E poscia cel goderemo qui insieme col domine».
Il prete disse che gli era molto caro. Disse allora Bruno: «Qui si vuole usare un poco d’arte: tu sai, Buffalmacco, come Calandrino è avaro e come egli bee volentieri quando altri paga; andiamo e meniallo alla taverna, e quivi il prete faccia vista di pagare tutto per onorarci e non lasci pagare a lui nulla; egli si ciurmerà, e verracci troppo ben fatto poi, per ciò che egli è solo in casa».
Come Brun disse, così fecero. Calandrino, veggendo che il prete nol lasciava pagare, si diede in sul bere, e benché non ne gli bisognasse troppo, pur si caricò bene; ed essendo già buona ora di notte quando dalla taverna si partì, senza volere altramenti cenare, se n’entrò in casa, e credendosi aver serrato l’uscio, il lasciò aperto e andossi al letto. Buffalmacco e Bruno se n’andarono a cenare col prete, e, come cenato ebbero, presi loro argomenti per entrare in casa Calandrino là onde Bruno aveva divisato, là chetamente n’andarono; ma, trovando aperto l’uscio, entrarono dentro, e ispiccato il porco, via a casa del prete nel portarono, e ripostolo, se n’andarono a dormire.
Calandrino, essendogli il vino uscito del capo, si levò la mattina, e, come scese giù, guardò e non vide il porco suo, e vide l’uscio aperto; per che, domandato questo e quell’altro se sapessero chi il porco s’avesse avuto, e non trovandolo, incominciò a fare il romore grande: ohisé, dolente sé, che il porco gli era stato imbolato. Bruno e Buffalmacco levatisi, se n’andarono verso Calandrino, per udir ciò che egli del porco dicesse. Il qual, come gli vide, quasi piagnendo chiamatigli, disse: «Ohimè, compagni miei, che il porco mio m’è stato imbolato».
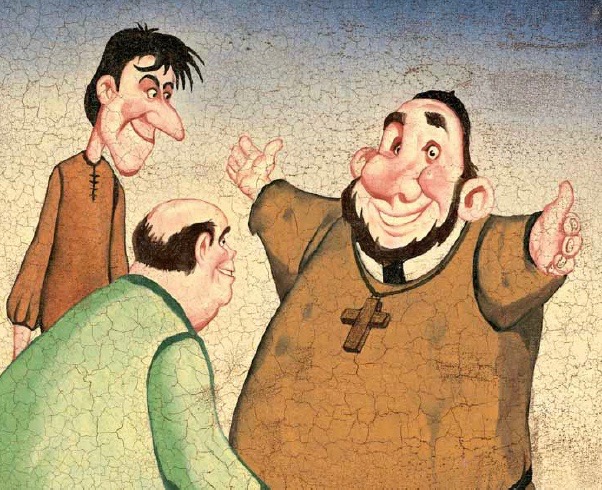
Bruno, Buffalmacco e il prete nell’edizione Federighi
Bruno, accostatoglisi, pianamente gli disse: «Maraviglia, che se’stato savio una volta».
«Ohimè», disse Calandrino «ché io dico da dovero».
«Così di’», diceva Bruno «grida forte sì, che paia bene che sia stato così».
Calandrino gridava allora più forte e diceva: «Al corpo di Dio, che io dico da dovero che egli m’è stato imbolato».
E Bruno diceva: «Ben dì, ben dì: e’ si vuol ben dir così, grida forte fatti ben sentire, sì che egli paia vero».
Disse Calandrino: «Tu mi faresti dar l’anima al nimico. Io dico che tu non mi credi, se io non sia impiccato per la gola, che egli m’è stato imbolato».
Disse allora Bruno: «Deh! come dee potere esser questo? Io il vidi pure ieri costì. Credimi tu far credere che egli sia volato?»
Disse Calandrino: «Egli è come io ti dico».
«Deh!» disse Bruno «può egli essere?»
«Per certo», disse Calandrino «egli è così, di che io son diserto e non so come io mi torni a casa: mogliema nol mi crederà, e se ella il mi pur crede, io non avrò uguanno pace con lei».
Disse allora Bruno: «Se Dio mi salvi, questo è mal fatto, se vero è; ma tu sai, Calandrino, che ieri io t’insegnai dir così: io non vorrei che tu ad un’ora ti facessi beffe di moglieta e di noi».
Calandrino incominciò a gridare e a dire: «Deh perché mi farete disperare e bestemmiare Iddio e’santi e ciò che v’è? Io vi dico che il porco m’è stato sta notte imbolato».
Disse allora Buffalmacco: «Se egli è pur così, vuolsi veder via, se noi sappiamo, di riaverlo».
«E che via» disse Calandrino «potrem noi trovare?»
Disse allora Buffalmacco: «Per certo egli non c’è venuto d’India niuno a torti il porco; alcuno di questi tuoi vicini dee essere stato; e per ciò, se tu gli potessi ragunare, io so fare la esperienza del pane e del formaggio e vederemmo di botto chi l’ha avuto».
«Sì», disse Bruno ben farai con pane e con formaggio a certi gentilotti che ci ha dattorno, ché son certo che alcun di loro l’ha avuto, e avvederebbesi del fatto, e non ci vorrebber venire».
«Come è dunque da fare?» disse Buffalmacco.
Rispose Bruno: «Vorrebbesi fare con belle galle di gengiovo e con bella vernaccia, e invitargli a bere. Essi non sel penserebbono e verrebbono; e così si possono benedire le galle del gengiovo, come il pane e ‘l cacio».
Disse Buffalmacco: «Per certo tu di’ il vero; e tu, Calandrino, che di’? Vogliallo fare?»
Disse Calandrino: «Anzi ve ne priego io per l’amor di Dio; ché, se io sapessi pur chi l’ha avuto, sì mi parrebbe esser mezzo consolato».
«Or via», disse Bruno «io sono acconcio d’andare infino a Firenze per quelle cose in tuo servigio, se tu mi dai i denari».
Aveva Calandrino forse quaranta soldi, li quali egli gli diede. Bruno, andatosene a Firenze ad un suo amico speziale, comperò una libbra di belle galle di gengiovo, e fecene far due di quelle del cane, le quali egli fece confettare in uno aloè patico fresco; poscia fece dar loro le coverte del zucchero, come avevan l’altre, e per non ismarrirle o scambiarle, fece lor fare un certo segnaluzzo per lo quale egli molto bene le conoscea, e comperato un fiasco d’una buona vernaccia, se ne tornò in villa a Calandrino e dissegli: «Farai che tu inviti domattina a ber con teco tutti coloro di cui tu hai sospetto; egli è festa, ciascun verrà volentieri, e io farò stanotte insieme con Buffalmacco la ‘ncantagione sopra le galle, e recherolleti domattina a casa, e per tuo amore io stesso le darò, e farò e dirò ciò che fia da dire e da fare».
Calandrino così fece. Ragunata adunque una buona brigata tra di giovani fiorentini, che per la villa erano, e di lavoratori, la mattina vegnente, dinanzi alla chiesa intorno all’olmo, Bruno e Buffalmacco vennono con una scatola di galle e col fiasco del vino, e fatti stare costoro in cerchio, disse Bruno: «Signori, e’ mi vi convien dir la cagione per che voi siete qui, acciò che, se altro avvenisse che non vi piacesse, voi non v’abbiate a ramaricar di me. A Calandrino, che qui è, fu ier notte tolto un suo bel porco, né sa trovare chi avuto se l’abbia; e per ciò che altri che alcun di noi che qui siamo non gliele dee potere aver tolto, esso, per ritrovar chi avuto l’ha, vi dà a mangiar queste galle una per uno, e bere. E infino da ora sappiate che chi avuto avrà il porco, non potrà mandar giù la galla, anzi gli parrà più amara che veleno, e sputeralla; e per ciò, anzi che questa vergogna gli sia fatta in presenza di tanti, è forse il meglio che quel cotale che avuto l’avesse, in penitenzia il dica al sere, e io mi rimarrò di questo fatto».
Ciascun che v’era disse che ne voleva volentier mangiare; per che Bruno, ordinatigli e messo Calandrino tra loro, cominciatosi all’un de’ capi, cominciò a dare a ciascun la sua, e, come fu per mei Calandrino, presa una delle canine, gliele pose in mano. Calandrino prestamente la si gittò in bocca e cominciò a masticare; ma sì tosto come la lingua sentì l’aloè, così Calandrino, non potendo l’amaritudine sostenere, la sputò fuori.
Quivi ciascun guatava nel viso l’uno all’altro, perveder chi la sua sputasse; e non avendo Bruno ancora compiuto di darle, non faccendo sembianti d’intendere a ciò, s’udì dir dietro: «Eja, Calandrino, che vuol dir questo?» per che prestamente rivolto, e veduto che Calandrino la sua aveva sputata, disse: «Aspettati, forse che alcuna altra cosa gliele fece sputare: tenne un’altra»; e presa la seconda, gliele mise in bocca, e fornì di dare l’altre che a dare aveva.
Calandrino, se la prima gli era paruta amara, questa gli parve amarissima; ma pur vergognandosi di sputarla, alquanto masticandola la tenne in bocca, e tenendola cominciò a gittar le lagrime che parevan nocciuole, sì eran grosse; e ultimamente, non potendo più, la gittò fuori come la prima aveva fatto. Buffalmacco faceva dar bere alla brigata, e Bruno; li quali, insieme con gli altri questo vedendo, tutti dissero che per certo Calandrino se l’aveva imbolato egli stesso; e furonvene di quegli che aspramente il ripresono.
Ma pur, poi che partiti si furono, rimasi Bruno e Buffalmacco con Calandrino, gl’incominciò Buffalmacco a dire: «Io l’aveva per lo certo tuttavia che tu te l’avevi avuto tu, e a noi volevi mostrare che ti fosse stato imbolato, per non darci una volta bere de’ denari che tu n’avesti».
Calandrino, il quale ancora non aveva sputata l’amaritudine dello aloè, incominciò a giurare che egli avuto non l’avea.
Disse Buffalmacco: «Ma che n’avesti, sozio, alla buona fè? Avestine sei?»
Calandrino, udendo questo, s’incominciò a disperare. A cui Brun disse: «Intendi sanamente, Calandrino, che egli fu tale nella brigata che con noi mangiò e bevve, che mi disse che tu avevi quinci su una giovinetta che tu tenevi a tua posta, e davile ciò che tu potevi rimedire, e che egli aveva per certo che tu l’avevi mandato questo porco. Tu sì hai apparato ad esser beffardo! Tu ci menasti una volta giù per lo Mugnone ricogliendo pietre nere, e quando tu ci avesti messo in galea senza biscotto, e tu te ne venisti; e poscia ci volevi far credere che tu l’avessi trovata; e ora similmente ti credi co’ tuoi giuramenti far credere altressì che il porco, che tu hai donato o ver venduto, ti sia stato imbolato. Noi sì siamo usi delle tue beffe e conoscialle; tu non ce ne potresti far più; e per ciò, a dirti il vero, noi ci abbiamo durata fatica in far l’arte, per che noi intendiamo che tu ci doni due paia di capponi, se non che noi diremo a monna Tessa ogni cosa.
Calandrino, vedendo che creduto non gli era, parendogli avere assai dolore, non volendo anche il riscaldamento della moglie, diede a costoro due paia di capponi. Li quali, avendo essi salato il porco, portatisene a Firenze, lasciaron Calandrino col danno e con le beffe.
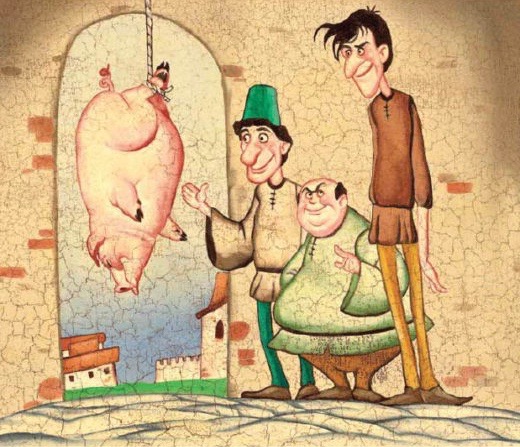
Calandrino, Bruno e Buffalmacco e il porco salato nell’edizione Federighi
Chi fossero Calandrino, Bruno e Buffalmacco non c’è bisogno che ve lo dica, perché lo avete ascoltato prima. Per questo, cominciando da subito la narrazione, vi dico che Calandrino aveva un piccolo podere non molto lontano da Firenze, che aveva avuto in dote dalla moglie, nel quale, tra le altre cose che qui vi raccoglieva, vi allevava annualmente un maiale; ed era sua abitudine di andarci ogni anno a dicembre insieme alla moglie per ucciderlo e farlo salare.
Una volta capitò che Calandrino, essendo la moglie malata, andò solo ad uccidere il porco, e quando lo seppero Bruno e Buffalmacco, accertatosi che la sposa non sarebbe arrivata, decisero di andare qualche giorno da lui insieme ad un loro amico prete. Calandrino, il giorno in cui arrivarono, aveva appena ucciso il maiale e vedendoli col prete, disse loro: «Siate i benvenuti: voglio che vediate che buon massaro sono io» e fatti entrare in casa, mostrò loro il porco.
Questi videro il porco e lo reputarono bellissimo e sentirono da Calandrino che lo voleva salare per la famiglia. Bruno allora gli disse: «Accidenti, quanto sei stupido! Vendilo, divertiamoci con i soldi che ci fai e a tua moglie di’ che te l’hanno rubato».
Calandrino disse: «No, non mi crederebbe e mi caccerebbe di casa, non immischiatevi, perché non lo farei mai»
I tentativi per convincerlo furono molti, ma non produssero alcun effetto. Calandrino li invitò a cena da lui, ma lo fece con tale malagrazia che essi rifiutarono e se ne andarono.
Disse Bruno a Buffalmacco: «Vogliamo rubarglielo noi stanotte quel porco?»
Disse Buffalmacco. «Come potremo fare?»
Disse Bruno: «Il come l’ho già capito, se non si sposta da dov’era poco fa»
«Dunque» disse Buffalmacco «facciamolo, perché non dovremmo farlo? E dopo ce lo goderemo con il prete».
Il prete disse che era d’accordo; ancora Bruno aggiunse: Qui ci vuole un po’ di astuzia. Sai, Buffalmacco, come Calandrino è avaro e come beve volentieri quando paga qualcun’altro: andiamo e portiamolo alla caverna, qui il prete faccia finta di pagare tutto lui per farci onore e non faccia pagare lui in nessun modo: egli si ubriacherà e ci verrà tutto più facile, allora, essendo solo in casa».
Così come Bruno suggerì, fecero. Calandrino, vedendo che il prete non lo lasciava pagare, si lasciò andare al bere e benché non gli giovasse troppo ne bevve in modo esagerato ed essendo già notte inoltrata andò a casa e credendo di aver chiuso la porta, la lasciò aperta e si buttò a letto. Bruno e Buffalmacco andarono a cena con il prete e dopo aver mangiato, si armarono di alcuni attrezzi per entrare in casa di Calandrino dove Bruno aveva già progettato e vi si diressero, in silenzio; ma trovando la porta aperta entrarono, presero il porco e lo nascosero a casa del prete. Quindi andarono a dormire.
Calandrino, essendo ritornato sobrio, la mattina si alzò, e scese le scale vide che il porco non c’era più e che la porta era rimasta aperta: per questo, domandando in giro chi avesse preso il maiale e non trovandolo, cominciò a fare un gran baccano: accidenti! peggio per lui, che gli avevano rubato il porco. Bruno e Buffalmacco, svegliatisi anche loro, andarono verso casa di Calandrino per vedere cosa costui avrebbe detto del porco ed appena li vide, quasi piangendo li chiamò e disse loro: «Ahimè, amici miei, mi è stato rubato il maiale!»
Bruno, fattosi vicino, gli disse a bassa voce: «Splendido! per questa volta sei stato furbo!»
«Povero me», disse Calandrino «è successo per davvero»
«Di’ così» diceva Bruno «grida forte, in modo che sembri vero che ti sia stato rubato»
Calandrino allora urlava più forte e diceva: «Per il corpo di Cristo ti dico che mi è stato rubato per davvero»
E Bruno diceva: «Dici bene, dici bene; ma bisogna dirlo meglio, gridalo, fatti sentire, in modo che sembri vero»
Disse Calandrino: «Venderesti la mia anima al diavolo, non mi credi; potessi essere impiccato, se non dico la verità che mi è stato rubato!»
Disse allora Bruno: «Accidenti! come può essere? L’ho visto qui ieri, vorresti farmi credere che sia volato?»
Calandrino: «E’ come ti dico».
Bruno: «Come può essere?»
«Sicuramente», disse Calandrino «è così! sono rovinato e non so come tornare a casa; mia moglie non mi crederà e seppure dovesse crederci non mi darà mai più pace».
Disse allora Bruno: «Dio mi scampi, se questo è vero; ma tu sai Calandrino che io ieri sera ti consigliai di far finta che ti sia stato rubato per dirlo a tua moglie e non vorrei che nello stesso momento ti facessi beffe sia di tua moglie che di noi».
Calandrino cominciò a gridare: «Ma insomma perché mi fate disperare? e bestemmiare Dio e tutti i santi del paradiso? Vi dico che stanotte il porco mi è stato rubato»
Disse allora Buffalmacco: «Se è così, bisogna trovare il modo per sapere chi sia stato».
«E che modo» disse Calandrino «potremo trovare?»
Disse allora Buffalmacco: «Sicuramente nessuno è venuto dall’India a portarti via il porco, dev’essere stato uno dei tuoi vicini e perciò, se tu li potessi riunire, io so fare il rito del pane e formaggio e capiremo subito chi ce l’ha»
«Sì», disse Bruno «farai bene con pane e formaggio con questi “galantuomini” che sono qui attorno! Certamente ce l’ha uno di loro e si accorgerebbe (della prova) e non ci verrebbe»
«E allora cosa fare?» disse Buffalmacco.
Rispose Bruno: «Si potrebbe fare con delle gallette di zenzero accompagnati da una buona vernaccia ed invitarli a bere: non penserebbero (al rito) e verrebbero: si potrebbero benedire le gallette come il pane e il formaggio»
Disse Buffalmacco: «Bella trovata. E tu Calandrino che ne pensi? vogliamo provarci?»
Disse Calandrino: «Ve ne prego, per l’amor di Dio, che se solo sapessi chi se l’è preso, mi parrebbe d’essere perlomeno rinfrancato»
«Suvvia», – disse Bruno, – io sono pronto ad andare a Firenze a procurarmi le cose necessarie se tu mi dai i soldi».
Calandrino aveva forse quaranta soldi e in tutto e glieli diede. Bruno, sceso a Firenze, andò da un amico droghiere, comprò circa una libbra (due chilogrammi circa) di biscotti allo zenzero; ma due ne fece fare due confezionati zenzero canino mescolato con amarissimo aloe; quindi le fece tutte coprire di zucchero come le altre e per non scambiarle fece fare un piccolo segno con cui egli le poteva riconosceva; comperato un fiasco di buona vernaccia, tornò al paese e disse a Calandrino: «Domattina, invita tutti quelli di cui hai sospetto: è festa e verranno volentieri ed io, stanotte, farò, insieme a Buffalmacco, l’incantesimo sui biscotti e domattina verrò a portarteli e, per amor tuo, sarò io stesso a darle e ti suggerirò cosa sia necessario dire e cosa fare».
Calandrino così fece. Radunato un buon numero di persone tra giovani fiorentini che erano lì in campagna e i contadini del luogo, la mattina seguente, sotto l’olmo davanti alla chiesa, Bruno e Buffalmacco arrivarono, con una scatola di biscotti e il fiasco della vernaccia e fatti mettere tutti in circolo, Bruno disse loro: «Signori, io devo spiegarvi perché siete stati qui riuniti, affinché, se dovesse capitarvi qualcosa di spiacevole, non ve la prendiate con me. A Calandrino, che è qui in mezzo a noi, ieri notte è stato rubato il maiale e non riesce più a trovarlo; e poiché chi l’ ha rubato deve essere stato uno di noi, Calandrino v’invita a mangiare questi biscotti allo zenzero e a bere. Sappiate però, che chi avrà preso il maiale non potrà mangiare il biscotto perché gli sembrerà più amaro del veleno e la sputerà. Io lo invito dunque, prima di patire questa vergogna in presenza di tutti, di dirlo in confessione al prete e mi asterrò dal compiere il rito».
Tutti risposero che erano pronti a mangiare i biscotti e allora Bruno, dopo averli disposti in giro e messo Calandrino in mezzo a loro, cominciò a dare a ciascuno il biscotto, ma arrivato a Calandrino, afferrata una galletta con lo zenzero canino, glielo diede. Calandrino se lo mise subito in bocca e cominciò a masticare, ma appena sentì l’amaro dell’aloe non poté più sopportarlo e lo sputò. Gli altri, nel frattempo, si tenevano tutti d’occhio per vedere chi sputasse, e non avendo ancora Bruno finita la distribuzione, facendo finta di non essersi accorto che Calandrino l’aveva sputato, sentì dire a un tratto: «Ohè, Calandrino, che significa questo?» e subito voltato, vide che Calandrino l’aveva buttato fuori il biscotto, disse: «Forse gli sarà andato di traverso; diamogliene un altro. E gli mise in bocca il secondo biscotto all’aloe, continuando a distribuire agli altri. A Calandrino, se il primo era sembrato amaro, il secondo biscotto parve amarissimo; tuttavia, vergognandosi di sputarlo, lo tenne in bocca cercando di masticarlo, e avendolo in bocca cominciò a sprizzare lacrime che parevano nocciole, ma alla fine non ce la fece più e lo sputò come il primo. Buffalmacco e Bruno che davano frattanto da bere alla brigata, e tutti gli altri, nel vedere questo, dissero che di certo Calandrino si era rubato lui stesso il maiale, e ci furono anche quelli che lo rimproverarono aspramente.
Dopo che tutti se ne furono andati, Buffalmacco cominciò a dire: «Io lo sapevo che lo avevi tu e che volevi ingannarci per non pagarci nemmeno un bicchiere di vino, con i soldi che ne avresti avuto (vendendolo)».
Calandrino, con la bocca amara, incominciò a giurare e spergiurare di non averlo. »Andiamo, andiamo», continuò Buffalmacco, «ma, amico mio, quanto ne hai ricavato? forse sei fiorini?»
E Calandrino, sentendolo dir così cominciò a disperarsi; allora Bruno disse: «Stammi a sentire, Calandrino, c’è uno qui nella brigata che ha mangiato e bevuto con noi, che mi ha detto che tu avevi qui una ragazzetta che mantenevi per i tuoi affari e che le davi ciò che potevi rimediare, e lui era certo che tu le avevi dato il porco. Hai imparato a prenderci in giro! Già una volta ci hai portato per il Mugnone a cercar pietre, e quando poi ci hai messo nei guai, te ne sei andato e volevi farci credere di aver trovato la pietra che rendeva invisibile, e adesso, allo stesso modo, vorresti darci a intendere che il maiale, che hai regalato o venduto, ti sia stato rubato. Siamo abituati ai tuoi scherzi e li conosciamo, e adesso non ti diamo più retta! Per questo, ci hai fatto passare la notte a preparare l’incantesimo. Sai che ti dico? O ci regali due capponi per il disturbo, o noi raccontiamo tutto a monna Tessa, tua moglie».
Calandrino, vedendo che non era creduto, sembrandogli di aver già avuto troppi dispiaceri, non volendo anche l’arrabbiatura ella moglie, diede loro i due capponi. E Bruno e Buffalmacco, avendo salato loro il porco, se ne andarono a Firenze lasciando Calandrino col danno e le beffe.

Riduzione teatrale della novella
Rispetto alla novella precedente qui Calandrino sembra essere una vittima meno colpevole della beffa ordita dai due amici; certo tra Bruno, Buffalmacco e il prete, non si sa chi sia il peggiore. Ma, al di là di ogni giudizio morale, quello che emerge è che a vincere, pur con la cattiveria tipica di questi buontemponi fiorentini, è sempre l’intelligenza contro la stupidità.
L’intelligenza di Bruno è tutta nel capovolgimento blasfemo di un rito molto in voga nella Firenze del Trecento: “… era un sortilegio, un incantesimo assai diffuso, che aveva assunto quasi forma di rito: (…) fatti certi segni e data la benedizione su bocconi confezionati con formaggio e pane (d’orzo, in genere), si invitavano i presunti ladri a giurare la loro innocenza; e, dette speciali orazioni, si davano loro da mangiare quei bocconi che non potevano essere inghiottiti dal colpevole” (Vittore Branca). Bruno infatti sostituisce al pane e formaggio un biscotto, all’acqua benedetta la vernaccia, al prete benedicente se stesso: tale capovolgimento rituale ha bisogno di un progetto che lo sciocco Calandrino non può capire.
D’altra parte l’ingenuo Calandrino continua ad essere mal visto dallo stesso Boccaccio: manca di convivialità (invita malvolentieri gli amici) ed è avaro (beve solo se gli pagano da bere).
Ma qui si svela ancora una volta anche la capacità comica dell’autore: il dialogo tra Calandrino e Bruno, il derubato e chi pensa sia stato lui, è un capolavoro costruito sul fraintendimento, uno degli elementi basilari della comicità narrativa.
NONA GIORNATA
Alla fine dell’VIII giornata viene nominata Emilia come regina per la nona, la quale, non senza vergogna, così cominciò a parlare ai compagni: E per ciò quello che domane, seguendo il vostro dilettevole ragionare, sia da dire, non intendo di ristrigneni sotto alcuna spezialità, ma voglio che ciascun secondo che gli piace ragioni, cioè, come successo nella prima l’argomento è libero.
La novella seguente è raccontata da Elissa:

Werner Klemke . La badessa con le braghe in testa (1972)
LEVASI UNA BADESSA IN FRETTA E AL BUIO PER TROVARE UNA SUA MONACA, A LEI ACCUSATA, COL SUO AMANTE NEL LETTO; ED ESSENDO CON LEI UN PRETE, CREDENDO IL SALTERO DE’ VELI AVER POSTO IN CAPO, LE BRACHE DEL PRETE VI SI POSE; LE QUALI VEDENDO L’ACCUSATA E FATTALENE ACCORGERE, FU DILIBERATA, ED EBBE AGIO DI STARSI COL SUO AMANTE.
(IX, 2)
Sapere adunque dovete in Lombardia essere un famosissimo monistero di santità e di religione, nel quale, tra l’altre donne monache che v’erano, v’era una giovane di sangue nobile e di maravigliosa bellezza dotata, la quale, Isabetta chiamata, essendo un dì ad un suo parente alla grata venuta, d’un bel giovane che con lui era s’innamorò. Ed esso, lei veggendo bellissima, già il suo disidero avendo con gli occhi concetto, similmente di lei s’accese; e non senza gran pena di ciascuno questo amore un gran tempo senza frutto sostennero. Ultimamente, essendone ciascun sollicito, venne al giovane veduta una via da potere alla sua monaca occultissimamente andare; di che ella contentandosi, non una volta ma molte, con gran piacer di ciascuno, la visitò. Ma continuandosi questo, avvenne una notte che egli da una delle donne di là entro fu veduto, senza avvedersene egli o ella, dall’Isabetta partirsi e andarsene. Il che costei con alquante altre comunicò. E prima ebber consiglio d’accusarla alla badessa, la quale madonna Usimbalda ebbe nome, buona e santa donna secondo la oppinione delle donne monache e di chiunque la conoscea; poi pensarono, acciò che la negazione non avesse luogo, di volerla far cogliere col giovane alla badessa. E così taciutesi, tra sé le vigilie e le guardie segretamente partirono per incoglier costei.

Carolina Crescentini nei panni di Isabetta nel film dei fratelli Taviani Meraviglioso Boccaccio (2001)
Or, non guardandosi l’Isabetta da questo, né alcuna cosa sappiendone, avvenne che ella una notte vel fece venire; il che tantosto sepper quelle che a ciò badavano. Le quali, quando a loro parve tempo, essendo già buona pezza di notte, in due si divisero, e una parte se ne mise a guardia del l’uscio della cella dell’Isabetta, e un’altra n’andò correndo alla camera della badessa; e picchiando l’uscio, a lei che già rispondeva, dissero: «Su, madonna, levatevi tosto, ché noi abbiam trovato che l’Isabetta ha un giovane nella cella».
Era quella notte la badessa accompagnata d’un prete, il quale ella spesse volte in una cassa si faceva venire. La quale, udendo questo, temendo non forse le monache per troppa fretta o troppo volonterose, tanto l’uscio sospignessero che egli s’aprisse, spacciatamente si levò suso, e come il meglio seppe si vestì al buio, e credendosi tor certi veli piegati, li quali in capo portano e chiamanli il saltero, le venner tolte le brache del prete; e tanta fu la fretta, che, senza avvedersene, in luogo del saltero le si gittò in capo e uscì fuori, e prestamente l’uscio si riserrò dietro, dicendo: «Dove è questa maladetta da Dio?» e con l’altre, che sì focose e sì attente erano a dover far trovare in fallo l’Isabetta, che di cosa che la badessa in capo avesse non s’avvedieno, giunse all’uscio della cella, e quello, dall’altre aiutata, pinse in terra; ed entrate dentro, nel letto trovarono i due amanti abbracciati, li quali, da così subito soprapprendimento storditi, non sappiendo che farsi, stettero fermi. La giovane fu incontanente dall’altre monache presa, e per comandamento della badessa menata in capitolo. Il giovane s’era rimaso; e vestitosi, aspettava di veder che fine la cosa avesse, con intenzione di fare un mal giuoco a quante giugner ne potesse, se alla sua giovane novità niuna fosse fatta, e di lei menarne con seco.
La badessa, postasi a sedere in capitolo, in presenzia di tutte le monache, le quali solamente alla colpevole riguardavano, incominciò a dirle la maggior villania che mai a femina fosse detta, sì come a colei la quale la santità, l’onestà e la buona fama del monistero con le sue sconce e vituperevoli opere, se di fuor si sapesse, contaminate avea; e dietro alla villania aggiugneva gravissime minacce.
La giovane, vergognosa e timida, sì come colpevole, non sapeva che si rispondere, ma tacendo, di sé metteva compassion nell’altre; e, multiplicando pur la badessa in novelle, venne alla giovane alzato il viso e veduto ciò che la badessa aveva in capo, e gli usolieri che di qua e di là pendevano.
Di che ella, avvisando ciò che era, tutta rassicurata disse: «Madonna, se Iddio v’aiuti, annodatevi la cuffia, e poscia mi dite ciò che voi volete».
La badessa, che non la intendeva, disse: «Che cuffia, rea femina? Ora hai tu viso di motteggiare? Parti egli aver fatta cosa che i motti ci abbian luogo?»
Allora la giovane un’altra volta disse: «Madonna, io vi priego che voi v’annodiate la cuffia, poi dite a me ciò che vi piace». Laonde molte delle monache levarono il viso al capo della badessa, ed ella similmente ponendovisi le mani, s’accorsero perché l’Isabetta così diceva. Di che la badessa, avvedutasi del suo medesimo fallo e vedendo che da tutte veduto era né aveva ricoperta, mutò sermone, e in tutta altra guisa che fatto non avea cominciò a parlare, e conchiudendo venne impossibile essere il potersi dagli stimoli della carne difendere; e per ciò chetamente, come infino a quel dì fatto s’era, disse che ciascuna si desse buon tempo quando potesse.
E liberata la giovane, col suo prete si tornò a dormire, e l’Isabetta col suo amante. Il qual poi molte volte, in dispetto di quelle che di lei avevano invidia, vi fe’ venire. L’altre che senza amante erano, come seppero il meglio, segretamente procacciaron lor ventura.

Paola Cortellesi nei panni di Usimbalda nel film dei fratelli Taviani Meraviglioso Boccaccio (2001)
Dovete dunque sapere che in Lombardia vi era un monastero famosissimo per religiosità e santità delle monache, nel quale tra le diverse monache che vi risiedevano, v’era una giovane di nobile famiglia e di straordinaria bellezza, di nome Isabetta, che, essendo andata al parlatorio per parlare con suo parente, s’innamorò di un bel giovane che lo accompagnava e lui, vedendola bellissima, avendo compreso dallo sguardo il desiderio della monaca, allo stesso modo la desiderò: e non senza grande sforzo di entrambi per lungo tempo dovettero sostenere questo amore senza appagamento.
Infine, essendo ambedue spinti dal desiderio, il giovane trovò un modo per incontrarsi in modo nascosto con la monaca e, mostrandosi lei felice per ciò, non una volta sola, ma per lungo tempo con grande soddisfazione andò a farle visita.
Mentre la storia tra i due proseguiva, capitò una notte che una monaca vide il giovane dentro il monastero e, senza che lui o lei se ne accorgessero, allontanarsi da Isabetta e uscire. Questa avvisò le altre monache e decisero dapprima di dirlo alla badessa, di nome Usimbalda, secondo l’opinione di tutte le monache e di chiunque la conoscesse, buona e santa donna, poi pensarono, affinché ella non potesse negare la colpa, di far sì che la badessa la cogliesse in fragrante; e così, senza dir niente, si spartirono i turni di veglia e di guardia per sorprenderla.
Ora, Isabetta né stando in guardia né sospettando che qualche monaca sapesse (del suo incontro con il giovane), una notte lo fece venire, cosa che seppero subito quelle monache che facevano la guardia; queste, quando a loro parve opportuno, essendo già notte inoltrata, si divisero in due: una parte si mise davanti alla porta d’Isabetta e un’altra corse alla camera della badessa; queste ultime bussarono alla sua porta e a lei che già rispondeva, dissero: «Signora, alzatevi immediatamente, che abbiamo scoperto che Isabetta ha un giovane in camera».
Quella notte la badessa stava con un prete che spesso lei faceva entrare nella sua camera nascosto dentro una cassa. Dopo aver sentito, temendo che le monache per la troppa foga o per la troppa voglia di denunciare la compagna potessero spingere la porta fino ad aprirla, in tutta fretta si alzò e come meglio poté si vestì al buio, e credendo di prendere certi veli, che erano stati piegati, che le monache si mettono in testa e chiamano salterio, afferrò le braghe del prete; e tanta fu la fretta che senza accorgersene, al posto del velo se le mise in testa e uscì e, chiudendo la porta con precipitazione, disse: «Dov’è questa maledetta da Dio?». E con le altre monache, tutte prese e determinate nel voler cogliere Isabetta in fallo, da non accorgersi cosa la badessa avesse in testa, giunse all’uscio della cella e questo, con l’aiuto delle altre, abbatté in terra e una volta entrate, trovarono i due amanti nel letto. Questi, confusi per esser stati colti così di sorpresa, non sapendo che fare, stettero fermi. La giovane fu subito afferrata dalle altre monache e, per ordine della badessa, portata nella sala capitolare. Il giovane, rimasto, si vestiva per vedere che piega prendesse la cosa e con l’intenzione di fare qualche brutto scherzo alle monache che avesse potuto prendere, se alla sua amante fosse stato fatto alcun male, e poi di condurla via con sé.
La badessa, messasi a sedere nella sala insieme a tutte le altre, che solo a Isabetta guardavano, cominciò ad insultare la giovane pesantemente, come mai nessun’altra donna fosse stata insultata, come se, con le azioni vergognose da lei compiute, se si fossero sapute, avesse infangato la santità, l’onestà e l’ottima fama del monastero; e insieme all’aspro rimprovero, aggiungeva non so quali altre orribili minacce.
La giovane, piena di vergogna ed intimidita, in quanto colpevole non sapeva cosa rispondere, ma tacendo suscitava compassione delle altre per sé, e dilungandosi la badessa nei rimproveri, successe che la giovane alzò il viso e visto ciò che la superiora aveva in testa e i legacci (delle braghe) che pendevano dalla sua testa da una parte e dall’altra, capì cosa fosse e, rinfrancata le disse: «Signora, che Dio vi benedica, legatevi la cuffia e poi ditemi tutto ciò che volete».
La badessa, che non capiva, disse: «Che cuffia, femmina svergognata, hai proprio ora la faccia di prendermi in giro? Ti pare di aver fatto qualcosa che abbia a che fare con gli scherzi?»
Allora la giovane le disse un’altra volta: «Signora, vi prego, legatevi la cuffia e poi ditemi tutto ciò che volete»; allora molte monache rivolsero lo sguardo verso la testa della badessa e lei stessa, mettendosi le mani sul capo, capì perché Isabetta le avesse detto quelle cose.
Resosi conto di ciò, la badessa scoperta da tutte le monache nello stesso errore di cui aveva accusato la giovane, e non potendolo più nascondere, trasformò il discorso rispetto a quello fatto sinora e concluse dicendo che era impossibile difendersi dagli stimoli della carne; per cui, in modo discreto, come si era fatto sino allora, disse a ciascuna di svagarsi quando se ne fosse presentata l’occasione e, liberata la giovane, andò a dormire col prete e Isabetta col suo amante.
La giovane, per dispetto di tutte quelle che avevano invidia, fece venire l’amante molto spesso e le altre, che l’amante non ce l’avevano, in segreto si procurarono i loro piaceri come meglio seppero fare.
La novella qui presentata è forse una delle più divertite di Boccaccio e non per il tema estremamente abituale della sessualità nel mondo ecclesiastico, quanto per lo stile veloce ed incalzante con cui descrive l’intera azione. Tutto, infatti, viene filtrato attraverso lo sguardo: Isabetta, da dietro la grata, guarda il giovane (una sola proposizione per l’innamoramento); le monache vedono il giovane (velocissima la sequenza del vederlo, rimanere a guardia e la denuncia); Isabetta, non guarda ma è guardata, rovesciamento con la stessa situazione, stavolta rivolta alla badessa, che è costretta, a sua volta, guardare, attraverso le mani se stessa.
Per il resto la novella si chiude nel discorso della badessa e nel capovolgimento morale: dalla riprensione alla “naturale” accettazione dell’istinto sessuale (impossibile essere il potersi dagli stimoli della carne difendere). E’ che a tale conclusione si arriva attraverso un sentimento che sentiamo aborrito dallo stesso Boccaccio: quello dell’invidia e, novello Minosse (quel conoscitor de la peccata, direbbe Dante) le punisce in uno sterile autoerotismo.

Gabriele Castagnola: Isabetta con l’amante (1858)
La terza novella su Caladrino ce la racconta Filostrato. Ve n’è una quarta nella stessa giornata, raccontata da Fiammetta, in cui il povero Calandrino s’innamora, subendo l’ira dell’irosa Monna Tessa.
MAESTRO SIMONE, AD INSTANZIA DI BRUNO E DI BUFFALMACCO E DI NELLO, FA CREDERE A CALANDRINO CHE EGLI E’ PREGNO; IL QUALE PER MEDICINE DA’ A’ PREDETTI CAPPONI E DENARI, E GUARISCE DELLA PREGNEZZA SENZA PARTORIRE.
(IX, 3)

Manoscritto del XV secolo con l’illustrazione della novella
Mostrato è di sopra assai chiaro chi Calandrin fosse e gli altri de’ quali in questa novella ragionar debbo; e per ciò, senza più dirne, dico che egli avvenne che una zia di Calandrin si morì e lasciogli dugento lire di piccioli con tanti; per la qual cosa Calandrino cominciò a dire che egli voleva comperare un podere; e con quanti sensali aveva in Firenze, come se da spendere avesse avuti diecimila fiorin d’oro, teneva mercato, il quale sempre si guastava quando al prezzo del poder domandato si perveniva.
Bruno e Buffalmacco, che queste cose sapevano, gli avevan più volte detto che egli farebbe il meglio a goderglisi con loro insieme, che andar comperando terra, come se egli avesse avuto a far pallottole; ma, non che a questo, essi non l’aveano mai potuto conducere che egli loro una volta desse mangiare.
Per che un dì dolendosene, ed essendo a ciò sopravenuto un lor compagno, che aveva nome Nello, dipintore, di liberar tutti e tre di dover trovar modo da ugnersi il grifo alle spese di Calandrino; e senza troppo indugio darvi, avendo tra sé ordinato quello che a fare avessero, la seguente mattina appostato quando Calandrino di casa uscisse, non essendo egli guari andato, gli si fece incontro Nello e disse: «Buon dì, Calandrino».
Calandrino gli rispose che Iddio gli desse il buon dì e ‘l buono anno. Appresso questo, Nello rattenutosi un poco, lo ‘ncominciò a guardar nel viso. A cui Calandrino disse: «Che guati tu?»
E Nello disse a lui: «Haiti tu sentita sta notte cosa niuna? Tu non mi par desso».
Calandrino incontanente incominciò a dubitare e disse: «Ohimè, come! Che ti pare egli che io abbia?»
Disse Nello: «Deh! io nol dico per ciò; ma tu mi pari tutto cambiato; fia forse altro»; e lasciollo andare.
Calandrino tutto sospettoso, non sentendosi per ciò cosa del mondo, andò avanti. Ma Buffalmacco, che guari non era lontano, vedendol partito da Nello, gli si fece incontro, salutatolo il domandò se egli si sentisse niente. Calandrino rispose: «Io non so, pur testé mi diceva Nello che io gli pareva tutto cambiato; potrebbe egli essere che io avessi nulla?»
Disse Buffalmacco: «Sì, potrestu aver cavelle, non che nulla: tu par mezzo morto».
A Calandrino pareva già aver la febbre. Ed ecco Bruno sopravvenne, e prima che altro dicesse, disse: «Calandrino, che viso è quello? E’ par che tu sia morto: che ti senti tu?»
Calandrino, udendo ciascun di costor così dire, per certissimo ebbe seco medesimo d’esser malato; e tutto sgomentato gli domandò: «Che fo?»
Disse Bruno: «A me pare che tu te ne torni a casa a vaditene in su ‘l letto e facciti ben coprire, e che tu mandi il segnal tuo al maestro Simone, che è così nostra cosa come tu sai. Egli ti dirà incontanente ciò che tu avrai a fare, e noi ne verrem teco, e se bisognerà far cosa niuna, noi la faremo».
E con loro aggiuntosi Nello, con Calandrino se ne tornarono a casa sua, ed egli entratosene tutto affaticato nella camera, disse alla moglie: «Vieni e cuoprimi bene, ché io mi sento un gran male».
Essendo adunque a giacer posto, il suo segnale per una fanticella mandò al maestro Simone, il quale allora a bottega stava in Mercato Vecchio alla ‘nsegna del mellone.
E Bruno disse a’ compagni: «Voi vi rimarrete qui con lui, e io voglio andare a sapere che il medico dirà; e, se bisogno sarà, a menarloci».
Calandrino allora disse: «Deh! sì, compagno mio, vavvi e sappimi ridire come il fatto sta, ché io mi sento non so che dentro».
Bruno, andatosene al maestro Simone, vi fu prima che la fanticella che il segno portava, ed ebbe informato maestro Simone del fatto. Per che, venuta la fanticella e il maestro veduto il segno, disse alla fanticella: «Vattene, e di’ a Calandrino che egli si tenga ben caldo, e io verrò a lui incontanente e dirogli ciò che egli ha, e ciò che egli avrà a fare».
La fanticella così rapportò: né stette guari che il maestro e Brun vennero, e postoglisi il medico a sedere allato, gli ‘ncominciò a toccare il polso, e dopo alquanto, essendo ivi presente la moglie, disse: «Vedi, Calandrino, a parlarti come ad amico, tu non hai altro male se non che tu se’ pregno».
Come Calandrino udì questo, dolorosamente cominciò a gridare e a dire: «Ohimè! Tessa, questo m’hai fatto tu, che non vuogli stare altro che di sopra: io il ti diceva bene».
La donna, che assai onesta persona era, udendo così dire al marito, tutta di vergogna arrossò, e abbassata la fronte, senza risponder parola s’uscì della camera.
Calandrino, continuando il suo ramarichio, diceva: «Ohimè, tristo me! Come farò io? Come partorirò io questo figliuolo? Onde uscirà egli? Ben veggo che io son morto per la rabbia di questa mia moglie, che tanto la faccia Iddio trista quanto io voglio esser lieto; ma, così foss’io sano come io non sono, ché io mi leverei e dare’le tante busse, che io la romperei tutta, avvegna che egli mi stea molto bene, ché io non la doveva mai lasciar salir di sopra; ma per certo, se io scampo di questa, ella se ne potrà ben prima morir di voglia».
Bruno e Buffalmacco e Nello avevan sì gran voglia di ridere che scoppiavano, udendo le parole di Calandrino, ma pur se ne tenevano; ma il maestro Scimmione rideva sì squaccheratamente, che tutti i denti gli si sarebber potuti trarre. Ma pure al lungo andare, raccomandandosi Calandrino al medico e pregandolo che in questo gli dovesse dar consiglio e aiuto, gli disse il maestro: «Calandrino, io non voglio che tu ti sgomenti, ché, lodato sia Iddio, noi ci siamo sì tosto accorti del fatto, che con poca fatica e in pochi dì ti dilibererò; ma conviensi un poco spendere».
Disse Calandrino: «Ohimè! maestro mio, sì per l’amor di Dio. Io ho qui dugento lire di che io voleva comperare un podere; se tutti bisognano, tutti gli togliete, purché io non abbia a partorire, ché io non so come io mi facessi, ché io odo fare alle femine un sì gran romore quando son per partorire, con tutto che elle abbian buon cotal grande donde farlo, che io credo, se io avessi quel dolore, che io mi morrei prima che io partorissi».
Disse il medico: «Non aver pensiero. Io ti farò fare una certa bevanda stillata molto buona e molto piacevole. a bere, che in tre mattine risolverà ogni cosa, e rimarrai più sano che pesce; ma farai che tu sii poscia savio e più non incappi in queste sciocchezze. Ora ci bisogna per quella acqua tre paia di buon capponi e grossi, e per altre cose che bisognano darai ad un di costoro cinque lire di piccioli, che le comperi, e fara’mi ogni cosa recare alla bottega, e io al nome di Dio domattina ti manderò di quel beveraggio stillato, e comincera’ ne a bere un buon bicchiere grande per volta.
Calandrino, udito questo, disse: «Maestro mio, ciò siane in voi»; e date cinque lire a Bruno e denari per tre paia di capponi, il pregò che in suo servigio in queste cose durasse fatica.
Il medico, partitosi, gli fece fare un poco di chiarea e mandogliele. Bruno, comperati i capponi e altre cose necessarie al godere, insieme col medico e co’ compagni suoi se li mangiò.
Calandrino bevve tre mattine della chiarea, e il medico venne a lui, e i suoi compagni, e toccatogli il polso gli disse: «Calandrino, tu se’ guerito senza fallo; e però sicuramente oggimai va a fare ogni tuo fatto, né per questo star più in casa».
Calandrino lieto levatosi s’andò a fare i fatti suoi, lodando molto, ovunque con persona a parlar s’avveniva, la bella cura che di lui il maestro Simone aveva fatta, d’averlo fatto in tre dì senza pena alcuna spregnare. E Bruno e Buffalmacco e Nello rimasero contenti d’aver con ingegni saputo schernire l’avarizia di Calandrino, quantunque monna Tessa, avvedendosene, molto col marito ne brontolasse.
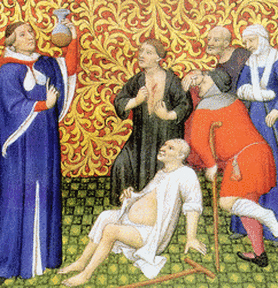
Illustrazione di un medico che osserva le urine dei malati
Nelle storie che sono già state raccontate è dimostrato con chiarezza che razza di uomini fossero Calandrino e i suoi due amici, dei quali io devo parlare in questa novella; e per questo senza aggiungere altro, dico che accadde che una zia di Calandrino morì e gli lasciò in eredità duecento lire di piccioli in contanti; per cui Calandrino cominciò a dire di voler comprare un pezzo di terra e, come se avesse avuto da spendere diecimila fiorini d’oro, avviava una trattativa con tutti i sensali che operavano a Firenze, trattativa che sempre si interrompeva quando si arrivava al prezzo richiesto del podere. Bruno e Buffalmacco, che queste cose sapevano, gli avevano più volte detto che sarebbe stato meglio godersi quei soldi insieme piuttosto che comprare un pezzo di terra per farne delle pallottole (per una balestra); ma essi non solo non poterono condurre Calandrino a questo, nemmeno a offrire loro una volta un pranzo.
Per cui un giorno, rammaricandosi di ciò, ed essendo sopraggiunto mentre parlavano un loro compagno, che si chiamava Nello, pittore anche lui, decisero tutti e tre di trovare il modo di fare una bella scorpacciata alle spese di Calandrino; e senza starci troppo a pensare, avendo tra loro ordito quello che dovessero fare, il giorno dopo Nello, rimasto in attesa che Calandrino uscisse di casa, andato non lontano gli si fece incontro e gli disse : «Buongiorno Calandrino».
Calandrino gli rispose che Dio gli desse il buongiorno ed il buon anno. Dopo questo, Nello, fermatosi un po’, cominciò a guardarlo attentamente nel viso, per cui Calandrino disse : «Che hai da guardare?».
E Nello a lui : «Questa notte hai sentito qualcosa di strano? Hai un aspetto diverso dal solito».
Calandrino subito iniziò a spaventarsi e disse: «Ohimé, come! Cosa ti sembra che io abbia?».
Disse Nello: «Non lo dico per spaventarti; ma mi sembri diverso dal solito; sarà soltanto una mia impressione»; e lo lasciò andar via. Calandrino molto preoccupato, non sentendosi per nulla diverso dal solito continuò a camminare, ma Buffalmacco, che non era lontano, vedendolo andar via da Nello, gli si fece incontro e, salutandolo, gli domandò se sentisse qualcosa di strano. Calandrino rispose: «Non lo so, poco fa Nello mi diceva che gli sembravo cambiato, potrebbe forse essere che io abbia qualcosa?». Disse Buffalmacco: «Tu potresti proprio avere qualcosa, altro che nulla: sembri mezzo morto».
A Calandrino sembrava già di avere la febbre. Ed ecco sopraggiungere Bruno e prima di salutarlo disse: «Calandrino, che faccia è quella? Sembri morto: che ti senti?».
Calandrino, sentendo costoro dire così, stabilì fra sé e sé con assoluta certezza di essere malato e, pieno di sgomento, domandò loro: «Che faccio?»
Disse Bruno: «Mi sembra opportuno che tu torni a casa e che ti metta sul letto e che ti faccia coprire bene e che tu mandi un campione della tua urina al medico Simone, che, come sai, è un nostro intimo amico. Egli ti dirà subito ciò che dovrai fare e noi ti accompagneremo, se bisognerà fare qualcosa noi la faremo».
E con loro si aggiunse Nello e con Calandrino se ne andarono a casa sua ed egli entrò tutto affannato; e arrivato in camera disse alla moglie: «Vieni e coprimi bene che mi sento molto male».
Stando dunque a letto, mandò per mezzo di una servetta le sue urine al maestro Simone, che aveva bottega presso Mercato Vecchio e aveva per insegna un melone.
E Bruno disse ai compagni: «Voi rimanete qui con lui, io voglio andare a sentire cosa dirà il medico e se ci sarà bisogno a portarlo qui».
Calandrino allora disse: «Si amico mio, vacci e riferiscimi come stanno le cose, che io già mi sento un non so che dentro il corpo».
Bruno, andato dal maestro Simone, vi giunse prima della servetta che aveva con sé le urine e informò maestro Simone della beffa organizzata ai danni di Calandrino. Per ciò, venuta la servetta e vista l’urina, il medico le disse: «Va’, e di’ a Calandrino che si tenga al caldo che io andrò da lui subito e gli dirò che cosa ha e che cosa dovrà fare».
La servetta così riferì e non passò molto tempo che il maestro e Bruno giunsero: il medico si mise a sedere a fianco del letto e cominciò a toccargli il polso, e dopo un po’, alla presenza della moglie, gli disse: «Vedi, Calandrino, a parlarti come ad un amico, tu non hai altro male che quello di essere incinto».
Come Calandrino sentì questo, cominciò a gridare disperatamente e a dire: «Ahimé, Tessa, questo guaio me lo hai procurato tu, volendo sempre stare sopra, e io ti avevo avvisato».
La donna, che era una persona molto onesta, sentendo dire queste cose dal marito diventò rossa per la vergogna e, abbassata la fronte, se ne andò dalla camera.
Calandrino, continuando il suo lamento, diceva: «Ahimé, povero me, come farò? Come partorirò questo figliolo? Da dove uscirà? Vedo soltanto che io sono destinato a morire per la lussuria di questa mia moglie, che Dio la faccia soffrire tanto quanto io vorrei essere felice; ma, se stessi bene e non come ora, mi alzerei e le darei tante di quelle botte da farla a pezzi, e mi sta proprio bene, perché io non avrei dovuto farla salire sopra di me; ma state sicuri che se esco da questa malattia lei potrà morire dal desiderio prima di avere un altro rapporto con me».
Bruno, Buffalmacco e Nello avevano un così gran voglia di ridere che stavano per scoppiare, sentendo le parole di Calandrino, ma si trattenevano; invece lo stesso maestro “Scimmione” rideva in modo così sgangherato che gli si sarebbero potuti cavare tutti i denti. Ma, procedendo nella beffa, affidandosi Calandrino al medico e pregandolo che in questo lo dovesse consigliare ed aiutare, gli disse il medico: « Calandrino, io non voglio che tu ti spaventi, perché, sia lodato Dio, noi ci siamo accorti del fatto in tempo, per cui con poca fatica e in pochi giorni ti libererò; ma bisogna che tu spenda un po’ di denaro».
Disse Calandrino: Ahimè, maestro mio, certamente per l’amor di Dio. Io ho qui duecento lire con cui volevo comprare un podere; se vi servono, prendeteli tutti, purché io non debba partorire, perché non so come potrei fare, perché io so che le femmine quando stanno per partorire fanno un grande strepito, sebbene esse abbiano un organo abbastanza grande per fare uscire i figli, perché credo, se io avessi quel dolore, che io morirei prima di partorire».
Disse il medico: «Non ci pensare. Io ti farò fare una certa bevanda distillata molto buona e molto piacevole da bere, che in tre giorni risolverà ogni cosa e così rimarrai più sano di un pesce; ma dovrai fare in modo che tu dopo, con più saggezza, non incappi più in simili guai. Ora ci occorrono per quella bevanda tre paia di buoni e grassi capponi, e per le altre cose che ci occorreranno darai per ciascuno di loro cinque lire di piccioli affinché le comperi, e mi farai portare ogni cosa in bottega ed io, in nome di Dio, domani mattina ti manderò quella bevanda distillata e comincerai a berla, un grande bicchiere pieno al giorno.»
Calandrino, sentito questo, disse: «Maestro mio, pensateci voi»; e date a Bruno cinque lire e soldi per i capponi, lo pregò che si prendesse la briga di fare queste cose per lui.
Il medico, andatosene via, gli fece fare un po’ di bevanda medicinale e gliela mandò. Bruno, comprati i capponi e altre cose prelibate, insieme con il medico e con i compagni se li mangiarono.
Calandrino bevve per tre mattine la bevanda medicale e il medico giunse da lui, insieme con i compagni, e gli toccò il polso e gli disse: «Calandrino, tu, senza dubbio, sei guarito; e perciò ora vai a fare tranquillamente le tue cose, e non devi più restare a casa».
Calandrino, alzatosi dal letto felice, andò a fare i suoi affari, apprezzando molto con chiunque parlasse, la bella cura che il maestro Simone gli aveva dato, cioè di averlo fatto abortire in tre giorni senza alcuna sofferenza. Bruno, Buffalmacco e Nello godettero di avere, con astuzia, saputo ingannare l’avarizia di Calandrino, sebbene monna Tessa, accortasi della burla, borbottasse continuamente contro il marito.
La novella non si distanza molto dalle precedenti, anzi rimarca in modo più diretto come anche nella costruzione di uno scherzo vi stia, alla base, un motivo economico. Se per Boccaccio diventare “buon massaio” (vedi Federigo) è saper ben amministrare, Calandrino non riconosce il valore dei soldi, cioè non sa come si amministri un bene economico. Per questo è continuamente beffato.

Bruno, Buffalmacco e Calandrino
Se dovessimo, volendo, fare con quest’ultima un sunto delle sue caratteristiche, oltre ad essere straordinariamente “stupido” (crede al mondo favoloso di Bengodi presentato da Maso; crede in un rituale fatto con biscotti e vino; crede di essere incinto) è “peccaminosamente” avaro, cioè vien meno al precetto fondamentale di una società in cui l’aspetto borghese non dimentica l’aspetto cortese, cioè la liberalità, quando quest’ultima viene esercitata con discrezione.
DECIMA GIORNATA
A reggere l’ultima giornata e, naturalmente ad essere l’ultimo re dell’allebra brigata di novellatori è Panfilo (il cui nome – amico di tutti o verso tutti – richiama il tema da lui scelto): Egli infatti propone di ragionare di chi liberalmente ovvero magnificamente alcuna cosa operasse intorno a’ fatti d’amore o d’altra cosa.
A raccontarci la storia del famoso “bandito” è Elissa

Un’immagine, tratta da un fumetto di Ghino di Tacco
GHINO DI TACCO PIGLIA L’ABATE DI CLIGNI’ E MEDICALO DEL MALO ALLO STOMACO E POI IL LASCIA QUALE, TORNATO IN CORTE DI ROMA, LUI RICONCILIA CON BONIFAZIO PAPA E FALLO FRIERE DELLO SPEDALE.
(X, 2)
Ghino di Tacco, per la sua fierezza e per le sue ruberie uomo assai famoso, essendo di Siena cacciato e nimico de’ conti di Santa Fiore, ribellò Radicofani alla Chiesa di Roma, e in quel dimorando, chiunque per le circustanti parti passava rubar faceva a’suoi masnadieri. Ora, essendo Bonifazio papa ottavo in Roma, venne a corte l’abate di Clignì, il quale si crede essere un de’ più ricchi prelati del mondo, e quivi guastatoglisi lo stomaco, fu da’ medici consigliato che egli andasse a’ bagni di Siena, e guerirebbe senza fallo. Per la qual cosa, concedutogliele il papa, senza curar della fama di Ghino, con grandissima pompa d’arnesi e di some e di cavalli e di famiglia entrò in cammino. Ghino di Tacco, sentendo la sua venuta, tese le reti, e, senza perderne un sol ragazzetto, l’abate con tutta la sua famiglia e le sue cose in uno stretto luogo racchiuse. E questo fatto, un de’ suoi, il più saccente, bene accompagnato mandò allo abate; il qual da parte di lui assai amorevolmente gli disse, che gli dovesse piacere d’andare a smontare con esso Ghino al castello. Il che l’abate udendo, tutto furioso rispose che egli non ne voleva far niente, sì come quegli che con Ghino niente aveva a fare; ma che egli andrebbe avanti, e vorrebbe veder chi l’andar gli vietasse.
Al quale l’ambasciadore umilmente parlando disse: «Messere, voi siete in parte venuto dove, dalla forza di Dio in fuori, di niente ci si teme per noi, e dove le scomunicazioni e gl’interdetti sono scomunicati tutti; e per ciò piacciavi per lo migliore di compiacere a Ghino di questo».
Era già, mentre queste parole erano, tutto il luogo di masnadieri circundato; per che l’abate, co’ suoi preso veggendosi, disdegnoso forte, con l’ambasciadore prese la via verso il castello, e tutta la sua brigata e li suoi arnesi con lui; e smontato, come Ghino volle, tutto solo fu messo in una cameretta d’un palagio assai oscura e disagiata, e ogn’altro uomo secondo la sua qualità per lo castello fu assai bene adagiato, e i cavalli e tutto l’arnese messo in salvo, senza alcuna cosa toccarne.
E questo fatto, se n’andò Ghino all’abate e dissegli: «Messere, Ghino, di cui voi siete oste, vi manda pregando che vi piaccia di significarli dove voi andavate, e per qual cagione».
L’abate, che, come savio, aveva l’altierezza giù posta, gli significò dove andasse e perché. Ghino, udito questo, si partì, e pensossi di volerlo guerire senza bagno; e faccendo nella cameretta sempre ardere un gran fuoco e ben guardarla, non tornò a lui infino alla seguente mattina; e allora in una tovagliuola bianchissima gli portò due fette di pane arrostito e un gran bicchiere di vernaccia da Corniglia, di quella dello abate medesimo, e sì disse all’abate: «Messer, quando Ghino era più giovane, egli studiò in medicina, e dice che apparò niuna medicina al mal dello stomaco esser miglior che quella che egli vi farà, della quale queste cose che io vi reco sono il cominciamento; e per ciò prendetele e confortatevi».
L’abate, che maggior fame aveva che voglia di motteggiare, ancora che con isdegno il facesse, si mangiò il pane e bevve la vernaccia, e poi molte cose altiere disse e di molte domandò e molte ne consigliò, e in ispezieltà chiese di poter veder Ghino. Ghino, udendo quelle, parte ne lasciò andar sì come vane, e ad alcuna assai cortesemente rispose, affermando che come Ghino più tosto potesse il visiterebbe; e questo detto, da lui si partì, né prima vi tornò che il seguente dì con altrettanto pane arrostito e con altrettanta vernaccia; e così il tenne più giorni, tanto che egli s’accorse l’abate aver mangiate fave secche, le quali egli studiosamente e di nascoso portate v’aveva e lasciate.
Per la qual cosa egli il domandò da parte di Ghino come star gli pareva dello stomaco; al quale l’abate rispose: «A me parrebbe star bene, se io fossi fuori delle sue mani; e appresso questo, niun altro talento ho maggiore che di mangiare, sì ben m’hanno le sue medicine guerito».
Ghino adunque avendogli de’ suoi arnesi medesimi e alla sua famiglia fatta acconciare una bella camera, e fatto apparecchiare un gran convito, al quale con molti uomini del castello fu tutta la famiglia dello abate, a lui se n’andò la mattina seguente e dissegli: «Messere, poi che voi ben vi sentite, tempo è d’uscire d’infermeria»; e per la man presolo, nella camera apparecchiatagli nel menò, e in quella co’ suoi medesimi lasciatolo, a far che il convito fosse magnifico attese. L’abate co’ suoi alquanto si ricreò, e qual fosse la sua vita stata narrò loro, dove essi in contrario tutti dissero sé essere stati maravigliosamente onorati da Ghino. Ma l’ora del mangiar venuta, l’abate e tutti gli altri ordinatamente e di buone vivande e di buoni vini serviti furono, senza lasciarsi Ghino ancora all’abate conoscere. Ma poi che l’abate alquanti dì in questa maniera fu dimorato, avendo Ghino in una sala tutti li suoi arnesi fatti venire, e in una corte, che di sotto a quella era, tutti i suoi cavalli in fino al più misero ronzino allo abate se n’andò e domandollo come star gli pareva e se forte si credeva essere da cavalcare. A cui l’abate rispose che forte era egli assai e dello stomaco ben guerito, e che starebbe bene qualora fosse fuori delle mani di Ghino.
Menò allora Ghino l’abate nella sala dove erano i suoi arnesi e la sua famiglia tutta, e fattolo ad una finestra accostare donde egli poteva tutti i suoi cavalli vedere, disse: «Messer l’abate, voi dovete sapere che l’esser gentile uomo e cacciato di casa sua e povero, e avere molti e possenti nimici, hanno, per potere la sua vita e la sua nobiltà difendere, e non malvagità d’animo, condotto Ghino di Tacco, il quale io sono, ad essere rubatore delle strade e nimico della corte di Roma. Ma per ciò che voi mi parete valente signore, avendovi io dello stomaco guerito, come io ho, non intendo di trattarvi come un altro farei, a cui, quando nelle mie mani fosse come voi siete, quella parte delle sue cose mi farei che mi paresse; ma io intendo che voi a me, il mio bisogno considerato, quella parte delle vostre cose facciate che voi medesimo volete. Elle sono interamente qui dinanzi da voi tutte, e i vostri cavalli potete voi da cotesta finestra nella corte vedere; e per ciò e la parte e il tutto come vi piace prendete, a da questa ora innanzi sia e l’andare e lo stare nel piacer vostro».
Maravigliossi l’abate che in un rubator di strada fosser parole sì libere, e piacendogli molto, subitamente la sua ira e lo sdegno caduti, anzi in benivolenzia mutatisi, col cuore amico di Ghino divenuto, il corse ad abbracciar dicendo: «Io giuro a Dio che, per dover guadagnar l’amistà d’uno uomo fatto come omai io giudico che tu sii, io sofferrei di ricevere troppo maggiore ingiuria che quella che infino a qui paruta m’è che tu m’abbi fatta. Maladetta sia la fortuna, la quale a sì dannevole mestier ti costrigne!» E appresso questo, fatto delle sue molte cose pochissime e opportune prendere, e de’ cavalli similmente, e l’altre lasciategli tutte, a Roma se ne tornò.
Aveva il papa saputa la presura dello abate e, come che molto gravata gli fosse, veggendolo il domandò come i bagni fatto gli avesser pro. Al quale l’abate sorridendo rispose: «Santo Padre, io trovai più vicino che i bagni un valente medico, il quale ottimamente guerito m’ha; e contogli il modo; di che il papa rise». Al quale l’abate, seguitando il suo parlare, da magnifico animo mosso, domandò una grazia.
Il papa, credendo lui dover domandare altro, liberamente offerse di far ciò che domandasse. Allora l’abate disse: «Santo Padre, quello che io intendo di domandarvi è che voi rendiate la grazia vostra a Ghino di Tacco mio medico, per ciò che tra gli altri uomini valorosi e da molto che io accontai mai, egli è per certo un de’ più; e quel male il quale egli fa, io il reputo molto maggior peccato della fortuna che suo; la qual se voi con alcuna cosa dandogli, donde egli possa secondo lo stato suo vivere, mutate, io non dubito punto che in poco di tempo non ne paia a voi quello che a me ne pare».
Il papa, udendo questo, sì come colui che di grande animo fu e vago de’ valenti uomini, disse di farlo volentieri, se da tanto fosse come diceva, e che egli il facesse sicuramente venire. Venne adunque Ghino fidato, come allo abate piacque, a corte; né guari appresso del papa fu, che egli il reputò valoroso, e riconciliatoselo gli donò una gran prioria di quelle dello Spedale, di quello avendol fatto far cavaliere. La quale egli, amico e servidore di santa Chiesa e dello abate di Clignì, tenne mentre visse.

Il castello di Radicofani dove si svolge la vicenda
Ghino di Tacco uomo molto conosciuto per la sua ferocia ed i suoi ladrocini, essendo nemico dei conti dei Biancofiore ed essendo stato bandito da Siena, fece ribellare Radicofani alla Chiesa di Roma e lì dimorando, chiunque fosse passato per quei luoghi o per quelli circostanti subiva le ruberie dalla sua compagnia. Mentre a Roma vi era il papa Bonifacio VIII, vi giunse l’abate di Clignì, che sembra fosse uno dei più ricchi prelati del mondo e qui, ammalatosi di stomaco, gli fu consigliato di andare alle terme di Siena dove sarebbe certamente guarito. Perciò, ricevuta la concessione papale, senza preoccuparsi della presenza di Ghino in quei luoghi, con gran ricchezza di arnesi, di some, di cavalli e di persone iniziò il viaggio.
Ghino di Tacco, saputo del suo passaggio, organizzò l’agguato e senza che gli sfuggisse un solo servitorello racchiuse in una gola l’abate con tutta la sua compagnia; dopo ciò mandò all’abate, opportunamente accompagnato, il più loquace dei suoi servitori a cui, con estrema cortesia, disse di dover andare e di alloggiare insieme alle sue cose al castello di Ghino. L’abate, dopo aver ascoltato le parole del messaggere, furiosamente gli rispose che non l’avrebbe fatto, ma che sarebbe andato avanti e voleva vedere chi glielo avrebbe impedito.
A lui, l’ambasciatore, con atteggiamento rispettoso, rispose: «Signore, voi siete venuto in quella parte del luogo dove, all’infuori della potenza di Dio, niente temiamo e dove non c’è uomo che non sia scomunicato o interdetto; perciò, per il vostro bene, gradisca di compiacere la volontà di Ghino»
Mentre parlavano, tutto il luogo era stato già circondato dagli uomini di Ghino, per cui l’abate, vedendosi ormai catturato con tutta la sua famiglia, con forte disprezzo, prese la via del castello con l’ambasciatore e con tutta la sua compagnia e, smontato da cavallo, su ordinazione di Ghino, fu messo da solo in una cameretta disagevole e con poca luce, mentre tutti gli altri uomini, secondo la loro condizione, furono comodamente alloggiati; allo stesso modo tutti cavalli e tutte le cose portate dall’abate fu messo in disparte senza toccare nulla.
Dopo ciò Ghino andò dall’abate e gli disse: «Signore, Ghino, di cui siete ospite, mi manda per sapere dove eravate diretto e il motivo per cui vi andavate».
L’abate, saggiamente, messa da parte l’alterigia, gli riferì in quale luogo fosse diretto ed il perché. Ghino, dopo averlo ascoltato, uscì e pensò di volerlo guarire senza che lui andasse alle terme; nella cameretta in cui stava l’abate fece fare e governare un fuoco ardente e il giorno dopo vi tornò e arrotolate in una tovaglietta bianchissima mise due fette di pane abbrustolito un bel bicchiere di vernaccia di Corniglia, dalle terre dello stesso abate e così disse all’abate: «Signore, quando Ghino era più giovane, studiò medicina e afferma che ha appreso una cura che nessun’altra ve n’è di migliore per il mal di stomaco di quella che lui stesso vi preparerà, di cui queste cose che vi porto sono l’inizio, perciò prendete e state di buon animo».
L’abate che aveva più fame che voglia di parlare, sebbene lo facesse con un atteggiamento un po’ sdegnoso, mangio lo stesso il pane e bevve la vernaccia e poi disse parole alterate e domandò molte cose e molte disse di dover fare e per ultimo chiese di poter vedere Ghino. Quest’ultimo, ascoltandolo, lasciò che molte parole dell’abate risuonassero vuote ad altre rispose con gentilezza e infine gli disse che, non appena Ghino avesse potuto, sarebbe andato a salutarlo. Detto questo si allontanò e non vi tornò che il giorno dopo con lo stesso pane abbrustolito e con la stessa vernaccia e così continuò per un po’ di giorni tanto che si accorse che l’abate, di nascosto, aveva mangiato fave secche che Ghino stesso aveva portato e lasciato.
Per questo egli gli domandò da parte di Ghino come gli sembrasse andasse il suo mal di stomaco, a cui l’abate rispose: «A me sembrerebbe di star bene, se non fossi nelle sue mani e, a parte questo, non ho altra voglia che di mangiare, così bene mi hanno guarito le sue medicine».
Ghino, quindi, fatta raccogliere in una camera tutte le sue cose e l’intero suo seguito e fatta preparare una grande tavolata alla quale fu invitata tutta la famiglia di Ghino e tutti gli accompagnatori dell’abate da lui, il giorno dopo, andò e gli disse: «Signore, dal momento che state bene, è ora che voi usciate dall’infermeria», e presolo per mano lo portò nella sala che aveva allestito e qui, lasciatolo con i suoi, prestò la sua attenzione a preparare un convito sontuoso.
L’abate con i suoi accompagnatori molto si svagò e come avesse passato quei giorni raccontò loro, mentre essi al contrario gli di essere di essere stati meravigliosamente trattati da Ghino; ma giunta l’ora di mangiare, l’abate e tutti gli altri furono serviti in modo convenevole, senza che Ghino si lasciasse ancora riconoscere. Ma dopo che l’abate un po’ di giorni rimase al castello in questo modo, avendo Ghino raccolto tutti i suoi arnesi in una sala e i cavalli, sino al più misero ronzio, radunati nel cortile, andò dall’abate e gli domandò lo stato della sua salute e se si riteneva abbastanza in forma da poter cavalcare; a lui l’abate rispose che stava bene e che era guarito dal mal di stomaco e che starebbe bene qualora fosse fuori dalla prigionia in cui lo teneva Ghino.

Ghino allora lo condusse dove aveva i suoi arnesi e tutta la sua compagnia e lo fece affacciare alla finestra da dove poteva vedere tutti i suoi cavalli e dopo gli disse: «Signor abate, voi dovete sapere che essere un nobile uomo, cacciato di casa e ridotto in povertà, l’avere molti e potenti nemici, per poter difendere la sua nobiltà e la libertà, e non per malvagità, hanno portato Ghino di Tacco, che sono io, a essere rapinatore e nemico della Chiesa. Ma, dal momento in cui vi reputo un uomo pieno di virtù, avendovi guarito dal mal di stomaco, non intendo trattarvi come qualsiasi altro al quale, quando fosse nelle mie mani, come siete voi ora, prenderei dalle sue cose tutto ciò di cui avessi voglia, ma io desidero che voi a me, considerata la mia condizione, mi diate quella parte che voi stesso volete darmi. Sono tutte qui davanti a voi e dalla finestra potete vedere i vostri cavalli; perciò prendete una parte o tutta e sia nella vostra volontà l’andare via o il voler rimanere qui».
L’abate rimase meravigliato che un rapinatore di strada avesse parle così liberali e ciò gli piacque molto: immediatamente mutando la sua ira in benevolenza, diventato dentro il suo cuore amico di Ghino, corse ad abbracciarlo, dicendo: «Giuro su Dio che per dovermi guadagnare l’amicizia di un uomo con quei valori che ormai giudico tu abbia, sarei disposto a subire un’offesa maggiore di quella che mi è parso tu abbia fatto a me. Sia maledetta la sorte che ti ha condannato ad un così deprecabile stato!» E detto ciò, prese con sé se non pochissime e necessarie cose e lo stesso fece dei cavalli, lasciando tutto il resto a Ghino, e se ne tornò a Roma.
Il papa aveva saputo del rapimento dell’abate e ne era molto preoccupato; vedendolo gli domandò se avesse ricevuto benefici dalle terme, a cui l’abate rispose con un sorriso: «Santo padre, ho trovato un bravissimo medico più vicino delle terme, che mi ha ottimamente guarito» e gli raccontò l’episodio occorsogli. Di ciò il papa rise e a lui l’abate, spinto da generosità d’animo, domandò una grazia.
Il papa, capendo che l’abate voleva domandare di più, liberamente lo pregò che glielo svelasse, allora l’abate disse: «Santo padre, quello che voglio domandarvi e che voi concediate il vostro perdono a Ghino di Tacco, mio medico, perché tra gli uomini valorosi e d’importanza che io ho incontrato nel corso della mia vita, egli è fra i più, e il male che egli fa, ritengo sia più frutto della sorte che della sua indole. Per cui se voi gli donate la vostra grazia, egli potrà vivere secondo il suo stato e non dubito affatto, cambiate le cose, che lui appaia a voi come è sembrato a me».
Il papa, sentendo questo, essendo lui stesso d’animo grande e amando perciò gli uomini valorosi, disse che l’avrebbe fatto volentieri se ciò era detto da una così degna di fede persona, e che lo facesse senza por tempo in mezzo a Roma. Giunse quindi Ghino, assicurato dalla parola del papa, secondo la volontà dell’abate, nella corte papale; né molto tempo dopo, reputandolo lo stesso papa pieno di virtù e fatto in modo che si riconciliasse con lui, lo nominò priore di un grande territorio di quelli degli Spedalieri e lo rese cavaliere; per cui lui si mantenne, finché visse amico della Chiesa e dell’abate di Clignì.

Immagine tratta da un manoscritto che illustra la novella di Ghino di Tacco e dell’abate di Clignì
“Quiv’era l’Aretin che da le braccia / fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte” in questi due versi tratti dal Purgatorio di Dante, in cui ci ricorda come il giuriconsulto Benincasa da Laterina venne ammazzato appunto da Ghino di Tacco, ci dice forse quanto fosse popolare tale personaggio, tanto da essere sfruttato, in modo anche più ampio, dalla novella di Boccaccio.
Tuttavia nel Decameron la figura del criminale viene trasfigurata in una sorta di bandito gentiluomo, la cui vicenda si disegna sul piano della costrizione più che della scelta. Non sappiamo se sia vero il perdono del papa, ma che su di lui girassero notizie secondo le quali chiunque fosse stato rapito da lui, veniva poi rilasciato lasciandogli qualcosa con cui continuare a vivere, ne alimentò la leggenda.

Statua rappresentante Ghino di Tacco a Radicofani
Ma a Boccaccio non serve costruire un personaggio che tanto sarebbe piaciuto alla lettura romantica, quanto invece un rappresentante di un mondo in cui la liberalità era segno distintivo di grandezza e nobiltà d’animo. Ghino di Tacco in questo è fratello di Federigo degli Alberighi, la cui generosità sarà premiata in uno con il matrimonio, nell’altro con il cavalierato. Infatti una delle parole che emerge in questa novella è il concetto di fortuna: ma dietro essa vi è sempre l’uomo e ancora al di sopra di lui, Dio. Suiamo non a caso nella decima giornata in cui è premiata la liberalità dei protagonisti; ma a liberalità è un frutto di scelta dell’uomo, che, sembra dirci Boccaccio non viene cancellata dalla storia, ma permane in lui fino ad esserne premiato.
L’ultima novella, forse tra le più apprezzate, grazie alla traduzione latina che ne fece Petrarca, ci è raccontata dal più intemperante dei novellatori, Dioneo.
IL MARCHESE DI SANLUZZO DA’ PREGHI DE’ SUOI UOMINI COSTRETTO DI PIGLIAR MOGLIE, PER PRENDERLA A SUO MODO, PIGLIA UNA FIGLIUOLA D’UN VILLANO, DELLA QUALE HA DUE FIGLIUOLI, LI QUALI LI FA VEDUTO D’UCCIDERGLI; POI, MOSTTRANDO LEI ESSERGLI RINCRESCIUTA E AVERE ALTRA MOGLIE PRESA A CASA FACCENDOSI RITORNARE LA PROPRIA FIGLIUOLA COME SE SUA MOGLIE FOSSE, LEI AVENDO IN CAMISCIA CACCIATA E A OGNI COSA TROVANDOLA PAZIENTE, PIU’ CARA CHE MAI IN CASA TORNATALASI, I SUOI FIGLIUOLI GRANDI LE MOSTRA E COME MARCHESANA L’ONORA E FA ONORARE.
(X, 10)

Pesellino: Le storie di Griselda (1445)
Già è gran tempo, fu tra’ marchesi di Sanluzzo il maggior della casa un giovane chiamato Gualtieri, il quale, essendo senza moglie e senza figliuoli, in niuna altra cosa il suo tempo spendeva che in uccellare e in cacciare, né di prender moglie né d’aver figliuoli alcun pensiere avea, di che egli era da reputar molto savio. La qual cosa a’ suoi uomini non piacendo, più volte il pregarono che moglie prendesse, acciò che egli senza erede né essi senza signor rimanessero, offerendosi di trovargliele tale e di sì fatto padre e madre discesa, che buona speranza se ne potrebbe avere, ed esso contentarsene molto.
A’ quali Gualtieri rispose: «Amici miei, voi mi strignete a quello che io del tutto aveva disposto di non far mai, considerando quanto grave cosa sia a poter trovare chi co’ suoi costumi ben si convenga, e quanto del contrario sia grande la copia, e come dura vita sia quella di colui che a donna non bene a sé conveniente s’abbatte. E il dire che voi vi crediate a’ costumi de’ padri e delle madri le figliuole conoscere, donde argomentate di darlami tal che mi piacerà, è una sciocchezza; con ciò sia cosa che io non sappia dove i padri possiate conoscere, né come i segreti delle madri di quelle; quantunque, pur conoscendoli, sieno spesse volte le figliuole a’ padri e alle madri dissimili. Ma poi che pure in queste catene vi piace d’annodarmi, e io voglio esser contento; e acciò che io non abbia da dolermi d’altrui che di me, se mal venisse fatto, io stesso ne voglio essere il trovatore, affermandovi che, cui che io mi tolga, se da voi non fia come donna onorata, voi proverete con gran vostro danno quanto grave mi sia l’aver contra mia voglia presa mogliere a’ vostri prieghi». I valenti uomini risposon ch’eran contenti, sol che esso si recasse a prender moglie.

Anonimo: Griselda svestita (1494)
Erano a Gualtieri buona pezza piaciuti i costumi d’una povera giovinetta che d’una villa vicina a casa sua era, e parendogli bella assai, estimò che con costei dovesse aver vita assai consolata; e per ciò, senza più avanti cercare, costei propose di volere sposare; e fattosi il padre chiamare, con lui, che poverissimo era, si convenne di torla per moglie. Fatto questo, fece Gualtieri tutti i suoi amici della contrada adunare, e disse loro: «Amici miei, egli v’è piaciuto e piace che io mi disponga a tor moglie, e io mi vi son disposto più per compiacere a voi che per disiderio che io di moglie avessi. Voi sapete quello che voi mi prometteste, cioè d’esser contenti e d’onorar come donna qualunque quella fosse che io togliessi; e per ciò venuto è il tempo che io sono per servare a voi la promessa, e che io voglio che voi a me la serviate. Io ho trovata una giovane secondo il cuor mio, assai presso di qui, la quale io intendo di tor per moglie e di menarlami fra qui a pochi dì a casa; e per ciò pensate come la festa delle nozze sia bella, e come voi onorevolmente ricever la possiate, acciò che io mi possa della vostra promession chiamar contento, come voi della mia vi potrete chiamare».
I buoni uomini lieti tutti risposero ciò piacer loro, e che, fosse chi volesse, essi l’avrebber per donna e onorerebbonla in tutte cose sì come donna. Appresso questo, tutti si misero in assetto di far bella e grande e lieta festa, e il simigliante fece Gualtieri. Egli fece preparare le nozze grandissime e belle, e invitarvi molti suoi amici e parenti e gran gentili uomini e altri dattorno; e oltre a questo fece tagliare e far più robe belle e ricche al dosso d’una giovane, la quale della persona gli pareva che la giovinetta la quale avea proposto di sposare; e oltre a questo apparecchiò cinture e anella e una ricca e bella corona, e tutto ciò che a novella sposa si richiedea.

Pesellino: Incontro e matrimonio tra Gualtieri e Griselda (1445)
E venuto il dì che alle nozze predetto avea, Gualtieri in su la mezza terza montò a cavallo, e ciascuno altro che ad onorarlo era venuto; e ogni cosa opportuna avendo disposta, disse: «Signori, tempo è d’andare per la novella sposa»; e messosi in via con tutta la compagnia sua pervennero alla villetta. E giunti a casa del padre della fanciulla, e lei trovata che con acqua tornava dalla fonte in gran fretta, per andar poi con altre femine a veder venire la sposa di Gualtieri, la quale come Gualtieri vide, chiamatala per nome, cioè Griselda, domandò dove il padre fosse; al quale ella vergognosamente rispose: «Signor mio, egli è in casa».
Allora Gualtieri smontato e comandato ad ogn’uomo che l’aspettasse, solo se n’entrò nella povera casa, dove trovò il padre di lei che aveva nome Giannucole, e dissegli: «Io son venuto a sposar la Griselda, ma prima da lei voglio sapere alcuna cosa in tua presenzia»; e domandolla se ella sempre, togliendola egli per moglie, s’ingegnerebbe di compiacergli e di niuna cosa che egli dicesse o facesse non turbarsi, e s’ella sarebbe obbediente, e simili altre cose assai, delle quali ella a tutte rispose del sì.
Allora Gualtieri, presala per mano, la menò fuori, e in presenzia di tutta la sua compagnia e d’ogni altra persona la fece spogliare ignuda, e fattisi quegli vestimenti venire che fatti aveva fare, prestamente la fece vestire e calzare, e sopra i suoi capegli così scarmigliati com’egli erano le fece mettere una corona, e appresso questo, maravigliandosi ogn’uomo di questa cosa, disse: «Signori, costei è colei la quale io intendo che mia moglie sia, dove ella me voglia per marito»; e poi a lei rivolto, che di sé medesima vergognosa e sospesa stava, le disse: «Griselda, vuo’ mi tu per tuo marito?»
A cui ella rispose: «Signor mio, sì».
Ed egli disse: «E io voglio te per mia moglie»; e in presenza di tutti la sposò; e fattala sopra un pallafren montare, onorevolmente accompagnata a casa la si menò. Quivi furon le nozze belle e grandi e la festa non altramenti che se presa avesse la figliuola del re di Francia. La giovane sposa parve che co’ vestimenti insieme l’animo e i costumi mutasse. Ella era, come già dicemmo, di persona e di viso bella: e così come bella era, divenne tanto avvenevole, tanto piacevole e tanto costumata, che non figliuola di Giannucole e guardiana di pecore pareva stata, ma d’alcun nobile signore; di che ella faceva maravigliare ogn’uom che prima conosciuta l’avea; e oltre a questo era tanto obbediente al marito e tanto servente, che egli si teneva il più contento e il più appagato uomo del mondo; e similmente verso i sudditi del marito era tanto graziosa e tanto benigna, che niun ve n’era che più che sé non l’amasse e che non l’onorasse di grado, tutti per lo suo bene e per lo suo stato e per lo suo essaltamento pregando; dicendo, dove dir solieno Gualtieri aver fatto come poco savio d’averla per moglie presa, che egli era il più savio e il più avveduto uomo che al mondo fosse; per ciò che niun altro che egli avrebbe mai potuto conoscere l’alta virtù di costei nascosa sotto i poveri panni e sotto l’abito villesco. E in brieve non solamente nel suo marchesato, ma per tutto, anzi che gran tempo fosse passato, seppe ella sì fare che ella fece ragionare del suo valore e del suo bene adoperare, e in contrario rivolgere, se alcuna cosa detta s’era contra ‘l marito per lei quando sposata l’avea.
Ella non fu guari con Gualtieri dimorata, che ella ingravidò, e al tempo partorì una fanciulla, di che Gualtieri fece gran festa. Ma poco appresso, entratogli un nuovo pensier nell’animo, cioè di volere con lunga esperienzia e con cose intollerabili provare la pazienzia di lei, primieramente la punse con parole, mostrandosi turbato e dicendo che i suoi uomini pessimamente si contentavano di lei per la sua bassa condizione, e spezialmente poi che vedevano che ella portava figliuoli; e della figliuola che nata era tristissimi, altro che mormorar non facevano.

Charles West Cope: La prima prova della pazienza di Griselda (1849)
Le quali parole udendo la donna, senza mutar viso o buon proponimento in alcuno atto, disse: «Signor mio, fa di me quello che tu credi che più tuo onore e consolazion sia, ché io sarò di tutto contenta, sì come colei che conosco che io sono da men di loro, e che io non era degna di questo onore al quale tu per tua cortesia mi recasti». Questa risposta fu molto cara a Gualtieri, conoscendo costei non essere in alcuna superbia levata, per onor che egli o altri fatto l’avesse.
Poco tempo appresso, avendo con parole generali detto alla moglie che i sudditi non potevan patir quella fanciulla di lei nata, informato un suo famigliare, il mandò a lei, il quale con assai dolente viso le disse: «Madonna, se io non voglio morire, a me conviene far quello che il mio signor mi comanda. Egli m’ha comandato che io prenda questa vostra figliuola e ch’io…» e non disse più.
La donna, udendo le parole e vedendo il viso del famigliare, e delle parole dette ricordandosi, comprese che a costui fosse imposto che egli l’uccidesse; per che prestamente presala della culla e baciatala e benedettala, come che gran noia nel cuor sentisse, senza mutar viso in braccio la pose al famigliare e dissegli: «Te’: fa compiutamente quello che il tuo e mio signore t’ha imposto; ma non la lasciar per modo che le bestie e gli uccelli la divorino, salvo se egli nol ti comandasse». Il famigliare, presa la fanciulla, e fatto a Gualtieri sentire ciò che detto aveva la donna, maravigliandosi egli della sua costanzia, lui con essa ne mandò a Bologna ad una sua parente, pregandola che, senza mai dire cui figliuola si fosse, diligentemente l’allevasse e costumasse.
Sopravenne appresso che la donna da capo ingravidò, e al tempo debito partorì un figliuol maschio, il che carissimo fu a Gualtieri; ma, non bastandogli quello che fatto avea, con maggior puntura trafisse la donna, e con sembiante turbato un dì le disse: «Donna, poscia che tu questo figliuol maschio facesti, per niuna guisa con questi miei viver son potuto, sì duramente si ramaricano che uno nepote di Giannucole dopo me debba rimaner lor signore; di che io mi dotto, se io non ci vorrò esser cacciato, che non mi convenga far di quello che io altra volta feci, e alla fine lasciar te e prendere un’altra moglie». La donna con paziente animo l’ascoltò, né altro rispose se non: «Signor mio, pensa di contentar te e di sodisfare al piacer tuo, e di me non avere pensiere alcuno, per ciò che niuna cosa m’è cara se non quant’io la veggo a te piacere».
Dopo non molti dì Gualtieri, in quella medesima maniera che mandato avea per la figliuola, mandò per lo figliuolo, e similmente dimostrato d’averlo fatto uccidere, a nutricar nel mandò a Bologna, come la fanciulla aveva mandata; della qual cosa la donna né altro viso né altre parole fece che della fanciulla fatto avesse; di che Gualtieri si maravigliava forte e seco stesso affermava niun’altra femina questo poter fare che ella faceva; e se non fosse che carnalissima de’ figliuoli, mentre gli piacea, la vedea, lei avrebbe creduto ciò fare per più non curarsene, dove come savia lei farlo cognobbe. I sudditi suoi, credendo che egli uccidere avesse fatti i figliuoli, il biasimavan forte e reputavanlo crudele uomo, e alla donna avevan grandissima compassione; la quale con le donne, le quali con lei de’ figliuoli così morti si condoleano, mai altro non disse se non che quello ne piaceva a lei che a colui che generati gli avea.
Ma, essendo più anni passati dopo la natività della fanciulla, parendo tempo a Gualtieri di fare l’ultima pruova della sofferenza di costei, con molti de’ suoi disse che per niuna guisa più sofferir poteva d’aver per moglie Griselda e che egli cognosceva che male e giovenilmente aveva fatto quando l’aveva presa, e per ciò a suo poter voleva procacciar col papa che con lui dispensasse che un’altra donna prender potesse e lasciar Griselda; di che egli da assai buoni uomini fu molto ripreso. A che null’altro rispose, se non che convenia che così fosse. La donna, sentendo queste cose e parendole dovere sperare di ritornare a casa del padre e forse a guardar le pecore come altra volta aveva fatto e vedere ad un’altra donna tener colui al quale ella voleva tutto il suo bene, forte in sé medesima si dolea; ma pur, come l’altre ingiurie della fortuna avea sostenute, così con fermo viso si dispose a questa dover sostenere.
Non dopo molto tempo Gualtieri fece venire sue lettere contraffatte da Roma, e fece veduto a’ suoi sudditi il papa per quelle aver seco dispensato di poter torre altra moglie e lasciar Griselda. Per che, fattalasi venir dinanzi, in presenza di molti le disse: «Donna, per concession fattami dal papa, io posso altra donna pigliare e lasciar te; e per ciò che i miei passati sono stati gran gentili uomini e signori di queste contrade, dove i tuoi stati son sempre lavoratori, io intendo che tu più mia moglie non sia, ma che tu a casa Giannucole te ne torni con la dote che tu mi recasti, e io poi un’altra, che trovata n’ho convenevole a me, ce ne menerò».
La donna, udendo queste parole, non senza grandissima fatica, oltre alla natura delle femine, ritenne le lagrime, e rispose: «Signor mio, io conobbi sempre la mia bassa condizione alla vostra nobilità in alcun modo non convenirsi, e quello che io stata son con voi, da Dio e da voi il riconoscea, né mai, come donatolmi, mio il feci o tenni, ma sempre l’ebbi come prestatomi; piacevi di rivolerlo, e a me dee piacere e piace di renderlovi; ecco il vostro anello col quale voi mi sposaste, prendetelo. Comandatemi che io quella dote me ne porti che io ci recai, alla qual cosa fare, né a voi pagator né a me borsa bisognerà né somiere, per ciò che di mente uscito non m’è che ignuda m’aveste: e se voi giudicate onesto che quel corpo, nel qual io ho portati figliuoli da voi generati, sia da tutti veduto, io me n’andrò ignuda; ma io vi priego, in premio della mia verginità, che io ci recai e non ne la porto, che almeno una sola camiscia sopra la dote mia vi piaccia che io portar ne possa».
Gualtieri, che maggior voglia di piagnere avea che d’altro, stando pur col viso duro, disse: «E tu una camiscia ne porta».
Quanti dintorno v’erano il pregavano che egli una roba le donasse, ché non fosse veduta colei, che sua moglie tredici anni e più era stata, di casa sua così poveramente e così vituperosamente uscire, come era uscirne in camicia; ma in vano andarono i prieghi; di che la donna, in camiscia e scalza e senza alcuna cosa in capo, accomandatili a Dio, gli uscì di casa, e al padre se ne tornò con lagrime e con pianto di tutti coloro che la videro. Giannucole, che creder non avea mai potuto questo esser vero che Gualtieri la figliuola dovesse tener moglie, e ogni dì questo caso aspettando guardati l’aveva i panni che spogliati s’avea quella mattina che Gualtieri la sposò; per che recatigliele ed ella rivestitiglisi, ai piccoli servigi della paterna casa si diede, sì come far soleva, con forte animo sostenendo il fiero assalto della nimica fortuna.
Come Gualtieri questo ebbe fatto, così fece veduto a’ suoi che presa aveva una figliuola d’uno dei conti da Panago; e faccendo fare l’appresto grande per le nozze, mandò per Griselda che a lui venisse, alla quale venuta disse: «Io meno questa donna la quale io ho nuovamente tolta, e intendo in questa sua prima venuta d’onorarla; e tu sai che io non ho in casa donne che mi sappiano acconciare le camere né fare molte cose che a così fatta festa si richeggiono; e per ciò tu, che meglio che altra persona queste cose di casa sai, metti in ordine quello che da far ci è, e quelle donne fa invitare che ti pare, e ricevile come se donna di qui fossi; poi, fatte le nozze, te ne potrai a casa tua tornare».
Come che queste parole fossero tutte coltella al cuore di Griselda, come a colei che non aveva così potuto por giù l’amore che ella gli portava, come fatto avea la buona fortuna, rispose: «Signor mio, io son presta e apparecchiata». Ed entratasene co’ suoi pannicelli romagnuoli e grossi in quella casa, della qual poco avanti era uscita in camicia, cominciò a spazzare le camere e ordinarle, e a far porre capoletti e pancali per le sale, a fare apprestare la cucina, e ad ogni cosa, come se una piccola fanticella della casa fosse, porre le mani; né mai ristette che ella ebbe tutto acconcio e ordinato quanto si convenia. E appresso questo, fatto da parte di Gualtieri invitare tutte le donne della contrada, cominciò ad attender la festa; e venuto il giorno delle nozze, come che i panni avesse poveri in dosso, con animo e con costume donnesco tutte le donne che a quelle vennero, e con lieto viso, ricevette.
Gualtieri, il quale diligentemente aveva i figliuoli fatti allevare in Bologna alla sua parente, che maritata era in casa de’ conti da Panago, essendo già la fanciulla d’età di dodici anni la più bella cosa che mai si vedesse, e il fanciullo era di sei, avea mandato a Bologna al parente suo, pregandol che gli piacesse di dovere con questa sua figliuola e col figliuolo venire a Saluzzo, e ordinare di menare bella e orrevole compagnia con seco, e di dire a tutti che costei per sua mogliere gli menasse, senza manifestare alcuna cosa ad alcuno chi ella si fosse altramenti. Il gentile uomo, fatto secondo che il marchese il pregava, entrato in cammino, dopo alquanti dì con la fanciulla e col fratello e con nobile compagnia in su l’ora del desinare giunse a Saluzzo, dove tutti i paesani e molti altri vicini dattorno trovò, che attendevan questa novella sposa di Gualtieri. La quale dalle donne ricevuta, e nella sala dove erano messe le tavole venuta, Griselda, così come era, le si fece lietamente incontro dicendo: «Ben venga la mia donna». Le donne (che molto avevano, ma invano, pregato Gualtieri che o facesse che la Griselda si stesse in una camera, o che egli alcuna delle robe che sue erano state le prestasse, acciò che così non andasse davanti a’ suoi forestieri) furon messe a tavola, e cominciate a servire. La fanciulla era guardata da ogn’uomo, e ciascun diceva che Gualtieri aveva fatto buon cambio; ma intra gli altri Griselda la lodava molto, e lei e il suo fratellino.
Gualtieri, al qual pareva pienamente aver veduto quantunque disiderava della pazienza della sua donna, veggendo che di niente la novità delle cose la cambiava, ed essendo certo ciò per mentecattaggine non avvenire, per ciò che savia molto la conoscea, gli parve tempo di doverla trarre dell’amaritudine, la quale estimava che ella sotto il forte viso nascosa tenesse. Per che, fattalasi venire, in presenzia d’ogn’uomo sorridendo le disse: «Che ti par della nostra sposa?»
«Signor mio», rispose Griselda «a me ne par molto bene; e se così è savia come ella è bella, che ‘l credo, io non dubito punto che voi non dobbiate con lei vivere il più consolato signore del mondo; ma quanto posso vi priego che quelle punture, le quali all’altra, che vostra fu, già deste, non diate a questa; ché appena che io creda che ella le potesse sostenere, sì perché più giovane è, e sì ancora perché in dilicatezze è allevata, ove colei in continue fatiche da piccolina era stata».
Gualtieri, veggendo che ella fermamente credeva costei dovere esser sua moglie, né per ciò in alcuna cosa men che ben parlava, la si fece sedere allato, e disse: «Griselda, tempo è omai che tu senta frutto della tua lunga pazienza, e che coloro, li quali me hanno reputato crudele e iniquo e bestiale, conoscano che ciò che io faceva, ad antiveduto fine operava, vogliendo a te insegnar d’esser moglie e a loro di saperla torre e tenere, e a me partorire perpetua quiete mentre teco a vivere avessi; il che, quando venni a prender moglie, gran paura ebbi che non mi intervenisse, e per ciò, per prova pigliarne, in quanti modi tu sai ti punsi e trafissi. E però che io mai non mi sono accorto che in parola né in fatto dal mio piacer partita ti sii, parendo a me aver di te quella consolazione che io disiderava, intendo di rendere a te ad una ora ciò che io tra molte ti tolsi, e con somma dolcezza le punture ristorare che io ti diedi; e per ciò con lieto animo prendi questa, che tu mia sposa credi, e il suo fratello: sono i nostri figliuoli, li quali e tu e molti altri lungamente stimato avete che io crudelmente uccider facessi; e io sono il tuo marito, il quale sopra ogn’altra cosa t’amo, credendomi poter dar vanto che niuno altro sia che, sì com’io, si possa di sua moglie contentare».
E così detto, l’abbracciò e baciò, e con lei insieme, la qual d’allegrezza piagnea, levatosi, n’andarono là dove la figliuola tutta stupefatta queste cose ascoltando sedea, e abbracciatala teneramente e il fratello altressì, lei e molti altri che quivi erano sgannarono. Le donne lietissime levate dalle tavole, con Griselda n’andarono in camera, e con migliore augurio trattile i suoi pannicelli, d’una nobile roba delle sue la rivestirono, e come donna, la quale ella eziandio negli stracci pareva, nella sala la rimenarono. E quivi fattasi co’ figliuoli maravigliosa festa, essendo ogn’uomo lietissimo di questa cosa, il sollazzo e ‘ festeggiare multiplicarono e in più giorni tirarono; e savissimo reputaron Gualtieri, come che troppo reputassero agre e intollerabili l’esperienze prese della sua donna; e sopra tutti savissima tenner Griselda.
Il conte da Panago si tornò dopo alquanti dì a Bologna, e Gualtieri, tolto Giannucole dal suo lavorio, come suocero il puose in istato, che egli onoratamente e con gran consolazione visse e finì la sua vecchiezza. Ed egli appresso, maritata altamente la sua figliuola, con Griselda, onorandola sempre quanto più si potea, lungamente e consolato visse. Che si potrà dir qui, se non che anche nelle povere case piovono dal cielo de’ divini spiriti, come nelle reali di quegli che sarien più degni di guardar porci che d’avere soprauomini signoria? Chi avrebbe, altri che Griselda, potuto col viso, non solamente asciutto ma lieto, sofferire le rigide e mai più non udite prove da Gualtieri fatte? Al quale non sarebbe forse stato male investito d’essersi abbattuto a una, che quando fuor di casa l’avesse in camicia cacciata, s’avesse sì ad un altro fatto scuotere il pelliccione, che riuscita ne fosse una bella roba.

Esilio di Griselda (1494)
Molto tempo fa, un giovane chiamato Gualtieri fu tra i marchesi di Saluzzo il capo della famiglia, il quale non avendo moglie né figlioli, in nessuna altra cosa trascorreva il suo tempo se non andando a caccia di uccelli e di selvaggina, e non aveva nessuna intenzione né di prendere moglie né di avere figli, cosa per cui egli era reputato molto saggio. Questa cosa ai suoi sudditi non piaceva e più volte lo pregarono di prender moglie affinché lui non rimanesse senza eredi ed essi senza signore, dichiarandosi pronti a trovare per lui una donna tanto nobile e gentile e figlia di padre e madre tali che si potesse nutrire buona speranza e ne potesse rimanere molto soddisfatto.
A questi Gualtieri rispose: «Amici miei, non mi costringete a fare quello che io avevo deliberato di non fare mai, considerando come sia difficile trovare chi si accordi alle proprie abitudini, e quanto grande sia la quantità del contrario e come sia dura la vita di colui che si imbatte in una donna non adatta a lui. Ed è una sciocchezza dire che voi crediate di conoscere le figlie dai costumi dei padri e delle madri e da qui argomentare di trovarmene una che mi piacerà, perché io non so come possiate conoscere i loro padri e i segreti delle loro madri e, pur conoscendoli, spesse volte accade che le figliole siano molto diverse dai padri e dalle madri. Ma dal momento in cui a voi piace mettermi le catene, ecco che vi voglio accontentare; e affinché non debba poi lamentarmi con altri se non con me stesso, se la cosa dovesse riuscire male, io stesso voglio individuare la fanciulla da sposare, dichiarandovi in modo esplicito che chiunque sia la donna che sposerò, se non sarà rispettata da voi come signora, voi sperimenterete a vostro danno quali possano essere gravi le conseguenze dell’avere io preso moglie contro i miei desideri, in base alle vostre sollecitazioni». I valenti nobiluomini risposero che erano d’accordo, a patto che lui stesso si inducesse a prender moglie.
Da molto tempo erano piaciuti a Gualtieri i modi di una povera giovinetta di un villaggio vicino a casa sua e sembrandogli molto bella credette che con lei avrebbe potuto avere una vita assai felice. E per questo, senza cercare ulteriormente, propose di volerla sposare e fattosi chiamare il padre, che era poverissimo, si accordò con lui per prenderla come moglie.
Fatto questo, Gualtieri fece riunire tutti i suoi amici dei dintorni e disse loro: «Amici miei, vi è piaciuto e vi piace che io mi decida a prender moglie , e io mi sono deciso più per accontentarvi che per il desiderio di avere moglie. Voi sapete quello che mi avete promesso, cioè di essere contenti e onorare come vostra signora chiunque io sposi; e per questo è venuto il tempo che io vi mantenga la promessa, e voglio che voi la manteniate a me. Io ho trovato qua vicino una giovane secondo il mio desiderio, che io intendo prendere per moglie e condurla a casa fra pochi giorni, e per questo pensate ad organizzare una bella festa e a riceverla con tutti gli onori, dimostrandomi che io mi possa ritenere soddisfatto della vostra parola come voi possiate ritenervi soddisfatti della mia».
I nobiluomini risposero che gradivano ciò che il marchese aveva deciso e che la donna fosse chi volesse lui e che essi l’avrebbero accettata come padrona e l’avrebbero adorata in ogni occasione come signora; e dopo ciò tutti si prepararono per fare una bella, grande e straordinaria festa, e lo stesso fece Gualtieri. Egli fece preparare nozze assai sfarzose e belle, invitò molti suoi amici, parenti e nobili importanti e altra gente del circondario; e oltre a questo fece tagliare molti vestiti eleganti e preziosi sul modello di una giovane che gli sembrava simile, nella persona, alla ragazza che aveva deciso di sposare, e oltre a ciò preparò cinture e anelli e una ricca e bella acconciatura e tutto ciò che si riteneva opportuno per una nuova sposa.
Giunto il giorno stabilito per le nozze, Gualtieri alle sette e mezza del mattino montò a cavallo e con lui tutti coloro che erano venuti a fargli onore e, avendo preparato ogni cosa, disse: «Signori è ormai tempo di andare a prendere la sposa» e messosi in cammino con tutti i suoi invitanti giunsero fino alla piccola fattoria. Arrivati a casa del padre della fanciulla e trovatala che stava tornando dalla fonte con una brocca d’acqua e s’affrettava, per poi andare a vedere insieme alle altre compagne la sposa di Gualtieri, appena questi la vide la chiamò per nome, cioé Griselda, e le domandò dove fosse suo padre al quale lei rispose timidamente: «Mio signore, è in casa». Gualtieri smontò allora da cavallo, fece segno a tutti d’attendere ed entrò nella casupola, dove trovò Giannucole, il padre di Griselda, e gli disse: «Sono qui per sposare tua figlia, ma prima voglio che lei mi dica una cosa qui in tua presenza» e le domandò se sempre, una volta presa per moglie, si preoccupasse di compiacergli e di non turbarsi per nessuna cosa egli avrebbe detto o fatto, se gli sarebbe stata sempre ubbidiente, e altre cose simili, alle quali richieste lei rispose di sì.
Allora Gualtieri prendendola per mano, la condusse fuori e in presenza di tutta la sua compagnia e di ogni persona che stava li a guardare, la fece spogliare nuda e fattosi portare quegli abiti che aveva fatto preparare, immediatamente la fece vestire e calzare, e sui capelli. così com’erano, scarmigliati, le fece posare il diadema e dopo questo, tra la meraviglia generale, disse: «Signori, lei è quella che io desidero come mia moglie, purché ella mi voglia per marito». Poi a lei rivolto, che se ne stava titubante e vergognosa di se medesima, le chiese: «Griselda, mi vuoi per tuo marito?»
A cui ella rispose: «Signor mio, sì».
E lui le disse: «Ed io voglio te per mia moglie» e, in presenza di tutti, la sposò. E fattala montare su un cavallo e se la portò a casa con tutti gli onori.
Qui le nozze furono splendide e maestose, e lo stesso fu la festa non diversamente se Gualtieri avesse sposato la figlia del re di Francia.
La giovane sposa sembrò che cambiasse insieme con i vestiti anche il suo carattere e i suoi modi. Lei era come già abbiamo detto molto bella sia di corpo che di viso e così come era bella divenne tanto elegante e disinvolta che non sembrava più essere stata la figlia di Giannucole e custode di pecore, ma quella di un nobile signore, e perciò lei suscitò la meraviglia in tutti quelli che l’avevano conosciuta prima. E oltre a ciò era così obbediente e servizievole verso il marito che lui si sentiva l’uomo più felice ed appagato del mondo; e nello stesso modo era tanto gentile e benevola verso i sudditi che non c’era nessuno che non l’amasse più di se stesso e non la onorasse volentieri; e tutti pregavano per la sua salute, la sua fortuna e la sua prosperità, affermando, quando prima si era soliti dire che Gualtieri , prendendola in moglie, si era comportato in modo poco avveduto, che egli era il più saggio e il più previdente uomo che si fosse al mondo, per ciò che nessun altro, se non lui, avrebbe mai potuto conoscere l’alta virtù di lei nascosta sotto poveri panni ed un abito contadino.
Ed essendo passato poco tempo dal suo matrimonio, non solamente nel suo marchesato ma dappertutto, seppe ella così comportarsi che fece in modo si ragionasse del suo valore e del buon operato e fece ritirare e correggere i giudizi contrari che erano stati formulati contro il marito, a causa sua, quando l’aveva sposata.
Non molto tempo dopo che ella era vissuta con Gualtieri, rimase incinta e dopo nove mesi partorì una bambina, e per questo Gualtieri fece una gran festa.
Ma poco dopo, venutogli nella mente un pensiero bizzarro, cioè di volere con un lungo esperimento e con intollerabili prove saggiare la pazienza di lei. in primo luogo la offese con male parole mostrandosi arrabbiato e dicendo che i suoi sudditi non erano affatto contenti di lei a causa della sua bassa condizione e specialmente ora che lei generava figli ed erano addoloratissimi che era nata una femmina, tanto che non facevano altro che mormorare.
La donna, ascoltando queste parole, senza cambiare l’espressione del viso o i buoni propositi alla base di ogni suo comportamento, disse: «Signor mio, fa’ di me quello che sia più consono al tuo onore e alla tua consolazione, perché io sarò soddisfatta di tutto essendo una che, come so, sono inferiore a loro e che io non ero degna di questo onore al quale tu, per tua generosità, mi hai offerto».
Questa risposta fu molto gradita a Gualtieri, riconoscendo che lei non si era assolutamente insuperbita a causa degli onori che da lui o da altri aveva ricevuto.
Poco tempo dopo, avendo detto con parole generiche che i sudditi non potevano sopportare quella fanciulla che aveva partorito, addestrato un suo servo lo mandò a lei, il quale con un viso dolorante, le disse: «Signora, se non voglio morire devo fare quello che il mio signore mi comanda. Egli mi ha comandato che io prenda questa vostra figliola e che io … » e non aggiunse altro.
La donna, ascoltando le parole e vedendo il viso del servo, e ricordandosi di ciò (che Gualtieri le aveva detto), comprese che a costui fosse stato imposto di ucciderla; per cui immediatamente, sollevatala dalla culla la baciò e la benedisse, e benché nel cuore provasse un grande dolore, senza mutare espressione, la diede in braccio al servo e gli disse: «Tieni: fa’ fino in fondo quello che il tuo e il mio signore ti ha imposto, ma non lasciarla in modo che le bestie e gli uccelli la divorino, sempre che lui non te lo comandasse».
Il servo, presa la fanciulla, riferito a Gualtieri ciò che la donna aveva detto e meravigliandosi molto della sua fermezza, lo mandò con la piccola a Bologna da una sua parente, pregandola, senza mai dirle di chi fosse figlia, di allevarla in maniera diligente e di educarla.
Accadde in seguito che la donna rimase di nuovo incinta e dopo nove mesi partorì un maschio, di che fu contentissimo Gualtieri; ma non bastandogli quello che aveva fatto prima, colpì la donna con maggiori insulti, e con un atteggiamento offeso un giorno le disse: «Donna, dopo che hai partorito questo figlio maschio, non ho potuto stare in alcun modo con i miei vassalli, così aspramente si lamentano che un nipote di Giannucole debba diventare, dopo la mia morte, loro signore; pertanto io temo che, se non voglio essere cacciato dalla mia terra, mi convenga fare quello che ho già fatto un’altra volta, e alla fine lasciare te e prendere un’altra moglie».
La donna lo ascoltò con pazienza e non rispose altro se non: «Signor mio, preoccupati di rendere felice te e di soddisfare il tuo piacere e non pensare a me, dal momento che nessuna cosa mi è cara se non quando la vedo gradita a te».
Dopo non molti giorni, nella stessa maniera che aveva mandato a prelevare la figlia, o fece per il figlio e allo stesso modo, mostrando di averlo fatto ammazzare, lo mandò a Bologna per allevarlo, come prima aveva fatto con la fanciulla; e di questo fatto la donna non fece altro viso né disse altre parole che avesse fatto con l’episodio della figlia; di ciò Gualtieri si stupiva molto e affermava tra sé che nessuna donna poteva fare quello che lei faceva e se non fosse che l’aveva vista affezionatissima ai figli, finché a lui piaceva, avrebbe creduto che ciò dipendesse dal fatto che non se ne curava, mentre riconobbe che così faceva per la sua saggezza.
I suoi sudditi, credendo che egli avesse fatto uccidere i figli, lo rimproveravano aspramente e lo ritenevano un uomo crudele e avevano una grandissima compassione verso la donna; la quale, con le altre donne che con lei condividevano il dolore per i figli così uccisi, non disse altro se non che a lei stava bene ciò che piaceva a lui che li aveva generati.
Ma essendo passati abbastanza anni dalla nascita della fanciulla, sembrando a Gualtieri che fosse giunto il momento di fare l’ultima prova della paziente capacità di sopportazione di lei, disse a molti suoi vassalli che non poteva più in alcun modo sopportare di avere Griselda per moglie, e che capiva di aver agito male e per inesperienza giovanile quando l’aveva sposata, e che perciò voleva ottenere dal papa, con il suo prestigio, la dispensa di poter lasciare Griselda e sposare un’altra donna; cosa di cui lui stesso da valentissimi uomini fu molto rimproverato. Al che non rispose niente altro che era necessario che si facesse così.
La donna, avendo sentito queste cose, sembrandole che si dovesse aspettare di ritornare a casa dal padre e forse a governare le pecore come in passato, e vedere che un’altra donna aveva per marito l’uomo al quale voleva tutto il bene di cui era capace, molto si rammaricava dentro di sé, ma pure come aveva sostenuto le altre avversità così, con viso risoluto, si dispose a dover sostenere anche questa.
Non dopo molto tempo Gualtieri fece arrivare le sue lettere contraffatte da Roma e lasciò credere ai suoi sudditi attraverso queste che il papa gli aveva concesso la dispensa e di poter prendere un’altra moglie, lasciando Griselda; per cui, chiamatala al suo cospetto, alla presenza di molti, le disse: «Donna, per una concessione fattami dal papa io posso prendere un’altra donna e lasciare te; e dal momento che i miei antenati sono stati degli aristocratici e nobili di questi luoghi, dal momento che i tuoi sono sempre stati contadini, voglio che tu non sia più mia moglie ma che tu te ne torni a casa di Giannucolo con la dote che mi hai portato, e poi un’altra, che ho trovato della mia classe, la condurrò qui come moglie».
La donna, ascoltando queste parole, non senza una grandissima fatica, al di là della natura femminile, trattenne le lacrime e rispose: «Signor mio, ho sempre saputo che la mia bassa condizione non era assolutamente conveniente alla vostra nobiltà e quello che io sono stata con voi l’ho sempre riconosciuto come dono vostro e di Dio, né mai proprio come dono, lo feci mio o lo trattenni, ma sempre lo considerai come un prestito, e anche a me deve piacere e mi piace rendervelo: ecco l’anello con il quale mi sposaste, prendetevelo. Mi ordinate che io me ne vada con quella dote che vi ho recato: per fare ciò né voi avete bisogno di un servitore adibito a pagare né io di borsa o bestia da soma, perché non mi sono dimenticata che mi avete preso nuda; e se voi giudicate cosa onesta che quel corpo nel quale io ho portato i figlioli da voi generati sia visto da tutti, me ne andrò nuda; ma io vi prego, in premio della mia verginità che vi ho portato e che non posso portar via, che almeno una sola camicia sopra la mia dote vi piaccia che io possa portare».
Gualtieri, che non aveva altra voglia che quella di piangere, pur rimanendo con un atteggiamento altero, disse: «E tu, vattene con una camicia».
Tutti quelli che avevano osservato ciò, lo pregavano di darle almeno un abito, che non si vedesse colei che per sua moglie era stata per tredici anni o più nella sua casa, uscire così poveramente e così ingiuriosamente, come era appunto uscire con una semplice camicia; ma inutili furono le preghiere, per cui la donna, in camicia, scalza e senza nulla in capo, dopo averlo raccomandato a Dio, uscì dalla sua casa e se ne tornò dal padre, con le lacrime e con il pianto di tutti coloro che la videro andar via. Giannucolo, che non aveva mai potuto credere che fosse vero che Gualtieri dovesse trattenere la figliola come moglie, e aspettandosi da un giorno all’altro che questo che gli era capitato avvenisse, gli aveva conservato i vestiti che quella mattina che Gualtieri la sposò le aveva tolto; per cui ripresi i vestiti e rivestita, si dedicò ai piccoli servizi nella casa del padre, così come era stata abituata a fare, sostenendo con grande fortezza d’animo il feroce assalto della fortuna nemica.
Dopo che Gualtieri ebbe fatto questo, fece credere ai suoi sudditi di aver preso una figliola da uno dei conti di Panico e facendo fare grandi preparativi per le nozze mandò qualcuno a chiamare Griselda e a lei, dopo esser giunta, disse: «Io conduco questa donna alla quale mi sono nuovamente legato con una solenne promessa di nozze e intendo farle onore in questa sua prima visita; tu sai che non ho in casa donne che mi sappiano preparare le camere né fare molte altre cose che sono richieste per un così grande evento: e perciò tu,che sai meglio di qualunque altra persona delle cose di casa, metti in ordine quello che c’e da mettere in ordine e chiama quelle donne che ti servono e ricevile come se fossi la padrona di questa casa; poi, celebrate le nozze, te ne potrai tornare a casa».
Nonostante queste parole fossero tutte colpi al cuore di Griselda, poiché non aveva potuto deporre l’amore che gli portava, come invece le accadde con la sorte, rispose: «Signor mio, sono pronta e disponibile». E entrata in quella casa coi suoi miseri e dozzinali abiti, dalla quale era uscita poco tempo prima in camicia, cominciò a pulire le camere e a far porre drappi sulle pareti e in capo ai letti e tappeti sulle panche nelle varie sale, e a far attrezzare la cucina e porre mani a tutte le altre incombenze, come se fosse una piccola servetta della casa; né mai si fermò, prima di avere tutto sistemato e ordinato come era necessario.
Dopo questo, fatte invitare da Gualtieri tutte le donne del circondario, si cominciò a preparare la festa; e venuto il giorno delle nozze, sebbene avesse poveri panni addosso, con animo e atteggiamento signorile tutte le donne che giunsero alla cerimonia ricevette con cortesia.
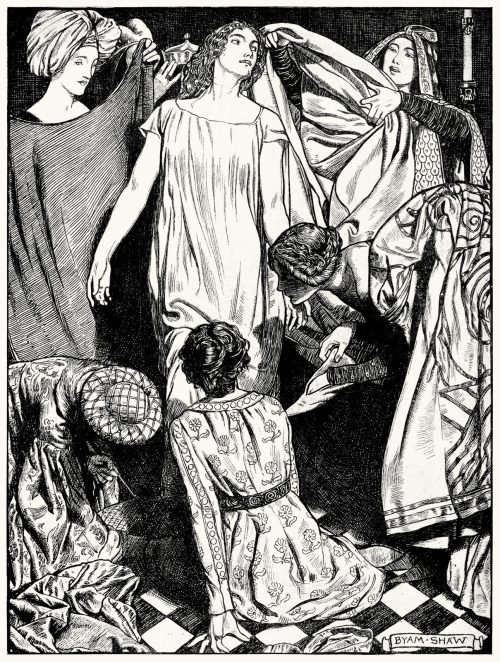
Griselda nell’interpretazione inglese
Gualtieri, il quale aveva fatto allevare con diligenza dalla sua parente, che era sposata con uno dei conti di Panico, i figli da Bologna, essendo già la fanciulla di dodici anni di una straordinaria bellezza, e il fanciullo avendo raggiunto i sei anni, aveva mandato un servo a Bologna dal suo parente pregandolo di venire con questa figliola e con questo figlio a Saluzzo e di portare con sé una bella e onorevole compagnia, e di dire a tutti che lui gli stava portando questa fanciulla per moglie, senza dire ad alcuno chi ella fosse realmente.
Il gentiluomo, fatto come il marchese desiderava, messosi in cammino, dopo diversi giorni con la fanciulla, col fratello e con una nobile compagnia, verso l’ora di cena giunse a Saluzzo, dove trovò tutti gli abitanti del paese e di altre località vicine che aspettavano questa nuova sposa di Gualtieri.
Questa, ricevuta dalle donne, e giunta nella sala dove erano state apparecchiate le tavole, venne accolta da Griselda, così come era, che le si fece incontro con viso lieto dicendo: «Benvenuta mia signora». Alle donne, che avevano molto ma inutilmente pregato Gualtieri di fare in modo che Griselda rimanesse in una stanza o che le prestasse qualcuno dei vestiti che erano già stati suoi affinché non andasse così davanti agli ospiti, fu ordinato di apprestarsi alla tavola e di iniziare a servire.
La fanciulla era osservata da tutti gli uomini e ciascuno di loro diceva che Gualtieri aveva fatto uno scambio vantaggioso, ma fra gli altri anche Griselda la lodava molto, sia lei che il suo fratellino.
Gualtieri, al quale sembrava di avere ormai visto e sperimentato tutto ciò che desiderava riguardo alla mansuetudine della sua donna, constatando che nessun cambiamento la scalfiva, ed essendo sicuro che questo accadeva non per la stupidità di Griselda, dal momento che la conosceva come donna molto saggia, gli parve fosse giunto il momento di liberarla dalle sofferenze che egli credeva che ella nascondesse dietro il suo atteggiamento impassibile. Per cui, fattala venire vicino a sé, in presenza degli altri uomini, sorridendole disse: «Che ti sembra della nostra sposa?».
«Signor mio,» rispose Griselda «a me sembra molto bella e se è così saggia quanto bella, cosa che credo, io non dubito assolutamente che voi vivrete con lei come il più felice uomo del mondo; ma per quanto posso, che quei dolori, che avete inferto all’altra che fu già vostra moglie, non diate a lei, perché io credo che ella li possa sostenere appena perché è più giovane e perché è stata allevata signorilmente, mentre l’altra era stata abituata alle fatiche sin da piccolina».
Gualtieri, vedendo che lei sicuramente credeva che questa fanciulla dovesse essere sua moglie e nonostante questo non ne parlasse meno bene, la fece sedere accanto a lui e disse: «Griselda, è arrivato il momento in cui tu possa godere il frutto della tua lunga pazienza, e tutti quelli che mi hanno reputato crudele, ingiusto e feroce conoscano che ciò che io ho fatto mirava a un fine prestabilito, volendo insegnare a te ad essere moglie e ai sudditi di saper scegliere e mantenerne una, e a me procurare una perpetua pace per tutto il tempo in cui dovessi vivere con te, il che quando ti scelsi come moglie ebbi una gran paura che non mi capitasse e per questo, per metterti alla prova in tutti i modi che tu sai, ti ho ferito e offeso. Ma io non mi sono mai accorto che in qualche parola o in qualche atto tu ti sia allontanata dal mio amore, sembrandomi aver da te quella consolazione che desideravo, intendendo rendere in un solo attimo ciò che io in molto tempo ti tolsi, e con estrema dolcezza ristorarti dalle ingiurie che ti feci; e perciò con lieto animo guarda questa, che tu credi essere mia sposa, e il suo fratello: sono i nostri figli, i quali tu e molti altri avete a lungo creduto che io avessi fatto uccidere; e io sono tuo marito, che ti ama sopra ogni altra cosa dal momento che credo di potermi vantare che nessuno al mondo si possa dire contento e soddisfatto di sua moglie quanto me».
E così detto l’abbracciò e la baciò e con lei insieme, che piangeva per la gioia, alzatisi andarono là dove la figlia, completamente stupefatta, sedeva ascoltando queste cose e l’abbracciarono teneramente, facendo lo stesso con il fratello, e disingannarono lei e molti altri che era giunti sin qui.
Le donne, felicissime, uscendo dalla sala andarono in camera con Griselda e con i migliori auguri le tolsero i suoi poveri panni e la rivestirono di un nobile abito fra quelli che aveva e come signora, la quale sembrava ugualmente nei poveri stracci, la riportarono nella sala.
E qui, fatta una meravigliosa festa con i figlioli, essendo tutti felicissimi per questa cosa, il divertimento e i festeggiamenti si moltiplicarono e si prolungarono per più giorni, e si reputò Gualtieri uomo estremamente saggio, le cui ingiustizie verso la sua donna prima avevano considerato crudeli e intollerabili, ma sopra tutti considerarono Griselda saggissima.
Il conte di Panico, dopo qualche giorno, tornò a Bologna e Gualtieri, tolto Giannucolo dal suo lavoro, come suocero lo mise in una condizione agiata tanto che egli, in modo onorevole, e con gran consolazione, visse fino a che morì. Lui stesso, dopo, maritata nobilmente la sua figliola, lungamente e con consolazione visse con Griselda, onorandola quanto più avrebbe potuto.
Che cosa si potrà dire qui, se non che nelle povere case arrivano dal cielo degli spiriti divini, come nelle case reali di quelli che sarebbero più degni di governare maiali che di avere il dominio sugli altri uomini? Chi avrebbe, se non Griselda, potuto con il viso non solamente mai bagnato da una lacrima, ma sereno, sopportare le rigide e mai udite prove inflittele da Gualtieri? E questo Gualtieri, forse, si sarebbe invece meritato di imbattersi in una donna che, cacciata da lui di casa con soltanto una camicia addosso, avrebbe avuto rapporti con un altro in modo da ricavare una bella veste.

Illustrazione in cui vediamo Gualtieri, Griselda e Giannucolo
La novella di Griselda può assumere più letture, vista la sua complessità interpretativa; ma prima di addentrarci in esse, ci sembra giusto osservarla da un punto di vista strutturale all’interno dell’intera opera: come infatti nella I, 1, quella iniziale su ser Cepperello leggevamo la massima depravazione, quasi fossimo nel punto più basso di degradazione umana portata al rinnegamento/capovolgimento del sacramento della confessione, in quella di Griselda, appunto X, 10, quindi la finale ci troviamo nel massimo della virtù, quella appunto della cancellazione di sé per lei.
Le interpretazioni sulla novella sono tre:
- la prima ce la fornisce Petrarca stesso che, come abbiamo detto, ne ha fatto una traduzione; riprendendo le Storie di Giobbe di biblica memoria, Boccaccio ha fatto di Griselda l’esempio della rinuncia per volere di Dio. Dio dà all’uomo prove d’incredibile sopportazione, avendo in mente un disegno di cui solo Lui sa il fine. Se l’uomo le supera otterrà il premio dovuto. Quindi Gualtieri come Dio, Griselda come Giobbe o Maria Vergine.
- La seconda ce la offre l’analisi sulla fiaba di Vladimir Propp; la novella ha tutte le caratteristiche della fiaba: ad iniziare dalla svestizione, dalle prove da superare e il lieto fine. (elemento portante, inoltre, è la presenza dell’anello, onnipresente nelle fiabe, nella versione fatata);
- La versione sociologica: la novella presenta l’obbedienza cieca che un suddito doveva al feudatario, non per niente è ambientata in un tempo lontano e in luogo dove, al tempo di Boccaccio, ignari dei cambiamenti sociali, ancora persisteva. Ma si chiude anche con la vittoria della borghesia, cioè con un matrimonio sulla cui base vi è l’amore d’entrambi e la costruzione di una famiglia.
Abbiamo già detto, sebbene in modo piuttosto sintetico, quali sono state le fonti di cui Boccaccio si è servito per scrivere il suo capolavoro ma ora è interessante, dopo aver visto alcune novelle, riprendere il discorso sottolineando il motivo per cui lo ha pensato, quali sono stati gli argomenti maggiormente trattati e se ha cercato, nella varietà delle novelle, d’utilizzare uno stile che potesse variare, ma nel contempo non inficiare l’architettura complessiva dell’opera.
L’opera ha un fine edonistico, procurare piacere a chi lo legge (le donne), ma anche didascalico, insegnar loro delle regole di vita attraverso gli exempla che le stesse novelle potevano offrire. Certo il primo fine si può ottenere proprio dall’atto stesso del narrare: il sentire storie è piacevole in sé, mostra cose del mondo che si ignorano nel tempo, nello spazio e nella morale, ma è proprio dal continuo raffronto tra il mondo e i lettori, oltre ad interessare ora e quindi provare diletto, s’impara dallo stesso a trovare o a evitare atteggiamenti, facendoli propri, ma non venendo mai meno al mondo ideale che i dieci novellatori hanno creato.
Se proprio questi dieci ragazzi sono gli espositori di racconti tratti dalla vita, l’autore (narratore di primo grado) oltre che costruire intorno a loro una ferrea struttura, non si prende la responsabilità di prendere la parola, ma li usa come schermo al fine d’allontanare la materia trattata per poterla osservare con più attenzione, cogliendo l’universo mondo, allo stesso modo di come lo aveva colto il suo dichiarato maestro, Dante.

I dieci novellatori nel film dei Taviani
Ed è proprio a Dante a cui bisogna guardare per capire l’identità e la differenza tra i due capolavori trecenteschi: 10 gironi a cantica, 10 giornate e 10 giovani (tre ragazzi e tre ragazze, ad indicare – in modo inconsapevole? – le tre virtù teologali e le sette cardinali – ma ci piace aggiungere che la sottolineatura dei critici poco ci convince), 100 novelle, 100 canti: ma se il tomistico Dante da tale regola non scantona, il laico Boccaccio ci sta stretto: 10 giornate a cui 2 a tema libero; Dioneo che racconta sempre quello che gli pare, le novelle non sono 100 ma 101 se si ci mette anche quella delle papere (raccontata dal narratore di primo grado).
Torniamo per un attimo alla cornice: non è semplicemente costituita dal Proemio, dall’Introduzione alla I e alla IV giornata e dalla Conclusione: essa s’insinua anche all’interno di ogni giornata in cui l’autore ci illustra la vita (stereotipata, certo, ma anche ordinata) dei dieci novellatori, nonché la conclusione di ognuna di esse che viene celebrata alla fine dei racconti con una ballata e dopo con la nomina della regina o del re che detterà l’argomento da trattare il giorno seguente. Perché tale bisogno di inserire il tutto in uno schema così perfetto? Per un bisogno d’armonia interna: se fino ad allora, nella tradizione novellistica i racconti si seguivano uno dopo l’altro, qui essi s’inseriscono all’interno di un tempo e di un tema; ma anche questo ha bisogno di una pur minima graffiatura. Ciò non inficia l’armonia, ma la rafforza se gestisco le due libere nella prima, quasi ad introdurre il lettore alla varietà dell’opera e alla nona, ad invitarlo a respirare prima dell’apoteosi della liberalità e cortesia dell’ultima; se il libero Dioneo obbedisce al tema dettato o no e se lo stesso, dopo esser stato per tutta l’opera il più irriverente e scanzonato nelle novelle raccontate, chiude con la più drammatica e perfetta che Petrarca traduce e Chauser riprende: Griselda
Passiamo quindi ai temi che si possono individuare in tre nuclei:
- Fortuna;
- Natura/amore;
- Ingegno
Partiamo dal primo: se la fortuna dantesca non è che un cielo ruotante per volontà di Dio a cui l’uomo non si può contrapporre, per Boccaccio, pur ancora casuale, si può in qualche caso piegarla a proprio vantaggio: si prendano ad esempio le novelle di Andreuccio, Landolfo e Masetto; vengono tutti tre “mossi dalla fortuna”, il primo dalla casualità della morte del vescovo, il secondo dalla salvezza grazie ad una cassa piena di gioielli, il terzo dalla morte del fattore. Se Landolfo è in qualche modo agito dalla fortuna, gli altri due la gestiscono in modo “intelligente”. E’ normale aggiungere, poi, che ad essa Boccaccio sposi spesso l’avventura, che trova la sua massima espressione nel “realismo” della Napoli di Andreuccio e nel mare metaforicamente espressione dell’imprevedibilità del caso di Masetto.
L’eros è quasi il tema più rappresentato nell’intera opera e trattato secondo diversi stili e diversi ambienti. Quello che tuttavia emerge è, quasi in maniera trasversale, che Boccaccio intende l’amore in modo naturale, per meglio dire, istintuale e questo si può vedere sia a livello alto (si pensi all’arringa di Ghismuda contro Tancredi) sia a livello popolare (ma non bisogna dimenticare che ciò si verifica quando si tratta di semplice soddisfacimento), sia a livello di censura (la novella di Lisabetta), sia di rapporti cortesi (Federigo degli Alberighi) e ancora, ma non ultima, come raggiungimento di un obiettivo (Masetto salernitano e Agifulfo). Insomma il Boccaccio non accetta una dicotomia natura / eros, essendo parte ambedue della stessa costituzione umana, e quindi non più il peccato di lussuria di dantesca memoria ma soddisfacimento con soddisfazione o negazione con tragedia; ma l’idea del nostro autore continua ad essere, al di là del pianto o del sorriso, quella di un “matrimonio” borghese, come ci dicono le novelle di Federigo, appunto, o di Nastagio.
L’ingegno come capacità di sbrogliarsi da situazioni difficoltose caratterizza trasversalmente l’intera opera. Nella sesta giornata è il tema fondamentale quando esso s’accompagna con la parola, la battuta sagace che riesce ad annichilire l’avversario (si tratti di Cavalcanti o di Cisti). Ma l’ingegno si può tradurre anche in situazioni in cui è l’intelligenza a trovare l’occasione per ottenere ciò che si è proposto: è il caso del palafreniere di Agifulf o dell’ebreo Melchisedech, chi con un gesto e chi con una risposta non solo scampano ma vengono definiti, da Boccaccio, savi.














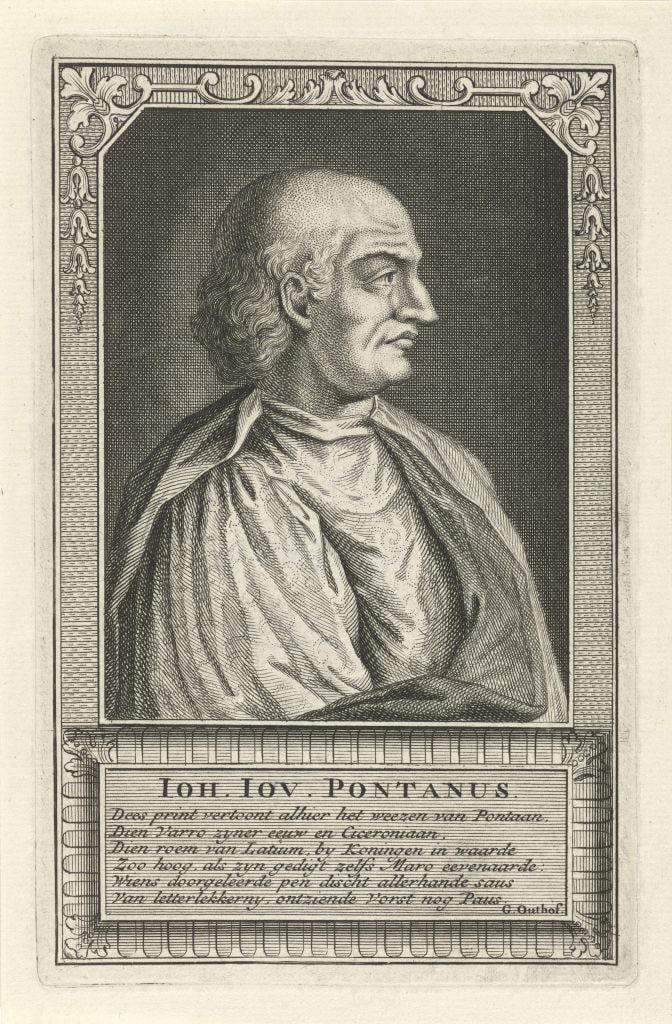

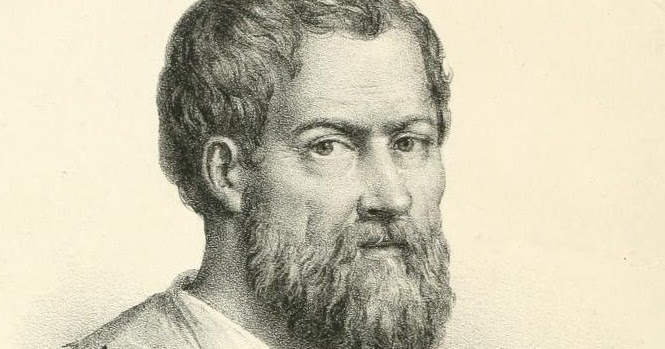

![Boiardo Matteo Maria : Orlando innamorato [...] insieme coi tre libri di M. Nicolo de gli Agostini, già](https://www.gonnelli.it/photos/auctions/xlarge/11283_1.jpg)

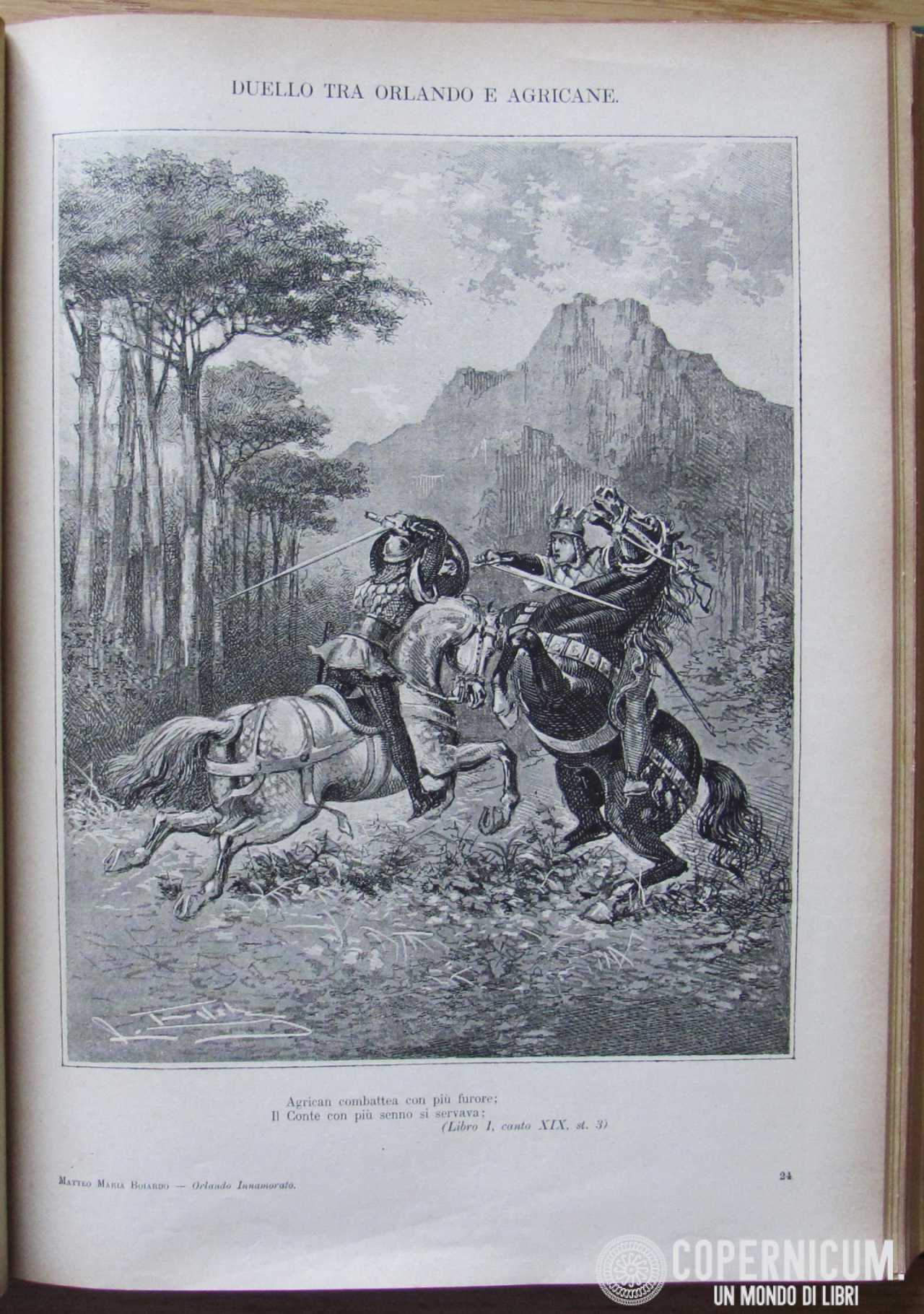
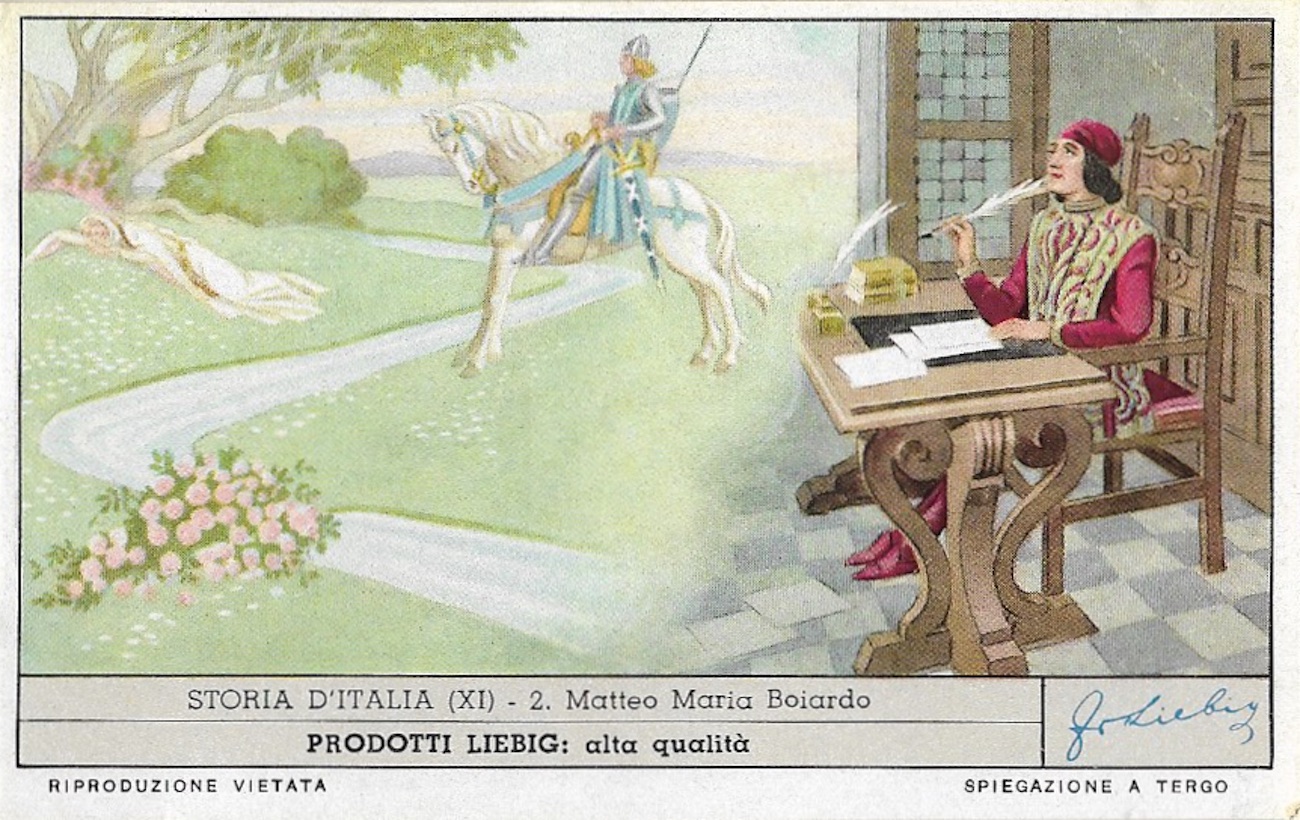

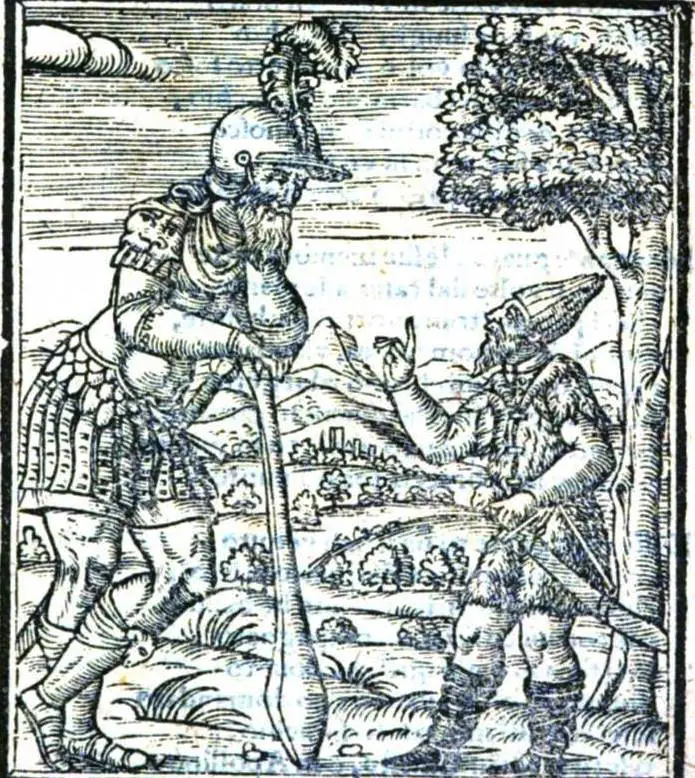











 Troilo e Criseide si incontrano e vanno a letto insieme”, miniatura tratta dal ‘Filostrato’ (terzo quarto del XV secolo)
Troilo e Criseide si incontrano e vanno a letto insieme”, miniatura tratta dal ‘Filostrato’ (terzo quarto del XV secolo)





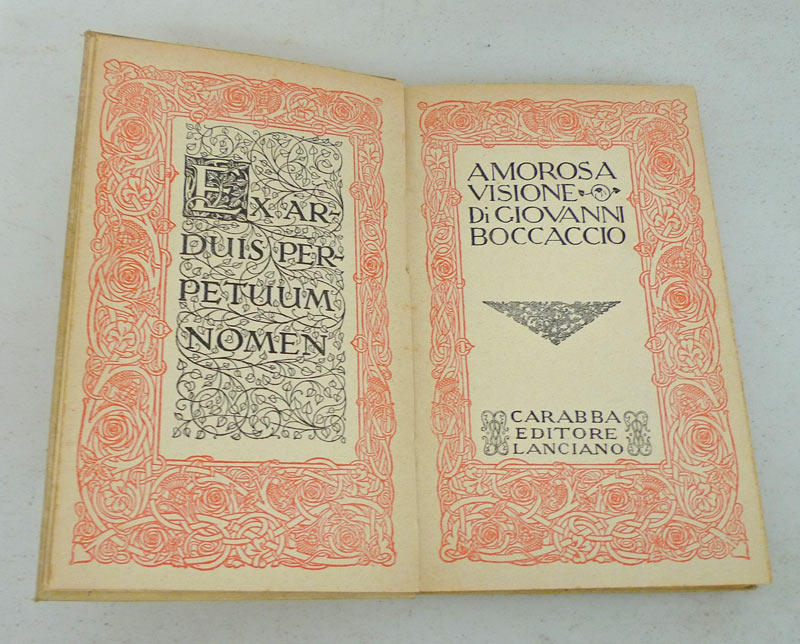

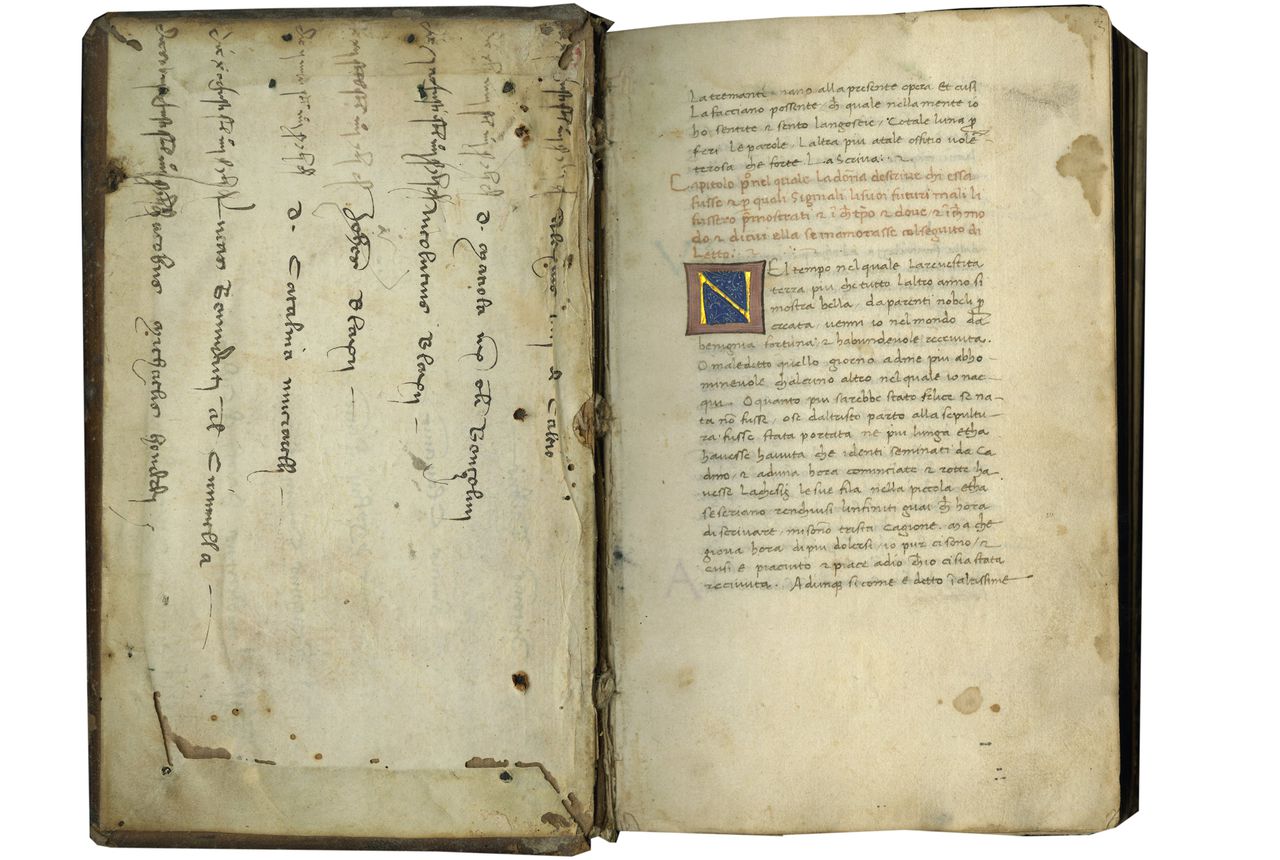






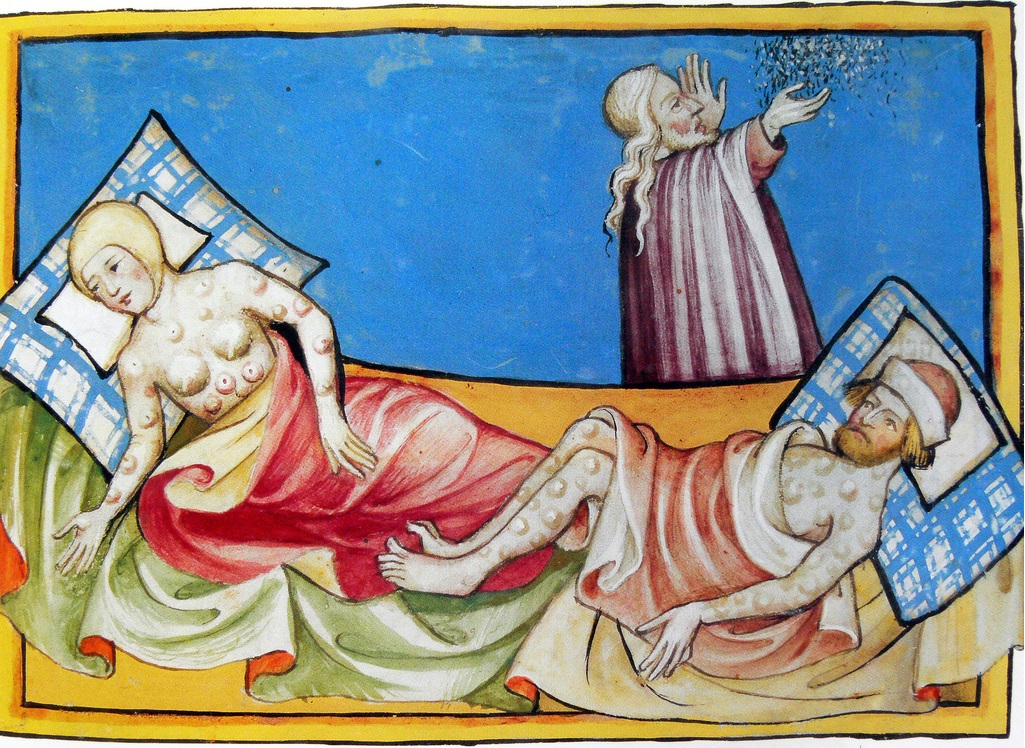







 Il peccatore Ser Ciappelletto s’ammala in viaggio. Prima di morire si finge santo, il prete confessore ne beatifica la memoria”. Miniatura tratta dal ‘Decameron’ (codice del XV secolo)
Il peccatore Ser Ciappelletto s’ammala in viaggio. Prima di morire si finge santo, il prete confessore ne beatifica la memoria”. Miniatura tratta dal ‘Decameron’ (codice del XV secolo)
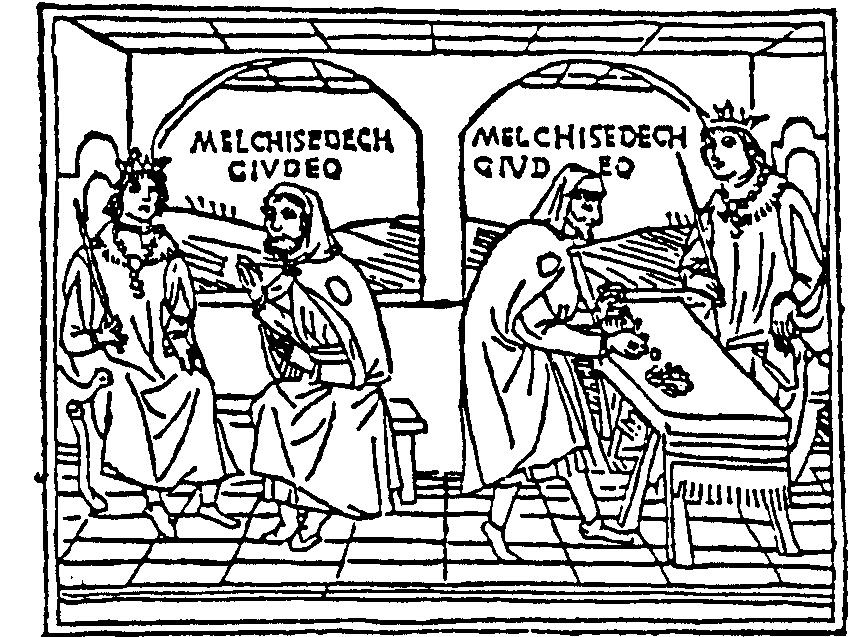





 Progetto di un libro con le più importanti novelle di Boccaccio illustrato per ragazzi, in via di realizzazione.
Progetto di un libro con le più importanti novelle di Boccaccio illustrato per ragazzi, in via di realizzazione.


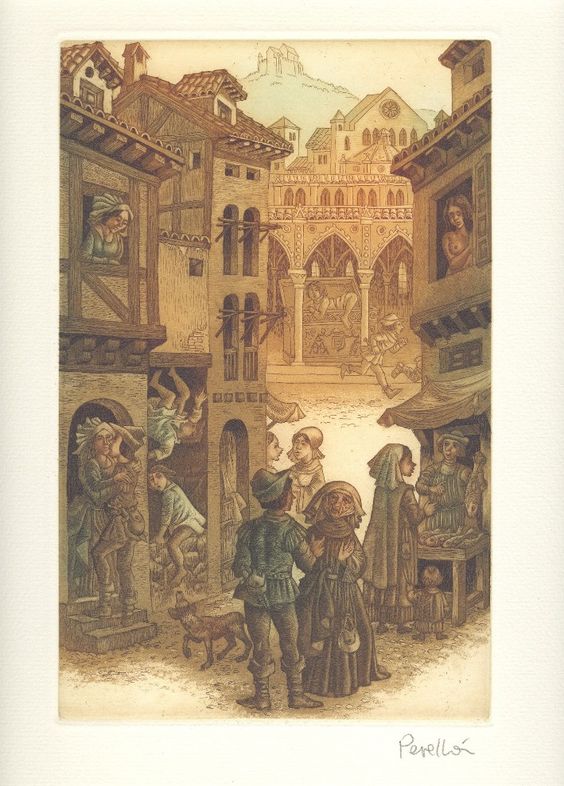
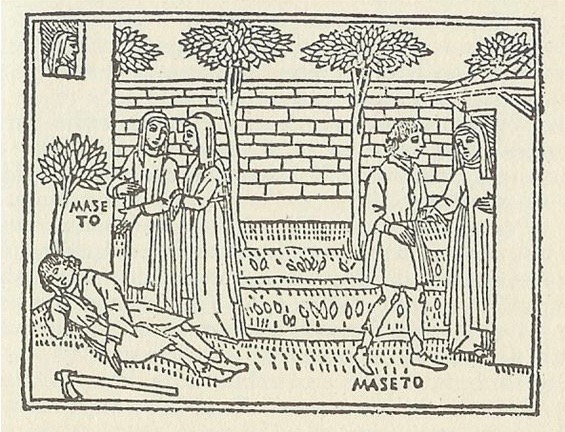







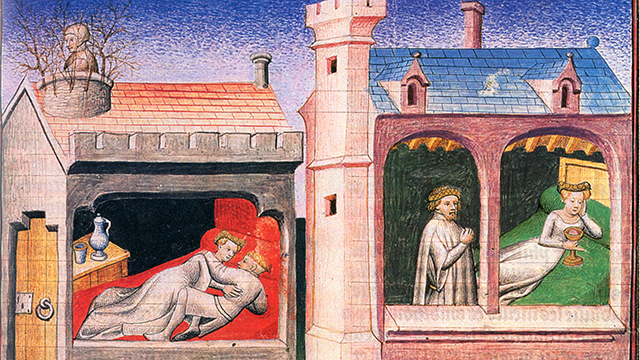
 Kasia Smutniak e Michele Riondino (Guiscardo e Ghismunda) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)
Kasia Smutniak e Michele Riondino (Guiscardo e Ghismunda) da Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2011)

 Lavennia Illustratrice canadese: Ghismunda sdraiata col cuore di Guiscardo (2017)
Lavennia Illustratrice canadese: Ghismunda sdraiata col cuore di Guiscardo (2017)




 William Holman Hunt: Isabella e il vaso di basilico (1876)
William Holman Hunt: Isabella e il vaso di basilico (1876)