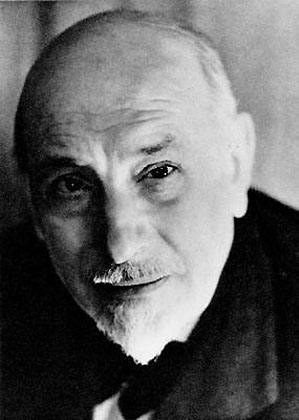
Luigi Pirandello nasce a Girgenti (l’attuale Agrigento) nella notte del 28 giugno nel 1867, da Stefano, speculatore del mercato dello zolfo e Caterina Ricci Gramitto, di famiglia antiborbonica. Studia dapprima all’università di Palermo discipline scientifiche per volere del padre, poi, nel 1887 si trasferisce a Roma dove si iscrive alla facoltà di lettere. Per uno scontro con il professore di latino dell’Università e su consiglio del professore di filologia romanza, deve infine trasferirsi in Germania, e più precisamente a Bonn dove si laurea nel 1891 con una tesi sui dialetti greco-siculi. Sono di questi anni due raccolte di poesie, pubblicate una Palermo, nell’anno del trasferimento a Roma (Mal giocondo) e l’altra per un’infatuazione per una ragazza tedesca (Pasqua di Gea).
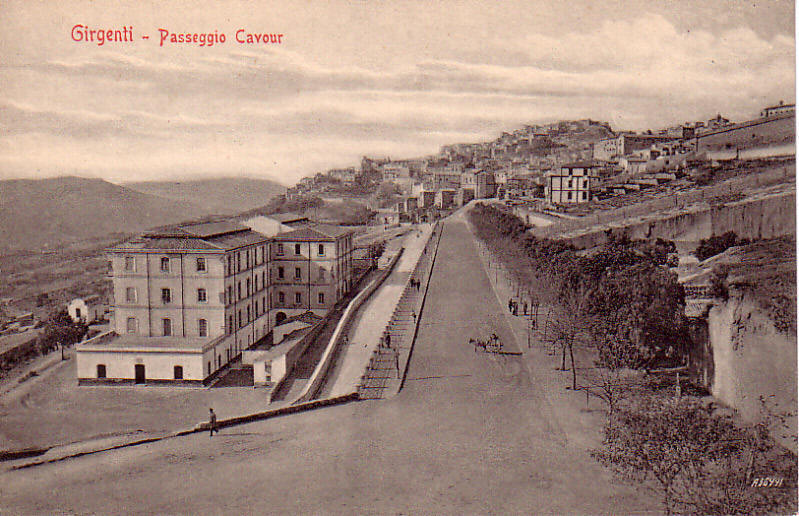
Girgenti
Ritornato a Roma nel 1892 ed entrato a contatto con altri intellettuali meridionali, tra cui Luigi Capuana, intraprende la carriera letteraria, grazie anche ad un assegno che il padre mensilmente gli invia. Il critico sicilano lo incoraggia sia a pubblicare novelle su riviste, la cui prima raccolta è Amori senza amore (1894), sia per i romanzi L’esclusa (1901) che, sotto l’apparente struttura verista, mostra già il nucleo del suo pensiero, cioè la contraddittorietà tra ciò che sembra e ciò che è, ed il romanzo breve Il turno (1902).

Pirandello giovane
Nel 1894 si sposa, con un matrimonio concordato dalle famiglie, con Maria Antonietta Portulano, da cui avrà, tra il 1895 ed il 1899 tre figli: Stefano, Rosalia, detta Lietta e Fausto e nel 1897 ottiene, come supplente, la cattedra nel Magistero di Roma, in cui insegna Letteratura italiana. Nel 1903 un grave dissesto economico, a causa dell’allagamento di una miniera di zolfo su cui Luigi aveva investito l’intera dote della moglie, provoca una crisi sul già fragile equilibrio mentale della sua signora che infine sfocerà in una vera e propria pazzia, che si concretizza in crisi ossessive di gelosia (questo fatto non sarà senza conseguenze nella sua produzione letteraria).

Maria Antonietta Portulano
Il suo vero primo capolavoro è Il fu Mattia Pascal (1904), scritto mentre Pirandello assiste alla moglie malata; con questo romanzo Pirandello supera definitivamente la concezione realista della letteratura naturalista e verista. Le difficoltà economiche spingono lo scrittore siciliano ad aumentare la sua attività: scrive su riviste ed intensifica la sua produzione: pubblica I vecchi e i giovani (1908), collabora con il Corriere della Sera sul quale appaiono varie novelle e, spinto dal famoso attore siciliano Angelo Musco, comincerà a scrivere per il teatro.

Angelo Musco
La vita pirandelliana s’incupisce con lo scoppio della prima guerra mondiale. Il figlio Stefano viene fatto prigioniero dagli austriaci e la moglie, la cui pazzia si fa sempre più palese, lo incolpa di averlo lasciato partire e quindi, direttamente, della sua prigionia. Chiuso in casa continua a pubblicare romanzi, I quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915), ma è soprattutto il teatro ad assorbirlo, Pensaci Giacomino, Così è se vi pare, Il berretto a sonagli per citarne alcune, tutte tra il 1916 ed il 1918.
Tra il 1921 e il 1930 Pirandello attua quella che viene definita una vera rivoluzione teatrale con Sei personaggi in cerca d’autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto: saranno proprio queste opere a far risuonare il nome dello scrittore siciliano tra i grandi della letteratura mondiale, che culminerà con il premio Nobel per la letteratura nel 1934. Per la narrativa uscirà nel 1925 forse uno dei suoi romanzi più importanti: Uno, nessuno e centomila.
Precedentemente tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta emergono due episodi piuttosto importanti per la vita di Pirandello:

Marta Abba
- il primo di ordine sentimentale (l’innamoramento “platonico” per l’attrice Marta Abba, alla quale dedicherà nuove opere teatrali);
- il secondo di ordine politico: il rapporto con il regime fascista, con la sua adesione al partito, che verrà sanzionato dalla firma al Manifesto degli intellettuali fascisti nel 1929. Da questo momento farà parte all’Accademia d’Italia.
L’ultima fase della produzione pirandelliana è legata alla frenetica attività di attento curatore della messa in scena, nonché di alcune riduzioni cinematografiche delle sue opere.
Scrive drammi che lui stesso definirà “miti”, La nuova colonia (1927), Lazzaro (1928) e I giganti della montagna (1934).
Muore per una polmonite nel 1936: per suo desiderio il funerale sarà nudo, solitario, ma con le sue ceneri deposte sulla terra di un antico albero della città in cui è nato, nonostante il suo primo desiderio fosse quello di essere cremato.
Come per Pascoli anche per Pirandello dobbiamo partire da un’opera di poetica, concepita sin dal 1897, come saggio scritto per il Concorso per il Regio Istituto superiore di Magistero femminile; rivisto viene pubblicato con il titolo L’umorismo nel 1908, dove emerge la sua concezione estetica:

Una delle prime edizioni del saggio pirandelliano
POETICA DELL’UMORISMO
Vediamo dunque, senz’altro, qual è il processo da cui risulta quella particolar rappresentazione che si suol chiamare umoristica; se questa ha peculiari caratteri che la distinguono, e da che derivano: se vi è un particolar modo di considerare il mondo, che costituisce appunto la materia e la ragione dell’umorismo.
Ordinariamente (…) l’opera d’arte è creata dal libero movimento della vita interiore che organa le idee e le imagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra loro e con l’idea-madre che le coordina. La riflessione, durante la concezione, come durante l’esecuzione dell’opera d’arte, non resta certamente inattiva: assiste al nascere e al crescere dell’opera, ne segue le fasi progressive e ne gode, raccosta i varii elementi, li coordina, li compara. La coscienza non rischiara tutto lo spirito; segnatamente per l’artista, essa non è un lume distinto dal pensiero, che permetta alla volontà di attingere in lei come in un tesoro d’immagini e d’idee. La coscienza, in somma, non è una potenza creatrice; ma lo specchio interiore in cui il pensiero si rimira; si può dire anzi ch’essa sia il pensiero che vede sé stesso, assistendo a quello che esso fa spontaneamente. E, d’ordinario, nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si nasconde, resta, per così dire, invisibile: è, quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man mano che l’opera si fa, essa la critica, non freddamente, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola; ma d’un tratto, mercè l’impressione che ne riceve.
Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione d’animo di quegli scrittori che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di intuire e di considerar gli uomini e la vita, questo stesso procedimento avviene nella concezione delle loro opere; se cioè la riflessione vi tenga la parte che abbiamo or ora descritto, o non vi assuma piuttosto una speciale attività.
Ebbene, nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone l’imagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario.
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.
Il concetto artistico pirandelliano si muove su muove su un principio che potremo definire, grosso modo, anticrociano.
Croce, uno dei più grandi filosofi degli inizi del Novecento in Europa, nonché autore/firmatario del Manifesto degli intellettuali antifascisti individua, nella creazione della poesia un processo della pura intuizione che trova il suo compimento trasformandosi in forma, per meglio dire assoluta corrispondenza tra intuizione ed espressione. Tutto ciò che è estrinseco a tale processo non rientra propriamente nella definizione di poesia, ma di sovrastrutturale ad essa. Crocianamente si tratta di poesia e non poesia.
Pirandello, al contrario, fa della riflessione un percorso intrinseco al fatto poetico. Tale riflessione se è presente in ogni creazione poetica lo è ancor di più se si guarda con occhio attento a quegli autori o a quelle opere nate espressamente con intento comico o umoristico, si pensi all’attenzione posta da Pirandello stesso alle Operette morali.
Come ci descrive tale momento l’autore siciliano? Attraverso tre processi, uno legato indissolubilmente all’altro:
- avvertimento del contrario: ciò che provoca normalmente il comico è il rovesciamento di ciò che avviene nella norma (esempio pirandelliano: una donna di una certa età “agghindata” come una “ragazzina”);
- riflessione: perché è avvenuto tale rovesciamento (esempio pirandelliano: la donna si agghinda da quindicenne per non perdere l’amore di un marito molto più giovane di lei);
- sentimento del contrario: derivata dalla riflessione che si traduce in comprensione e per un autore in immagine poetica.
Pur non volendo fare del testo di Pirandello la spiegazione onnicomprensiva di tutta la sua opera, è opportuno prenderla come base per cercare di capire il modus con cui lo scrittore siciliano guarda ai suoi personaggi e al loro modo d’agire in società.
I romanzi
Se nella preistoria dell’attività letteraria pirandelliana vi sono due raccolte di poesie Mal Giocondo (1889) La pasqua di Gea (1991), che non portano alcun rinnovamento estetico nella lirica di allora, il vero e proprio primo lavoro è il romanzo L’esclusa (1901):
Marta Ajala viene ripudiata dal marito ed anche dal padre perché creduta adultera, mentre in realtà è innocente. Costretta a lasciare il paese, Marta ripara a Palermo, dove incontra gravi difficoltà economiche, finché non viene aiutata da un amico con il quale inizia una relazione. Quando però la suocera, che era stata la prima ad accusarla, si rende conto, in punto di morte di aver sbagliato e scagiona Marta, ella viene riaccolta in casa dal marito e riabbracciata dai famigliari, ormai tutti convinti della sua innocenza.
Osserviamo questo minuscolo frammento tratto dal romanzo:
«Che sono io ora? Mi vedi? Che sono…Sono ciò che la gente, per causa tua, mi ha creduta e mi crede ancora e sempre mi crederebbe, anche se io accettassi ora il tuo pentimento! E’ troppo tardi: lo intendi? Sono perduta! Ero sola, mi avete perseguitata… ero sola e senza aiuto. Ora sono perduta!».
In esso, nella seconda riga, si usa per tre volte il verbo “credere”: tale verbo sta ad indicare che la realtà non è più quella che si “vede”, ma quella che si “crede”, cioè quella che “appare”: è evidente che in tale teoria vi è un superamento del Positivismo, cui tuttavia il romanzo si iscrive: ambientazione siciliana, vita di provincia, dialoghi realistici; ma è proprio l’ideologia di fondo ad allontanare la narrazione da tale esito.
Il secondo romanzo pirandelliano, anch’esso considerato minore, è Il turno del 1902:

Film di Tonino Cervi tratto dal romanzo (1981)
Il “turno” è quello di tre personaggi che si succedono come aspiranti mariti di un’avvenente donna. Il primo, don Diego, è un vecchio e ricco gentiluomo che la protagonista, Stellina, spinta dal padre, acconsente a sposare per interesse. Il secondo è don Ciro, un avvocato intrigante e prepotente, che scopre la non validità del matrimonio con don Diego e arriva a farlo annullare per sposare lui la donna. Il terzo è don Pepè, il giovane spasimante di Stellina, che si è visto portar via la donna dagli altri due ed aspetta impaziente il proprio “turno”. Alla fine don Ciro morirà, mentre il vecchio don Diego si risposerà con un’altra giovane.
Anche qui, pur inserendo la storia all’interno di una provincia siciliana e legando il suo racconto al mito della “roba” di verghiana memoria, troviamo uno scarto rispetto alla cultura del romanzo verista: l’imprevedibilità dei casi umani. Per quanto si progetti il futuro, sarà sempre il caso a determinarlo.

Edizione de “Il fu Mattia Pascal” con la foto dell’autore
Il primo romanzo che scardina qualsiasi legame sia con il verismo con il quale, per ragioni direi d’ambientazione, Pirandello dovette confrontarsi con le sue due prime prove narrative, sia con la narrativa dannunziana, assolutamente lontana dalla sua idea estetica, è Il fu Mattia Pascal (1904), che proietta il nostro tra i grandi della narrativa europea.

Ivan Mozzhukhin nel film di Marcel L’Herbier dedicato a Mattia Pascal (1926)
Mattia Pascal, allontanatosi dalla famiglia dopo un litigio, arriva a Montecarlo, dove vince una notevole somma al gioco. Da una notizia di cronaca apprende che è stato ritrovato il cadavere di uno sconosciuto suicida, il quale è stato scambiato per lui: ufficialmente, dunque, Mattia è morto, e ne approfitta per evadere dalla vita sociale. Ma la società, anche quando egli è diventato Adriano Meis, inevitabilmente gli tende intorno la sua inevitabile rete: e quando Mattia scopre che la vera identità è quella che conferisce lo stato civile e che così com’è, praticamente, non esiste – non può fare una denuncia, non può sposarsi – deluso decide di simulare un secondo suicidio, quello di Adriano Meis, e di rivelare la verità ai suoi concittadini. Ma tornato a casa si accorge che la moglie, risposata con altri figli, non può riprenderlo con sé. Non gli resta che il suo vecchio impiego nella polverosa biblioteca della città, dove avrà il tempo di rievocare, da protagonista e narratore, la sua singolare vicenda.
PREMESSA n. 1
Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo:
«Io mi chiamo Mattia Pascal.»
«Grazie, caro. Questo lo so.»
«E ti par poco?»
Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come prima, all’occorrenza: «Io mi chiamo Mattia Pascal.»
Qualcuno vorrà bene compiangermi (costa così poco), immaginando l’atroce cordoglio d’un disgraziato, al quale avvenga di scoprire tutt’a un tratto che… sì, niente, insomma: né padre, né madre, né come fu o come non fu; e vorrà pur bene indignarsi (costa anche meno) della corruzione dei costumi, e de’ vizii, e della tristezza dei tempi, che di tanto male possono esser cagione a un povero innocente.
Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre, di fatti, in un albero genealogico, l’origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli.
E allora?
Ecco: il mio caso è assai più strano e diverso; tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo.
Il protagonista del libro quindi descrive la sua precedente ed anche attuale attività di guardiano di un’antichissima biblioteca allogata in una chiesa fuori paese, piena di muffe, tarme e topi:
(…) fin dal primo giorno io concepii così misera stima dei libri, sieno essi a stampa o manoscritti (come alcuni antichissimi della nostra biblioteca), che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere, se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire d’ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l’antica speranza della buon’anima di monsignor Boccamazza*, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l’obbligo però che nessuno possa aprirlo se non cinquant’anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due volte, ma la prima per errore, e la seconda… sentirete.
*Colui che donò la Biblioteca al paese.
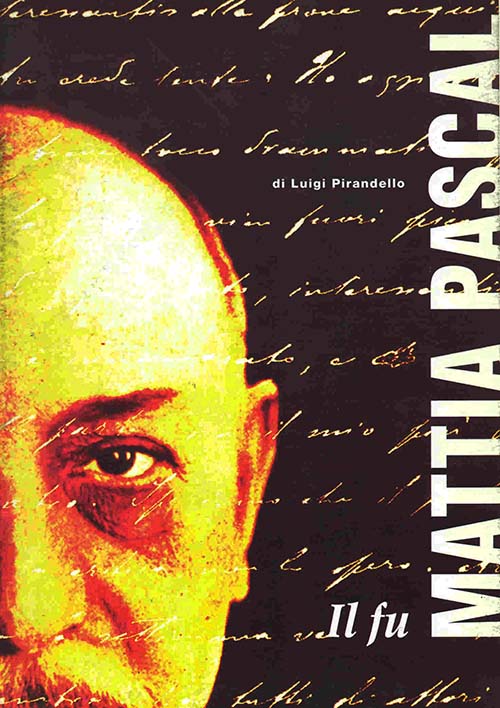
Locandina di un film con Flavio Bucci (1993)
Il passo inizia con il problema dell’identità certificata da un nome: ma tale identità viene sin da subito messa in crisi dall’uso di verbi coniugati al passato: se prima un essere era tale grazie al nome che ne certificata l’esistenza, Mattia Pascal ci dice che lui non è, anzi alla fine del brano sottolinea di essersi già suicidato due volte.
Il fatto interessante è che oltre a non essere, vive in un non luogo, circondato da un non sapere: la vecchia biblioteca è posta al limite, assolutamente non frequentata (pertanto la cultura è muta) ed è piena di un sapere confuso, polveroso, vecchio e stantio. Per meglio dire, come d’altra parte altri intellettuali a lui contemporanei, sottolinea l’emarginazione della cultura nella società del tempo.
PREMESSA n. 2
(…)
«Eh, mio reverendo amico,» gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone, mentr’egli attende alle sue lattughe.
«Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico!»
«Oh oh oh, che c’entra Copernico!» esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato sotto il cappellaccio di paglia.
«C’entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava…»
«E dàlli! Ma se ha sempre girato!»
«Non è vero. L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non gira. L’ho detto l’altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m’ha risposto? ch’era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole.* Ma lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d’oziosi particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano, come voi m’avete insegnato, che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per provare?**
*Si riferisce ad un passo del Vecchio Testamento in cui si racconta che “il sole si arrestò in mezzo del cielo e non si affrettò a tramontare quasi per un giorno”. (Giosué, 10)
** Quintiliano nelle Istitutiones oratoriae afferma che compito della storia sia quello di raccontare e non argomentare, che spetta all’arte giuridica.

Marcello Mastroianni in un film di Monicelli (1985)
Quando a determinare la realtà erano le leggi copernicane non vi era alcuna frattura tra la realtà ed il modo di rappresentarla. Così era successo fino alla cultura positivistica che aveva trovato nel sapere scientifico la base filosofica del suo operare. Pirandello in questo passo sembra dirci che oggi tutto questo non è più possibile: laddove cadono le certezze non resiste più alcuna realtà, ed allora, il modo in cui l’uomo moderno deve operare (e quindi lo stesso Mattia) è un relativismo conoscitivo entro cui coordinare la propria esistenza e muoversi in un mondo dominato dall’“imprevedibilità” o più semplicemente dal caso.
La vera e propria narrazione inizia dal terzo capitolo. Qui vi si narra il modo in cui il nostro povero Pascal, morto il padre quand’era piccolo, vede il tracollo della famiglia, grazie all’amministratore Malagna, che, a poco a poco, ha rosicchiato tutti gli averi dei Pascal. Quindi prosegue a raccontare come si sposi con una giovane ragazza, Romilda, figlia della vedova Pescatrice, più per far dispetto all’amministratore che per amore e di come la suocera, che sperava in un matrimonio più fortunato con lo stesso Malagna, avesse in odio il genero.
Mattia è sull’orlo della disperazione: vive in casa con suocera e la vecchia madre, nonché con il figlio e la moglie, che ormai lo ha in odio. Saputolo nella disperazione un suo amico gli trova posto come bibliotecario. Preferisce quel luogo che vivere in casa. Un giorno le portano la notizia della nascita di due gemelline: moriranno giovanissime, dopo un po’ muore anche la madre. Mattia è solo e disperato. Un amico gli presta 500 lire per il funerale.

Mattia Pascal nel film di Marcel L’Herbier (vincita a Montecarlo)
Ritroviamo Mattia a Montecarlo con le 500 lire in tasca. Come avesse nell’anima un diavolo che gli vuole bene, preso della febbre del gioco, punta alla roulette e vince. Vince per ben dodici giorni, fino ad 82.000 lire e smette quando la fortuna sembra voltargli le spalle. Prende un treno per tornare a casa:
CAMBIO TRENO!
Pensavo: «Riscatterò la Stìa, e mi ritirerò là, in campagna, a fare il mugnajo. Si sta meglio vicini alla terra; e – sotto – fors’anche meglio.
(…)
Così pensavo, e il treno intanto correva. Non potevo chiudere gli occhi, ché subito m’appariva con terribile precisione il cadavere di quel giovinetto, là, nel viale, piccolo e composto sotto i grandi alberi immobili nella fresca mattina. Dovevo perciò consolarmi così, con un altro incubo, non tanto sanguinoso, almeno materialmente: quello di mia suocera e di mia moglie. E godevo nel rappresentarmi la scena dell’arrivo, dopo quei tredici giorni di scomparsa misteriosa.
(…)
Alla prima stazione italiana comprai un giornale con la speranza che mi facesse addormentare. Lo spiegai, e al lume del lampadino elettrico, mi misi a leggere.
(…)
Avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli del Lama. Gli occhi mi andarono su un SUICIDIO così, in grassetto.
Pensai subito che potesse esser quello di Montecarlo, e m’affrettai a leggere. Ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato di minutissimo carattere: “Ci telegrafano da Miragno”.
«Miragno? Chi si sarà suicidato nel mio paese?»
Lessi: “Jeri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora d’un mulino un cadavere in istato d’avanzata putrefazione….” A un tratto, la vista mi s’annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio podere; e, siccome stentavo a leggere, con un occhio solo, quella stampa minuscola, m’alzai in piedi, per essere più vicino al lume.
“… putrefazione. Il mulino è sito in un podere detto della Stìa, a circa due chilometri dalla nostra città. Accorsa sopra luogo l’autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro…” Il cuore mi balzò in gola e guardai, spiritato, i miei compagni di viaggio che dormivano tutti. “Accorsa sopra luogo… estratto dalla gora… e piantonato… fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario…”
«Io?»
“Accorsa sopra luogo… più tardi… per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni. Causa del suicidio: dissesti finanziarii.”
«Io?… Scomparso… riconosciuto… Mattia Pascal…»
Rilessi con piglio feroce e col cuore in tumulto non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto, tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare: come se quella notizia, così irritante nella sua impassibile laconicità, potesse anche per me esser vera. Ma, se non per me, era pur vera per gli altri; e la certezza che questi altri avevano fin da jeri della mia morte era su me come una insopportabile sopraffazione, permanente, schiacciante… Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio e, quasi anch’essi, lì, sotto gli occhi miei, riposassero in quella certezza, ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli, per gridar loro che non era vero.
«Possibile?»
E rilessi ancora una volta la notizia sbalorditoja. Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s’arrestasse, avrei voluto che corresse a precipizio: quel suo andar monotono, da automa duro, sordo e greve, mi faceva crescere di punto in punto l’orgasmo. Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondandomi le unghie nelle palme; spiegazzavo il giornale; lo rimettevo in sesto per rilegger la notizia che già sapevo a memoria, parola per parola.
«Riconosciuto! Ma è possibile che m’abbiano riconosciuto?… “In istato d’avanzata putrefazione”… puàh!»
Mi vidi per un momento, lì nell’acqua verdastra della gora, fradicio, gonfio, orribile, galleggiante… Nel raccapriccio istintivo, incrociai le braccia sul petto e con le mani mi palpai, mi strinsi: «Io, no; io, no… Chi sarà stato?… mi somigliava, certo… Avrà forse avuto la barba anche lui, come la mia… la mia stessa corporatura… E m’han riconosciuto!… Scomparso da parecchi giorni… Eh già! Ma io vorrei sapere, vorrei sapere chi si è affrettato così a riconoscermi. Possibile che quel disgraziato là fosse tanto simile a me? vestito come me? tal quale? Ma sarà stata lei, forse, lei, Marianna Dondi, la vedova Pescatore: oh! m’ha pescato subito, m’ha riconosciuto subito! Non le sarà parso vero, figuriamoci! “È lui, è lui! mio genero! ah, povero Mattia! ah, povero figliuolo mio!” E si sarà messa a piangere fors’anche; si sarà pure inginocchiata accanto al cadavere di quel poveretto, che non ha potuto tirarle un calcio e gridarle: “Ma lèvati di qua: non ti conosco”.»
Fremevo. Finalmente il treno s’arrestò a un’altra stazione. Aprii lo sportello e mi precipitai giù, con l’idea confusa di fare qualche cosa, subito: un telegramma d’urgenza per smentire quella notizia.
Il salto che spiccai dal vagone mi salvò: come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida fissazione, intravidi in un baleno… ma sì! la mia liberazione la libertà una vita nuova!
Avevo con me ottantaduemila lire, e non avrei più dovuto darle a nessuno! Ero morto, ero morto: non avevo più debiti, non avevo più moglie, non avevo più suocera: nessuno! libero! libero! libero! Che cercavo di più?
Pensando così, dovevo esser rimasto in un atteggiamento stranissimo, là su la banchina di quella stazione. Avevo lasciato aperto lo sportello del vagone. Mi vidi attorno parecchia gente, che mi gridava non so che cosa; uno, infine, mi scosse e mi spinse, gridandomi più forte: «Il treno riparte!» «Ma lo lasci, lo lasci ripartire, caro signore!» gli gridai io, a mia volta. «Cambio treno!»

Mattia Pascal a teatro (episodio della lettura del proprio suicidio)
L’episodio su riportato ci rimanda a due elementi fondamentali nella narrativa pirandelliana: il caso e lo sdoppiamento. Se è un caso la vincita a Montecarlo è altrettanto un caso l’acquisto di un giornale che lo aiutasse a trovar requie in una notte agitatissima, leggiucchiando qua e là notizie. Potremmo accostare, quasi a “classicheggiare” il romanzo pirandelliano, al topos della “catabasi” di virgiliana memoria, viaggio agli inferi per “rigenerarsi: così è stato per Dante, per l’Innominato, così è per Mattia. Dopo un sonno agitato, dopo aver letto della sua morte, dopo la rabbia per non essere più stesso, l’illuminazione: Mattia si sdoppierà. Ad una prima morte una rinascita. E come rinascerà Mattia?
UN ALTRO UOMO
Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevan o voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d’encomio, quanto per obbedire alla Fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altr’uomo.
(…)
Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato, poche ore prima di partire, da un barbiere, per farmi accorciar la barba: avrei voluto levarmela tutta, lì stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali su la punta del naso. Più che barbiere doveva esser sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m’apparteneva più, armato di certi forbicioni da maestro di lana, che avevan bisogno d’esser sorretti in punta con l’altra mano. Non m’arrischiai neppure a fiatare: chiusi gli occhi, e non li riaprii, se non quando mi sentii scuotere pian piano. Il brav’uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo!
«No, grazie,» mi schermii. «Lo riponga. Non vorrei fargli paura.» Sbarrò tanto d’occhi, e: «A chi?» domandò. «Ma a codesto specchietto. Bellino! Dev’essere antico…» Era tondo, col manico d’osso intarsiato: chi sa che storia aveva e donde e come era capitato lì, in quella sarto-barbieria.
Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto gli occhi. Se era stato bravo! Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale alterazione dei connotati di Mattia Pascal! Ed ecco una nuova ragione d’odio per lui! Il mento piccolissimo, puntato e rientrato, ch’egli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo! E che naso mi aveva lasciato in eredità! E quell’occhio! «Ah, quest’occhio,» pensai, «così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia! Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un pajo d’occhiali colorati, che coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l’aspetto. Mi farò crescere i capelli e, con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese.» Non c’era via di mezzo: filosofo dovevo essere per forza con quella razza d’aspetto.
(…)
Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Alenga per Torino. Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente d’iconografia cristiana, in cui si dimostravano entrambi molto eruditi, per un ignorante come me. Uno, il più giovane, dalla faccia pallida, oppressa da una folta e ruvida barba nera, pareva provasse una grande e particolar soddisfazione nell’enunciar la notizia ch’egli diceva antichissima, sostenuta da Giustino Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo. Parlava con un vocione cavernoso, che contrastava stranamente con la sua aria da ispirato.
«Ma sì, ma sì, bruttissimo! bruttissimo! Ma anche Cirillo d’Alessandria! Sicuro, Cirillo d’Alessandria arriva finanche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini.»
L’altro, ch’era un vecchietto magro magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega a gli angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi su la schiena, col collo lungo proteso come sotto un giogo, sosteneva invece che non c’era da fidarsi delle più antiche testimonianze.
«Perché la Chiesa, nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo ispiratore, si dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute immagini di Cristo e della emorroissa.»
«Ma sì!» scattò il giovane barbuto. «Ma se non c’è più dubbio ormai! Quelle due statue rappresentano l’imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi.»
Il vecchietto seguitava a sostener pacificamente la sua opinione, che doveva esser contraria, perché quell’altro, incrollabile, guardando me, s’ostinava a ripetere : «Adriano! … Beronike, in greco. Da Beronike poi: Veronica… Adriano!» (a me).
«Oppure, Veronica, vera icon: storpiatura probabilissima..».
«Adriano!» (a me).
Perché la Beronike degli Atti di Pilato..
«Adriano!»
Ripeté così Adriano! non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. Quando scesero entrambi a una stazione e mi lasciarono solo nello scompartimento, m’affacciai al finestrino, per seguirli con gli occhi: discutevano ancora, allontanandosi. A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa.
«Chi lo dice?» gli domandò forte il giovane, fermo, con aria di sfida. Quegli allora si voltò per gridargli: «Camillo De Meis! Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome, a me che stavo intanto a ripetere meccanicamente: «Adriano…» Buttai subito via quel de e ritenni il Meis. «Adriano Meis! Si… Adriano Meis: suona bene…»
Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, ai capelli lunghi, al cappellaccio alla finanziera che avrei dovuto portare.
«Adriano Meis. Benone! M’hanno battezzato.»
Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l’animo alla deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, io era invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile; mi sentivo come rifatta vergine e trasparente la coscienza, e lo spirito vigile e pronto a trar profitto di tutto per la costruzione del mio nuovo io. Intanto l’anima mi tumultuava nella gioja di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto così uomini e cose; l’aria tra essi e me s’era d’un tratto quasi snebbiata; e mi si presentavan facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio intimo compiacimento. Oh levità deliziosa dell’anima; serena, ineffabile ebbrezza! La Fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico, all’improvviso, mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro: «Vedrai, vedrai com’essa t’apparirà curiosa, ora, a guardarla così da fuori! Ecco là uno che si guasta il fegato e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostener che Cristo fu il più brutto degli uomini…» Sorridevo. Mi veniva di sorridere così di tutto e a ogni cosa: a gli alberi della campagna, per esempio, che mi correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria; a le ville sparse qua e là, dove mi piaceva d’immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi o con le braccia levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandar acqua: e sorridevo agli uccelletti che si sbandavano, spaventati da quel coso nero che correva per la campagna, fragoroso; all’ondeggiar dei fili telegrafici, per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella da Miragno del mio suicidio nel molino della Stìa; alle povere mogli dei cantonieri che presentavan la bandieruola arrotolata, gravide e col cappello del marito in capo.
Se non che, a un certo punto, mi cadde lo sguardo su l’anellino di fede che mi stringeva ancora l’anulare della mano sinistra. Ne ricevetti una scossa violentissima: strizzai gli occhi e mi strinsi la mano con l’altra mano, tentando di strapparmi quel cerchietto d’oro, così, di nascosto, per non vederlo più. Pensai ch’esso si apriva e che, internamente, vi erano incisi due nomi: Mattia-Romilda, e la data del matrimonio. Che dovevo farne? Aprii gli occhi e rimasi un pezzo accigliato, a contemplarlo nella palma della mano. Tutto, attorno, mi s’era rifatto nero. Ecco ancora un resto della catena che mi legava al passato! Piccolo anello, lieve per sé, eppur così pesante! Ma la catena era già spezzata, e dunque via anche quell’ultimo anello! Feci per buttarlo dal finestrino, ma mi trattenni. Favorito così eccezionalmente dal caso, io non potevo più fidarmi di esso; tutto ormai dovevo creder possibile, finanche questo: che un anellino buttato nell’aperta campagna, trovato per combinazione da un contadino, passando di mano in mano, con quei due nomi incisi internamente e la data, facesse scoprir la verità, che l’annegato della Stìa cioè non era il bibliotecario Mattia Pascal. «No, no,» pensai, «in luogo più sicuro… Ma dove?» Il treno, in quella, si fermò a un’altra stazione. Guardai, e subito mi sorse un pensiero, per la cui attuazione provai dapprima un certo ritegno. Lo dico, perché mi serva di scusa presso coloro che amano il bel gesto, gente poco riflessiva, alla quale piace di non ricordarsi che l’umanità è pure oppressa da certi bisogni, a cui purtroppo deve obbedire anche chi sia compreso da un profondo cordoglio. Cesare, Napoleone e, per quanto possa parere indegno, anche la donna più bella… Basta. Da una parte c’era scritto Uomini e dall’altra Donne; e lì intombai il mio anellino di fede.

Mattia Pascal e Adriano Meis nel film del 1925
Mattia si trasforma e diventa un altro. La cosa più banale affinché questo avvenga non può che essere il cambiarsi i connotati. Ed è qui che troviamo l’episodio del barbiere. A ben guardare Mattia non si “ripulisce”, ma scopre il suo vero “io”, che aveva tentato di nascondere con la barba. Dentro quello specchietto quest’io, libero da ogni costrizione sociale può porsi fuori dal mondo e osservarlo, così come fa un filosofo, capace di analizzare la vita, proprio perché è estraneo ad essa (l’atteggiamento tipico dell’avvertimento del contrario). Ed è proprio attraverso questa possibilità che il nostro può osservare il dialogo, acceso e certamente inutile, dei due viaggiatori, che diventano metafora dell’inutilità di determinata cultura erudita, ma addirittura inutilità di qualsiasi forma di raffronto sociale, che certamente non porta ad alcuna felicità.
Scelto il nuovo nome, si accorge di possedere ancora l’anello matrimoniale; piccola riflessione sul caso ed intervento del “comico” più prettamente detto: gettato nel water. Cosa c’è di più contrario alla morale corrente che gettare un anello matrimoniale nel water?
UN PO’ DI NEBBIA
Ma una casa, una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla? I miei denari erano pochini… Ma una casettina modesta, di poche stanze? Piano: bisognava vedere, considerar bene prima, tante cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con la valigia in mano: oggi qua, domani là. Fermo in un luogo, proprietario d’una casa, eh, allora: registri e tasse subito! E non mi avrebbero iscritto all’anagrafe? Ma sicuramente! E come? con un nome falso? E allora, chi sa?, forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia… Insomma, impicci, imbrogli!… No, via: prevedevo di non poter più avere una casa mia, oggetti miei. Ma mi sarei allogato a pensione in qualche famiglia, in una camera mobiliata. Dovevo affliggermi per così poco?
(…)
E che seguiva da questa riflessione? Ahimè, che io, condannato inevitabilmente a mentire dalla mia condizione, non avrei potuto avere mai più un amico, un vero amico. E dunque, né casa, né amici… Amicizia vuol dire confidenza; e come avrei potuto io confidare a qualcuno il segreto di quella mia vita senza nome e senza passato, sorta come un fungo dal suicidio di Mattia Pascal? Io potevo aver solamente relazioni superficiali, permettermi solo co’ miei simili un breve scambio di parole aliene.
(…)
Là, in un corridojo, sospesa nel vano d’una finestra, c’era una gabbia con un canarino. Non potendo con gli altri e non sapendo che fare, mi mettevo a conversar con lui, col canarino: gli rifacevo il verso con le labbra, ed esso veramente credeva che qualcuno gli parlasse e ascoltava e forse coglieva in quel mio pispissìo care notizie di nidi, di foglie, di libertà… Si agitava nella gabbia, si voltava, saltava, guardava di traverso, scotendo la testina, poi mi rispondeva, chiedeva, ascoltava ancora. Povero uccellino! lui sì m’inteneriva, mentre io non sapevo che cosa gli avessi detto… Ebbene, a pensarci non avviene anche a noi uomini qualcosa di simile? Non crediamo anche noi che la natura ci parli? e non ci sembra di cogliere un senso nelle sue voci misteriose, una risposta, secondo i nostri desiderii, alle affannose domande che le rivolgiamo? E intanto la natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più lontano sentore di noi e della nostra vana illusione. Ma vedete un po’ a quali conclusioni uno scherzo suggerito dall’ozio può condurre un uomo condannato a star solo con se stesso! Mi veniva quasi di prendermi a schiaffi. Ero io dunque sul punto di diventare sul serio un filosofo? No, no, via, non era logica la mia condotta. Così, non avrei potuto più oltre durarla. Bisognava ch’io vincessi ogni ritegno, prendessi a ogni costo una risoluzione. Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere.

Locandina del film del 1925
Un po’ di nebbia s’insinua nella mente di Mattia/Adriano. Egli comincia a percepire se stesso come “forestiere” della vita e quindi a vedersi e a rendersi conto di non “poter” essere, cioè vivere: non può comprare una casa, non può avere veri amici con cui condividere ciò che non ha mai vissuto. Vive in una gabbia, come ci dice l’ultima parte del capitolo, che sembra richiamare una delle Operette morali di Leopardi, cioè in una “stanza della tortura” secondo la definizione del critico Macchia, in cui s’insinua l’opposizione tra vita e forma.
Alcune vicende portano Mattia a trasferirsi a Roma, presso la famiglia Paleari, dove vive il padrone di casa, la sua figliola Adriana, Terenzio marito della sorella morta di Adriana e Silvia Caporale, vecchia pensionante. Le dinamiche oserei dire le forme, cominciano a delinearsi all’interno della casa: il vecchio è appassionato di teosofia, con grande dispiacere della figliola, fervente cattolica. Il Paleari è un uomo, non chiaro, che sembra voglia recare danno a Mattia. Come naturalmente accade, Mattia s’innamora. Un giorno sente in casa uno spagnolo, che aveva già visto a Montecarlo. Per non farsi riconoscere si opera ad un occhio. Durante la convalescenza riceve la visita del signor Paleari:

Lorenzo Caprioli: interpretazione della lanterninosofia
LA LANTERNINOSOFIA
Quaranta giorni al bujo.
Riuscita, oh, riuscita benissimo l’operazione. Solo che l’occhio mi sarebbe forse rimasto un pochino pochino più grosso dell’altro. Pazienza! E intanto, sì, al bujo quaranta giorni, in camera mia.
Potei sperimentare che l’uomo, quando soffre, si fa una particolare idea del bene e del male, e cioè del bene che gli altri dovrebbero fargli e a cui egli pretende, come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto al compenso; e del male che egli può fare a gli altri, come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa e di tutto il male ch’egli fa quasi per diritto, facilmente si scusa.
Dopo alcuni giorni di quella prigionia cieca, il desiderio, il bisogno d’esser confortato in qualche modo crebbe fino all’esasperazione.
(…)
Per consolarmi, il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare con un lungo ragionamento che il bujo era immaginario.
«Immaginario? Questo?» gli gridai.
«Abbia pazienza mi spiego.»
E mi svolse (fors’anche perché fossi preparato a gli esperimenti spiritici, che si sarebbero fatti questa volta in camera mia, per procurarmi un divertimento) mi svolse, dico, una sua concezione filosofica, speciosissima, che si potrebbe forse chiamare lanterninosofia.
Di tratto in tratto, il brav’uomo s’interrompeva per domandarmi: «Dorme, signor Meis?»
E io ero tentato di rispondergli: «Sì, grazie, dormo, signor Anselmo.»
Ma poiché l’intenzione in fondo era buona, di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare.
E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che, per nostra disgrazia, noi non siamo come l’albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l’aria, la pioggia, il vento, non sembra che sieno cose ch’esso non sia: cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna.
E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che projetta tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo creder vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione?
«Dorme, signor Meis?»
«Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino.»
«Ah, bene… Ma poiché lei ha l’occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto d’inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel bujo della sorte umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l’illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io… E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell’idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d’un tratto tutti quei lanternoni.
Che piacere! Nell’improvviso bujo, allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più trova la via: si urtano, s’aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d’accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele.
Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. A chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucernette superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono accese su le loro tombe? Ricordo una bella poesia di Niccolò Tommaseo:
La piccola mia lampa
non, come sol, risplende,
né, come incendio, fuma;
non stride e non consuma,
ma con la cima tende
al ciel che me la diè.
Starà su me, sepolto,
viva; né pioggia o vento,
né in lei le età potranno;
e quei che passeranno
erranti, a lume spento,
lo accenderan da me.
Ma come, signor Meis, se alla lampa nostra manca l’olio sacro che alimentava quella del Poeta? Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell’alimento necessario le loro lanternucce. Sono, per lo più, poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita, e che vanno innanzi, nel bujo dell’esistenza, con quel loro sentimento acceso come una lampadina votiva, cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, ché duri almeno accesa fin là, fino all’orlo fatale, al quale s’affrettano, tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo: «Dio mi vede!» per non udire i clamori della vita intorno, che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. «Dio mi vede…» perché lo vedono loro, non solamente in sé, ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un premio, alla fine. Il fioco, ma placido lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi; a certi altri, invece, che si credono armati, come tanti Giove, del fulmine domato dalla scienza, e, in luogo di quelle lanternucce, recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa commiserazione. Ma domando io ora, signor Meis: E se tutto questo bujo, quest’enorme mistero, nel quale indarno i filosofi dapprima specularono, e che ora, pur rinunziando all’indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non si colora? Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente, per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè, di cui le ho finora parlato? Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non esistesse e fosse soltanto, non l’estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d’ombra fittizia, oltre il breve àmbito dello scarso lume, che noi, povere lucciole sperdute, ci projettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d’esilio che ci angoscia? Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità: nella realtà della natura non esiste. Noi, – non so se questo possa farle piacere – noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l’universo; anche ora, in questa forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell’universo, ma non lo sappiamo, non lo vediamo, perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva; e ce lo facesse vedere almeno com’esso è in realtà! Ma nossignore: ce lo colora a modo suo, e ci fa vedere certe cose, che noi dobbiamo veramente lamentare, perbacco, che forse in un’altra forma d’esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane, stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e intorno, della paura che c’ispirò!

Mattia Pascal e Adriano Meis: scissione dell’io
E’ forse uno dei passi più importanti del romanzo, ovvero uno in cui traspaia in modo diretto la filosofia pirandelliana. Certo, Pirandello non è un filosofo (nel senso che non vi è nella sua opera sistematicità di pensiero), ma ciò non toglie che in alcuni romanzi sia presente la sua personale visione della vita e in questo passo di lanterninosofia essa ci appare in tutta la sua chiarezza.
In questo passo vi è tutto il concetto ontologico e gnoseologico del relativismo del sapere e della scissione dell’io.
L’uomo, contrariamente a tutti gli altri esseri viventi, ha il triste destino di sentirsi vivere. Se la vita, pertanto, si percepisce al di fuori dell’uomo stesso, ne consegue una frattura tra l’io e la vita. Il modo con cui osserviamo la vita esterna a noi c’è offerto dalla piccola luce che emaniamo al di fuori di noi, appunto quella di un lanternino, che avendo la capacità d’illuminare solo una piccola parte intorno a noi, non può che essere relativa: non solo ontologicamente l’uomo è solo, ma gnoseologicamente non ha più verità, se non la propria, in quanto ognuno di noi proietta la sua luce solo intorno a se stesso.
Certo ci sono stati momenti in cui lanternoni hanno illuminato epoche intere, per meglio dire periodi in cui grandi ideologie, virtù morali, credenze religiose hanno permeato di sé l’intera esistenza creando comunanza d’interessi e di passioni. Ma oggi, ci dice Pirandello/Paleari si vive nel buio: buia è la situazione di Mattia/Adriano sul letto, buia è l’epoca in cui vive. Ma è proprio il buio della sua condizione che gli permette di concepire l’essenza stessa dell’esistere: soltanto spegnendo il lanternino egli può superare la frattura l’io e la vita e lasciarsi andare al fluire della stessa, vivendo nell’universo in cui è sempre esistito. Solo la cecità gli offre la possibilità di capire, come solo l’occhio strabico gli aveva offerto la possibilità di osservare, straniandosi, l’assurdità del mondo.

Disegno giovanile di Edward Hopper
IO E L’OMBRA MIA
Mi è avvenuto più volte, svegliandomi nel cuor della notte (la notte, in questo caso, non dimostra veramente d’aver cuore), mi è avvenuto di provare al bujo, nel silenzio, una strana meraviglia, uno strano impaccio al ricordo di qualche cosa fatta durante il giorno, alla luce, senz’abbadarci, e ho domandato allora a me stesso se, a determinar le nostre azioni, non concorrano anche i colori, la vista delle cose circostanti, il vario frastuono della vita. Ma sì, senza dubbio; e chi sa quant’altre cose! Non viviamo noi, secondo il signor Anselmo, in relazione con l’universo? Ora sta a vedere quante sciocchezze questo maledetto universo ci fa commettere, di cui chiamiamo responsabile la misera coscienza nostra, tirata da forze esterne, abbagliata da una luce che è fuori di lei. E, all’incontro, quante deliberazioni prese, quanti disegni architettati, quanti espedienti macchinati durante la notte non appajono poi vani e non crollano e poi sfumano alla luce del giorno? Com’altro è il giorno, altro la notte, così forse una cosa siamo noi di giorno, altra di notte: miserabilissima cosa, ahimè, così di notte come di giorno.
So che, aprendo dopo quaranta giorni le finestre della mia camera, io non provai alcuna gioja nel riveder la luce. Il ricordo di ciò che avevo fatto in quei giorni al bujo me la offuscò orribilmente. Tutte le ragioni e le scuse e le persuasioni che in quel bujo avevano avuto il loro peso e il loro valore, non ne ebbero più alcuno, appena spalancate le finestre, o ne ebbero un altro al tutto opposto. E invano quel povero me che per tanto tempo se n’era stato con le finestre chiuse e aveva fatto di tutto per alleviarsi la noja smaniosa della prigionia, ora – timido come un cane bastonato – andava appresso a quell’altro me che aveva aperte le finestre e si destava alla luce del giorno, accigliato, severo, impetuoso, invano cercava di stornarlo dai foschi pensieri, inducendolo a compiacersi piuttosto, dinanzi allo specchio, del buon esito dell’operazione e della barba ricresciuta e anche del pallore che in qualche modo mi ingentiliva l’aspetto.
«Imbecille, che hai fatto? Che hai fatto?»
Che avevo fatto? Niente, siamo giusti! Avevo fatto all’amore. Al bujo – era colpa mia? – non avevo veduto più ostacoli, e avevo perduto il ritegno che m’ero imposto. Papiano voleva togliermi Adriana; la signora Caporale me l’aveva data, me l’aveva fatta sedere accanto, e s’era buscato un pugno sulla bocca, poverina; io soffrivo, e – naturalmente – per quelle sofferenze credevo com’ogni altro sciagurato (leggi uomo) d’aver diritto ad un compenso, e – poiché l’avevo allato – me l’ero preso; lì si facevano gli esperimenti della morte, e Adriana, accanto a me, era la vita, la vita che aspetta un bacio per schiudersi alla gioja; ora Manuel Bernandez aveva baciato al bujo la sua Pepita, e allora anch’io…
«Ah!»
Mi buttai su la poltrona, con le mani in faccia. Mi sentivo fremere le labbra al ricordo di quel bacio. Adriana! Adriana! Che speranze le avevo acceso in cuore con quel bacio? Mia sposa, è vero? Aperte le finestre, festa per tutti!
Rimasi, non so per quanto tempo, lì su quella poltrona, a pensare, ora con gli occhi sbarrati, ora restringendomi tutto in me, rabbiosamente, come per schermirmi da un fitto spasimo interno. Vedevo finalmente: vedevo in tutta la sua crudezza la frode della mia illusione: che cos’era in fondo ciò che m’era sembrata la più grande delle fortune, nella prima ebbrezza della mia liberazione.
Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio m’era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza del mio denaro; poi m’ero anche accorto ch’essa più propriamente avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noja, e che mi condannava a una terribile pena: quella della compagnia di me stesso; mi ero allora accostato agli altri; ma il proponimento di guardarmi bene dal riallacciare, foss’anche debolissimamente, le fila recise, a che era valso? Ecco: s’erano riallacciate da sé, quelle fila; e la vita, per quanto io, già in guardia, mi fossi opposto, la vita mi aveva trascinato, con la sua foga irresistibile: la vita che non era più in me. Ah, ora me n’accorgevo veramente, ora non potevo più con vani pretesti, con infingimenti quasi puerili, con pietose, meschinissime scuse impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per Adriana, attenuare il valore delle mie intenzioni, delle mie parole, de’ miei atti. Troppe cose, senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, inducendola a intrecciar con le mie le sue dita; e un bacio, un bacio infine aveva suggellato il nostro amore. Ora, come risponder coi fatti alla promessa? Potevo far mia Adriana? Ma nella gora del molino, là alla Stìa, ci avevano buttato me quelle due buone donne, Romilda e la vedova Pescatore; non ci s’eran mica buttate loro! E libera dunque era rimasta lei, mia moglie; non io, che m’ero acconciato a fare il morto, lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un’altra vita. Un altr’uomo, sì, ma a patto di non far nulla. E che uomo, dunque? Un’ombra d’uomo! E che vita? Finché m’ero contentato di star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male salvar l’illusione ch’io stessi vivendo un’altra vita; ma ora che a questa m’ero accostato fino a cogliere un bacio da due care labbra, ecco, mi toccava a ritrarmene inorridito, come se avessi baciato Adriana con le labbra d’un morto, d’un morto che non poteva rivivere per lei! Labbra mercenarie, sì, avrei potuto baciarne; ma che sapor di vita in quelle labbra? Oh, se Adriana, conoscendo il mio strano caso… Lei? No… no… che! neanche a pensarci! Lei, così pura, così timida… Ma se pur l’amore fosse stato in lei più forte di tutto, più forte di ogni riguardo sociale… ah povera Adriana, e come avrei potuto io chiuderla con me nel vuoto della mia sorte, farla compagna d’un uomo che non poteva in alcun modo dichiararsi e provarsi vivo? Che fare? che fare?
Due colpi all’uscio mi fecero balzar dalla poltrona. Era lei, Adriana.
Per quanto con uno sforzo violento cercassi di arrestare in me il tumulto dei sentimenti, non potei impedire che non le apparissi almeno turbato. Turbata era anche lei, ma dal pudore, che non le consentiva di mostrarsi lieta, come avrebbe voluto, di rivedermi finalmente guarito, alla luce, e contento… No? Perché no?… Alzò appena gli occhi a guardarmi; arrossì; mi porse una busta:
«Ecco, per lei…»
«Una lettera?»
«Non credo. Sarà la nota del dottor Ambrosini? Il servo vuol sapere se c’è risposta.»
Le tremava la voce. Sorrise.
«Subito,» diss’io; ma un’improvvisa tenerezza mi prese, comprendendo ch’ella era venuta con la scusa di quella nota per aver da me una parola che la raffermasse nelle sue speranze; un’angosciosa, profonda pietà mi vinse, pietà di lei e di me, pietà crudele, che mi spingeva irresistibilmente a carezzarla, a carezzare in lei il mio dolore, il quale soltanto in lei, che pur ne era la causa, poteva trovar conforto. E pur sapendo che mi sarei compromesso ancor più, non seppi resistere: le porsi ambo le mani. Ella, fiduciosa, ma col volto in fiamme, alzò pian piano le sue e le pose sulle mie. Mi attirai allora la sua testina bionda sul petto e le passai una mano su i capelli.
«Povera Adriana!»
«Perché?» mi domandò, sotto la carezza. «Non siamo contenti?»
«Sì…»
«E allora perché povera?»
Ebbi in quel momento un impeto di ribellione, fui tentato di svelarle tutto, di risponderle: «Perché? Senti: io ti amo, e non posso, non debbo amarti! Se tu vuoi, però…». Ma dàlli! Che poteva volere quella mite creatura? Mi premetti forte sul petto la sua testina, e sentii che sarei stato molto più crudele se dalla gioja suprema a cui ella, ignara, si sentiva in quel punto, inalzata dall’amore, io l’avessi fatta precipitare nell’abisso della disperazione che era in me.
«Perché,» dissi, lasciandola, «perché so tante cose, per cui lei non può essere contenta…»
Ebbe come uno smarrimento penosissimo, nel vedersi, così d’un tratto, sciolta dalle mie braccia. Si aspettava forse, dopo quelle carezze, che io le dessi del tu? Mi guardò e, notando la mia agitazione, domandò esitante:
«Cose… che sa lei… per sé, o qui… di casa mia?»
Le risposi col gesto: “Qui, qui” per togliermi la tentazione che di punto in punto mi vinceva, di parlare, di aprirmi con lei.
L’avessi fatto! Cagionandole subito quell’unico, forte dolore, gliene avrei risparmiato altri, e io non mi sarei cacciato in nuovi e più aspri garbugli. Ma troppo recente era allora la mia triste scoperta, avevo ancor bisogno d’approfondirla bene, e l’amore e la pietà mi toglievano il coraggio d’infrangere così d’un tratto le speranze di lei e la mia vita stessa, cioè quell’ombra d’illusione che di essa, finché tacevo, poteva ancora restarmi. Sentivo poi quanto odiosa sarebbe stata la dichiarazione che avrei dovuto farle, che io, cioè, avevo moglie ancora. Sì! sì! Svelandole che non ero Adriano Meis, io tornavo ad essere Mattia Pascal, MORTO E ANCORA AMMOGLIATO! Come si possono dire siffatte cose? Era il colmo, questo, della persecuzione che una moglie possa esercitare sul proprio marito: liberarsene lei, riconoscendolo morto nel cadavere d’un povero annegato, e pesare ancora, dopo la morte, su lui, addosso a lui, così. Io avrei potuto ribellarmi, è vero, dichiararmi vivo, allora… Ma chi, al posto mio, non si sarebbe regolato come me? Tutti, tutti, come me, in quel punto, nei panni miei, avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare in un modo così inatteso, insperato, insperabile, della moglie, della suocera, dei debiti, d’un’egra e misera esistenza come quella mia. Potevo mai pensare, allora, che neanche morto mi sarei liberato della moglie? lei, sì, di me, e io no di lei? e che la vita che m’ero veduta dinanzi libera libera libera, non fosse in fondo che una illusione, la quale non poteva ridursi in realtà, se non superficialissimamente, e più schiava che mai, schiava delle finzioni, delle menzogne che con tanto disgusto m’ero veduto costretto a usare, schiava del timore d’esser scoperto, pur senza aver commesso alcun delitto?
Adriana riconobbe che non aveva in casa, veramente, di che esser contenta; ma ora… E con gli occhi chiusi e con un mesto sorriso mi domandò se mai per me potesse rappresentare un ostacolo ciò che per lei era cagione di dolore. “No, è vero?” chiedeva quello sguardo e quel mesto sorriso.
«Oh, ma paghiamo il dottor Ambrosini!» esclamai, fingendo di ricordarmi improvvisamente della nota e del servo che attendeva di là. Lacerai la busta e, senza por tempo in mezzo, sforzandomi d’assumere un tono scherzoso: «Seicento lire!» dissi. «Guardi un po’, Adriana: la Natura fa una delle sue solite stramberie; per tanti anni mi condanna a portare un occhio, diciamo così disobbediente; io soffro dolori e prigionia per correggere lo sbaglio di lei, e ora per giunta mi tocca a pagare. Le sembra giusto?»
Adriana sorrise con pena.
«Forse,» disse, «il dottor Ambrosini non sarebbe contento se lei gli rispondesse di rivolgersi alla Natura per il pagamento. Credo che si aspetti anche d’esser ringraziato, perché l’occhio…»
«Le par che stia bene?»
Ella si sforzò a guardarmi, e disse piano, riabbassando subito gli occhi,: «Sì… Pare un altro…»
«Io o l’occhio?»
«Lei.»
«Forse con questa barbaccia…»
«No… perché? Le sta bene…»
Me lo sarei cavato con un dito, quell’occhio! Che mi importava più d’averlo a posto?
«Eppure,» dissi, «forse esso per conto suo, era più contento prima. Ora mi dà un certo fastidio… Basta. Passerà!»
Mi recai allo stipetto a muro, in cui tenevo il denaro. Allora Adriana accennò a volersene andare; io stupido la trattenni; ma già, come potevo prevedere? In tutti gli impicci miei, grandi e piccini, sono stato, come s’è visto, soccorso sempre dalla fortuna. Ora ecco com’essa, anche questa volta, mi venne in ajuto.
Facendo per aprire lo stipetto, notai che la chiave non girava entro la serratura: spinsi appena appena e, subito, lo sportellino cedette: era aperto!
«Come!» esclamai. «Possibile ch’io l’abbia lasciato così?»
Notando il mio improvviso turbamento, Adriana era diventata pallidissima. La guardai, e: «Ma qui… guardi, signorina, qui qualcuno ha dovuto metter le mani!»
C’era dentro lo stipetto un gran disordine: i miei biglietti di banca erano stati tratti dalla busta di cuojo, in cui li avevo custoditi, ed erano lì sul palchetto sparpagliati. Adriana si nascose il volto tra le mani, inorridita. Io raccolsi febbrilmente quei biglietti e mi diedi a contarli.
«Possibile?» esclamai, dopo aver contato, passandomi le mani tremanti su la fronte ghiaccia di sudore.
Adriana fu per mancare, ma si sorresse ad un tavolinetto lì presso e domandò con una voce che non mi parve più la sua: «Hanno rubato?»
«Aspetti… aspetti… Com’è possibile?» dissi io.
E mi rimisi a contare, sforzando rabbiosamente le dita e la carta, come se, a furia di stroppicciare, potessero da quei biglietti venir fuori gli altri che mancavano.
«Quanto?» mi domandò ella, scontraffatta dall’orrore, dal ribrezzo, appena ebbi finito di contare.
«Dodici… dodici mila lire…» balbettai. «Erano sessantacinque… sono cinquantatré! Conti lei…»
Se non avessi fatto a tempo a sorreggerla, la povera Adriana sarebbe caduta per terra, come sotto una mazzata. Tuttavia, con uno sforzo supremo, ella poté riaversi ancora una volta, e singhiozzando, convulsa, cercò di sciogliersi da me che volevo adagiarla su la poltrona e fece per spingersi verso l’uscio: «Chiamo il babbo! chiamo il babbo!»
«No!» le gridai, trattenendola e costringendola a sedere. «Non si agiti così, per carità, si calmi. Mi lasci prima accertare, perché… sì, lo stipetto era aperto, ma io non posso, non voglio credere ancora a un furto così ingente… Stia buona, via!»
E daccapo, per un ultimo scrupolo, tornai a contare i biglietti; pur sapendo di certo che tutto il mio denaro stava lì, in quello stipetto, mi diedi a rovistare da per tutto, anche dove non era in alcun modo possibile ch’io avessi lasciato una tal somma, tranne che non fossi stato colto da un momento di pazzia. E per indurmi a quella ricerca che m’appariva a mano a mano sempre più sciocca e vana, mi sforzavo di credere inverosimile l’audacia del ladro. Ma Adriana, quasi farneticando, con le mani sul volto, con la voce rotta dai singhiozzi:
«E’ inutile! è inutile!» gemeva. «Ladro… ladro… anche ladro!… Tutto congegnato avanti… Ho sentito nel bujo… m’è nato il sospetto… ma non volli credere ch’egli potesse arrivare fino a tanto…»
Papiano, sì: il ladro non poteva esser altri che lui; lui, per mezzo del fratello, durante quelle sedute spiritiche…
«Ma come mai,» gemette ella, angosciata, «come mai teneva lei tanto denaro, così, in casa?»
Mi voltai a guardarla, inebetito. Che risponderle? Potevo dirle che per forza, nella condizione mia, dovevo tener con me il denaro? potevo dirle che mi era interdetto d’investirlo in qualche modo, d’affidarlo a qualcuno? che non avrei potuto neanche lasciarlo in deposito in qualche banca, giacché, se poi per caso fosse sorta qualche difficoltà non improbabile per ritirarlo, non avrei più avuto modo di far riconoscere il mio diritto su esso?
«Potevo mai supporre?» dissi.
Adriana si coprì di nuovo il volto con le mani, gemendo, straziata: «Dio! Dio! Dio!»
Lo sgomento che avrebbe dovuto assalire il ladro nel commettere il furto, invase me, invece, al pensiero di ciò che sarebbe avvenuto. Papiano non poteva certo supporre ch’io incolpassi di quel furto il pittore spagnuolo o il signor Anselmo, la signorina Caporale o la serva di casa o lo spirito di Max: doveva esser certo che avrei incolpato lui, lui e il fratello: eppure, ecco, ci s’era messo, quasi sfidandomi.
E io? che potevo far io? Denunziarlo? E come? Ma niente, niente! io non potevo far niente! ancora una volta, niente! Mi sentii atterrato, annichilito. Era la seconda scoperta, in quel giorno! Conoscevo il ladro, e non potevo denunziarlo. Che diritto avevo io alla protezione della legge? Io ero fuori d’ogni legge. Chi ero io? nessuno! Non esistevo io, per la legge. E chiunque, ormai, poteva rubarmi; e io, zitto!
Ma tutto questo, Papiano non poteva saperlo. E dunque?
«Come ha potuto farlo?» dissi quasi tra me. «Da che gli è potuto venire tanto ardire?»
Adriana levò il volto dalle mani e mi guardò stupita, come per dire: “E non lo sai”»
«Ah, già!» feci, comprendendo a un tratto.
«Ma lei lo denunzierà!» eslamò ella, levandosi in piedi. «Mi lasci, la prego, mi lasci chiamare il babbo… Lo denunzierà subito!»
Feci in tempo a trattenerla ancora una volta. Non ci mancava altro, che ora, per giunta, Adriana mi costringesse a denunziare il furto! Non bastava che mi avessero rubato, come niente, dodici mila lire? Dovevo anche temere che il furto si conoscesse; pregare, scongiurare Adriana che non lo gridasse forte, non lo dicesse a nessuno, per carità? Ma che! Adriana – e ora lo intendo bene – non poteva assolutamente permettere che io tacessi e obbligassi anche lei al silenzio, non poteva in verun modo accettare quella che pareva una mia generosità, per tante ragioni: prima per il suo amore, poi per l’onorabilità della casa, e anche per me e per l’odio ch’ella portava al cognato.
Ma in quel frangente, la sua giusta ribellione mi parve proprio di più: esasperato, le gridai: «Lei si starà zitta: gliel’impongo! Non dirà nulla a nessuno, ha capito? Vuole uno scandalo?»
«No! no!» s’affrettò a protestare, piangendo, la povera Adriana. «Voglio liberar la mia casa dall’ignominia di quell’uomo!»
«Ma egli negherà!» incalzai io. «E allora, lei, tutti di casa innanzi al giudice… Non capisce?»
«Sì, benissimo!» rispose Adriana con fuoco, tutta vibrante di sdegno. «Neghi, neghi pure! Ma noi, per conto nostro, abbiamo altro, creda, da dire contro di lui. Lei lo denunzii, non abbia riguardo, non tema per noi… Ci farà un bene, creda, un gran bene! Vendicherà la povera sorella mia… Dovrebbe intenderlo, signor Meis, che mi offenderebbe, se non lo facesse. Io voglio, voglio che lei lo denunzii. Se non lo fa lei, lo farò io! Come vuole che io rimanga con mio padre sotto quest’onta! No! no! no! E poi…»
Me la strinsi fra le braccia: non pensai più al denaro rubato, vedendola soffrire così, disperata: e le promisi che avrei fatto com’ella voleva, purché si calmasse. No, che onta? non c’era alcuna onta per lei, né per il suo babbo; io sapevo su chi ricadeva la colpa di quel furto; Papiano aveva stimato che il mio amore per lei valesse bene dodici mila lire, e io dovevo dimostrargli di no? Denunziarlo? Ebbene, sì, l’avrei fatto, non per me, ma per liberar la casa di lei da quel miserabile: così, via! via! e poi, che mi giurasse su quel che aveva di più caro al mondo, che non avrebbe parlato a nessuno, a nessuno, di quel furto, se prima io non consultavo un avvocato per tutte le conseguenze che, in tanta sovreccitazione, né io né lei potevamo prevedere.
«Me lo giura? Su ciò che ha di più caro?»
Me lo giurò, e con uno sguardo, tra le lagrime, mi fece intendere su che cosa me lo giurava, che cosa avesse di più caro.
Povera Adriana!
Rimasi lì, solo, in mezzo alla camera, sbalordito, vuoto, annientato, come se tutto il mondo per me si fosse fatto vano. Quanto tempo passò prima ch’io mi riavessi? E come mi riebbi? Scemo… scemo!… Come uno scemo, andai a osservare lo sportello dello stipetto, per vedere se non ci fosse qualche traccia di violenza. No: nessuna traccia: era stato aperto pulitamente; con un grimaldello, mentr’io custodivo con tanta cura in tasca la chiave.
“E non si sente lei,” mi aveva domandato il Paleari alla fine dell’ultima seduta, “non si sente lei come se le avessero sottratto qualche cosa?”
Dodici mila lire!
Di nuovo il pensiero della mia assoluta impotenza, della mia nullità, mi assalì, mi schiacciò. Il caso che potessero rubarmi e che io fossi costretto a restar zitto, e finanche con la paura che il furto fosse scoperto, come se l’avessi commesso io e non un ladro a mio danno, non mi s’era davvero affacciato alla mente.
Dodici mila lire? Ma poche! poche! Possono rubarmi tutto, levarmi fin la camicia di dosso; e io, zitto! Che diritto ho io di parlare? La prima cosa che mi domanderebbero, sarebbe questa: “E voi chi siete? Donde vi era venuto quel denaro?”. Ma senza denunziarlo… vediamo un po’! se questa sera io l’afferro per il collo e gli grido: “Qua subito il denaro che hai tolto di là, dallo stipetto, pezzo di ladro!” Egli strilla; nega; può forse dirmi: “Sissignore, eccolo qua, lo preso per isbaglio…”? E allora? Ma c’è il caso che mi dia anche querela per diffamazione. Zitto, dunque, zitto! M’è sembrata una fortuna l’esser creduto morto; ebbene, sono morto davvero. Morto? Peggio che morto; me l’ha ricordato il signor Anselmo: i morti non debbono più morire, e io sì: io sono ancora vivo per la morte e morto per la vita. Che vita infatti può esser più la mia? La noja di prima, la solitudine, la compagnia di me stesso?
Mi nascosi il volto con le mani; caddi a sedere su la poltrona.
Ah, fossi stato almeno un mascalzone! avrei potuto forse adattarmi a restar così, sospeso nell’incertezza della sorte, abbandonato al caso, esposto a un rischio continuo, senza base, senza consistenza. Ma io? Io, no. E che fare, dunque? Andarmene via? E dove? E Adriana? Ma che potevo fare per lei? Nulla… nulla… Come andarmene però così, senz’alcuna spiegazione, dopo quanto era accaduto? Ella ne avrebbe cercato la causa in quel furto; avrebbe detto: “E perché avrebbe voluto salvare il reo, e punir me innocente?”. Ah, no, no, povera Adriana! Ma, d’altra parte, non potendo far nulla come sperare di rendere men trista la mia parte verso di lei? Per forza dovevo dimostrarmi inconseguente e crudele. L’inconseguenza, la crudeltà erano della mia stessa sorte, e io per primo ne soffrivo. Fin Papiano, il ladro, commettendo il furto, era stato più conseguente e meno crudele di quel che pur troppo avrei dovuto dimostrarmi io.
Egli voleva Adriana, per non restituire al suocero la dote della prima moglie: e io avevo voluto togliergli Adriana? e dunque la dote bisognava che la restituissi io, al Paleari.
Per ladro, conseguentissimo!
Ladro? Ma neanche ladro: perché la sottrazione, in fondo, sarebbe stata più apparente che reale: infatti, conoscendo egli l’onestà di Adriana, non poteva pensare ch’io volessi farne la mia amante: volevo certo farla mia moglie: ebbene allora avrei riavuto il mio denaro sotto forma di dote d’Adriana, e per di più avrei avuto una mogliettina saggia e buona: che cercavo di più?
Oh, io ero sicuro che, potendo aspettare, e se Adriana avesse avuto la forza di serbare il segreto, avremmo veduto Papiano attener la promessa di restituire, anche prima dell’anno di comporto, la dote della defunta moglie.
Quel denaro, è vero, non poteva più venire a me, perché Adriana non poteva esser mia: ma sarebbe andato a lei, se ella ora avesse saputo tacere, seguendo il mio consiglio, e se io mi fossi potuto trattenere ancora per qualche po’ di tempo lì. Molta arte, molta arte avrei dovuto adoperare, e allora Adriana, se non altro, ci avrebbe forse guadagnato questo: la restituzione della sua dote.
M’acquietai un po’, almeno per lei, pensando così. Ah, non per me! Per me rimaneva la crudezza della frode scoperta, quella de la mia illusione, di fronte a cui era nulla il furto delle dodici mila lire, era anzi un bene, se poteva risolversi in un vantaggio per Adriana.
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affissarono su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là, per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita…
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.
“Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Su, da bravo, sì, alza un’anca! alza un’anca!”
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre; alla fine, non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,» pensai, «mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa d’un ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.

Pirandello sul set del film con Pierre Blanchar e Isa Miranda
Questo lungo brano rappresenta il climax (o lo spannung) dell’intero romanzo. Esso avviene, non a caso, quando a Mattia/Adriano vengono tolte le bende, cioè quando smette, nel buio, nella cecità di fluire nell’universo e ritorna ad essere estraneo alla vita.
Paradossalmente (molte opere pirandelliane giocheranno proprio sul paradosso) l’inizio del capitolo insiste sul concetto di libertà: il fatto che egli si sia cancellato, e che ciò avrebbe pertanto dovuto costituire la più totale liberazione, rappresenta invece una terribile costrizione; chi invece non si è affatto preoccupata di “liberarsi di sé” lo è effettivamente, Romilda che lo ha riconosciuto cadavere.
Il problema è che lui si è estraniato dalla vita: egli vive fuori dalla vita, osservandola dall’esterno (il tema dell’occhio è centrale: lo strabismo, la cecità) e nel momento in cui tenta di rientrarci non può.
La vita infatti, per Pirandello si vive all’interno di una forma: Andrea Meis non è in quanto mancante di forma. E’ un non esistente in quanto non è stato certificato nella vita, non ha niente che sia riconoscibile alla vita (nome, documento, identità). Non può amare, non può denunciare.
Ecco allora la chiusa, giocata sul doppio: Mattia e la sua ombra (Meis). Potremo definire le due parti intercambiabili: Mattia come ombra di Adriano o viceversa. Ma un uomo “morto” non ha ombra: da qui la disperazione: egli non esiste e quindi deve fuggire dall’ombra che lo perseguita.
Può farlo solo suicidandosi: lascia un cappello, un bastone e un biglietto a firma Adriano Meis.
Quindi torna da dove era partito, vuole ricongiungersi alla sua storia, ma la moglie si è risposata ed ha un figlio con un altro uomo. Mattia decide di rimanere estraneo alla vita:

Mastroianni nel film di Monicelli
IL FU MATTIA PASCAL
Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua. La mia bislacca avventura m’ha rialzato d’un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto qui egli serberà il segreto, come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme su i casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa cavare.
«Intanto, questo,» egli mi dice: «che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere.»
Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch’io mi sia. Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s’uccise alla Stìa, c’è ancora la lapide dettata da Lodoletta:
COLPITO DA AVVERSI FATI
MATTIA PASCAL
BIBLIOTECARIO
CVOR GENEROSO ANIMA APERTA
QVI VOLONTARIO
RIPOSA
LA PIETA’ DEI CONCITTADINI
QVESTA LAPIDE POSE
Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e – considerando la mia condizione – mi domanda: «Ma voi, insomma, si può sapere chi siete?»
Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: «Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal.»
L’importanza, nonché la novità del romanzo pirandelliano è già nel titolo: far precedere un fu (come si usa nella definizione dei defunti) ad un nome significa parlare di un morto, ma la sorpresa è che il libro è in prima persona e non è possibile che un morto scriva, a meno che non si racconti di due non vite quella di Mattia Pascal e quella di Adriano Meis.
A ben guardare è un romanzo apparentemente circolare: inizia nello stesso paese dove in effetti si conclude: eppure il ritorno non corrisponde ad uno scioglimento. E’ un percorso a ritroso dove il protagonista ripercorre le sue vicende: il problema è che nel suo lungo flash-back il narratore non è mai il protagonista di ciò che fa, è sempre più agito che agente, per questo vi è bisogno di uno sdoppiamento non solo tra Mattia ed Adriano, ma tra Mattia, Adriano e l’autore stesso che, assumendo di volta in volta vari ruoli, storicizza, riflette, filosofeggia, con una parola tira le fila. Infatti il racconto si muove in un tempo preciso (6 anni) ma gli episodi narrati hanno una valenza temporale soggettiva, ora sintetizza ora divaga; lo spazio non è lineare (Liguria, Francia, Montecarlo, Roma) è uno zigzagare, come zigzagano i pensieri rappresentati. Ciò determina un andamento non preciso, punteggiato da riflessioni a posteriori, che ne fanno anche un romanzo, come già detto, filosofico. La sua non circolarità è determinata dal fatto che il romanzo comincia con una vita e finisce con una sconfitta una non-vita.
Il romanzo successivo a Il fu Mattia Pascal, fu Suo marito uscito per la prima volta nel 1911, e, dopo essere stato ritirato, riuscito postumo nel 1941 per volontà del figlio Stefano, col titolo Giustino Roncella nato Bocciolo.
Silvia Roncella, giovane scrittrice di Taranto sposa Giustino Boggiolo, un modesto impiegato, fornito di una cultura altrettanto modesta. Egli dimostra di essere, dopo che la moglie diventa celebre, uno straordinario amministratore, prendendo tutte le iniziative di contratto con gli editori, i critici, i giornalisti, i traduttori e il pubblico, per reclamizzare e far fruttare la produzione letteraria della moglie. Questa sua frenetica attività di agente pubblicitario lo espone alla malignità dei colleghi d’ufficio, che lo ridicolizzano appioppandogli il nomignolo di Roncello e facendogli trovare i biglietti da visita intestati a Giustino Roncella nato Boggiolo. Silvia, che vede il ridicolo della situazione, si distacca sempre più dal marito e si separa da lui, cedendo al corteggiamento di un maturo scrittore, Maurizio Gueli, né si ricongiunge più col marito quando perde l’amore del Gueli e le muore il figlio, sicché sia Giustino sia lei restano soli, ciascuno per la propria strada, chiusi nel proprio dramma interiore.

Grazia Deledda con suo marito
“Il romanzo è sospeso tra propositi satirici e addirittura caricaturali (sia per la vicenda della protagonista, che esplicitamente allude a quella della Deledda, sia per l’impietosa presentazione della società letteraria, delle sue finzioni e delle sue volgarità) e l’intenzione di seguire più da vicino il senso dell’esperienza artistica, il sorgere e lo svilupparsi delle sue forme nella mente dell’artista, il legame (che sempre ha ossessionato Pirandello) tra creazione e gestazione. Tra molte ambiguità e sotterranee lacerazioni, si interroga la natura femminile della creatività, i contrasti e le scissioni che da esse prendono corpo, il suo opporsi alle finzioni e agli artifici sociali motivato dalla ricerca di un “arcano senso” nascono nella “vita delle cose”” (Ferroni).
Se il tema presente nei romanzi finora descritti appartiene a tematiche, ora accennate ora chiaramente espresse, tipicamente pirandelliane come l’imprevedibilità del caso, la labilità tra realtà ed apparenza, l’io diviso tra forma e contenuto, diverso è l’impegno con cui l’autore siciliano dà alle stampe un romanzo storico I vecchi e i giovani (1913), con cui il nostro oltre ad ispirarsi al grande precedente di De Roberto, I viceré del 1891, svolge un’amara riflessione sulla conclusione del processo risorgimentale a cui da giovane aveva creduto.

I vecchi e i giovani in Tv (1979)
A Girgenti, nel 1893, si deve eleggere il deputato del collegio da inviare in Parlamento; la contesa politica vede schierati clericali e affaristi, governativi, socialisti e il nuovo movimento dei Fasci siciliani. Flaminio Salvo, banchiere, proprietario di miniere, rappresentante del ceto borghese imprenditoriale, offre al partito clericale il suo appoggio elettorale e, per sancire l’alleanza, combina, il matrimonio della cinquantenne sorella Adelaide con il sessantacinquenne principe Ippolito Laurentano, feudatario di fede borbonica e clericale, candidando Ignazio Capolino, consulente legale e uomo di fiducia di Salvo. I governativi candidano invece un reduce garibaldino, Roberto Auriti, figlio di Caterina Laurentano – sorella del principe Ippolito che aveva scelto con dignità una vita di ristrettezze. Nell’imminenza delle elezioni, Roberto – che vive a Roma dove esercita con modesta fortuna la professione di avvocato – torna a Girgenti. Nei suoi confronti il partito clericale scatena sulla stampa cittadina una campagna diffamatoria, orchestrata da mestatori prezzolati che ne decretano la sconfitta. Nel mentre in tutta la Sicilia monta la protesta sociale di contadini e zolfatari, sullo sfondo della crisi economica e dell’industria zolfifera dell’isola. Nella seconda parte del romanzo l’azione si sposta a Roma, dove Roberto Auriti è ritornato. La capitale è sommersa dal “fango” dello scandalo della Banca Romana in cui l’avvocato rimane coinvolto, ma ne esce scagionato. A Roma si riannodano le vicende di alcuni personaggi girgentini convenuti nella capitale con motivazioni diverse: tra i quali l’onorevole Ignazio Capolino, con la giovane moglie Nicoletta, per svolgere il suo mandato parlamentare; Flaminio Salvo e l’ingegnere minerario Aurelio Costa, per presentare al Ministero un progetto di consorzio fra i produttori di zolfo siciliani; Flaminio Salvo è accompagnato dalla figlia Dianella, per la quale, perseverando nei suoi disegni di alleanze matrimoniali, vorrebbe combinare le nozze con Lando Laurentano (figlio del principe Ippolito), che risiede a Roma impegnato nella causa socialista. Respinto dal Ministero il progetto di consorzio, Aurelio Costa è rimandato a Girgenti per placare l’animo degli zolfatari «inferociti dalla fame per la chiusura delle zolfare»; nel viaggio di ritorno l’accompagna Nicoletta Capolino. Il viaggio si trasforma in una fuga d’amore fra i due giovani. Giunto in Sicilia, Costa, seguito da Nicoletta, si reca ad Aragona per parlamentare con gli zolfatari delle miniere, ma questi, sobillati da un provocatore, assalgono la carrozza dell’ingegnere, lo uccidono insieme con l’amante e ne bruciano i corpi. Alla notizia della morte di Costa, Dianella Salvo, che ne era innamorata, impazzisce. Intanto tutta la Sicilia è in tumulto. Il principe Lando Laurentano lascia Roma e si reca a Palermo, per seguire da vicino gli eventi rivoluzionari. Il governo decreta lo stato d’assedio in Sicilia e procede ad arresti in massa degli esponenti socialisti e degli aderenti ai Fasci. Lando, con alcuni compagni, fugge da Palermo e si dirige verso Porto Empedocle, dove intende imbarcarsi per espatriare. Sulla strada della fuga raggiunge Valsania, il feudo di famiglia dove vive estraniato, in filosofico distacco dal mondo, lo zio don Cosmo Laurentano. Vittima di un’estrema illusione sarà, a conclusione del romanzo, Mauro Mortara, antico garibaldino settantasettenne, uomo di fiducia di don Cosmo Laurentano. Mortara, turbato dalla ribellione dei Fasci che disonora la Sicilia, sconvolgendo l’unità nazionale e disfacendo «l’opera dei vecchi», corre armato, con il petto fregiato di medaglie garibaldine, a unirsi ai soldati inviati a reprimere la rivolta, ma, scambiato per un rivoltoso, viene ucciso dai militari. Con la morte di Mauro Mortara, l’Italia unita, uccidendo il suo passato risorgimentale, sembra aver rinnegato se stessa.
Il romanzo è ambientato in Sicilia durante i sanguinosi moti dei “Fasci” del 1893, in cui emergono con forza le divisioni di classe, da una parte i clericali, tesi ad impedire il consolidamento del nuovo regime liberale, dall’altra la classe dirigente, che disperde nel disordine morale i sacrifici e i meriti acquisiti e ancora a sé la classe popolare che vede dispersa l’illusione di una rigenerazione sociale. Più che casi individuali, i personaggi del romanzo interpretano i diversi aspetti della complessa situazione storica che stanno vivendo. Così il principe don Ippolito di Colimbreta, fedele suddito borbonico; don Flaminio Salvo, esponente della nuova borghesia capitalista; Roberto Auriti, glorioso garibaldino che si spegne in un’esistenza amorfa; il giovane principe Gerlando di Colimbetra, sostenitore delle nuove idee e per questo costretto all’esilio. I personaggi rappresentano un contrasto di concezioni e di ideali che si risolve nel contrasto tra due generazioni: quella che ha fatto l’Unità e che vede perduta l’eredità del Risorgimento, e quella più giovane, che nel gretto conservatorismo dei padri scorge solo la difesa di interessi reazionari.
Nel romanzo ci sono presentate tre generazioni che vivono, nel momento della loro giovinezze tre momenti cruciali della storia siciliana: prendiamo, oltre a quelli citati nella sinossi, tre esempi: don Gerlando Lauretano, uomo che ha combattuto per la libertà contro il regime borbonico; Roberto Auriti, che ha combattuto per l’unificazione nazionale; Lando Lauretano, che ha lottato per una giustizia sociale. Tre identità psicologiche mosse da un valore, un ideale, messo in crisi dalla non realizzazione dello stesso, che ha reso loro mediocri, vuoti, o cristallizzati “fuori tempo” a rimpiangere l’idea per cui aveva combattuto.
Quest’ultima è forse la figura più umoristicamente presente in questo romanzo storico:
NEL CAMERONE DEL GENERALE
Quella visita alla famosa stanza del Generale, detta per antonomasia il Camerone, era una grazia veramente particolare concessa a Dianella. Mauro Mortara, che ne teneva la chiave, non vi lasciava entrar mai nessuno. E non l’uscio soltanto, ma anche le persiane dei due terrazzini e della finestra stavano sempre chiuse, quasi che l’aria e la luce, entrandovi apertamente, potessero fugare i ricordi raccolti e custoditi con tanta gelosa venerazione. Certo, dopo la partenza del vecchio principe per l’esilio, uscio e finestre erano stati spalancati chi sa quante volte; ma il Mortara, da che era ritornato a Valsanìa, aveva tenute almeno le persiane sempre chiuse così, e aveva l’illusione che così appunto fossero rimaste da allora, sempre, e che però quelle pareti serbassero ancora il respiro del Generale, l’aria di quel tempo. Questa illusione era sostenuta dalla vista della suppellettile rimasta intatta, tranne la lettiera d’ottone a baldacchino, che non aveva più né materasse, né tavole, né l’ampio parato a padiglione. Quella penombra era così propizia alla rievocazione dei lontani ricordi! Mauro, ogni volta, girava un po’ per la stanza; si fermava innanzi a questo o a quel mobile decrepito, dall’impiallacciatura gonfia e crepacchiata qua e là; poi andava a sedere sul divano imbottito d’una stoffa verde, ora ingiallita, con due rulli alla base di ciascuna testata, e lì, con gli occhi socchiusi, lisciandosi con la piccola mano tozza e vigorosa la lunga barba bianca, pensava, e più spesso ricordava, assorto, come in chiesa un divoto nella preghiera.
Non lo disturbavano neppure i topi che facevano talvolta una gazzarra indiavolata sul terrazzo di sopra, il cui piano, per impedire che il soffitto del camerone rovinasse, s’era dovuto ricoprire di lastre di bandone. Il rimedio era giovato poco e per poco tempo; le lastre di bandone s’erano staccate e accartocciate al sole, con molta soddisfazione dei topi che, rincorrendosi, vi s’appiattavano; e il soffitto già s’era aggobbato, gocciava d’inverno per due o tre stillicidii, e le pareti serbavano, anche d’estate, due larghe chiose d’umido, grommose di muffa. Don Cosmo non se ne dava pensiero: non entrava quasi mai nel camerone; Mauro non voleva che si riattasse: poco più gli restava da vivere e voleva che tutto lì rimanesse com’era; sapeva che, morto lui, nessuno si sarebbe preso più cura di custodire quel “santuario della libertà”; e il soffitto allora poteva anche crollare o essere riattato. Intanto, ogni anno, al sopravvenire dell’autunno, egli si recava sul terrazzo a rassettare e fissar le lastre di bandone con grosse pietre, e sul pavimento del camerone collocava concole e concoline sotto gli stillicidii. Le gocce vi piombavan sonore, ad una ad una; e quel tin-tan cadenzato pareva gli conciliasse il raccoglimento.
Dianella, entrando, ebbe subito come un urto dalla vista inattesa d’una belva imbalsamata che, nella penombra, pareva viva, là, nella parete di fronte, presso l’angolo, con la coda bassa e la testa volta da un lato, felinamente.
«Che paura!» esclamò, levando le mani verso il volto e sorridendo d’un riso nervoso. «Non me l’aspettavo… Che è?»
«Leopardo.»
«Bello!»
E Dianella abbassò una mano a carezzare quel pelame variegato; ma subito la ritrasse tutta impolverata, e notò che alla belva mancava uno degli occhi di vetro, il sinistro.
«Un altro, compagno a questo,» riprese Mauro «l’ho regalato al Museo dell’Istituto, a Girgenti. Non l’avete mai veduto? C’è una vetrina mia, nel Museo. Accanto al leopardo una jena, bella grossa, e, sopra un’aquila imperiale. Su la vetrina sta scritto: “Cacciati, inbalsamati e donati da Mauro Mortara.” Gnorsì. Ma venite qua, prima. Voglio farvi vedere un’altra cosa. La condusse davanti al vecchio divano sgangherato. Appese alla parete, sopra il divano, eran quattro medaglie, due d’argento, due di bronzo, fisse in una targhetta di velluto rosso ragnato e scolorito. Sopra la targhetta era una lettera, chiusa in cornice, scritta di minutissimo carattere in un foglietto cilestrino, sbiadito.
«Ah, le medaglie!» esclamò Dianella.
«No,» disse Mauro, turbato, con gli occhi chiusi. «La lettera. Leggete la lettera.»
Dianella s’accostò di più al divano e lesse prima la firma: GERLANDO LAURENTANO.
«Del Generale?»
Mauro, ancora con gli occhi chiusi, accenno di sì col capo, gravemente. E Dianella lesse:
“Amici, Le notizie di Francia, il colpo di Stato di Luigi Napoleone recheranno certamente una grave e lunga sosta al momento per la nostra santa causa e ritarderanno, chi sa fino a quando, il nostro ritorno in Sicilia. Vecchio come sono, non so né posso più sopportare il peso di questa vita d’esilio. Penso che non sarò più in grado di prestare il mio braccio alla Patria, quand’essa, meglio maturati gli eventi, ne avrà bisogno. Viene meno pertanto la ragione di trascinare così un’esistenza incresciosa a me, dannosa a’ miei figli. Voi, più giovani, questa ragione avete ancora, epperò vivete per essa e ricordatevi qualche volta con affetto del vostro Gerlando Laurentano.”
Dianella si volse a guardare il Mortara che, tutto ristretto in sé, con gli occhi ora strizzati, il volto contratto e una mano su la bocca, si sforzava di soffocare nel barbone abbatuffolato i singhiozzi irrompenti.
«Non la rileggevo piú da anni,» mormorò quando poté parlare. Tentennò a lungo la testa, poi prese a dire: «Mi fece questo tradimento. Scrisse la lettera e si vestì di tutto punto, come dovesse andare a una festa da ballo. Ero in cucina; mi chiamò. “Questa lettera a Mariano Gioéni, a La Valletta”. C’erano a La Valletta gli altri esiliati siciliani, ch’erano stati tutti qua, in questa camera, prima del Quarantotto, al tempo della cospirazione. Mi pare di vederli ancora: don Giovanni Ricci-Gramitto, il poeta; don Mariano Gioèni e suo fratello don Francesco; don Francesco De Luca; don Gerlando Bianchini; don Vincenzo Barresi: tutti qua; e io sotto a far la guardia. Basta! Portai la lettera… Come avrei potuto supporre? Quando ritornai a Burmula, lo trovai morto.
«S’era ucciso?» domandò, intimidita, Dianella.
«Col veleno,» rispose Mauro. «Non aveva fatto neanche in tempo a tirare sul letto l’altra gamba. Come era bello’ Conoscete don Ippolito? Più bello. Diritto, con un pajo d’occhi che fulminavano: un San Giorgio! Anche da vecchio, innamorava le donne. Richiuse gli occhi e a bassa voce recitò la chiusa della lettera, che sapeva a memoria: “Voi, più giovani, questa ragione avete ancora, epperò vivete per essa e ricordatevi qualche volta con affetto del vostro Gerlando Laurentano.” Vedete? E vissi io, come lui volle. E qua, sotto la lettera, che mi feci restituire da don Mariano Gioèni, ho voluto appendere, come in risposta, le mie medaglie.»

Immagine della sigla dello sceneggiato televisivo
I personaggi presenti in questo passo sono una ragazza Dianella, figlia di Flaminio Salvo, un banchiere e Mario Mortara, fedele servitore del principe Gerlando Laurentano, morto suicida dopo il fallimento dei moti quarantotteschi.
Ciò che emerge, nonostante il romanzo storico, è che ci troviamo di fronte ad un processo di straniamento: duplice è lo sguardo del narratore, da una parte il narratore che non può che cogliere il lato di piena decadenza del luogo, con i topi sul soffitto superiore, il ticchettio della pioggia che cade dalle fessure dello stesso, dal diffuso odore di muffa e polvere, dall’altro la visione “quasi religiosa” del vecchio servitore che guarda a quello stesso ambiente come luogo sacro, in cui gli oggetti fanno parte di un rito, da celebrare come fosse una messa. La lettura della lettera è ascoltata dal vecchio servitore con tale compunzone, come fosse passo evangelico. E’ evidente che dal contrasto tra ciò che è e ciò che viene nasce quel sentimento del contrario già teorizzato da Pirandello.
Ma il significato del romanzo è proprio nel finale, nelle parole di don Cosmo, fratello intellettuale di Bruno Laurentano, portavoce di Pirandello stesso:
AVER CAPITO IL GIOCO!
«Una sola cosa è triste, cari miei: aver capito il gioco! Dico il gioco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori, come realtà, ciò che poco dopo egli stesso ci scopre come una nostra illusione, deridendoci degli affanni che per essa ci siamo dati, e deridendoci anche, come avviene a me, del non averci saputo illudere, poiché fuori di queste illusioni non c’è più altra realtà…E dunque non vi lagnate! Affannatevi e tormentatevi, senza pensare che tutto questo non conclude. Se non conclude, è segno che non deve concludere, e che è vano dunque cercare una conclusione. Bisogna vivere, cioè illudersi: lasciar giocare in noi il demoniaccio beffardo finché non si sarà stancato; e pensare che tutto questo passerà… passerà…»
Sono le parole che don Cosmo pronuncia ai figli, costretti a fuggire a Malta, come il nonno, dopo il fallimento della lotta dei Fasci. Egli vedendo quasi l’inutilità dell’azione, se non tirandosi proprio fuori dalla storia, ha imparato ad estraniarsi. Essa non è che il frutto delle illusioni di cui i portatori non hanno mai visto la realizzazione, come un camera in cui si siano riversati tutte le utopie, i desideri di generazioni che le hanno viste tramontare, non realizzarsi. Questo perché la storia non conclude.

Interpretazione suggestiva del romanzo pirandelliano
Altro grande romanzo pirandelliano è I quaderni di Serafino Gubbio operatore, (uscito nel 1915 con il titolo Si gira!, poi rivisto nel 1925 con il titolo con cui è conosciuto) dove, in modo mirabile, viene amplificato il problema già toccato nelle altre sue opere, ma che qui assume nuove risonanze grazie alla presenza del tema dell’intrecciarsi tra finzione filmica e realtà. Serafino Gubbio, infatti, fa l’operatore cinematografico (è il primo romanzo sul cinema) ed il suo occhio è soprattutto quello della macchina da presa che filma una falsa realtà, che tuttavia, alla fine, diventa l’unica realtà. Il mondo cioè non sa più distinguere tra finzione e verità, ancora, quindi, tra apparenza e realtà e tutto ciò, secondo il nostro autore, è ormai molto più accentuato in un contesto industriale, dove è la macchina a dominare sull’uomo.
Il protagonista, Serafino Gubbio, è un giovane napoletano dalle velleità intellettuali frustrate, di professione operatore cinematografico. Serafino viene prima riconosciuto e poi assunto dal direttore di scena, un suo ex compagno di studi. Serafino viene coinvolto nelle riprese di un film commerciale, uno dei tanti che la nuova industria del cinema sforna per soddisfare i gusti dozzinali del pubblico, amante di storie a tinte fosche dal sapore esotico. Il film, della casa cinematografica Kosmograph, si intitolerà La donna e la tigre e avrà come protagonista Varia Nestoroff, donna-tigre divoratrice di uomini anche nella realtà. Serafino riconosce nella donna una sua vecchia conoscenza dal passato tormentato: l’attrice era stata infatti fidanzata con Giorgio Mirelli, pittore e caro amico di Serafino, ma lo aveva tradito con Aldo Nuti, fidanzato della sorella di Vera. Nuti aveva voluto dare a quest’ultimo la prova dell’infedeltà della Nestoroff: la rivelazione era stata però fatale a Mirelli, che si era suicidato dopo averli scoperti insieme. Ora Nuti, che medita vendetta, è ricomparso, facendosi assumere come attore alla Kosmograph; è armato di fucile, perché deve girare una scena di caccia grossa in cui è prevista l’uccisione di una tigre. Durante le riprese, Aldo Nuti spara alla Nestoroff invece che alla tigre, saldando così il conto; poi, per placare i suoi rimorsi, si lascia sbranare dalla belva. Serafino, quasi in trance, riprende tutta la scena impassibilmente. Portato via di peso dal set, egli consegna alla produzione un film “perfetto”, destinato a soddisfare completamente la morbosità del pubblico. Lo choc subìto lo farà però ammutolire per sempre riducendolo a un “silenzio di cosa”.

Operatori del cinematografo delle origini
STUDIO LA GENTE
Studio la gente nelle sue più ordinarie occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello che manca a me per ogni cosa ch’io faccia: la certezza che capiscano ciò che fanno.
In prima, sì, mi sembra che molti l’abbiano, dal modo come tra loro si guardano e si salutano, correndo di qua, di là, dietro alle loro faccende o ai loro capricci. Ma poi, se mi fermo a guardarli un po’ addentro negli occhi con questi miei occhi intenti e silenziosi, ecco che subito s’adombrano. Taluni anzi si smarriscono in una perplessità così inquieta, che se per poco io seguitassi a scrutarli, m’ingiurierebbero o m’aggredirebbero.
No, via, tranquilli. Mi basta questo: sapere, signori, che non è chiaro né certo neanche a voi neppur quel poco che vi viene a mano a mano determinato dalle consuetissime condizioni in cui vivete. C’è un oltre in tutto. Voi non volete o non sapete vederlo. Ma appena appena quest’oltre baleni negli occhi d’un ozioso come me, che si metta a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi turbate o irritate.
Conosco anch’io il congegno esterno, vorrei dir meccanico della vita che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Oggi, così e così; questo e quest’altro da fare; correre qua, con l’orologio alla mano, per essere in tempo là. «No, caro, grazie: non posso!» «Ah sì, davvero? Beato te! Debbo scappare…» «Alle undici, la colazione.» «Il giornale, la borsa, l’ufficio, la scuola…» «Bel tempo, peccato! Ma gli affari…» «Chi passa? Ah, un carro funebre… Un saluto, di corsa, a chi se n’è andato.» «La bottega, la fabbrica, il tribunale…».
Nessuno ha tempo o modo d’arrestarsi un momento a considerare, se quel che vede fare agli altri, quel che lui stesso fa, sia veramente ciò che sopra tutto gli convenga, ciò che gli possa dare quella certezza vera, nella quale solamente potrebbe trovar riposo. Il riposo che ci è dato dopo tanto fragore e tanta vertigine è gravato da tale stanchezza, intronato da tanto stordimento, che non ci è più possibile raccoglierci un minuto a pensare. Con una mano ci teniamo la testa, con l’altra facciamo un gesto da ubriachi.
«Svaghiamoci!»
Sì. Più faticosi e complicati del lavoro troviamo gli svaghi che ci si offrono; sicché dal riposo non otteniamo altro che un accrescimento di stanchezza.
Guardo per via le donne, come vestono, come camminano, i cappelli che portano in capo; gli uomini, le arie che hanno o che si dànno; ne ascolto i discorsi, i propositi; e in certi momenti mi sembra così impossibile credere alla realtà di quanto vedo e sento, che non potendo d’altra parte credere che tutti facciano per ischerzo, mi domando se veramente tutto questo fragoroso e vertiginoso meccanismo della vita, che di giorno in giorno sempre più si complica e s’accélera, non abbia ridotto l’umanità in tale stato di follìa, che presto proromperà frenetica a sconvolgere e a distruggere tutto. Sarebbe forse, in fin de’ conti, tanto di guadagnato. Non per altro, badiamo: per fare una volta tanto punto e daccapo.
Qua da noi non siamo ancora arrivati ad assistere allo spettacolo, che dicono frequente in America, di uomini che a mezzo d’una qualche faccenda, fra il tumulto della vita, traboccano giù, fulminati. Ma forse, Dio ajutando, ci arriveremo presto. So che tante cose si preparano. Ah, si lavora! E io – modestamente – sono uno degli impiegati a questi lavori “per lo svago”.
Sono operatore. Ma veramente, essere operatore, nel mondo in cui vivo e di cui vivo, non vuol mica dire operare.
Io non opero nulla.
Ecco qua. Colloco sul treppiedi a gambe rientranti la mia macchinetta. Uno o due apparatori, secondo le mie indicazioni, tracciano sul tappeto o su la piattaforma con una lunga pertica e un lapis turchino i limiti entro i quali gli attori debbono muoversi per tenere in fuoco la scena.
Questo si chiama segnare il campo.
Lo segnano gli altri; non io: io non faccio altro che prestare i miei occhi alla macchinetta perché possa indicare in fin dove arriva a prendere.
Apparecchiata la scena, il direttore vi dispone gli attori e suggerisce loro l’azione da svolgere.
Io domando al direttore: «Quanti metri?»
Il direttore, secondo la lunghezza della scena, mi dice approssimativamente il numero dei metri di pellicola che abbisognano, poi grida agli attori: «Attenti, si gira!»
E io mi metto a girar la manovella.
Potrei farmi l’illusione che, girando la manovella, faccia muover io quegli attori, press’a poco come un sonatore d’organetto fa la sonata girando il manubrio. Ma non mi faccio né questa né altra illusione, e sèguito a girare finché la scena non è compiuta; poi guardo nella macchinetta e annunzio al direttore: «Diciotto metri, – oppure: – trentacinque.»
E tutto è qui.
Un signore, venuto a curiosare, una volta mi domandò: «Scusi, non si è trovato ancor modo di far girare la macchinetta da sé?»
Vedo ancora la faccia di questo signore: gracile, pallida, con radi capelli biondi; occhi cilestri, arguti; barbetta a punta, gialliccia, sotto la quale si nascondeva un sorrisetto, che voleva parer timido e cortese, ma era malizioso. Perché con quella domanda voleva dirmi: “Siete proprio necessari voi? Che cosa siete voi? Una mano che gira la manovella. Non si potrebbe fare a meno di questa mano? Non potreste esser soppresso, sostituito da un qualche meccanismo?».
Sorrisi e risposi: «Forse col tempo, signore. A dir il vero, la qualità precipua che si richiede in uno che faccia la mia professione è l’impassibilità di fronte all’azione che si svolge davanti alla macchina. Un meccanismo, per questo riguardo, sarebbe senza dubbio più adatto e da preferire a un uomo. Ma la difficoltà più grave, per ora, è questa: trovare un meccanismo, che possa regolare il movimento secondo l’azione che si svolge davanti alla macchina. Giacché io, caro signore, non giro sempre allo stesso modo la manovella, ma ora più presto ora più piano, secondo il bisogno. Non dubito però, che col tempo – sissignore – si arriverà a sopprimermi. La macchinetta – anche questa macchinetta, come tante altre macchinette – girerà da sé. Ma che cosa poi farà l’uomo quando tutte le macchinette gireranno da sé, questo, caro signore, resta ancora da vedere.
L’incipit del romanzo si presenta sin da subito problematico: noi non sappiamo chi egli sia: la tecnica autodiegetica ci dice che egli osserva la gente: certo non si tratta di un’attività. Ma ci dice ancora che egli la guarda con occhio straniato, la osserva come non facesse egli stesso parte di essa. E si accorge della totale alienazione delle persone, del loro correre e zigzagare senza senso. Solo dopo ci dice che egli fa l’operatore cinematografico e allora capiamo che la sua capacità straniante è determinata dal fatto che tra sé e la realtà osservata c’è un altro occhio oltre il suo. Così come in Mattia era l’occhio strabico, qui è quello della macchina che lo distanzia dalle cose, che gli permette di vedere in modo critico gli effetti della modernità.
Nell’ultima parte vi è l’intervento di un ometto, alcuni critici vi hanno voluto vedere una specie di autoritratto pirandelliano, che si pone una domanda di fondamentale valore ancora oggi: fino a quando il progresso tecnologico non toglierà all’uomo la possibilità di utilizzare la ragione per produrre nuove forme lavorative?
LO SFOGO NELLA SCRITTURA
Soddisfo, scrivendo, a un bisogno di sfogo, prepotente. Scarico la mia professionale impassibilità e mi vendico, anche; e con me vendico tanti, condannati come me a non esser altro, che una mano che gira una manovella.
Questo doveva avvenire, e questo è finalmente avvenuto!
L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di esse.
Viva la Macchina che meccanizza la vita!
Vi resta ancora, o signori, un po’ d’anima, un po’ di cuore e di mente? Date, date qua alle macchine voraci, che aspettano! Vedrete e sentirete, che prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare.
Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?
È per forza il trionfo della stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, i nostri padroni.
La macchina è fatta per agire, per muoversi, ha bisogno di ingojarsi la nostra anima, di divorar la nostra vita. E come volete che ce le ridiano, l’anima e la vita, in produzione centuplicata e continua, le macchine? Ecco qua: in pezzetti e bocconcini, tutti d’uno stampo, stupidi e precisi, da farne, a metterli sù, uno su l’altro, una piramide che potrebbe arrivare alle stelle. Ma che stelle, no, signori! Non ci credete. Neppure all’altezza d’un palo telegrafico. Un soffio li abbatte e li ròtola giù, e tal altro ingombro, non più dentro ma fuori, ce ne fa, che – Dio, vedete quante scatole, scatolette, scatolone, scatoline? – non sappiamo più dove mettere i piedi, come muovere un passo. Ecco le produzioni dell’anima nostra, le scatolette della nostra vita!
Se il lavoro è straniante e lo conduce all’impassibilità, il nostro Serafino cerca di vendicarsi nella scrittura. Essa non è registrazione del reale (com’era nell’estetica verista), ma, viceversa libero sfogo, in forma diaristica, in cui ripercorre tutto ciò che l’occhio ha registrato, tracciando impressioni, riflessioni e tutto ciò che “sposta” pirandellianamente l’attenzione dal fatto narrato.
Quindi il brano riprende un po’ la tematica della fine di quello precedente e possiamo assolutamente notare che Pirandello, contro l’estetica imperante nel momento in cui scrive tale romanzo, si scagli contro il futurismo e la sua mitizzazione delle macchine.
Il rapporto tra l’uomo è la macchina percorre tutto il romanzo, ed è normale che trovasse una situazione paradossale “umoristica” (in senso pirandelliano) all’intero romanzo:

Dziga Vertov: L’uomo con la macchina da presa (1929)
IL SILENZIO DI SERAFINO
Girare, ho girato. Ho mantenuto la parola: fino all’ultimo. Ma la vendetta che ho voluto compiere dell’obbligo che m’è fatto, come servitore d’una macchina, di dare in pasto a questa macchina la vita, sul più bello la vita ha voluto ritorcerla contro me. Sta bene. Nessuno intanto potrà negare ch’io non abbia ora raggiunto la mia perfezione.
Come operatore, io sono ora, veramente, perfetto.
Dopo circa un mese dal fatto atrocissimo, di cui ancora si parla da per tutto, conchiudo queste mie note.
Una penna e un pezzo di carta: non mi resta più altro mezzo per comunicare con gli uomini. Ho perduto la voce; sono rimasto muto per sempre. In una parte di queste mie note sta scritto: “Soffro di questo mio silenzio, in cui tutti entrano come in un luogo di sicura ospitalità. Vorrei ora che il mio silenzio si chiudesse del tutto intorno a me”. Ecco, s’è chiuso. Non potrei meglio di così impostarmi servitore d’una macchina.
Ma ecco tutta la scena, come s’è svolta.
Quello sciagurato, la mattina appresso, si recò dal Borgalli a protestare fieramente contro il Polacco per la figura ridicola a cui questi a suo credere intendeva esporlo con quella misura di precauzione. Pretese a ogni costo che fosse revocata, dando un saggio a tutti, se occorreva, della sua ben nota valentia di tiratore. Il Polacco si scusò davanti al Borgalli dicendo d’aver preso quella misura non per poca fiducia nel coraggio o nell’occhio del Nuti, ma per prudenza, conoscendo il Nuti molto nervoso, come del resto ne dava or ora la prova con quella protesta così concitata, in luogo del doveroso, amichevole ringraziamento ch’egli s’aspettava.
«Poi,» soggiunse infelicemente, indicando me, «ecco, commendatore, c’è anche Gubbio qua, che deve entrar nella gabbia… Mi guardò con tale disprezzo quel disgraziato, che subito io scattai, rivolto a Polacco: «Ma no, caro! Non dire per me, ti prego! Tu sai bene ch’io starò a girare tranquillo, anche se vedo questo signore in bocca e tra le zampe della bestia!»
Risero gli attori accorsi ad assistere alla scena; e allora Polacco si strinse nelle spalle e si rimise, o piuttosto, finse di rimettersi. Per mia fortuna, com’ho saputo dopo, pregò segretamente Fantappiè e un altro di tenersi di nascosto armati e pronti al bisogno. Il Nuti andò nel suo camerino a vestirsi da cacciatore; io andai nel Reparto del negativo a preparare per il pasto la macchinetta. Per fortuna della Casa, tolsi là di pellicola vergine molto più che non bisognasse, a giudicare approssimativamente della durata della scena. Quando ritornai su lo spiazzo ingombro, in mezzo del gabbione enorme iscenato da bosco, l’altra gabbia, con la tigre dentro, era già stata trasportata e accostata per modo che le due gabbie s’inserivano l’una nell’altra. Non c’era che da tirar sù lo sportello della gabbia più piccola.
Moltissimi attori delle quattro compagnie s’erano disposti di qua e di là, da presso, per poter vedere dentro la gabbia di fra i tronchi e le fronde che nascondevano le sbarre. Sperai per un momento che la Nestoroff, ottenuto l’intento che s’era proposto, avesse avuto almeno la prudenza di non venire. Ma eccola là, purtroppo. Si teneva fuori della ressa, discosta, in disparte, con Carlo Ferro, vestita di verde gajo, e sorrideva chinando frequentemente il capo alle parole che il Ferro le diceva, benché dall’atteggiamento fosco con cui il Ferro le stava accanto apparisse chiaro che a quelle parole ella non avrebbe dovuto rispondere con quel sorriso. Ma era per gli altri, quel sorriso, per tutti coloro che stavano a guardarla, e fu anche per me, più vivo, quando la fissai; e mi disse ancora una volta che non temeva di nulla, perché quale fosse per lei il maggior male io lo sapevo: ella lo aveva accanto – eccolo là – il Ferro; era la sua condanna, e fino all’ultimo con quel sorriso voleva assaporarlo nelle parole villane, ch’egli forse in quel punto le diceva.
Distogliendo gli occhi da lei, cercai quelli del Nuti. Erano torbidi. Evidentemente anche lui aveva scorto la Nestoroff là in distanza; ma volle finger di no. Tutto il viso gli s’era come stirato. Si sforzava di sorridere, ma sorrideva con le sole labbra, appena, nervosamente, alle parole che qualcuno gli rivolgeva. Il berretto di velluto nero in capo, dalla lunga visiera, la giubba rossa, una tromba da caccia, d’ottone, a tracolla, i calzoni bianchi, di pelle, aderenti alle cosce, gli stivali con gli sproni, il fucile in mano: ecco, era pronto.

Storyboard di Giampaolo Filomeno per un racconto visuale
Fu sollevato di qua lo sportello del gabbione, per cui dovevamo introdurci io e lui; a facilitarci la salita, due apparatori accostarono uno sgabello a due gradi. S’introdusse prima lui, poi io. Mentre disponevo la macchina sul treppiedi, che m’era stato porto attraverso lo sportello, notai che il Nuti prima s’inginocchiò nel punto segnato per il suo appostamento, poi si alzò e andò a scostare un po’ in una parte del gabbione le fronde, come per aprirvi uno spiraglio. Io solo avrei potuto domandargli: «Perché?»
Ma la disposizione d’animo stabilitasi tra noi non ammetteva che ci scambiassimo in quel punto neppure una parola. Quell’atto poi poteva essere da me interpretato in più modi, che m’avrebbero tenuto incerto in un momento che la certezza più sicura e precisa m’era necessaria. E allora fu per me come se il Nuti non si fosse proprio mosso; non solo non pensai più a quel suo atto, ma fu proprio come se io non lo avessi affatto notato.
Egli si riappostò al punto segnato, imbracciando il fucile; io dissi: «Pronti.» S’udì dall’altra gabbia il rumore dello sportello che s’alzava. Polacco, forse vedendo la belva muoversi per entrare attraverso lo sportello alzato, gridò nel silenzio: «Attenti, si gira!»
E io mi misi a girare la manovella, con gli occhi ai tronchi in fondo, da cui già spuntava la testa della belva, bassa, come protesa a spiare in agguato; vidi quella testa piano ritrarsi indietro, le due zampe davanti restar ferme, unite, e quelle di dietro a poco a poco silenziosamente raccogliersi e la schiena tendersi ad arco per spiccare il salto. La mia mano obbediva impassibile alla misura che io imponevo al movimento, più presto, più piano, pianissimo, come se la volontà mi fosse scesa – ferma, lucida, inflessibile – nel polso, e da qui governasse lei sola, lasciandomi libero il cervello di pensare, il cuore di sentire; così che seguitò la mano a obbedire anche quando con terrore io vidi il Nuti distrarre dalla belva la mira e volgere lentamente la punta del fucile là dove poc’anzi aveva aperto tra le frondi lo spiraglio, e sparare, e la tigre subito dopo lanciarsi su lui e con lui mescolarsi, sotto gli occhi miei, in un orribile groviglio. Più forti delle grida altissime levate da tutti gli attori fuori della gabbia accorrenti istintivamente verso la Nestoroff caduta al colpo, più forti degli urli di Carlo Ferro, io udivo qua nella gabbia il sordo ruglio della belva e l’affanno orrendo dell’uomo che s’era abbandonato alle zanne, agli artigli di quella, che gli squarciavano la gola e il petto; udivo, udivo, seguitavo a udire su quel ruglio, su quell’affanno là, il ticchettìo continuo della macchinetta, di cui la mia mano, sola, da sé, ancora, seguitava a girare la manovella; e m’aspettavo che la belva ora si sarebbe lanciata addosso a me, atterrato quello; e gli attimi di quell’attesa mi parevano eterni e mi pareva che per l’eternità io li scandissi girando, girando ancora la manovella, senza poterne fare a meno, quando un braccio alla fine s’introdusse tra le sbarre armato di rivoltella e tirò un colpo a bruciapelo in un’orecchia della tigre sul Nuti già sbranato; e io fui tratto indietro, strappato dalla gabbia con la manovella della macchinetta così serrata nel pugno, che non fu possibile in prima strapparmela.
Non gemevo, non gridavo: la voce, dal terrore, mi s’era spenta in gola, per sempre.
Ecco. Ho reso alla Casa un servizio che frutterà tesori. Appena ho potuto, alla gente che mi stava attorno atterrita, ho prima significato con cenni, poi per iscritto, che fosse ben custodita la macchina, che a stento m’era stata strappata dalla mano: aveva in corpo quella macchina la vita d’un uomo; gliel’avevo data da mangiare fino all’ultimo, fino al punto che quel braccio s’era proteso a uccidere la tigre. Tesori si sarebbero cavati da quel film, col chiasso enorme e la curiosità morbosa, che la volgare atrocità del dramma di quei due uccisi avrebbe suscitato da per tutto.
Ah, che dovesse toccarmi di dare in pasto anche materialmente la vita d’un uomo a una delle tante macchine dall’uomo inventate per sua delizia, non avrei supposto. La vita, che questa macchina s’è divorata, era naturalmente quale poteva essere in un tempo come questo, tempo di macchine; produzione stupida da un canto, pazza dall’altro, per forza, e quella più e questa un po’ meno bollate da un marchio di volgarità.
Io mi salvo, io solo, nel mio silenzio, col mio silenzio, che m’ha reso così – come il tempo vuole – perfetto. Non vuole intenderlo il mio amico Simone Pau, che sempre più s’ostina ad annegarsi nel superfluo, inquilino perpetuo d’un ospizio di mendicità. Io ho già conquistato l’agiatezza con la retribuzione che la Casa m’ha dato per il servizio che le ho reso, e sarò ricco domani con le percentuali che mi sono state assegnate sui noli del film mostruoso. È vero che non saprò che farmi di questa ricchezza; ma non lo darò a vedere a nessuno; meno che a tutti, a Simone Pau che viene ogni giorno a scrollarmi, a ingiuriarmi per smuovermi da questo mio silenzio di cosa, ormai assoluto, che lo rende furente. Vorrebbe ch’io ne piangessi, ch’io almeno con gli occhi me ne mostrassi afflitto o adirato; che gli facessi capire per segni che sono con lui, che credo anch’io che la vita è là, in quel suo superfluo. Non batto ciglio; resto a guardarlo rigido, immobile, e lo faccio scappar via su le furie. Il povero Cavalena da un altro canto studia per me trattati di patologia nervosa, mi propone punture e scosse elettriche, mi sta attorno per persuadermi a un’operazione chirurgica sulle corde vocali; e la signorina Luisetta, pentita, addolorata per la mia sciagura, nella quale vuol sentire per forza un sapor d’eroismo, timidamente mi dà ora a vedere che avrebbe caro m’uscisse, se non più dalle labbra, almeno dal cuore un sì per lei.
No, grazie. Grazie a tutti. Ora basta. Voglio restare così. Il tempo è questo; la vita è questa; e nel senso che do alla mia professione, voglio seguitare così – solo, muto e impassibile – a far l’operatore.
La scena è pronta?
«Attenti, si gira…»
Il brano ci racconta due morti per amore: quella di Vera Nestoroff per mano di Aldo Nuti e di quest’ultimo nelle fauci della tigre.
Potremmo leggerlo in una duplice chiave:
- gli esseri umani, in quanto attori, quindi in quanto forme duplicate, hanno avuto la colpa di fare entrare la vita nella rappresentazione di essa e l’hanno pagata perdendola entrambi; la tigre è la vita, è la mancanza di forma, l’unica che ha usato il suo istinto come flusso vitale di vita;
- l’umorismo: Serafino vede una scena duplicandosi; egli già sa quello che accadrà, lo ha già registrato (ce lo dice Pirandello stesso: il movimento di Aldo visto da Serafino – ma poi rimosso – e la frase Ma no, caro! Non dire per me, ti prego! Tu sai bene ch’io starò a girare tranquillo, anche se vedo questo signore in bocca e tra le zampe della bestia!, che suscita il riso tra gli altri attori). La tecnica umoristica consiste proprio nel sottolineare che Serafino, nel raccontare la scena, ci sembra sia più intenzionato a dirci il suo problema nel rimanere legato alla macchina.
Ed è proprio nel finale che si evince come il tema del romanzo, al di là di una trama piuttosto scontata, sia centrato sul rapporto uomo-macchina. Pirandello ci mostra come sia essa a dominare ormai il mondo a lui contemporaneo, trasformando Serafino in una macchina afasica il cui compito è reiterato. Il problema è che il suo metamorfizzarsi in macchina lo renderà prodotto industriale perfetto.
Ma il silenzio di Serafino non è solo di parola; se Mattia si lascia ancora un istinto di vita nel suo io, trovando pietà per il morto col suo nome, Serafino riduce se stesso al nulla, perché, molto probabilmente, dopo aver scritto queste parole, farà tacere anche il suo diario, per diventare solo una mano che gira la manovella.
Il romanzo presenta delle novità tecniche: è costituito da sette Quaderni senza titoli, divisi per capitoli. La storia è divisa pertanto per quadri, in cui le varie vicende sono filtrate dallo sguardo di Serafino che le trascrive e le analizza, le commenta, viviseziona i sentimenti ed i comportamenti altrui.
Ci si domanda come mai tanta negatività verso il cinematografo, quando Pirandello invece mostrava un certo interesse per questa nuova forma d’arte e collaborava a sceneggiature tratte dalle sue opere. La sua critica verteva nella mera commercializzazione a cui il prodotto filmico era destinato, sperando che ad esso invece, venissero offerte possibilità di sviluppo “artistico”.
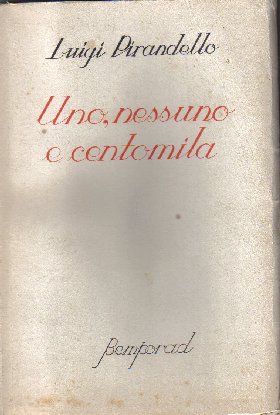
Una delle prime edizioni del romanzo
Il tema dell’essere e dell’apparire viene infine sviluppato in modo definitivo e senza più nessun ulteriore sviluppo nell’ultimo grande romanzo pirandelliano Uno, nessuno e centomila (1926) dove il protagonista Vitangelo Moscarda vive, in un lungo monologo, il dramma dell’uomo contemporaneo in quanto uno, cioè se stesso per sé; nessuno, in quanto la sua personalità viene annullata di fronte alla società ed infine centomila, come sono centomila gli sguardi che incontra e che lo giudicano differentemente uno dall’altro. Quindi, secondo le persone che incontrerà egli sarà di volta in volta ciò che gli altri vogliono che egli sia e mai ciò che veramente egli è. Tale frammentazione si riflette anche nella struttura del romanzo stesso, diviso in otto libri, suddivisi, a loro volta in sessantatré capitoletti ad indicare la scomposizione dell’io del protagonista.
Un’osservazione, di per sé abbastanza irrilevante della moglie circa la conformità del naso di Vitangelo Moscarda, inserisce in lui una serie di riflessioni a catena che metteranno in crisi il suo concetto d’identità. In primo luogo, per scrollarsi da dosso la fama d’usuraio di cui è investito, manda via una coppia di poveri da una topaia di sua proprietà che fin da suo padre non pagavano l’affitto e dona loro una casa molto bella. Se ciò getta nello stupore i suoi compaesani, non fa mutare loro l’impressione precedente: Vitangelo continua ad essere usuraio, solamente che adesso è diventato pazzo. Quando ordina ai suoi fiduciari di liquidare l’unica banca lasciatagli in eredità dal padre, gli stessi e la moglie, dopo i vani tentativi di dissuaderlo, si adoperano affinché gli venga riconosciuta l’infermità mentale. Ciò viene a conoscenza di Vitangelo da Anna Rosa, una sua amica, che in fondo gli vuole bene, ma di fronte ai ragionamenti incalzanti, preda dalle teorie che le mettono in crisi le certezze della sua esistenza, presa da raptus gli spara. Vitangelo, per difenderla, afferma che la reazione di Anna Rosa è stata determinata da una sua aggressione, da ciò ne deriva che ora, a fianco a quella d’usuraio pazzo si accompagni l’attribuzione di maniaco sessuale. Il tutto viene risolto dal vescovo che in cambio di un vero pentimento gli fa devolvere tutti i beni per un ospizio di mendicità, dove anche Vitangelo si ritira a vivere per il resto della sua vita.
L’incipit (umoristico) del romanzo:

René Magritte: La rivoluzione vietata
TUTTO COMINCIA DAL NASO
«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio.
«Niente,» le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino.
Mia moglie sorrise e disse: «Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: «Mi pende? A me? Il naso?»
E mia moglie, placidamente: «Ma sì, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra.»
Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzí come un immeritato castigo.
Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se riposavo nella certezza d’essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, come il naso mi pendeva verso destra, cosí…
«Che altro?»
Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell’altra; e altri difetti…
«Ancora?»
Eh sí, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino piú arcuata dell’altra: verso il ginocchio, un pochino.
Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento, la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi m’esortò a non affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell’uomo.
Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo “grazie” e, sicuro di non aver motivo né d’addolorarmi né d’avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant’anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe; e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi.
«Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito.»
Ecco, già – le mogli, non nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare, a ogni parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa; senza che di fuori ne paresse nulla.
«Si vede» voi dite, «che avevate molto tempo da perdere».
No, ecco. Per l’animo in cui mi trovavo. Ma del resto sí, anche per l’ozio, non nego. Ricco, due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre; il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla; tranne di prender moglie, questo sì, giovanissimo; forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo che non mi somigliasse punto; e, pover’uomo, neppur questo aveva potuto ottenere da me.
Non già, badiamo, ch’io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre m’incamminava. Tutte le prendevo. Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, e mi maravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni d’una montagna insormontabile, anzi d’un mondo in cui avrei potuto senz’altro domiciliarmi.
Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m’erano passati avanti e avevano percorso tutta la via, ne sapessero in sostanza più di me. M’erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini; ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro: il loro carro; vi erano stati attaccati con molta pazienza, e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro, io; e non avevo perciò né briglie né paraocchi; vedevo certamente più di loro; ma andare, non sapevo dove andare.
Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque – possibile? – non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente m’appartenevano: il naso le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per rifarne l’esame.
Cominciò da questo il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove in esso medesimo non avessi trovato (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene.
L’incipit del romanzo ci pone, sin da subito a varie strategie narrative messe in atto da Pirandello per quello che, da molti critici, è stato considerato un romanzo-saggio. In primo luogo il monologo con cui si presenta: il narratore non ci dice com’è il personaggio ma ce lo fa scoprire attraverso le osservazioni dello stesso davanti ad uno specchio. Tali osservazioni derivano da un’osservazione ingenua, casuale, della moglie, sul suo naso. Perché il naso? Forse perché questa parte anatomica aveva suscitato un certa rilevanza all’interno della scrittura “umoristica” del tempo, si pensi a Pinocchio o al famoso racconto Il naso di Gogol.
Leggendo poi scopriamo un “voi dite”, quando Vitangelo ci fa partecipi del suo modo, certamente ossessivo, con cui osserva le cose: è che egli dialoga per l’intero romanzo con il lettore, cooperando con lui, alla definizione del concetto d’identità.

Riduzione teatrale de “Uno, nessuno e centomila” (2005)
Ed è proprio in questo modo che inizia il secondo Libro del romanzo, in cui troviamo le “elucubrazioni” mentali di Vitangelo che analizza e filosofeggia in un dialogo col lettore:
CI FOSSE UNA SIGNORA REALTA’…
Non voglio offendervi. La vostra coscienza voi dite. Non volete che sia messa in dubbio. Me n’ero scordato, scusate. Ma riconosco, riconosco che per voi stesso, dentro di voi, non siete quale io, di fuori, vi vedo. Non per cattiva volontà. Vorrei che foste almeno persuaso di questo. Voi vi conoscete, vi sentite, vi volete in un modo che non è il mio, ma il vostro; e credete ancora una volta che il vostro sia giusto e il mio sbagliato. Sarà, non nego. Ma può il vostro modo essere il mio e viceversa?
Ecco che torniamo daccapo!
Io posso credere a tutto ciò che voi mi dite. Ci credo. Vi offro una sedia: sedete; e vediamo di metterci d’accordo.
Dopo una buona oretta di conversazione, ci siamo intesi perfettamente.
Domani mi venite con le mani in faccia, gridando:
«Ma come? Che avete inteso? Non mi avevate detto così e così?»
Così e così, perfettamente. Ma il guajo è che voi, caro, non saprete mai, né io vi potrò mai comunicare come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, no. Abbiamo usato, io e voi la stessa lingua, le stesse parole. Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole, per sé, non sono vuote? Vuote, caro mio. E voi le riempite del senso vostro, nel dirmele; e io nell’accoglierle, inevitabilmente, le riempio del senso mio. Abbiamo creduto d’intenderci; non ci siamo intesi affatto.
Eh, storia vecchia anche questa, si sa. E io non pretendo dir niente di nuovo. Solo torno a domandarvi: «Ma perché allora, santo Dio, seguitate a fare come se non si sapesse? A parlarmi di voi, se sapete che per essere per me quale siete per voi stesso, e io per voi quale sono per me, ci vorrebbe che io, dentro di me, vi déssi quella stessa realtà che voi vi date, e viceversa; e questo non è possibile?»
Ahimé, caro, per quanto facciate, voi mi darete sempre una realtà a modo vostro, anche credendo in buona fede che sia a modo mio; e sarà, non dico; magari sarà; ma un “modo mio” che io non so ne potrò mai sapere; che saprete soltanto voi che mi vedete da fuori: dunque un “modo mio” per voi, non un “modo mio” per me.
Ci fosse fuori di noi, per voi e per me, ci fosse una signora realtà mia e una signora realtà vostra, dico per se stesse, e uguali, immutabili. Non c’è. C’è in me e per me una realtà mia: quella che io mi do; una realtà vostra in voi e per voi: quella che voi vi date; le quali non saranno mai le stesse né per voi né per me.
E allora?
Allora, amico mio, bisogna consolarci con questo: che non è più vera la mia che la vostra, e che durano un momento così la vostra come la mia.
La forza pirandelliana è nella forma raziocinante con cui esclude ogni possibilità d’oggettività. Già nella “filosofia del lanternino” in Il fu Mattia Pascal, l’autore siciliano aveva illustrato il concetto relativistico del sapere: ma qui il processo della gnoseologia è portato alle estreme conseguente, negando ogni percorso conoscitivo. Con un processo con cui già Freud (ma sappiamo che Pirandello non ha letto lo psicoanalista tedesco) aveva affermato la presenza di un filtro “singolare” in ogni atto di percezione della realtà, Pirandello lo traduce nella comunicazione: se nella stessa ciò che viene detto viene “filtrato” e quindi personalizzato, è evidente che cessa l’obiettività dell’informazione, ma se tutte le informazioni sono recepite singolarmente, la verità non esiste. Allora molto probabilmente nemmeno quella di Vitangelo che si rappresenta come narratore autodiegetico (stessa operazione farà, negli stessi anni Svevo con il suo romanzo La coscienza di Zeno).
Eppure Vitangelo troverà, proprio nell’assenza di ogni parola che lo denoti, se stesso:
NON CONCLUDE
Anna Rosa doveva essere assolta; ma io credo che in parte la sua assoluzione fu anche dovuta all’ilarità che si diffuse in tutta la sala del tribunale, allorché, chiamato a fare la mia deposizione, mi videro comparire col berretto, gli zoccoli e il camiciotto turchino dell’ospizio.
Non mi sono più guardato in uno specchio, e non mi passa neppure per il capo di voler sapere che cosa sia avvenuto della mia faccia e di tutto il mio aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette apparir molto mutato e in un modo assai buffo, a giudicare dalla maraviglia e dalle risate con cui fui accolto. Eppure mi vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un significato così diverso da quello di prima, che avrebbero potuto risparmiare a quel povero svanito là, barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto turchino, la pena d’obbligarlo a voltarsi ancora a quel nome, come se realmente gli appartenesse.
Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani. Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo.
L’ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all’alba, perché ora voglio serbare lo spirito così, fresco d’alba, con tutte le cose come appena si scoprono, che sanno ancora del crudo della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. Quelle nubi d’acqua là pese plumbee ammassate sui monti lividi, che fanno parere più larga e chiara nella grana d’ombra ancora notturna, quella verde piaga di cielo. E qua questi fili d’erba, teneri d’acqua anch’essi, freschezza viva delle prode. E quell’asinello rimasto al sereno tutta la notte, che ora guarda con occhi appannati e sbruffa in questo silenzio che gli è tanto vicino e a mano a mano pare gli s’allontani cominciando, ma senza stupore a schiarirglisi attorno, con la luce che dilaga appena sulle campagne deserte e attonite. E queste carraje qua, tra siepi nere e muricce screpolate, che su lo strazio dei loro solchi ancora stanno e non vanno. E l’aria è nuova. E tutto, attimo per attimo, è com’è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni.
La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di gioja nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridío delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili aerei. Pensa alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l’ho più questo bisogno, perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.

Fotografia di Pirandello
Nell’ultimo brano del romanzo troviamo ancora presente la tecnica umoristica: l’apparizione di Vitangelo in tribunale suscita l’“avvertimento del contrario”, e quindi il riso degli astanti. Ma d’altra parte è Moscarda stesso a ridere di sé, definendosi “povero svanito là, barbuto e sorridente, con gli zoccoli e il camiciotto turchino, la pena d’obbligarlo a voltarsi ancora a quel nome, come se realmente gli appartenesse”. E’ che lui è riuscito non solo a farsi guardare senza lasciarsi condizionare dalle forme che gli altri vedono in lui, ma invece ad uscire fuori di sé per posare gli occhi a questo nuovo io, senza alcun nome, definizione o concetto che, precedentemente, lo tenevano “ingabbiato”. Egli infatti si è liberato ed è diventato “pazzo” per gli altri (il tema della pazzia come libertà è ben presente nella produzione pirandelliana). Ma la sua pazzia consiste nel non avere niente che lo definisca e partecipare in modo totale, avvincente, al ritmo biologico dell’esistere dell’universo: egli è ogni cosa che nasce e che muore nell’attimo stesso, per rinascere un momento dopo, in un ritmo incessante dell’avvicendarsi esistenziale in cui la vita “non conclude”. Non è un caso che la vicenda di Vitangelo si concluda fuori della città, in spazi liberi: solo qui egli trova se stesso: la città e quindi la modernità “ingabbia”.
Le novelle

Xilografia per il VII volume de “Novelle per un anno” realizzata da Fausto Pirandello
Pirandello scrisse novelle durante l’intera sua esistenza. Cominciò prestissimo (dal 1894, pubblicazione della prima raccolta Amore senza amori fino ad arrivare a quella postuma, pubblicata nel 1937, Una giornata) e la maggior parte di esse trovò poi distribuzione editoriale nel “Corriere della Sera”. Cominciarono poi ad essere raccolte in quindici volumi, contenenti quindici racconti ognuno e con il titolo di ognuna di esse dalla prima – con eccezione dell’ultima raccolta, il cui titolo si chiamò con l’ultima di esse. In seguito l’autore pensò di riunirle in un unico progetto editoriale che prese il titolo di Novelle per un anno, in cui intendeva scrivere trecentosessantacinque storie, una per ogni giorno, come ad accompagnare il lettore ad una rappresentazione, a volte ironica ed altre tragicomica, o ad una riflessione sulla condizione umana.
Tale progetto non venne completato: infatti riuscì a pubblicare dapprima solo tredici volumi, e, usciti postumi, altri due volumi, per un totale di 251 racconti.
Pur divisi in raccolte separate, ognuna di esse non ha un tema preciso: sembra proprio che Pirandello si sia preso gioco del lettore; prima di pubblicarle le ha scomposte e ricomposte, riscritte, mescolate per offrire al lettore il caos dell’esistenza umana.
Se sul piano formale esse non sono precedute o inserite da nessuna prefazione o cornice che sia, sul piano tematico esse non presentano novità: i temi dell’alienazione del vivere contemporaneo, della frattura tra forma e vita, della imprevedibilità del caso erano stati già trattati precedentemente, ma qui, nella singolarità di una breve vicenda, vengono sottolineati con maggiore evidenza e capacità illustrativa.
Soltanto le ultime novelle, raccolte poi postume, disegnano un’evoluzione (come d’altra parte vedremo nel teatro) verso le forme, allora presenti, dell’avanguardia espressionista e surrealista.
LA GIARA

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nell’episodio La giara del film Kaos dei fratelli Taviani
Piena anche per gli olivi quell’annata. Piante massaje, cariche l’anno avanti, avevano raffermato tutte, a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire.
Lo Zirafa, che ne aveva un bel giro nel suo podere delle Quote a Primosole, prevedendo che le cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contener tutto l’olio della nuova raccolta, ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace a Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricavano: alta a petto d’uomo, bella panciuta e maestosa, che fosse delle altre cinque la badessa.
Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciajo di là per questa giara. E con chi non l’attaccava Don Lollò Zirafa? Per ogni nonnulla, anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca di paglia, gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti. Così, a furia di carta bollata e d’onorarii agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti, s’era mezzo rovinato.
Dicevano che il suo consulente legale, stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la settimana, per levarselo di torno, gli aveva regalato un libricino come quelli da messa: il codice, perché ci si scapasse a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che voleva intentare.
Prima, tutti coloro con cui aveva da dire, per prenderlo in giro gli gridavano: «Sellate la mula!» Ora, invece: «Consultate il calepino!»
E Don Lollò rispondeva: «Sicuro, e vi fulmino tutti, figli d’un cane!»
Quella bella giara nuova, pagata quattr’onze ballanti e sonanti, in attesa del posto da trovarle in cantina, fu allogata provvisoriamente nel palmento. Una giara così non s’era mai veduta. Allogata in quell’antro intanfato di mosto e di quell’odore acre e crudo che cova nei luoghi senz’aria e senza luce, faceva pena.
Da due giorni era cominciata l’abbacchiatura delle olive, e Don Lollò era su tutte le furie perché, tra gli abbacchiatori e i mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi su la costa per la favata della nuova stagione, non sapeva più come spartirsi, a chi badar prima. E bestemmiava come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli, se un’oliva, che fosse un’oliva, gli fosse mancata, quasi le avesse prima contate tutte a una a una sugli alberi; o se non fosse ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri. Col cappellaccio bianco, in maniche di camicia, spettorato, affocato in volto e tutto sgocciolante di sudore, correva di qua e di là, girando gli occhi lupigni e stropicciandosi con rabbia le guance rase, su cui la barba prepotente rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasojo.
Ora, alla fine della terza giornata, tre dei contadini che avevano abbacchiato, entrando nel palmento per deporvi le scale e le canne, restarono alla vista della bella giara nuova, spaccata in due, come se qualcuno, con un taglio netto, prendendo tutta l’ampiezza della pancia, ne avesse staccato tutto il lembo davanti.
«Guardate! Guardate!»
«Chi sarà stato?»
«Oh, mamma mia! E chi lo sente ora Don Lollò? La giara nuova, peccato!»
Il primo, più spaurito di tutti, propose di raccostar subito la porta e andare via zitti zitti, lasciando fuori, appoggiate al muro, le scale e le canne. Ma il secondo: «Siete pazzi? Con Don Lollò? Sarebbe capace di credere che gliel’abbiamo rotta noi. Fermi qua tutti!»
Uscì davanti al palmento e, facendosi portavoce delle mani, chiamò: «Don Lollò! Ah, Don Lollòoo!»
Eccolo là sotto la costa con gli scaricatori del concime: gesticolava al solito furiosamente, dandosi di tratto in tratto con ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco. Arrivava talvolta, a forza di quelle rincalcate, a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte. Già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi del crepuscolo, e tra la pace che scendeva su la campagna con le ombre della sera e la dolce frescura, avventavano i gesti di quell’uomo sempre infuriato.
«Don Lollò! Ah, Don Lollòoo!»
Quando venne su e vide lo scempio, parve volesse impazzire. Si scagliò prima contro quei tre; ne afferrò uno per la gola e lo impiccò al muro gridando: «Sangue della Madonna, me la pagherete!»
Afferrato a sua volta dagli altri due, stravolti nelle facce terrigne e bestiali, rivolse contro se stesso la rabbia furibonda, sbatacchiò a terra il cappellaccio, si percosse le guance, pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un parente morto.
«La giara nuova! Quattr’onze di giara! Non incignata ancora!»
Voleva sapere chi gliel’avesse rotta! Possibile che si fosse rotta da sé? Qualcuno per forza doveva averla rotta, per infamità o per invidia! Ma quando? Ma come? Non gli si vedeva segno di violenza! Che fosse arrivata rotta dalla fabbrica? Ma che! Sonava come una campana!
Appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta, cominciarono ad esortarlo a calmarsi. La giara si poteva sanare. Non era poi rotta malamente. Un pezzo solo. Un bravo conciabrocche l’avrebbe rimessa su, nuova. C’era giusto Zi’ Dima Licasi, che aveva scoperto un mastice miracoloso, di cui serbava gelosamente il segreto: un mastice, che neanche il martello ci poteva, quando aveva fatto presa. Ecco, se don Lollò voleva, domani, alla punta dell’alba, Zi’ Dima Licasi sarebbe venuto lì e, in quattro e quattr’otto, la giara, meglio di prima.
Don Lollò diceva di no, a quelle esortazioni: ch’era tutto inutile; che non c’era più rimedio; ma alla fine si lasciò persuadere, e il giorno appresso, all’alba, puntuale, si presentò a Primosole Zi’ Dima Licasi con la cesta degli attrezzi dietro le spalle.
Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie e nodose, come un ceppo antico di olivo saraceno. Per cavargli una parola di bocca ci voleva l’uncino. Mutria o tristezza radicate in quel suo corpo deforme; o anche sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito d’inventore non ancora patentato. Voleva che parlassero i fatti, Zi’ Dima Licasi. Doveva poi guardarsi davanti e dietro, perché non gli rubassero il segreto.
«Fatemi vedere codesto mastice» gli disse per prima cosa Don Lollò, dopo averlo squadrato a lungo con diffidenza.
Zi’ Dima negò col capo, pieno di dignità.
«All’opera si vede.»
«Ma verrà bene?»
Zi’ Dima posò a terra la cesta; ne cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso, logoro e tutto avvoltolato; prese a svolgerlo pian piano, tra l’attenzione e la curiosità di tutti, e quando alla fine venne fuori un pajo d’occhiali col sellino e le stanghette rotte e legate con lo spago, lui sospirò e gli altri risero. Zi’ Dima non se ne curò; si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali; se li inforcò; poi si mise a esaminare con molta gravità la giara tratta sull’aja. Disse: «Verrà bene.»
«Col mastice solo però» mise per patto lo Zirafa «non mi fido. Ci voglio anche i punti.»
«Me ne vado» rispose senz’altro Zi’ Dima, rizzandosi e rimettendosi la cesta dietro le spalle.
Don Lollò lo acchiappò per un braccio.
«Dove? Messere e porco, così trattate? Ma guarda un po’ che arie da Carlomagno! Scannato miserabile e pezzo d’asino, ci devo metter olio, io, là dentro, e l’olio trasuda! Un miglio di spaccatura, col mastice solo? Ci voglio i punti. Mastice e punti. Comando io.»
Zi’ Dima chiuse gli occhi, strinse le labbra e scosse il capo. Tutti così! Gli era negato il piacere di fare un lavoro pulito, filato coscienziosamente a regola d’arte, e di dare una prova della virtù del suo mastice.
«Se la giara» disse «non suona di nuovo come una campana…»
«Non sento niente,» lo interruppe Don Lollò. «I punti! Pago mastice e punti. Quanto vi debbo dare?»
«Se col mastice solo…»
«Càzzica che testa!» esclamò lo Zirafa. «Come parlo? V’ho detto che ci voglio i punti. C’intenderemo a lavoro finito: non ho tempo da perdere con voi.»
E se ne andò a badare ai suoi uomini.
Zi’ Dima si mise all’opera gonfio d’ira e di dispetto. E l’ira e il dispetto gli crebbero ad ogni foro che praticava col trapano nella giara e nel lembo spaccato per farvi passare il fil di ferro della cucitura. Accompagnava il frullo della saettella con grugniti a mano a mano più frequenti e più forti; e il viso gli diventava più verde dalla bile e gli occhi più aguzzi e accesi di stizza. Finita quella prima operazione, scagliò con rabbia il trapano nella cesta; applicò il lembo staccato alla giara per provare se i fori erano a egual distanza e in corrispondenza tra loro, poi con le tenaglie fece del fil di ferro tanti pezzetti quanti erano i punti che doveva dare, e chiamò per ajuto uno dei contadini che abbacchiavano.
«Coraggio, Zi’ Dima!» gli disse quello, vedendogli la faccia alterata.
Zi’ Dima alzò la mano a un gesto rabbioso. Aprì la scatola di latta che conteneva il mastice, e lo levò al cielo, scotendolo, come per offrirlo a Dio, visto che gli uomini non volevano riconoscerne le virtù: poi col dito cominciò a spalmarlo tutt’in giro al lembo staccato e lungo la spaccatura; prese le tenaglie e i pezzetti di fil di ferro preparati avanti, e si cacciò dentro la pancia aperta della giara, ordinando al contadino di applicare il lembo alla giara, così come aveva fatto lui poc’anzi. Prima di cominciare a dare i punti.
«Tira!» disse dall’interno della giara al contadino. «Tira con tutta la tua forza! Vedi se si stacca più? Malanno a chi non ci crede! Picchia, picchia! Suona, sì o no, come una campana anche con me qua dentro? Va’, va’ a dirlo al tuo padrone!»
«Chi è sopra comanda, Zi’ Dima», sospirò il contadino «e chi è sotto si danna! Date i punti, date i punti.»
E Zi’ Dima si mise a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fori accanto, l’uno di qua e l’altro di là della saldatura; e con le tanaglie ne attorceva i due capi. Ci volle un’ora a passarli tutti. I sudori, giù a fontana, dentro la giara. Lavorando, si lagnava della sua mala sorte. E il contadino, di fuori, a confortarlo.
«Ora ajutami a uscirne,» disse alla fine Zi’ Dima.
Ma quanto larga di pancia, tanto quella giara era stretta di collo. Zi’ Dima, nella rabbia, non ci aveva fatto caso. Ora, prova e riprova, non trovava più il modo di uscirne. E il contadino invece di dargli ajuto, eccolo là, si torceva dalle risa. Imprigionato, imprigionato lì, nella giara da lui stesso sanata e che ora – non c’era via di mezzo – per farlo uscire, doveva essere rotta daccapo e per sempre.
Alle risa, alle grida, sopravvenne Don Lollò. Zi’ Dima, dento la giara, era come un gatto inferocito.
«Fatemi uscire!» urlava. «Corpo di Dio, voglio uscire! Subito! Datemi ajuto!
Don Lollò rimase dapprima come stordito. Non sapeva crederci.
«Ma come? Là dentro? S’è cucito là dentro?»
S’accostò alla giara e gridò al vecchio: «Ajuto? E che ajuto posso darvi io? Vecchiaccio stolido, ma come? Non dovevate prender prima le misure? Su, provate: fuori un braccio… così! e la testa… su… no, piano! Che! Giù… aspettate! Così no! Giù, giù… Ma come avete fatto? E la giara, adesso? Calma! Calma! Calma!» si mise a raccomandare tutt’intorno, come se la calma stessero per perderla gli altri e non lui. «Mi fuma la testa! Calma! Questo è caso nuovo… La mula!»
Picchiò con le nocche delle dita su la giara. Sonava davvero come una campana.
Bella! Rimessa a nuovo… Aspettate!» disse al prigioniero. «Va’ a sellarmi la mula!» ordinò al contadino; e, grattandosi con tutte le dita la fronte, seguitò a dire tra sé: «Ma vedete un po’ che mi capita! Questa non è giara! Quest’è ordigno del diavolo! Fermo! Fermo lì!»
E accorse a regger la giara, in cui Zi’ Dima, furibondo, si dibatteva come una bestia in trappola.
«Caso nuovo, caro mio, che deve risolvere l’avvocato! Io non mi fido. La mula! La mula! Vado e torno, abbiate pazienza! Nell’interesse vostro… Intanto, piano! Calma! Io mi guardo i miei. E prima di tutto, per salvare il mio diritto, faccio il mio dovere. Ecco: vi pago il lavoro, vi pago la giornata. Cinque lire. Vi bastano?»
«Non voglio nulla!» gridò Zi’ Dima. «Voglio uscire.»
«Uscirete. Ma io, intanto, vi pago. Qua, cinque lire.»
Le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella giara. Poi domandò, premuroso: «Avete fatto colazione? Pane e companatico, subito! Non ne volete? Buttatelo ai cani! A me basta che ve l’abbia dato.»
Ordinò che gli si désse; montò in sella, e via di galoppo per la città. Chi lo vide, credette che andasse a chiudersi da sé in manicomio, tanto e in così strano modo gesticolava.
Per fortuna, non gli toccò di fare anticamera nello studio dell’avvocato; ma gli toccò d’attendere un bel po’, prima che questo finisse di ridere, quando gli ebbe esposto il caso. Delle risa si stizzì.
«Che c’è da ridere, scusi? A vossignoria non brucia! La giara è mia!»
Ma quello seguitava a ridere e voleva che gli rinarrasse il caso com’era stato, per farci su altre risate. Dentro, eh? S’era cucito dentro? E lui, don Lollò che pretendeva? Te… tene… tenerlo là dentro… ah ah ah… ohi ohi ohi… tenerlo là dentro per non perderci la giara?
«Ce la devo perdere?» domandò lo Zirafa con le pugna serrate. «Il danno e lo scorno?»
«Ma sapete come si chiama questo?» gli disse infine l’avvocato. «Si chiama sequestro di persona!»
«Sequestro? E chi l’ha sequestrato?» esclamò lo Zirafa. «Si è sequestrato lui da sé! Che colpa ne ho io?»
L’avvocato allora gli spiegò che erano due casi. Da un canto, lui, Don Lollò, doveva subito liberare il prigioniero per non rispondere di sequestro di persona; dall’altro il conciabrocche doveva rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua imperizia o con la sua storditaggine.
«Ah!» rifiatò lo Zirafa. «Pagandomi la giara!»
«Piano!» osservò l’avvocato. «Non come se fosse nuova, badiamo!»
«E perché?»
«Ma perché era rotta, oh bella!»
«Rotta? Nossignore. Ora è sana. Meglio che sana, lo dice lui stesso! E se ora torno a romperla, non potrò più farla risanare. Giara perduta, signor avvocato!»
L’avvocato gli assicurò che se ne sarebbe tenuto conto, facendogliela pagare per quanto valeva nello stato in cui era adesso.
«Anzi,» gli consigliò «fatela stimare avanti da lui stesso.»
«Bacio le mani» disse Don Lollò, andando via di corsa.
Di ritorno, verso sera, trovò tutti i contadini in festa attorno alla giara abitata. Partecipava alla festa anche il cane di guardia, saltando e abbajando. Zi’ Dima s’era calmato, non solo, ma aveva preso gusto anche lui alla sua bizzarra avventura e ne rideva con la gajezza mala dei tristi. Lo Zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la giara.
«Ah! Ci stai bene?»
«Benone. Al fresco» rispose quello. «Meglio che a casa mia.»
«Piacere. Intanto ti avverto che questa giara mi costò quattr’onze nuova. Quanto credi che possa costare adesso?»
«Con me qua dentro?» domandò Zi’ Dima.
I villani risero.
«Silenzio!» gridò lo Zirafa. «Delle due l’una: o il tuo mastice serve a qualche cosa, o non serve a nulla: se non serve a nulla tu sei un imbroglione; se serve a qualche cosa, la giara, così com’è, deve avere il suo prezzo. Che prezzo? Stimala tu.»
Zi’ Dima rimase un pezzo a riflettere, poi disse: «Rispondo. Se lei me l’avesse fatta conciare col mastice solo, com’io volevo, io, prima di tutto, non mi troverei qua dentro, e la giara avrebbe su per giù lo stesso prezzo di prima. Così conciata con questi puntacci, che ho dovuto darle per forza di qua dentro, che prezzo potrà avere? Un terzo di quanto valeva, sì e no.» «Un terzo?» domandò lo Zirafa. «Un’onza e trentatré?»
«Meno sì, più no.»
«Ebbene,» disse Don Lollò. «Passi la tua parola, e dammi un’onza e trentatré.»
«Che?» fece Zi’ Dima, come se non avesse inteso.
«Rompo la giara per farti uscire,» rispose Don Lollò «e tu, dice l’avvocato, me la paghi per quanto l’hai stimata: un’onza e trentatré.»
«Io pagare?» sghignazzò Zi’ Dima. «Vossignoria scherza! Qua dentro ci faccio i vermi.»
E, tratta di tasca con qualche stento la pipetta intartarita, l’accese e si mise a fumare, cacciando il fumo per il collo della giara.
Don Lollò ci restò brutto. Quest’altro caso, che Zi’ Dima ora non volesse più uscire dalla giara, né lui né l’avvocato l’avevano previsto. E come si risolveva adesso? Fu lì lì per ordinare di nuovo: “La mula”, ma pensò che era già sera.
«Ah, sì» disse. «Tu vuoi domiciliare nella mia giara? Testimoni tutti qua! Non vuole uscirne lui, per non pagarla; io sono pronto a romperla! Intanto, poiché vuole stare lì, domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce l’uso della giara.
Zi’ Dima cacciò prima fuori un’altra boccata di fumo, poi rispose placido: «Nossignore. Non voglio impedirle niente, io. Sto forse qua per piacere? Mi faccia uscire, e me ne vado volentieri. Pagare… neanche per ischerzo, vossignoria!»
Don Lollò, in un impeto di rabbia, alzò un piede per avventare un calcio alla giara; ma si trattenne; la abbrancò invece con ambo le mani e la scrollò tutta, fremendo.
«Vede che mastice?» gli disse Zi’ Dima.
«Pezzo da galera!» ruggì allora lo Zirafa. «Chi l’ha fatto il male, io o tu? E devo pagarlo io? Muori di fame là dentro! Vediamo chi la vince!»
E se ne andò, non pensando alle cinque lire che gli aveva buttate la mattina dentro la giara. Con esse, per cominciare, Zi’ Dima pensò di far festa quella sera coi contadini che, avendo fatto tardi per quello strano accidente, rimanevano a passare la notte in campagna, all’aperto, su l’aja. Uno andò a far le spese in una taverna lì presso. A farlo apposta, c’era una luna che pareva fosse raggiornato.
A una cert’ora Don Lollò, andato a dormire, fu svegliato da un baccano d’inferno.
S’affacciò a un balcone della cascina, e vide su l’aja, sotto la luna, tanti diavoli; i contadini ubriachi che, presisi per mano, ballavano attorno alla giara. Zi’ Dima, là dentro, cantava a squarciagola.
Questa volta non poté più reggere, Don Lollò: si precipitò come un toro infuriato e, prima che quelli avessero tempo di pararlo, con uno spintone mandò a rotolare la giara giù per la costa. Rotolando, accompagnata dalle risa degli ubriachi, la giara andò a spaccarsi contro un olivo.
E la vinse Zi’ Dima.
A leggerla superficialmente si potrebbe pensarla come una novella d’ambientazione veristica, d’ambiente siciliano, in cui Pirandello, come il suo conterraneo Verga, avesse voluto rappresentare, seppure in modo comico, l’attaccamento alla roba di Don Lollò e come tale mondo, grazie a Zi’ Dima, venga sopraffatto.
Ma la novella è propriamente pirandelliana: i due coprotagonisti rappresentano proprio due mondi e due modi di vedere una stessa realtà; qualche critico ha voluto vedere nell’uomo dentro la giara, l’uomo alienato dentro i meccanismi alienanti della forma, mentre l’esterno di essa la vita; altri ancora, con una lettura di tipo sociale, la rivolta del mondo subalterno contro l’arroganza del potere.
La piacevolezza della novella è dovuta alla rappresentazione dell’ambiente contadino siciliano nel momento dell’abbacchiatura delle olive, in autunno e, soprattutto, alla descrizione di uno dei due personaggi principali, Don Lollò Zirafa, iracondo e litigioso, sempre pronto a ricorrere al codice civile o all’avvocato per risolvere ogni problema. Alla personalità maniacale di Don Lollò si contrappone il carattere chiuso, taciturno e cupo del conciabrocche, anch’egli per certi versi maniaco, torturato dalla scarsa fiducia che gli altri ripongono nel suo mastice. Nella novella compare anche un personaggio corale, collettivo, quello dei contadini, rappresentati non tanto nella fatica del lavoro, quanto nella gioia dei momenti di festa, allietati da un bellissimo paesaggio.
CIÁULA SCOPRE LA LUNA

Scultura ad Aragona che richiama la novella pirandelliana
I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senza aver finito d’estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s’affierò contr’essi, con la rivoltella in pugno, davanti la buca della Cace, per impedire che ne uscissero.
«Corpo di… sangue di… indietro tutti, giú tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue fino all’alba, o faccio fuoco!»
«Bum!» fece uno dal fondo della buca. «Bum!» echeggiarono parecchi altri; e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesú, che spavento! Gli si scagliò addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: «Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giú tutti alle cave, o faccio un macello!»
Zi’ Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com’era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il suo caruso.
Quegli altri… eccoli là, s’allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini; ridevano e gridavano: «Ecco, sì! tienti forte codesto, Cacciagallì! Te lo riempirà lui il calcherone per domani!»
«Gioventù!» sospirò con uno squallido sorriso d’indulgenza zi’ Scarda a Cacciagallina. E, ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore, e rimase così per un pezzo, come in attesa.
Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava della gioventù di quei compagni là?
Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal bujo crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, sforacchiate dalle solfare, come da tanti enormi formicai.
Ma no: zi’ Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una smorfia a Cacciagallina. Quello era il versaccio solito, con cui, non senza stento, si deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto gli colava dall’altro occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappar via neppure una.
Poco: una goccia di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più metri sotterra, col piccone in mano, che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, zi’ Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè.
Un gusto e un riposo.
Quando si sentiva l’occhio pieno, posava per un poco il piccone e, guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia, che alluciava nella tenebra dell’antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o l’acciajo del palo o della piccozza, piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti.
Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua lagrima.
Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute anche quelle del pianto, zi’ Scarda, quando, quattr’anni addietro gli era morto l’unico figliuolo, per lo scoppio d’una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre; ed egli la riconosceva subito: scoteva il capo, allora, e mormorava un nome: «Calicchio…»
In considerazione di Calicchio morto, e anche dell’occhio perduto per lo scoppio della stessa mina lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane; ma ogni sabato sera, la paga gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una carità che gli facessero: tanto che, intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: «Dio gliene renda merito.»
Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene.
Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata, zi’ Scarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese, ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui; poi si volse attorno a chiamare il suo caruso, che aveva più di trent’anni (e poteva averne anche sette o settanta, scemo com’era); e lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate: «Te’, pa’! te’, pa’!»
Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era stata forse una camicia: l’unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, un panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino (ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia, che a posarlo per terra stava ritto). Con somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore a’ suoi meriti: una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell’ammirazione, gli si accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio, gridandogli: «Quanto sei bello!» egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i calzoni, che avevano più d’una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi; s’avvolgeva in un cappottello d’albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia – cràh! cràh! – (per cui lo avevano soprannominato Ciàula), s’avviava al paese.
«Cràh! Cràh», rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone; e gli si presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato.
«Va’, va’ a rispogliarti,» gli disse zi’ Scarda. «Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il Signore non fa notte.»
Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete; poi si poggiò le mani su le reni e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e disse: «Gna bonu!» (Va bene).
E andò a levarsi il panciotto. Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non sarebbe stato niente, perché, laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma questo per zi’ Scarda.
Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco su la fronte, e schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, col fiato mòzzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi in un gemito di strozzato, rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato; poi col respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un poco e, senza che n’avesse chiara coscienza, se ne sentiva confortare.
Cosa strana; della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte, Ciàula non aveva paura; né paura delle ombre mostruose, che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno stagno d’acqua sulfurea: sapeva sempre dov’era; toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno.
Aveva paura, invece, del buio vano della notte.
Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall’imbuto della scala, per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolío di cornacchia strozzata. Ma il buio della notte non lo conosceva.
Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi’ Scarda; e là, appena finito d’ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane; e invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza; cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta dell’alba, soleva riscuoterlo un noto piede.
La paura che egli aveva del buio della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di zi’ Scarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciati dallo scoppio della mina, e zi’ Scarda stesso era stato preso in un occhio.
Giù, nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando s’era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio; egli solo, Ciàula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui.
Nella furia di cacciarsi là, gli s’era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta, e quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall’antro nel silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala; ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, invece, nell’uscir dalla buca nella notte nera, vana.
S’era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichío infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce.
Il bujo, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in tale subbuglio l’anima smarrita, che Ciàula s’era all’improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno lo avesse inseguito.
Ora, ritornato giù nella buca con zi’ Scarda, mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto, egli sentiva a mano a mano crescersi lo sgomento per quel bujo che avrebbe trovato, sbucando dalla zolfara. E più per quello, che per questo delle gallerie e della scala, rigovernava attentamente la lumierina di terracotta.
Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa, che non posava mai, né giorno né notte. E nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi s’intercalava il ruglio sordo di zi’ Scarda, come se il vecchio si facesse ajutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana.
Alla fine il carico fu pronto, e zi’ Scarda ajutò Ciàula a disporlo e rammontarlo sul sacco attorto dietro la nuca.
A mano a mano che zi’ Scarda caricava, Ciàula sentiva piegarsi, sotto, le gambe. Una, a un certo punto, prese a tremargli convulsamente così forte che, temendo di non più reggere al peso, con quel tremitio, Ciàula gridò: «Basta! Basta!»
«Che basta, carogna!» gli rispose zi’ Scarda. E seguitò a caricare.
Per un momento la paura del bujo della notte fu vinta dalla costernazione che, così caricato, e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva lavorato senza pietà per tutto il giorno. Non aveva mai pensato Ciàula che si potesse aver pietà del suo corpo, e non ci pensava neppur ora; ma sentiva che, proprio, non ne poteva più.
Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d’equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso, quando sarebbe cominciata la salita?
Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del bujo della notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato.
Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori.
La scala era cosí erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la buca che vaneggiava in alto.
Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca, che lassú lassú si apriva come un occhio chiaro, d’una deliziosa chiarità d’argento.
Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaría cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato.
Possibile?
Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento.
Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna.
Sí, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è data mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna?
Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva.
Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola, eccola là, la Luna… C’era la Luna! La Luna!
E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore.
Insieme con La giara, anche in questa novella Pirandello si mette in relazione con l’altro grande scrittore siciliano. Rosso Malpelo e Ciàula scopre la luna hanno la stessa ambientazione, le miniere, conosciute da Pirandello sia a livello letterario (con la lettura sia di Verga che del francese Zola) sia a livello personale, avendo assistito alla loro produzione grazie all’attività paterna e a quella di lui stesso per un breve periodo.
Osservando con più attenzione il testo, possiamo dividerlo in tre sequenze:
- nella prima il testo si presenta sotto forma naturalistica: il lavoro della maniera, gli operai, le violenze e i soprusi, la vigoria dei giovani, la rassegnazione del vecchio. Quest’ultimo potrebbe richiamare il Mastro Misciu verghiano, con la sua rassegnazione dettata dall’esigenza economica. Tale sequenza termina con il ghigno del vecchio, descritto in un’espressione propriamente espressionistica, che ne mette in rilievo quasi l’osservazione “umoristica” del vecchio verso il padrone, di cui si sottolinea il gesto grottesco.
- nella seconda è presente la descrizione, i giovani baldanzosi dediti al vizio del fumo e del vino e lo sguardo di Zi’ Scarda: anche qui il ritratto si riveste di elementi simbolici. L’occhio del narratore infatti indugia sulla lacrima che solca il viso rugoso e dà al palato un sapore acre. Essa è versata per il figlio morto in maniera, che gli ha lasciato sulle spalle sette orfanelle da mantenere. Gli echi tematici verghiani sono ben presenti: Padron ‘Ntoni e Bastianazzo e capovolgendo Rosso Malpelo e Mastro Misciu. A differenziarli è la tecnica narrativa.
- La terza è occupata da Ciàula. Il caruso ha trent’anni, ma è scemo e come tutti gli scemi ha un raziocinio talmente semplice che potrebbe essere un bambino. Eppure in questa sua semplicità c’è in embrione la vita, nascosta nell’antro di una miniera, ma pronta ad esplodere. Forse la miniera rappresenta, pur nell’oscurità, il luogo protettivo, l’alveo materno in cui rannicchiarsi. La luce gli fa vedere le cose, non le teme, e poi, ne vede talmente poca, tutto il giorno in miniera. La notte gli fa paura, gli fa “scricchiolare” le gambe, lo riempie di terrore panico. Ma quando è costretto a raffrontarsi con essa, quella vita implosa entra in lui trasformandolo in essere partecipe della vastità dell’universo. Essa è chiara, con la luna che illumina, silenziosa, deificata nel suo biancore, che fa trasparire placidezza, serenità. L’epifania di essa trasforma Ciàula in essere in piena armonia col creato.
IL TRENO HA FISCHIATO

Valentina Russo: Il treno ha fischiato
Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: «Frenesia, frenesia.»
«Encefalite.»
«Infiammazione della membrana.»
«Febbre cerebrale».
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale.
«Morrà? Impazzirà?»
«Mah!»
«Morire, pare di no…»
«Ma che dice? che dice»
«Sempre la stessa cosa. Farnetica…»
Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso.
Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che poi, all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale.
Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare.
Circoscritto… sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi.
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte.
Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale.
Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo.
Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai.
Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente.
La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: «E come mai? Che hai combinato tutt’oggi?»
Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani.
«Che significa?» aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. «Ohé, Belluca!»
«Niente,» aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. «Il treno, signor Cavaliere.»
«Il treno? Che treno?»
«Ha fischiato.»
«Ma che diavolo dici?»
«Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare…»
«Il treno?»
«Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo… Si fa in un attimo, signor Cavaliere!»
Gli altri impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi.
Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo.
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti.
Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: «Si parte, si parte… Signori, per dove? per dove?»
E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite.
Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell’improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa.
Difatti io accolsi in silenzio la notizia
E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi: «Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev’essergli accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l’avrò veduto e avrò parlato con lui.
Cammin facendo verso l’ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio: “A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l’incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d’un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell’uomo è impossibile. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale dev’essere, appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima”.
Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell’uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita.
Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta; l’altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. Tutt’e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l’una con quattro, l’altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto alla madre soltanto.
Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt’e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della casa. Letti ampii, matrimoniali; ma tre.
Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch’esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta.
Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé.
Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai.
Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito.
«Magari!» diceva «Magari!»
Signori, Belluca s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva.
Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno.
Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati.
Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno.
S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte.
C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava… Firenze, Bologna, Torino, Venezia… tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria… Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari… Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita impossibile, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti… sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così… c’erano gli oceani… le foreste…
E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo.
Gli bastava!
Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva.
Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capoufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capoufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo:
«Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato…»
E’ certamente una delle novelle più famose. Forse perché, più di altre, mostra in modo lineare ed esaustivo la poetica presentata nel saggio L’umorismo.
In primo luogo il narratore è rappresentato da un vicino di casa, che, attraverso una indagine conoscitiva, prima immagina, poi viene a sapere il perché del comportamento di Belluca. A leggerlo non è solo il narratore, ma anche i colleghi di lavoro che cercano di definirlo con una terminologia medica che, chiaramente, è completamente erronea (è evidente il tramonto della pretesa scientifica di spiegare il reale per Pirandello), nonché il capoufficio che il Belluca stesso. Il modo di vedere il reale è pertanto molteplice, non unico, quindi relativo.
Il modo di presentarsi di Belluca in ufficio, giorno in cui ha avuto la sua rilevazione, non può che essere letto come “un avvertimento del contrario”, così come lo scontro tra lo stesso impiegato e il capoufficio può essere interpretato come scontro tra vita e forma.
Ad interpretare il “sentimento del contrario” non può che essere il vicino di casa, che rappresenta la riflessione, quindi la spiegazione, dello strano comportamento di Belluca. Quest’ultimo ha ricevuto, come in fondo Ciàula, la sua epifania: il fischio del treno corrisponde al suono di una vita autentica contro ad una vita non vissuta e la esprime con un linguaggio che viene definito poetico immaginoso e bislacco la lingua della letteratura contro la medica dei colleghi. In conclusione sarà essa quindi a rappresentare la vera vita: la scienza ha fallito.
LA CARRIOLA

La carriola
Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso.
Vorrei farle intendere, a quattr’occhi, che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioja, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d’una divina, cosciente follia, che per un atto mi libera e mi vendica di tutto.
Dovevo essere sicuro (e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei) che questo mio atto non fosse scoperto. Giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m’acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti.
Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima.
Sono affidati a me la vita, l’onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m’assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza; d’altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati: ho moglie e figli, che spesso non sanno essere come dovrebbero, e che perciò hanno bisogno d’esser tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa, dall’esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno più serio dell’altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d’avvocato. Guaj, dunque, se il mio segreto si scoprisse!
La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia, da qualche giorno non mi sento più sicuro. Sono costernato e inquieto. Perché, se è vero che non può parlare, mi guarda, mi guarda con tali occhi e in questi occhi è così chiaro il terrore, che temo qualcuno possa da un momento all’altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione.
Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell’atto ch’io compio, può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi, a cui la vita si sia rivelata come d’un tratto s’è rivelata a me.
Dirlo e farlo intendere, non è facile. Ci proverò.
Ritornavo, quindici giorni or sono, da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione.
Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m’opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po’ di distrazione, che la mia mente affaticata di tanto in tanto riclama. L’unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un’altra nuova.
M’ero perciò portate in treno, nella busta di cuojo, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà.
Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano; vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra. Ma io, certo, non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano.
Se non che, a poco a poco, cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m’occupava, senza che per questo, intanto, mi s’avvistasse in più lo spettacolo della campagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante.
Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla: restai, per un tempo incalcolabile, come ina sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida. Ariosa. Lo spirito mi s’era quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita, ove avvertiva appena, chi sa come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d’una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto esser sua, non qua, non ora, ma là, in quell’infinita lontananza; d’una vita remota, che forse era stata sua, non sapeva come né quando; di cui gli alitava il ricordo indistinto non d’atti, non d’aspetti, ma quasi di desiderii prima svaniti che sorti; con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori, forse, che non han potuto sbocciare; il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere, là lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce; e non era nata; nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato; anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue.
Gli occhi a poco a poco mi si chiusero, senza che me n’accorgessi, e forse seguitai nel sogno di quella vita che non era nata. Dico forse, perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all’arrivo, mi ritrovai d’un tratto in tutt’altro animo, con un senso d’atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m’apparvero come vôtati di ogni senso, eppure, per i miei occhi, d’una gravezza crudele, insopportabile.
Con quest’animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m’attendeva all’uscita, e m’avviai per ritornare a casa.
Ebbene, fu nella scala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta.
Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d’ottone, su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da’ miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia.
Spaventosamente d’un tratto mi s’impose la certezza, che l’uomo che stava davanti a quella porta, con la busta di cuojo sotto il braccio, l’uomo che abitava là in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d’un tratto d’essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell’uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto; non ero mai stato nella vita; in una vita, intendo, che potessi riconoscer mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m’appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me; come se altri me l’avesse imposta e combinata, quella figura, per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita, da cui ero sempre stato assente, atti di presenza, nei quali ora, improvvisamente, il mio spirito s’accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai! Chi lo aveva fatto così, quell’uomo che figurava me? chi lo aveva voluto così? chi così lo vestiva e lo calzava? chi lo faceva muovere e parlare così? chi gli aveva imposto tutti quei doveri uno più gravoso e odioso dall’altro? Commendatore, professore, avvocato, quell’uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevan l’opera, il consiglio, l’assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro – ero io? io? propriamente? ma quando mai? E che m’importava di tutte le brighe in cui quell’uomo stava affogato dalla mattina alla sera; di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall’assiduo scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dell’esercizio della sua professione?
Ed erano lì, dietro quella porta che recava su la targa ovale d’ottone il mio nome, erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio ch’era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell’uomo insoffribile che dovevo esser io, e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico. Mia moglie? i miei figli? Ma se non ero mai stato io, veramente, se veramente non ero io (e lo sentivo con spaventosa certezza) quell’uomo insoffribile che stava davanti alla porta; di chi era moglie quella donna, di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei, no! Di quell’uomo, di quell’uomo che il mio spirito, in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza, e anche la moglie, sì, fors’anche la moglie…
Ma i ragazzi?
Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte.
No. Non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro; attraverso questo sentimento e col senso d’atroce afa col quale m’ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell’uomo insoffribile che stava davanti alla porta.
Trassi di tasca il chiavino; aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima.
Ora la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chi sa di quanti!
Chi vive, quando vive, non si vede: vive… Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più: la subisce, la trascina. Come una cosa morta, la trascina. Perché ogni forma è una morte.
Pochissimi lo sanno; i più, quasi tutti, lottano, s’affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma; raggiuntala, credono d’aver conquistato la loro vita, e cominciano invece a morire. Non lo sanno, perché non si vedono; perché non riescono più a staccarsi da quella forma moribonda che hanno raggiunta; non si conoscono per morti e credono d’esser vivi. Solo si conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa: perché se fosse, noi non la vedremmo: la vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte, senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire.
Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto; vedo che non sono mai stato vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data, e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c’è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un’anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l’anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia: “Ma come? io, questo? io, così? ma quando mai?”. E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io; di questa forma morta, in cui sono prigioniero, e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri, che non sento miei, oppressa da brighe di cui non m’importa nulla, fatta segno di una considerazione di cui non so che farmi; forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me: cose vuote, cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare.
Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto, e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene.
Ci sono i fatti. Quando tu, comunque, hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi, dopo, negli atti compiuti; quello che hai fatto resta, come una prigione per te. E come spire e tentacoli t’avviluppano le conseguenze delle tue azioni. E ti grava attorno come un’aria densa, irrespirabile la responsabilità, che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi più liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l’hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti? Dev’essere questa, per forza. Serve così, a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitarii della facoltà di legge, ai signori clienti che m’hanno affidato la vita, l’onore, la libertà, gli averi. Serve così, e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi; ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l’atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda.
Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta, da undici anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaja.
Tra lei e me non c’erano mai stati buoni rapporti. Forse, prima, essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa; s’era messa però ad approvarla a poco a poco, con la vecchiaja; tanto che, per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua, si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: “Bravo, sì, caro: lavora; non ti muovere da lì, perché è sicuro che, finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno.”
Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su di lei la mia vendetta mi sorse, quindici giorni or sono, all’improvviso, nel vedermi guardare così.
Non le faccio male; non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, dal mio seggiolone, perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto e d’avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone; e in punta di piedi mi reco all’uscio a spiare nel corridojo, se qualcuno non sopravvenga; chiudo l’uscio a chiave, per un momentino solo; gli occhi mi sfavillano di gioja, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, d’esser pazzo, d’esser pazzo per un attimo solo, d’uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d’annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia; corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto; piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola: le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro.
Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l’uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l’austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile.
Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere – ripeto – che non è nulla; che stia tranquilla, che non mi guardi così.
Comprende, la bestia, la terribilità dell’atto che compio.
Non sarebbe nulla, se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa ch’io non posso scherzare; non le è possibile ammettere che io scherzi, per un momento solo; e seguita maledettamente a guardarmi, atterrita.
Se l’opposizione forma/vita in Belluca viene rappresentata entro i limiti angusti di una esistenza mediocre, piccolo-borghese, in cui gli affanni economici soffocano l’esplosione della vita vera e che quando questa appare viene trasformata in pazzia, ne La carriola tale esplosione non può che essere sviluppata all’interno di una minuscola partentesi, estremamente privata, che vede il protagonista chiudersi in un momento oserei dire intimo, quasi onanistico.
Per raggiungere tale atto di consapevolezza, l’autore sceglie una narrazione autodiegetica, svolta come lungo monologo, e un personaggio altoborghese.
Tale personaggio non ha nome e si racconta in un presente in cui dice al lettore le condizioni in cui è vissuto e il dover trovare una soluzione (ma non ci dice quale); quindi con un flash-back, il viaggio in treno, ci confida la crisi e la presa di coscienza di non vivere, nella terza, tornando al presente, il modo in cui risolve tale situazione.
Ciò vuol dire che il modo attraverso cui Pirandello costruisce la novella lascia il lettore in suspance: attraverso indizi egli ci fa capire il modo in cui si percepisce, ma solo alla fine svelerà il segreto.
Il dramma del protagonista lo potremmo riassumere con la massima all’interno del testo Chi vive quando vive non si vede, vive: la vita è forma è quindi cancellazione dell’io. Nel momento in cui vivo assumo tante forme quante sono le forme che gli altri vogliono che io assuma: quindi rappresenterò il mio me attraverso le forme assunte. Se si svolge una vita in cui le forme prevalgono in ogni attimo cosciente, non vivo realmente, ma vivo una non vita che, esperendola, mi sembra “normale”.
Quando il protagonista si rende conto di essere un etichetta, il paso successo è straniarsi e straniarsi da sé può viversi come dramma personale e, soprattutto, sociale.
Da qui il bisogno di nascondersi, per fare alla cagnetta la carriola: cioè la libertà (la vita) di fare un gesto infantile, quand’anche stupido ma che permetta di uscire da sé per ritrovarsi.
Stesso tema de La carriola, ma rovesciato, in quanto il protagonista esige paradossalmente la “forma” che gli altri gli hanno assegnato è La patente:
LA PATENTE

“La patente” nella straordinaria maschera di Totò
Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, curvandosi, come chi regge rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: “Ah, figlio caro!” a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere!
Non era ancora vecchio; poteva avere appena quaranta anni; ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea.
E pareva ch’egli, oltre della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli, che su la vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la magra, misera personcina.
Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte.
Il giudice D’Andrea non poteva dormire.
Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d’una di quelle stelle e tra l’occhio e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo luminoso, e vi avviava l’anima a passeggiare come un ragnetto smarrito.
Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sé una certezza su la quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo qualche seria costipazione. Costipazione d’anima, s’intende. E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare – per quel tanto che a lui toccava – la giustizia ai piccoli uomini feroci.
Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nel suo ufficio d’Istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare e di rinunciare la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese.
Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescendibile, gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo d’amministrare la giustizia; ma d’amministrarla così, su due piedi.
Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d’ajutarsi meditando la notte. Ma, neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri contrari a quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giudice istruttore; così che, la mattina dopo, anziché ajutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice istruttore.
Eppure, per la prima volta, da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice D’Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un’irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante.
Si sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi aggrottati, a un certo punto, gli si chiudevano. Con la penna in mano,, dritto sul busto, il giudice D’Andrea si metteva allora a pisolare, prima racconciandosi, poi attrappandosi come un baco infratito che non possa più fare il bozzolo.
Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo, se ridestava e gli occhi andavano lì, a quell’angolo del tavolino dove giaceva l’incartamento, voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava con le nari fischianti aria aria aria e la mandava dentro, quanto più dentro poteva, ad allargar le viscere contratte dall’esasperazione, poi la ributtava via spalancando la bocca con un versaccio di nausea, e subito si portava una mano sul naso adunco a regger le lenti, che, per il sudore, gli scivolavano. Era veramente iniquo quel processo là: iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro la quale un pover’uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C’era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due, lì in quel processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano e – sissignori – la giustizia doveva dargli torto, torto, torto, senza remissione, ribadendo così, ferocemente, l’iniquità di cui quel pover’uomo era vittima.
A passeggio, tentava di parlarne coi colleghi; ma questi, appena egli faceva il nome del Chiàrchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l’indice e il mignolo a far le corna, o s’afferravano sul panciotto i gobbetti d’argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti a mo’ di ciondoli dalla catena dell’orologio. Qualcuno, più francamente, prorompeva:
«Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto?»
Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era fatta proprio una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava per forza a parlarne, per avere un qualche lume dai colleghi – diceva – per discutere così in astratto il caso.
Perché in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello di un jettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio.
Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di jettatore? se innumerevoli testimoni potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? Come condannare, in coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi giudici?
E il D’Andrea si struggeva; si struggeva di più incontrando per via gli avvocati, nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti, l’esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello di rapina, e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo su la pancia un enorme corno comperato per l’occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di un biondo majale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa.
Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella “magnifica festa” alle spalle d’un povero disgraziato, il giudice D’Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del Chiàrchiaro per invitarlo a venire all’ufficio d’Istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrargli quattro e quattr’otto che quei due giovanotti non potevano essere condannati, secondo giustizia, e che dalla loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione.
Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno; ma anche, anzi sopra tutto, perché questo bisogno d’aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficiare, che il beneficio diventa difficilissimo. Se n’accorse bene quella volta il giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella stanza, mentr’egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: «Ma fatemi il piacere! Che storie sono queste? Vergognatevi!»
Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata, s’era insellato sul naso un pajo di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto di un barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti.
Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce:
«Lei dunque non ci crede?»
«Ma fatemi il piacere!» ripeté il giudice D’Andrea. «Non facciamo scherzi, caro Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua.»
E gli s’accostò e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il Chiàrchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: «Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è vero Dio, diventa cieco!»
Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse: «Quando sarete comodo… Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c’è una sedia, sedete.»
Il Chiàrchiaro sedette, e, facendo rotolar con le mani su le cosce la canna d’India a mo’ d’un mattarello, si mise a tentennare il capo.
«Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla jettatura?»
Il D’Andrea sedette anche lui e disse: «Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene così!»
«Nossignore,» – negò recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi non ammette scherzi. «Lei deve crederci sul serio, e deve anche dimostrarlo istruendo il processo!»
«Questo sarà un po’ difficile,» sorrise mestamente il D’Andrea. «Ma vediamo di intenderci, caro Chiàrchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto.»
«Via? porto? Che porto e che via?» domandò, aggrondato, il Chiàrchiaro.
«Né questa d’adesso,» rispose il D’Andrea, «né quella là del processo. Già l’una e l’altra, scusate, sono tra loro così…»
E il giudice D’Andrea infrontò gl’indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte.
Il Chiàrchiaro si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito.
«Non è vero niente, signor giudice!» disse, agitando quel dito.
«Come no?» esclamò il D’Andrea. «Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono jettatore, e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di jettatore e pretendete anzi ch’io creda alla vostra jettatura.»
«Sissignore.»
«E non vi pare che ci sia contraddizione?»
Il Chiàrchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione.
«Mi pare piuttosto, signor giudice,» poi disse, «che lei non capisca niente.»
Il D’Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito.
«Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente.»
«Sissignore. Eccomi qua,» disse il Chiàrchiaro, accostando la seggiola.
«Non solo le farò vedere che lei non capisce niente; ma anche che lei è un mio nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il mio bene. Il mio più acerrimo nemico! Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell’avvocato Manin Baracca?»
«Sì. Questo lo so.»
«Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto: cioè, che non solo mi ero accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, capisce, signor giudice? la mia fama di jettatore!»
«Voi? Dal Baracca?»
«Sissignore, io.»
Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai: «Capisco anche meno di prima. Ma come? Per render più sicura l’assoluzione di quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato?»
Il Chiàrchiaro ebbe un proponimento di stizza per la durezza di mente dal giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia per aria: «Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza, non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale!»
E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d’India e rimase un pezzo impostato in quell’atteggiamento grottescamente imperioso.
Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: «Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te ne fai? che te ne fai?»
«Che me ne faccio?» rimboccò pronto il Chiàrchiaro. «Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male, come la esercita, mi dica un po’, non ha dovuto prender la laurea?»
«La laurea, sì.»
«Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale.»
«E poi?»
«E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegno; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di jettatore! Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico!»
«Io?»
«Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera città!
Il giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori e allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo.
Questi lo lasciò fare.
Potremo affermare che in questa novella Pirandello abbia voluto rovesciare la prospettiva di quella de La carriola, facendo del Chiàrchiaro l’emblema di una vita a cui la forma sia necessaria. Per farlo usa la consueta tecnica, quella dell’avvertimento e del sentimento del contrario, ma qui la sviluppa partendo da lontano, caratterizzando già in modo “comico” il personaggio dell’avvocato che occupa una parte importante della narrazione: è “strano”, un cespo di capelli negroidi su un viso piccolo, una spalla più alta dell’altra; insomma è un brutto, brutti sono anche gli altri due avvocati, con lo sguardo di cavallo uno e la pelle color maiale l’altro. E’ l’estetica del brutto pirandelliana che serve ad allontanare il lettore dai personaggi presentatici.
Il giudice però, non dorme, guarda il cielo, le stelle, riesce a fluire lui sulla scia di un ritmo universale, e lui solo può capire il dramma di Chiarchiaro.
A metà novella si presenta, suscitando nell’avvocato l’“avvertimento del contrario”; soltanto capendo la motivazione della richiesta della patente, prevarrà in lui “il sentimento del contrario”. Il gesto dell’abbracciarsi finale sembra sottolineare come gli esclusi dalla vita possono “capirsi”. Infatti è il pregiudizio invalidante ad essere quasi il vero motivo della novella: la forma che ci offrono gli altri è talmente forte da non poter essere sradicata, rimossa, nonostante lo sforzo che si possa fare. Insomma, come ne La carriola anche in questa si vive secondo le costrizioni sociali, che ci riducono, tutte a torturarci, impedendo al nostro vero io d’uscire.
C’E’ QUALCUNO CHE RIDE
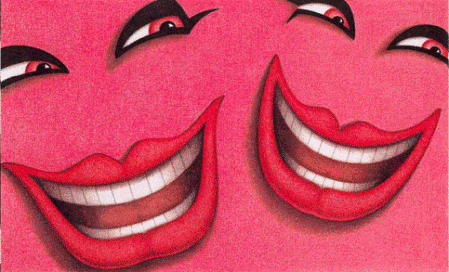
Disegno di un fondale teatrale
Serpeggia una voce in mezzo alla riunione: «C’è qualcuno che ride.»
Qua, là, dove la voce arriva, è come se si drizzi una vipera, o un grillo springhi, o sprazzi uno specchio a ferir gli occhi a tradimento.
Chi osa ridere?
Tutti si voltano di scatto a cercare in giro con occhi fulminanti.
(Il salone enorme, illuminato sopra la folla degli invitati dallo splendore di quattro grandi lampadarii di cristallo, rimane in alto, nella tetraggine della sua polverosa antichità, quasi spento e deserto; solo pare allarmata, da un capo all’altro della volta, la crosta del violento affresco secentesco che ha fatto tanto per soffocare e confondere in un nerume di notte perpetua le truculente frenesie della sua pittura; si direbbe non veda l’ora che ogni agitazione cessi anche in basso e il salone sia sgombrato.)
Qualche faccia lunga, forzata con pietoso stiracchiamento a un afflitto sorriso di compiacenza, forse, a guardar bene, si trova; ma nessuno che rida, propriamente. Ora, sorridere di compiacenza sarà lecito, sarà credo anzi doveroso, se è vero che la riunione – molto seria – vuole anche aver l’aria d’uno dei soliti trattenimenti cittadini in tempo di carnevale.
C’è difatti sulla pedana coperta da un tappeto nero un’orchestrina di calvi inteschiti che suona senza fine ballabili, e coppie ballano per dare alla riunione un’apparenza di festa da ballo, all’invito e quasi al comando di fotografi chiamati apposta. Stridono però talmente il rosso, il celeste di certi abiti femminili ed è così ribrezzosa la gracilità di certe spalle e di certe braccia nude, che quasi quasi vien fatto di pensare quei ballerini non siano stati estratti di sotterra per l’occasione, giocattoli vivi d’altro tempo, conservati e ora ricaricati artificialmente per dar questo spettacolo.
Si sente proprio il bisogno, dopo averli guardati, di attaccarsi a un che di solido e rude: ecco, per esempio, la nuca di questo vicino aggrondato che suda paonazzo e si fa vento con un fazzoletto bianchissimo; la fronte da idiota di quella vecchia signora. Strano intanto: sulla squallida tavola dei rinfreschi, i fiori non sono finti, e allora fa tanta malinconia pensare ai giardini da cui sono stati colti questa mattina sotto una pioggerella chiara che spruzzolava lieve pungente; e che peccato questa pallida rosa già disfatta che serba nelle foglie cadute un morente odore di carne incipriata.
Sperduto qua e là tra la folla, c’è anche qualche invitato in domino, che sembra un fratellone in cerca del funerale.
La verità è che tutti questi invitati non sanno la ragione dell’invito. E’ sonato in città come l’appello a un’adunata. Ora, perplessi se convenga meglio appartarsi o mettersi in mostra (che non sarebbe neanche facile tra tanta folla) l’uno osserva l’altro, e chi si vede osservato nell’atto di tirarsi indietro o di cercare di farsi avanti, appassisce e resta lì; perché sono anche in sospetto l’uno dell’altro e la diffidenza nella ressa dà smanie che a stento riescono a contenere; occhiate alle spalle s’allungano oblique che, appena scoperte, si ritraggono come serpi.
«Oh guarda, sei qua anche tu?»
«Eh, ci siamo tutti, mi pare.»
Nessuno intanto osa chiedere perché, temendo di essere lui solo ad ignorarlo, il che sarebbe colpa nel caso che la riunione sia stata indetta per prendere una grave decisione. Senza farsene accorgere, alcuni cercano con gli occhi quei due o tre che si presume debbano essere in grado di saperlo; ma non li trovano; si saranno riuniti a consulto in qualche sala segreta, dove di tanto in tanto qualcuno è chiamato e accorre impallidendo e lasciando gli altri in un ansioso sbigottimento. Si cerca di desumere dalle qualità di chi è stato chiamato e dalla sua posizione e dalle sue aderenze che cosa di là possa essere in deliberazione, e non si riesce a comprenderlo perché, poco prima, è stato chiamato un altro di qualità opposte e d’aderenze affatto contrarie.
Nella costernazione generale per questo mistero, l’orgasmo va crescendo di punto in punto. Si sa un’inquietudine come fa presto a propagarsi e come una cosa, passando di bocca in bocca, si alteri fino a diventare un’altra. Arrivano così da un capo all’altro del salone tali enormità da far restare tramortiti. E dagli animi così tutti in fermento vapora e si diffonde come un incubo, nel quale, al suono angoscioso e spasimante di quell’orchestrina, tra il brusìo confuso che stordisce e i riverberi dei lumi negli specchi, i più strani fantasmi guizzano davanti agli occhi di ciascuno, e come un fumo che trabocchi in dense volute, dalle coscienze che covano in segreto il fuoco d’inconfessati rimorsi, apprensioni traboccano e paure e sospetti d’ogni genere; in tanti la smania istintiva di correr subito a un riparo ha i più impreveduti effetti: chi sbatte gli occhi di continuo, chi guarda un vicino senza vederlo e teneramente gli sorride, chi sbottona e riabbottona senza fine un bottone del panciotto. Meglio far vista di niente. Pensare a cose aliene. La Pasqua ch’è bassa quest’anno. Uno che si chiama Buongiorno. Ma che soffocazione intanto questa commedia con noi stessi.
Il fatto (se vero) che qualcuno ride non dovrebbe far tanta impressione, mi sembra, se tutti sono in quest’animo. Ma altro che impressione! Suscita un fierissimo sdegno, e proprio perché tutti sono in quest’animo: sdegno come per un’offesa personale, che si possa avere il coraggio di ridere apertamente. L’incubo grava così insopportabile su tutti, appunto perché a nessuno par lecito ridere. Se uno si mette a ridere e gli altri seguono l’esempio, se tutto quest’incubo frana d’improvviso in una risata generale, addio ogni cosa! Bisogna che in tanta incertezza e sospensione d’animi si creda e si senta che la riunione di questa sera è molto seria.
Ma c’è poi veramente questo qualcuno che seguita a ridere, nonostante la voce che serpeggia ormai da un pezzo in mezzo alla riunione? Chi è? Dov’è? Bisogna dargli la caccia, afferrarlo per il petto, sbatterlo al muro, e, tutti coi pugni protesi, domandargli perché ride e di chi ride. Pare che non sia uno solo. Ah sì, più d’uno? Dicono che sono almeno tre. Ma come, di concerto, o ciascuno per sé? Pare di concerto tutt’e tre. Ah sì? venuti dunque col deliberato proposito di ridere? Pare.
E’ stata prima notata una ragazzona, vestita di bianco, tutta rossa in viso, prosperosa, un po’ goffa, che si buttava via dalle risa in un angolo della sala di là. Non ci s’è fatto caso in principio, sia perché donna, sia per l’età. Ha solo urtato il suono inatteso della risata e alcuni si sono voltati come per una sconvenienza, diciamo pure impertinenza, tracotanza là, se si vuole, ma perdonabile, via: un riso da bambina, del resto subito troncato, vedendosi osservata. Scappata via da quell’angolo, curva, comprimendosi, con tutte e due le mani sulla bocca, ha fatto senso – questo sì – udirla ancora ridere di là, in un prorompimento convulso, forse a causa della compressione che fuggendo s’era imposta. Bambina? Ora si viene a sapere che ha, a dir poco, sedici anni, e due occhi che schizzano fiamme. Pare che vada fuggendo da una sala all’altra, come inseguita. Sì, sì, è inseguita difatti, è inseguita da un giovinotto molto bello, biondo come lei, che ride anche lui come un pazzo inseguendola; e di tratto in tratto si ferma sbalordito dall’improntitudine di lei che si ficca da per tutto; vorrebbe darsi
un contegno ma non ci riesce; si volta di qua e di là come sentendosi chiamare, e certo si morde così le labbra per tenere a freno un impeto d’ilarità che gli gorgoglia dentro e gli fa sussultare lo stomaco. Ed ecco che ora hanno scoperto anche il terzo, un certo ometto elastico che va ballonzollando e battendo i due corti braccini sulla pancetta tonda e soda come due bacchette sul tamburo, la calvizie specchiante tra una rossa corona di capelli ricciuti e una faccia beata in cui il naso gli ride più della bocca, e gli occhi più della bocca e del naso, e gli ride il mento e gli ride la
fronte, gli ridono perfino le orecchie. In marsina come tutti gli altri. Chi l’ha invitato? Come si sono introdotti nella riunione? Nessuno li conosce. Nemmeno io. Ma so che è lui il padre di quei due ragazzi, signore agiato che vive in campagna con la figlia, mentre il figlio è agli studii qua in città. Saranno capitati a questa finta festa da ballo per combinazione. Chi sa che cosa, venendo, si saran detta tra loro, che intese e scherzi segreti si saran tra loro da tempo stabiliti, burle note soltanto a loro, polveri in serbo, colorate, da fuochi d’artificio, pronte a esplodere a un minimo incentivo, sia
pure d’uno sguardo di sfuggita: fatto si è che non possono stare insieme: si cercano però con gli occhi da lontano e, appena si sbirciano, voltano la faccia e sotto le mani sbruffano certe risate che sono veramente scandalose in mezzo a tanta serietà.
L’ossessione di questa serietà è così su tutti incombente e soffocante, che nessuno riesce a supporre che quei tre ne possano esser fuori, lontani, e possano avere in sé invece una innocente e magari sciocca ragione di ridere così di nulla; la ragazza, per esempio, solo perché ha sedici anni e perché è abituata a vivere come una puledra in mezzo a un prato fiorito, una puledra che imbizzarrisca a ogni alito d’aria e salti e corra felice, non sa lei stessa di che: si può giurare che non s’accorge di nulla, che non ha il minimo sospetto dello scandalo che sta sollevando insieme col padre e col fratello così anch’essi festanti, alieni e lontani d’ogni sospetto.
Sicché quando, riuniti alla fine tutt’e tre su di un divano della sala di là, il padre in mezzo tra il figlio e la figlia, contenti e spossati, con un gran desiderio di abbracciarsi per il divertimento che si son presi, sgorgato dalla loro stessa gioja in tutte quelle belle risate come in un fragorìo d’effimere spume, si vedono venire incontro dalle tre grandi porte vetrate, come una nera marea sotto un cielo d’improvviso incavernato, tutta la folla degli invitati, lentamente, lentamente, con melodrammatico passo di tenebrosa congiura, dapprima non capiscono nulla, non credono che quella buffa manovra possa esser fatta per loro e si scambiano un’occhiata, ancora un po’ sorridenti; il sorriso però va man mano smorendo in un crescente sbalordimento, finché, non potendo né fuggire e nemmeno indietreggiare, addossati come sono alla spalliera del divano, non più sbalorditi ma atterriti ora, levano istintivamente le mani come a parar la folla che, seguitando a procedere, s’è fatta loro sopra, terribile. I tre maggiorenti, quelli che, proprio per loro e non per altro, s’erano riuniti a consulto in una sala segreta, proprio per la voce che serpeggiava del loro riso inammissibile a cui han deliberato di dare una punizione solenne e memorabile, ecco, sono entrati dalla porta di mezzo e sono avanti a tutti, coi cappucci del domino abbassati fin sul mento e burlescamente ammanettati con tre tovaglioli, come rei da punire che vengano a implorare da loro pietà. Appena sono davanti al divano, una enorme sardonica risata di tutta la folla degli invitanti scoppia fracassante e rimbomba orribile più volte nella sala. Quel povero padre, sconvolto, annaspa tutto tremante, riesce a prendersi sotto braccio i due figli e, tutto ristretto in sé, coi brividi che gli spaccano le reni, senza poter nulla capire, se ne scappa, inseguito dal terrore che tutti gli abitanti della città siano improvvisamente impazziti.
E’ una novella tarda, del 1934. Non è una sorpresa che Pirandello si sia lasciato affascinare dalle correnti avanguardistiche e che approdi anche lui ad esiti che potremo definire sia espressionisti che surrealisti.
La novella non ha tempo (forse carnevale), ma in quale anno?, non ha luogo, (un salone con un orchestrina,) ma dove?, non ha un motivo (un’adunata di persone “dabbene”), perché?
Il tutto sembra sospeso in una serie d’immagini da un narratore interno che sa quanto i personaggi da lui descritti.
La novella si struttura in tre momenti:
- descrizione del salone, del soffitto, dell’orchestrina che suona; quindi descrizione dei personaggi, i loro sguardi furtivi, il loro interrogarsi sul perché sono lì;
- descrizione dell’effetto del riso, del suo irrefrenabile svolgersi tra una figlia, un figlio e un padre. Non vi è motivo del loro riso. Ma ciò crea scandalo;
- descrizione della vendetta terribile che i tre dovranno subire per aver riso.
Quindi Pirandello non ci offre alcuna spiegazione, alcun motivo; ma potremo leggerla come un momento in cui la posizione pirandelliana verso il regime stia mutando e quindi le adunate di gente che soffocano ogni forma di libertà, ma potrebbe anche leggersi, pirandellianamente, come la forma soffochi ogni forma di vita, laddove il riso rappresenti la seconda.
Il teatro
Pirandello approda piuttosto tardi al teatro, dopo la guerra, fra gli anni 1915 e 1936, ma è soprattutto in questo genere letterario che si precisa in modo completo la sua visione del mondo. Le opere teatrali sono più di quaranta e come per le novelle anch’esse vennero racchiuse in volume che prese il nome di Maschere nude. Molte di esse nascono dalle novelle, altre sono certamente originali; ma il loro travaso da un genere all’altro non aggiungono nulla di quanto tematicamente già detto, forse lo approfondiscono. Qualche critico ha parlato, a proposito di alcune di esse, soprattutto quelle nate per Marta Abba, come di un pirandellismo di maniera alla ricerca di una perfezione drammaturgica con un fine più didascalico che letterario.

Copertina per le opere teatrali pirandelliane
Potremo parlare di quattro fasi per il teatro:
- Le origini e il teatro siciliano. Esse nascono soprattutto sotto la spinta di un agente teatrale catanese e sono scritte in dialetto (poi, più tardi, riscritte in italiano). Fra le più importanti ricordiamo Lumié di Sicilia, Liolà e Pensaci Giacomino!;
Il professor Agostino Toti è un uomo anziano che non ha moglie né figli. A causa de suo povero stipensio, difatti, non ha potuto farsi una famiglia. Decide però di vendicarsi dello stato che lo ha miseramente ricompensato sposando una ragazza alla quale lascerà la sua pensione. Ma la ragazza scelta è incinta di un giovane, Giacomino, che il professore conosce. Pertanto, non venendo meno alla sua offerta, propone un menage a trois; ma Giacomino viene umiliato dalle cattiverie e risate della gente e vorrebbe interrompere la strana situazione, ma il professore lo fa ricredere, minacciandolo di fargli perdere il lavoro che gli ha procurato e mettendogli in braccio il figlio avuto dalla relazione con la ragazza.
 Pensaci Giacomino interpretato da Leo Gullotta
Pensaci Giacomino interpretato da Leo Gullotta
ATTO I
LILLINA: Ah, professore, quanto le sono grata! Che peso, che macigno mi leva dal petto! Mi metterei a saltare dalla contentezza, come una ragazzina.
TOTI: (con le lagrime in pelle). Figliuola mia, che dici? Bene? E che bene posso farti io? Bene di padre.
LILLINA: No, più! Un padre fa bene ai suoi figliuoli; ma li ha fatti lui: è suo dovere. Lei è più che padre per me!
TOTI: Sì, ma tu come padre considerami, e basta. Avessi – dico poco – vent’anni di meno! Settanta! E dunque – padre, e nient’altro.
LILLINA: Padre, padre, sì! Lei sarà il nostro vero padre, ecco! Ha bisogno di cura, d’assistenza: bene, ci sarò io; la curerò io! E lei sarà anche il padrone della mia casa e non si pentirà mai del bene che m’avrà fatto!
TOTI: Ma non dire così, figliuola mia! Che vuoi che sia il po’ di bene che ti fo io, di fronte a quello grande che mi farai tu, solo a sentirti ridere contenta accanto a me?
LILLINA: Io sola? Eh, saremo in due, professore, a rider contenti e felici!
TOTI: Tu e io, sì: in due!
LILLINA: E Giacomino, professore? E Giacomino che sarà più contento di me e di lei?
TOTI: (restando). Giacomino? Come, Giacomino?
LILLINA: Eh, scusi, vuole che non sia contento anche Giacomino?
TOTI: (c. s.). Quale Giacomino?
LILLINA: Come! Non è stato lui a pregarla di venire a dire una parolina per noi a mio padre?
TOTI: No, figliuola. Tu sbagli.
LILLINA: Come, sbaglio?
TOTI: (si prende la testa tra le mani). Aspetta… aspetta…
LILLINA: Oh Dio, che ha, professore?
TOTI: Niente. Una legnata in testa. Aspetta. – Padre, eh? Che volevo esser considerato da te soltanto come padre, t’ho detto, è vero?
LILLINA: Sì, certo. Ma mi dica che sbaglio può esserci stato?
TOTI: Aspetta. Dunque, padre… (Forte, a se stesso, con rabbia, come per richiamarsi al sentimento d’una realtà impreveduta): Padre, padre, padre. Non perdiamo la testa, Agostino! (Scrollandosi, come a significare che s’è liberato d’una illusione): Basta, è passato! Eccomi qua, figliuola mia. Sappiamoci intendere. Chi è codesto Giacomino che tu credi sia venuto a pregarmi? Da me non è venuto nessun Giacomino!
LILLINA: Ah, no? E allora? Che ha detto lei, allora, a mio padre per me?
TOTI: Gli ho detto quello che or ora ho finito di dire a te: che sono un povero vecchio, il quale potrebbe levarti da codesto stato, prendendoti con sé come una figliuola, e basta.
LILLINA: Me sola?
TOTI: (con bonomia, senz’ombra d’irrisione). Eh, vorresti che mi pigliassi insieme codesto Giacomino che tu dici? Capirai che per gli occhi del mondo…
LILLINA: Ma se è come figliuola, professore?
TOTI: Come figliuola, va bene. Tra me e te. Ma se debbo darti uno stato, capirai, non basta che tu te ne venga senz’altro a casa mia. Ci sarà pur bisogno…
LILLINA: E non c’è Giacomino?
TOTI: Ci sarà Giacomino, non dico di no! Ma lo stato, in faccia alla legge, non potrà dartelo lui; te lo dovrò dare io.
LILLINA: Professore, io non capisco più niente, allora! Ma come? Scusi… Mio padre m’ha detto ch’era contento, se ero contenta io; per quel che lei gli aveva detto per me.
TOTI: Sì, cara. Ma codesto Giacomino scappa fuori adesso! Io non ne sapevo nulla; non l’ho mai visto, mai sentito nominare.
LILLINA: Mai? Giacomino Delisi, professore!
TOTI: Ah, Giacomino Delisi? Oh guarda! Bravo giovanotto, sì. Fu mio scolaro, tant’anni fa. Lo conosco.
LILLINA: E da allora, appunto…
TOTI: Ah, fate all’amore da allora? È un bel pezzo!
LILLINA: M’ha detto che lei gli vuol bene…
TOTI: Eh, sì, gliene voglio…
LILLINA: E perciò m’ero immaginata che lei avesse parlato a papà per me: per me e per lui! Oh povera me! Che allegrezza in sogno! E ora come faremo? Siamo al punto di prima? E io che non posso più aspettare… che non posso più aspettare, professore! (Si nasconde la faccia.)
TOTI: (stupito, turbato). Perché? (La guarda e comprende.) Ah sì?
LILLINA: Sono perduta, sono perduta! non posso più aspettare! M’ajuti, professore, m’ajuti!
TOTI: E che ajuto potrei darti io, povera figliuola mia?
LILLINA: Parli a mio padre; gli dica… gli dica che conosce Giacomino, che sa che è un buon giovine; che lei farà di tutto per trovargli un posticino…
TOTI: Io?
LILLINA: Sì, tanto da potermi mantenere! E alla fine gli faccia comprendere che non posso più aspettare! Per carità, professore, per carità!
TOTI: Eh, io, per me, sì, figliuola, posso anche dirglielo. Ma ti pare che tuo padre vorrà dare ascolto a me?
LILLINA: Forse le darà ascolto! Lei è qua professore…
TOTI: Che professore, figliuola! Come professore – l’hai visto – non mi rispetta! E poi, ti sembra che possa credere sul serio che io abbia modo di procurare un posto a Giacomino?
LILLINA: Non importa! Si provi a dirglielo! Forse di lei si fiderà!
TOTI: Ma se il posto, per lui, è tutto! Tanto vero che era contento per me.
LILLINA: Come, per lei?
TOTI: Ma sì, figliuola! Siamo giusti, siete ragazzi e non considerate tante cose! Ti sei messa con un giovanotto – buono, non dico di no, educato, ma… senz’arte né parte, sventato… Come vuoi che ti mantenga? Le senti le campane?: «Con che? con che?». Non ne ha i mezzi, e credo neanche la voglia. L’amore? L’amore mangia, figliuola; non si mangia! Come farete a metter su casa? C’è ora anche un bambino per via… La faccenda era già complicata con codesto benedetto Giacomino! Ma, tanto, per me o prima o poi – meglio prima che poi! Ma ora si complica di più! Non bastava Giacomino; anche un Giacominino! Vuoi che diventi padre e nonno, tutt’in una volta?
LILLINA: No, no, professore! Che dice! Lei ha ragione: non avrei dovuto farlo; ma non so più io stessa come sia stato! Ora egli n’è più pentito e disperato di me; non sappiamo nessuno dei due come uscirne! Il tempo stringe. Ah, m’ajuti, professore, per carità, ora che lei sa tutto, ora che, per un caso, mi son trovata a confidarmi con lei, m’ajuti!
TOTI: Ma sì, io sono qua, figliuola mia, tutto per te. Non vedo che potrei fare. Ora che so tutto, non tirarmi indietro, ecco. Padre e nonno. Più di questo?
LILLINA: No, professore! Questo non è possibile!
TOTI: Dici per me? Se è per me – a pensarci (hai inteso ciò che ho detto al Direttore? dato il principio…) forse è meglio così, perché ora un po’ di bene te lo posso fare davvero. E se tu sei contenta, un bene farò io a te; un bene potrai fare tu a me; e potremo vivere in pace. Anche col bambino; anzi! Un bambinuccio a cui darò la mano, da nonno: non c’è meglio compagnia per avviarsi alla fossa.
LILLINA: Ma Giacomino, professore? Giacomino?
TOTI: Giacomino, figliuola… (fa un ampio gesto con la mano, come per dire: nascondilo!) Posso darti anche Giacomino?
LILLINA: No! no! Non dico questo! Oh Dio, mi fa avvampare dalla vergogna, professore!
TOTI: No, che vergogna, figliuola! Puoi far conto che in questo momento ti stai confidando con tuo padre. Mi dici Giacomino; io ti rispondo che Giacomino, sì, ci sarà; ma io… io non devo saperlo… cioè lo so, ma… ma dev’essere come se non lo sapessi, ecco! Amico di casa; antico scolaro. E posso voler bene anche a lui, come a un figliuolo: perché no?
LILLINA: Ma lui, professore, lui? Le sembra possibile che dica di sì? Questo può essere per me, per salvare me, sì; e io gliene sono grata; ma non può essere per lui: non consentirà mai! No, guardi: l’ajuto che m’aspetto da lei è quello che le ho già detto. Parli a mio padre, lo persuada a farmi sposar Giacomino, che non c’è più tempo da perdere. Un posticino lo troverà di certo. Lo sta cercando; lo troverà. E intanto ci facciano sposare! Ecco, questo. Mi faccia questa carità, professore! Io ora entro qua (indica il Gabinetto di Storia Naturale) con la scusa della pulizia. Perché deve venir lui…
TOTI: Giacomino? Là?
LILLINA: Sì, viene quasi ogni giorno, a quest’ora. Credevo che oggi non sarebbe venuto perché aveva parlato con lei; e invece… Ah, com’ero contenta! Credevo d’essermi levato questo peso, questo peso che mi schiaccia! – Vada vada a parlare a papà, professore! Io sono di là. Ma per carità non gli faccia capir niente! E grazie, grazie, professore: mi compatisca! (Lillina entra nel Gabinetto di Storia Naturale e richiude l’uscio.)
(Il professor Toti resta come stordito a considerar l’incarico che Lillina gli ha dato e fa una lunga scena muta, significando per cenni prima la sua sfiducia di riuscire e insieme la sua disillusione, poi come sarebbe stato bello per lui avere un bamboccetto, piccolo così, da portarsi per mano: se lo vede lì davanti; gli fa tanti attucci; ma poi pensa che c’è di mezzo questo benedetto Giacomino! Troppi, troppi a cui dovrebbe pensare il Governo: lui, uno; la moglie, due; Giacomino, tre; il bambino, quattro… Eh, troppi! troppi! E si gratta la testa. Guarda verso l’uscio del Gabinetto; pensa che Lillina e Giacomino forse sono di là insieme; e di nuovo considera la difficoltà dell’incarico; tentenna il capo e scuote le mani con le dita raccolte per le punte, come a dire: «Che posso farci io?». In quest’atto lo sorprende Cinquemani, che ritorna cauto e curioso dal corridoio a sinistra.)
 Sandro Randone impersona Toni nella commedia di Pirandello
Sandro Randone impersona Toni nella commedia di Pirandello
La piéce teatrale nasce da una novella del 1910 ed è stata scritta in pochi giorni nel 1916. Originariamente venne scritta in siciliano per l’attore Angelo Musco e solo in seguito venne poi proposta in italiano. Il vero protagonista, al di là del titolo della commedia, Pensaci Giacomino! è Agostino Toti, figlio del Pirandello più dell’Esclusa che del Mattia Pascal. La commedia infatti ha come tema fondamentale quello della convenzione sociale e di come esso, spesso e volentieri, nasconda ipocrisia e falsità, nonché, e forse più importante, il riscatto di un uomo vinto dall’impietoso meccanismo statale. Certo anche qui Pirandello utilizza mezzi tipicamente tipicamente “borghesi” (la prima parte) e del teatro leggero (il fraintendimento iniziale), ma poi vira mettendo al centro non soltanto la bonomia, ma la moralità del protagonista, moralità che va a frangersi, nell’ultima battuta della commedia, in cui, rivolgendosi al prete, urlerà “Che crede? Lei neanche a Cristo crede!”
- Il teatro grottesco: è la fase in cui Pirandello analizza e rovescia le convenzioni borghesi e ne svela le contraddizioni. Lo svelamento di esse fa di queste pièce, delle vere e proprie paradossali inchieste giudiziarie, dove a dominare vi è il protagonista filosofo.
Fra esse una delle più importanti è Così è (se vi pare):

Immagine tratta da una locandina
Lo strano comportamento del signor Ponza e di sua moglie, che comunica con la madre, signora Frola, solo per mezzo di bigliettini calati dalla finestra con un paniere, eccita a curiosità dei vicini. I tre personaggi vengono così, uno alla volta, a spiegare a ciascuno la propria verità. la signora Frola sostiene che il genero proibisce alla moglie di comunicare in altro modo con lei; Ponza implora che non le diano ascolto, perché la suocera è impazzita dopo la morte della figlia che lui si sforza di farle credere viva con l’aiuto della nuova moglie; torna la signora Frola a insistere che il pazzo è lui che ha mandato la moglie in manicomio con la sua gelosia (al suo ritorno Ponza non la riconosceva più: per questo si dovette simulare un nuovo matrimonio). Non resta che chiedere alla signora Ponza quale sia la verità.

Donna velata (Rossella Falk nella parte della signora Ponza)
FINALE
ATTO III
Scena VII
DETTI, (i personaggi della scena precedente) la SIGNORA AMALIA
AMALIA: (entra di furia, costernatissima, dall’uscio a sinistra, annunziando) La signora Frola! La signora Frola è qua!
AGAZZI: No! Perdio, chi l’ha chiamata?
AMALIA: Nessuno! È venuta da sé!
IL PREFETTO: No! Per carità! Ora? No! La faccia andar via, signora!
AGAZZI: Subito via! Non la fate entrare! Bisogna impedirglielo a ogni costo! Se la trovasse qua, gli sembrerebbe davvero un agguato!
Scena VIII
DETTI, la SIGNORA FROLA, TUTTI GLI ALTRI.
(La signora Frola s’introdurrà tremante, piangente, supplicante, con un fazzoletto in mano, in mezzo alla ressa degli altri, tutti esagitati.
SIGNORA FROLA: Signori miei, per pietà! per pietà! Lo dica lei a tutti, signor Consigliere!
AGAZZI: (facendosi avanti, irritatissimo) Io le dico, signora, di ritirarsi subito! Perché lei, per ora, non può stare qua!
SIGNORA FROLA (smarrita): E perché? perché? (Alla signora Amalia.) Mi rivolgo a lei, mia buona signora….
AMALIA: Ma guardi…. guardi, c’è lì il Prefetto.
SIGNORA FROLA: Oh! lei, signor Prefetto! Per pietà! Io volevo venire da lei!
IL PREFETTO: No, abbia pazienza, signora! Per ora io non posso darle ascolto. Bisogna che lei se ne vada! se ne vada via subito di qua!
SIGNORA FROLA: Sì, me ne andrò! Me ne andrò oggi stesso! Me ne partirò, signor Prefetto! per sempre me ne partirò!
AGAZZI: Ma no, signora! Abbia la bontà di ritirarsi per un momento nel suo quartierino qua accanto!. Mi faccia questa grazia! Poi parlerà col signor Prefetto!
SIGNORA FROLA: Ma perché?… Che cos’è? Che cos’è?
AGAZZI (perdendo la pazienza): Sta per tornare subito qua suo genero, ecco! Ha capito?
SIGNORA FROLA: Ah! Sì?…. E allora, sì…. sì, mi ritiro…. mi ritiro subito! Volevo dir loro questo soltanto: che per pietà, la finiscano! Loro credono di farmi bene e mi fanno tanto male! Io sarò costretta ad andarmene, se loro seguiteranno a far così; a partirmene oggi stesso, perché lui sia lasciato in pace! – Ma che vogliono, che vogliono ora qua da lui? Che deve venire a fare qua lui?… – Oh, signor Prefetto!
IL PREFETTO: Niente, signora, stia tranquilla! stia tranquilla, e se ne vada, per piacere!
AMALIA: Via, signora, sì! sia buona!
SIGNORA FROLA: Ah Dio, signora mia, loro mi priveranno dell’unico bene, dell’unico conforto che mi restava: vederla almeno da lontano la mia figliuola! (Si metterà) a piangere.
IL PREFETTO: Ma chi glielo dice? Lei non ha bisogno di partirsene! La invitiamo a ritirarsi ora per un momento. Stia tranquilla!
SIGNORA FROLA: Ma io sono in pensiero per lui! per lui, signor Prefetto! sono venuta qua a pregare tutti per lui, non per me!
IL PREFETTO: Sì, va bene! E lei può star tranquilla anche per lui, gliel’assicuro io. Vedrà che ora si accomoderà ogni cosa.
SIGNORA FROLA: E come? Li vedo qua tutti accaniti addosso a lui!
IL PREFETTO: No, signora! Non è vero! Ci sono qua io per lui! Stia tranquilla!
SIGNORA FROLA: Ah, grazie! Vuol dire che lei ha compreso.
IL PREFETTO: Sì, sì, signora, io ho compreso….
SIGNORA FROLA: E io l’ho ripetuto tante volte a tutti questi signori: è una disgrazia già superata, su cui non bisogna più ritornare.
IL PREFETTO: Sì, va bene, signora…. Se le dico che io ho compreso!
SIGNORA FROLA: Siamo contente di vivere così, la mia figliola è contenta. Dunque… – Ci pensi lei, ci pensi lei…. perché, se no, non mi resta altro che andarmene, proprio! e non vederla più, neanche così da lontano…. Lo lascino in pace, per carità!
(A questo punto, tra la ressa si fa un movimento d’ansia e di sgomento, tutti fanno cenni, alcuni guardano verso l’uscio; qualche voce repressa si fa sentire.)
VOCI: Oh Dio…. eccola, eccola!
SIGNORA FROLA: (notando lo sgomento, lo scompiglio, gemerà perplessa, tremante) Che cos’è?… Che cos’è?
Scena IX
DETTI, la SIGNORA PONZA, poi il SIGNOR PONZA.
(Tutti si scostano da una parte e dall’altra per dar passo alla signora Ponza che si fa avanti rigida, in gramaglie, col volto nascosto da un fitto velo nero, impenetrabile.)
SIGNORA FROLA (cacciando un grido straziante di frenetica gioja ): Ah! Lina…. Lina…. Lina….
(E si precipiterà e s’avvinghierà alla donna velata, con l’arsura d’una madre che da anni e anni non abbraccia più la sua figliuola. Ma contemporaneamente, dall’interno, si udranno le grida del signor Ponza che subito dopo si precipiterà sulla scena.)
PONZA: Giulia!… Giulia!… Giulia!… (La signora Ponza, alle grida di lui, s’irrigidisce tra le braccia della signora Frola che la cingono. Il signor Ponza s’accorge della suocera così perdutamente abbracciata alla moglie, e inveisce, furente.) Ah! Questo hanno fatto! L’avevo detto io! Si sono approfittati così, vigliaccamente, della mia buona fede?
SIGNORA PONZA: (volgendo il capo velato, quasi con austera solennità, verso il marito) Non temete! – Non temete! Andate via.
SIGNORA FROLA: (si stacca subito, da sé, tutta tremante, umile, dall’abbraccio, e accorre, premurosa, a lui) Sì, sì…. andiamo, caro, andiamo…. andiamo….
(E tutti e due abbracciati, carezzandosi a vicenda, tra due diversi pianti, si ritireranno bisbigliandosi tra loro parole affettuose. Silenzio. Dopo aver seguito con gli occhi fino all’ultimo i due, tutti si rivolgeranno, ora, sbigottiti e commossi, alla signora velata.)
SIGNORA PONZA (dopo averli guardati attraverso il velo, dirà con solennità cupa)
Che altro possono voler da me, dopo questo, lor signori? Qui c’è una sventura, come vedono, che deve restar nascosta, perché solo così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
IL PREFETTO (commosso): Ma noi vogliamo, vogliamo rispettar la pietà, signora…. Vorremmo però che lei ci dicesse….
SIGNORA PONZA (con un parlare lento e spiccato): Che cosa? la verità? è solo questa: che io sono, sì, la figlia della signora Frola, –
TUTTI (con un sospiro di soddisfazione): – ah!
SIGNORA PONZA: (subito c.s.)– e la seconda moglie del signor Ponza –
TUTTI: (stupiti, delusi, sommessamente) – oh, e come?
SIGNORA PONZA: (subito c.s.) – sì, e per me nessuna! nessuna!
IL PREFETTO: Ah, no, per sé, lei, signora, sarà l’una o l’altra!
SIGNORA PONZA:
Nossignori. Per me, io sono colei che mi si crede!
(Guarda, attraverso il velo, tutti, per un istante, e si ritirerà. Silenzio.)
LAUDISI
Ecco, o signori, come parla la verità! (Volge attorno uno sguardo di sfida derisoria.) Siete contenti? (Scoppierà a ridere) Ah! ah! ah! ah!
Nella scena vi è lo studio, accanto ad un salotto, di una casa borghese. Qui si svolge quella che si può chiamare una vera e propria inchiesta, ed assume, secondo la definizione del critico Giovanni Macchia, in una vera e propria stanza della tortura in cui scorrono tutti, tutti alla ricerca di una verità oggettiva.
Tuttavia, l’apparizione della signora Ponza certifica che non esiste realtà, sottolineando ancora una volta la relatività di essa (essa è ciò si vuole essa sia), ma ancor di più evidenzia l’inutilità di essa quando fa venir meno la pietà. Pirandello ci dice che non possono sussistere vita e forma, apparenza e realtà, ma fra le due antinomie scegli sempre quella che non porta dolore, il dolore di dover essere, come, appunto, la signora Ponza.
- Il metateatro. A questa definizione sono ascrivibili tre lavori teatrali (più un quarto): Sei personaggi in cerca d’autore (1921-25); Ciascuno a suo modo (1924-33); Questa sera si recita a soggetto (1930)
Queste opere sono caratterizzate dalla scomparsa della quarta parte, dalla esplicitazione del modus operandi all’interno di uno spazio scenico; della scomparsa di una linearità temporale; dalla struttura aperta e impossibilità del dramma stesso:

Messa in scena di Pitoeff per i “Sei personaggi in cerca d’autore” nel 1923
Mentre una compagnia drammatica prova Il gioco delle parti , di Pirandello, sulla scena appaiono misteriosamente sei personaggi: il Padre, la Madre, la Figliastra, il Figlio, due bambini. Essi nascono, spiega il Padre, dalla fantasia di un autore che non seppe o non volle farli vivere in un’opera d’arte; ma smaniano di vivere il loro dramma e vogliono che gli attori lo recitino. E il loro dramma è questo: la Madre, dopo aver dato alla luce il Figlio, si è innamorata del segretario del Padre, creatura dimessa e semplice come lei. Il Padre si è fatto da parte e dalla nuova unione sono nati tre figli. Dopo molti anni il Padre, inconsapevole, incontra la Figliastra in una casa d’appuntamenti: un rapporto incestuoso è evitato solo perché sopravviene la Madre, sconvolta di trovare la figliola in quel luogo, e con il suo legittimo marito. Il Padre, vergognoso, accoglie tutta la famiglia: ma si crea una situazione insostenibile. Il Figlio si chiude in un mutismo ostile; la bambina cade nella vasca e il ragazzo, che l’ha spiata morire senza intervenire, si uccide con una rivoltellata. Il Capocomico è, suo malgrado, affascinato dalla materia teatrale che gli viene proposta: ma qui si crea il secondo dramma dei personaggi. Essi non si riconoscono nella recitazione degli attori; solo loro possono rappresentare, o meglio vivere, la tragedia, che è poi la loro realtà: una realtà che si ripete nell’eternità dell’arte.
L’IRRUZIONE DEI SEI PERSONAGGI
L’Uscere del teatro sarà intanto entrato nella sala, col berretto gallonato in capo e, attraversato il corridojo fra le poltrone, si sarà appressato al palcoscenico per annunziare al Direttore-Capocomico l’arrivo dei Sei Personaggi, che, entrati anch’essi nella sala, si saranno messi a seguirlo, a una certa distanza, un po’ smarriti e perplessi, guardandosi attorno. Chi voglia tentare una traduzione scenica di questa commedia bisogna che s’adoperi con ogni mezzo a ottenere tutto l’effetto che questi “Sei Personaggi” non si confondano con gli Attori della Compagnia. La disposizione degli uni e degli altri, indicata nelle didascalie, allorché quelli saliranno sul palcoscenico, gioverà senza dubbio; come una diversa colorazione luminosa per mezzo di appositi riflettori. Ma il mezzo più efficace e idoneo, che qui si suggerisce, sarà l’uso di speciali maschere per i personaggi: maschere espressamente costruite d’una materia che per il sudore non s’afflosci e non pertanto sia lieve agli Attori che dovranno portarle: lavorate e tagliate in modo che lascino liberi gli occhi, le narici e la bocca. S’interpreterà così anche il senso profondo della commedia. I “Personaggi” non dovranno infatti apparire come “fantasmi”, ma come “realtà create”, costruzioni della fantasia immutabili: e dunque più reali e consistenti della volubile naturalità degli Attori. Le maschere ajuteranno a dare l’impressione della figura costruita per arte e fissata ciascuna immutabilmente nell’espressione del proprio sentimento fondamentale, che è il “rimorso” per il Padre, la “vendetta” per la Figliastra, lo “sdegno” per il Figlio, il “dolore” per la Madre con fisse lagrime di cera nel livido delle occhiaje e lungo le gote, come si vedono nelle immagini scolpite e dipinte della “Mater dolorosa” nelle chiese. E sia anche il vestiario di stoffa e foggia speciale, senza stravaganze, con pieghe rigide e volume quasi statuario, e insomma di maniera che non dia l’idea che sia fatto d’una stoffa che si possa comperare in una qualsiasi bottega della città e tagliato e cucito in una qualsiasi sartoria. Il Padre sarà sulla cinquantina: stempiato, ma non calvo, fulvo di pelo, con baffetti folti quasi acchiocciolati attorno alla bocca ancor fresca, aperta spesso a un sorriso incerto e vano. Pallido, segnatamente nell’ampia fronte; occhi azzurri ovati, lucidissimi e arguti; vestirà calzoni chiari e giacca scura: a volte sarà mellifluo, a volte avrà scatti aspri e duri. La Madre sarà come atterrita e schiacciata da un peso intollerabile di vergogna e d’avvilimento. Velata da un fitto crespo vedovile, vestirà umilmente di nero, e quando solleverà il velo, mostrerà un viso non patito, ma come di cera, e terrà sempre gli occhi bassi. La Figliastra, di diciotto anni, sarà spavalda, quasi impudente. Bellissima, vestirà a lutto anche lei, ma con vistosa eleganza. Mostrerà dispetto per l’aria timida, afflitta e quasi smarrita del fratellino, squallido Giovinetto di quattordici anni, vestito anch’egli di nero; e una vivace tenerezza, invece, per la sorellina, Bambina di circa quattro anni, vestita di bianco con una fascia di seta nera alla vita. Il Figlio, di ventidue anni, alto, quasi irrigidito in un contenuto sdegno per il Padre e in un’accigliata indifferenza per la Madre, porterà un soprabito viola e una lunga fascia verde girata attorno al collo.
L’USCERE (col berretto in mano): Scusi, signor Commendatore.
IL CAPOCOMICO (di scatto, sgarbato): Che altro c’è?
L’USCERE (timidamente): Ci sono qua certi signori, che chiedono di lei.
Il Capocomico e gli Attori si volteranno stupiti a guardare dal palcoscenico giù nella sala.
IL CAPOCOMICO (di nuovo sulle furie): Ma io qua provo! E sapete bene che durante la prova non deve passar nessuno! (Rivolgendosi in fondo) Chi sono lor signori? Che cosa vogliono?

Lamberto Picasso e Marta Abba nelle parti del Padre e della Figliastra (1925)
IL PADRE (facendosi avanti, seguito dagli altri, fino a una delle due scalette): Siamo qua in cerca d’un autore.
IL CAPOCOMICO (fra stordito e irato): D’un autore? Che autore?
IL PADRE: D’uno qualunque, signore.
IL CAPOCOMICO: Ma qui non c’è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova.
LA FIGLIASTRA: (con gaja vivacità, salendo di furia la scaletta) Tanto meglio, tanto meglio, allora, signore! Potremmo esser noi la loro commedia nuova.
QUALCUNO DEGLI ATTORI: (fra i vivaci commenti e le risate degli altri) Oh, senti, senti!
IL PADRE: (seguendo sul palcoscenico la Figliastra) Già, ma se non c’è l’autore! (Al Capocomico) Tranne che non voglia esser lei…
La Madre, con la Bambina per mano, e il Giovinetto saliranno i primi scalini della scaletta e resteranno lì in attesa. Il Figlio resterà sotto, scontroso.
IL CAPOCOMICO: Lor signori vogliono scherzare?
IL PADRE: No, che dice mai, signore! Le portiamo al contrario un dramma doloroso.
LA FIGLIASTRA: E potremmo essere la sua fortuna!
IL CAPOCOMICO: Ma mi facciano il piacere d’andar via, che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi!
IL PADRE (ferito e mellifluo): Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena d’infinite assurdità, le quali sfacciatamente non han neppure bisogno di parer verosimili; perché sono vere.
IL CAPOCOMICO: Ma che diavolo dice?
IL PADRE: Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sissignore, sforzarsi di fare il contrario; cioè, di crearne di verosimili, perché pajano vere. Ma mi permetta di farle osservare che, se pazzia è, questa è pur l’unica ragione del loro mestiere.
Gli Attori si agiteranno, sdegnati.
IL CAPOCOMICO: (alzandosi e squadrandolo) Ah sì? Le sembra un mestiere da pazzi, il nostro?
IL PADRE: Eh, far parer vero quello che non è; senza bisogno, signore: per giuoco… Non è loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantasticati?
IL CAPOCOMICO: (subito facendosi voce dello sdegno crescente dei suoi Attori) Ma io la prego di credere che la professione del comico, caro signore, è una nobilissima professione! Se oggi come oggi i signori commediografi nuovi ci danno da rappresentare stolide commedie e fantocci invece di uomini, sappia che è nostro vanto aver dato vita – qua, su queste tavole – a opere immortali!
Gli Attori, soddisfatti, approveranno e applaudiranno il loro Capocomico.
IL PADRE: (interrompendo e incalzando con foga). Ecco! benissimo! a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni! Meno reali, forse; ma più veri! Siamo dello stessissimo parere!
Gli Attori si guardano tra loro, sbalorditi.
IL CAPOCOMICO: Ma come! Se prima diceva…
IL PADRE: No, scusi, per lei dicevo, signore, che ci ha gridato di non aver tempo da perdere coi pazzi, mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire, più alta, la sua opera di creazione.
IL CAPOCOMICO: Sta bene, sta bene. Ma che cosa vuol concludere con questo?
IL PADRE: Niente, signore. Dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme: albero o sasso, acqua o farfalla… o donna. E che si nasce anche personaggi!
IL CAPOCOMICO: (con finto ironico stupore) E lei, con codesti signori attorno, è nato personaggio?
IL PADRE: Appunto, signore. E vivi, come ci vede.
Il Capocomico e gli Attori scoppieranno a ridere, come per una burla.
IL PADRE: (ferito) Mi dispiace che ridano così, perché portiamo in noi, ripeto, un dramma doloroso, come lor signori possono argomentare da questa donna velata di nero.
Così dicendo porgerà la mano alla Madre per aiutarla a salire gli ultimi scalini e, seguitando a tenerla per mano, la condurrà con una certa tragica solennità dall’altra parte del palcoscenico, che s’illuminerà subito di una fantastica luce. La Bambina e il Giovinetto seguiranno la Madre; poi il Figlio, che si terrà discosto, in fondo; poi la Figliastra, che s’apparterà anche lei sul davanti, appoggiata all’arcoscenico. Gli Attori, prima stupefatti, poi ammirati di questa evoluzione, scoppieranno in applausi come per uno spettacolo che sia stato loro offerto.
IL CAPOCOMICO: (prima sbalordito, poi sdegnato) Ma via! Facciano silenzio! (Poi, rivolgendosi ai Personaggi) E loro si levino! Sgombrino di qua! (Al Direttore di scena) Perdio, faccia sgombrare!
IL DIRETTORE DI SCENA: (facendosi avanti, ma poi fermandosi, come trattenuto da uno strano sgomento)Via! Via!
IL PADRE: (al Capocomico) Ma no, veda, noi…
IL CAPOCOMICO: (gridando) Insomma, noi qua dobbiamo lavorare!
IL PRIMO ATTORE: Non è lecito farsi beffe così…
IL PADRE: (risoluto, facendosi avanti) Io mi faccio maraviglia della loro incredulità! Non sono forse abituati lor signori a vedere balzar vivi quassù, uno di fronte all’altro, i personaggi creati da un autore? Forse perché non c’è là (indicherà la buca del Suggeritore) un copione che ci contenga?
LA FIGLIASTRA: (facendosi avanti al Capocomico, sorridente, lusingatrice) Creda che siamo veramente sei personaggi, signore, interessantissimi! Quantunque, sperduti.
IL PADRE: (scartandola) Sì, sperduti, va bene! (Al Capocomico subito) Nel senso, veda, che l’autore che ci creò, vivi, non volle poi, o non poté materialmente, metterci al mondo dell’arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte. Non muore più! Morrà l’uomo, lo scrittore, strumento della creazione; la creatura non muore più! E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché – vivi germi – ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l’eternità!
IL CAPOCOMICO: Tutto questo va benissimo! Ma che cosa vogliono loro qua?
IL PADRE: Vogliamo vivere, signore!
IL CAPOCOMICO: (ironico) Per l’eternità?
IL PADRE: No, signore: almeno per un momento, in loro.
UN ATTORE: Oh, guarda, guarda!
LA PRIMA ATTRICE: Vogliono vivere in noi!
L’ATTOR GIOVANE: (indicando la Figliastra) Eh, per me volentieri, se mi toccasse quella lì!
IL PADRE: Guardino, guardino: la commedia è da fare; al Capocomico: ma se lei vuole e i suoi attori vogliono, la concerteremo subito tra noi!
IL CAPOCOMICO: (seccato) Ma che vuol concertare! Qua non si fanno di questi concerti! Qua si recitano drammi e commedie!
IL PADRE: E va bene! Siamo venuti appunto per questo qua da lei!
IL CAPOCOMICO: E dov’è il copione?
IL PADRE: È in noi, signore. (Gli attori rideranno). Il dramma è in noi; siamo noi; e siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione!

I sei personaggi in una riduzione teatrale del 2013
Testo fondamentale della drammaturgia novecentesca europea I sei personaggi in cerca d’autore costituiscono un profondo spartiacque tra il modo di far teatro ottocentesco e quello novecentesco, cambiandone completamente la grammatica:
- l’ampliamento dello spazio scenico che diventa l’intero interno di una costruzione dedicata a questa tipologia artistica (come espliciterà meglio nell’intera trilogia metateatrale);
- l’utilizzo in un modo “fantastico/simbolico” della luce, che deve cancellare qualsiasi forma realistica;
- la dicotomia tra arte e vita, tra forma e realtà;
- l’impossibilità della vita d’essere rappresentata in una forma d’arte;
- la cristallizzazione della vita nell’arte;
- la fine della tragedia nell’arte perché la tragedia è nella vita.
Nella pagina presentata questi temi appaiono evidenti: la lunga didascalia (inusuale nel teatro verista, ma anche in quello borghese dello stesso Pirandello) ci dice come, in questa fase sia estremamente necessaria una forma di quasi narratività che si esplicita in una maniacalità di direzione. L’irruzione dei sei personaggi nasce da una novella del 1911 La tragedia di un personaggio che fa di essi la forma più cristallizzata nella loro autonomia; tornando all’esempio pirandelliano diremo che Sancho Panza e Don Abbondio saranno per sempre un servo più intelligente del padrone e un parroco pauroso, ma lo saranno proprio in virtù dell’essere stati resi eterni nella forma dell’arte che li incatena nella eternità della finzione; ora se la vita per Pirandello è un lasciarsi andare al fluido della vita (Vitangelo Moscarda) nessuna delle parti presenti nella pièce è libera: gli attori chiusi nella rappresentatività nel non essere mai stessi, rappresentando personaggi ed essendo conosciuti come tali; i personaggi che, pur essendo ora vivi e quindi veri, vogliono chiudersi in una forma e quindi cristallizzarli. Solo vivendo la loro tragedia potranno essere cristallizzati nell’eternità.
Ma Pirandello, alla fine confonde i piani:
L’ULTIMA SCENA

Un riduzione teatrale del 2011
IL CAPOCOMICO: Ma dica, dica lei almeno che cosa c’è stato! Lo dica a me! Se n’è uscito dalla sua camera, senza dir nulla?
IL FIGLIO: (dopo un momento d’esitazione) Nulla. Proprio, per non fare una scena!
IL CAPOCOMICO: (incitandolo) Ebbene, e poi? che ha fatto?
IL FIGLIO: (tra l’angosciosa attenzione di tutti, muovendo alcuni passi sul palcoscenico) Nulla…Attraversando il giardino… (S’interromperà, fosco, assorto.)
IL CAPOCOMICO: (spingendolo sempre più a dire, impressionato dal ritegno di lui) Ebbene? attraversando il giardino?
IL FIGLIO: (esasperato, nascondendo il volto con un braccio) Ma perché mi vuol far dire, signore? È orribile!
La Madre tremerà tutta, con gemiti soffocati, guardando verso la vasca.
IL CAPOCOMICO: (piano, notando quello sguardo, si rivolgerà al Figlio con crescente apprensione) La bambina?
IL FIGLIO: (guardando davanti a sé, nella sala) Là, nella vasca…
IL PADRE: (a terra, indicando pietosamente la Madre) E lei lo seguiva, signore!
IL CAPOCOMICO: (al Figlio, con ansia) E allora, lei?
IL FIGLIO: (lentamente, sempre guardando davanti a sè). Accorsi; mi precipitai per ripescarla…Ma a un tratto m’arrestai, perché dietro quegli alberi vidi una cosa che mi gelò: il ragazzo, il ragazzo che se ne stava lì fermo, con occhi da pazzo, a guardare nella vasca la sorellina affogata.
La Figliastra, rimasta curva presso la vasca a nascondere la Bambina, risponderà come un’eco dal fondo, singhiozzando perdutamente.
Pausa.
Feci per accostarmi; e allora…
Rintronerà dietro gli alberi, dove il Giovinetto è rimasto nascosto, un colpo di rivoltella.
LA MADRE: (con un grido straziante, accorrendo col Figlio e con tutti gli Attori in mezzo al subbuglio generale) Figlio! Figlio mio! (E poi, fra la confusione e le grida sconnesse degli altri) Ajuto! Ajuto!
IL CAPOCOMICO: (tra le grida, cercando di farsi largo, mentre il Giovinetto sarà sollevato da capo e da piedi e trasportato via, dietro la tenda bianca) S’è ferito? s’è ferito davvero?
Tutti, tranne il Capocomico e il Padre, rimasto per terra presso la scaletta, saranno scomparsi dietro il fondalino abbassato, che fa da cielo, e vi resteranno un po’ parlottando angosciosamente, poi, da una parte e dall’altra di esso, rientreranno in iscena gli Attori.
LA PRIMA ATTRICE: (rientrando da destra, addolorata) È morto! Povero ragazzo! È morto! Oh che cosa!
IL PRIMO ATTORE: (rientrando da sinistra, ridendo) Ma che morto! Finzione! finzione! Non ci creda!
ALTRI ATTORI DA DESTRA: Finzione? Realtà! realtà! È morto!
ALTRI ATTORI DA SINISTRA: No! Finzione! Finzione!
IL PADRE: (levandosi e gridando tra loro) Ma che finzione! Realtà, realtà, signori! realtà!
E scomparirà anche lui, disperatamente, dietro il fondalino.
IL CAPOCOMICO: (non potendone più) Finzione! realtà! Andate al diavolo tutti quanti! Luce! Luce! Luce!
D’un tratto, tutto il palcoscenico e tutta la sala del teatro sfolgoreranno di vivissima luce. Il capocomico rifiaterà come liberato da un incubo, e tutti si guarderanno negli occhi, sospesi e smarriti.
Ah! Non m’era mai capitata una cosa simile! Mi hanno fatto perdere una giornata! (Guarderà l’orologio). Andate, andate! Che volete più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova. A questa sera! (E appena gli Attori se ne saranno andati, salutandolo) Ehi, elettricista, spegni tutto!
Non avrà finito di dirlo, che il teatro piomberà per un attimo nella più fitta oscurità.
Eh, perdio! Lasciami almeno accesa una lampadina, per vedere dove metto i piedi!
Subito, dietro il fondalino, come per uno sbaglio d’attacco, s’accenderà un riflettore verde, che proietterà, grandi e spiccate, le ombre dei Personaggi, meno il Giovinetto e la Bambina. Il Capocomico, vedendole, schizzerà via dal palcoscenico, atterrito. Contemporaneamente si spegnerà il riflettore dietro il fondalino, e si rifarà sul palcoscenico il notturno azzurro di prima. Lentamente, dal lato destro della tela verrà prima avanti il Figlio, seguito dalla Madre con le braccia protese verso di lui; poi dal lato sinistro il Padre. Si fermeranno a metà del palcoscenico, rimanendo lì come forme trasognate. Verrà fuori, ultima, da sinistra, la Figliastra che correrà verso una delle scalette; sul primo scalino si fermerà un momento a guardare gli altri tre e scoppierà in una stridula risata, precipitandosi poi giù per la scaletta; correrà attraverso il corridojo tra le poltrone; si fermerà ancora una volta e di nuovo riderà, guardando i tre rimasti lassù; scomparirà dalla sala, e ancora, dal ridotto, se ne udrà la risata.
Poco dopo calerà la tela.

(2016)
L’ultima scena terminava nell’edizione del 1921 con le parole del capocomico; nel 1925 Pirandello aggiunse la parte finale. Se nella prima i piani realtà, arte, rappresentazione si confondono (è vero che il bambino sia morto o è finzione scenica), la scelta successiva di far riapparire i personaggi e d’isolare la Figliastra fuori dal palcoscenico con la sua stridula risata, sta ad indicare tre aspetti fondamentali:
- la vita continua e il teatro la blocca in una fissità;
- non esiste verità, ma solo una verità relativa;
- nella tragedia moderna non è possibile la catarsi.
Altro grande capolavoro teatrale è l’Enrico IV, che pur riprendendo forme teatrali tradizionali, s’iscrive tematicamente alla terza fase:
 Pirandello assieme a degli attori per l’allestimento dell’Enrico IV
Pirandello assieme a degli attori per l’allestimento dell’Enrico IV
Un giovane gentiluomo che impersona Enrico IV di Germania in una sorta di cavalcata storica, cade da cavallo, batte la testa e perde il senno. Per dodici anni si crede davvero l’imperatore; quando rinsavisce scopre che Matilde Spina, la donna che amava, è diventata l’amante di un suo odiato rivale, Tito Belcredi. Decide allora di fingersi ancora pazzo per non rientrare nella realtà: ma quanto Matilde con la figlia Frida, Belcredi e altri vengono a trovarlo, rivela la finzione. Tuttavia il ricordo della giovinezza perduta gli brucia: per di più, sa che la caduta da cavallo non fu accidentale, e vuole vendicarsi. La Matilde di adesso non rappresenta più nulla: per lui la Matilde di allora è la Frida di adesso, ed è Frida che vuole. Ma quando abbraccia la ragazza, Belcredi si avventa su di lui e Enrico lo trapassa con la spada. Ora che ha ucciso è condannato a non abbandonare mai più la finzione.
PAZZO PER SEMPRE

Franco Branciaroli nella parte di Enrico IV (2015)
ENRICO IV: Guarito, sì! Sono guarito! (A Belcredi) Ah, ma non per farla finita così subito, come tu credi! (Lo investe.) Lo sai che da venti anni nessuno ha mai osato comparirmi davanti qua, come te e codesto signore? (indica il Dottore.)
BELCREDI: Ma sì, lo so! E difatti anch’io, questa mattina, ti comparvi davanti vestito…
ENRICO IV: Da monaco, già!
BELCREDI: E tu mi prendesti per Pietro Damiani! E non ho mica riso, credendo appunto…
ENRICO IV: Che fossi pazzo! Ti viene da ridere, vedendo lei così, ora che sono guarito? Eppure potresti pensare che, ai miei occhi, il suo aspetto, ora s’interrompe con uno scatto di sdegno. Ah! (E subito si rivolge al Dottore) Voi siete un medico?
DOTTORE: Io, sì…
ENRICO IV: E l’avete parata voi da Marchesa di Toscana anche lei? Sapete, Dottore, che avete rischiato di rifarmi per un momento la notte nel cervello? Perdio, far parlare i ritratti, farli balzare vivi dalle cornici… (Contempla Frida e il Di Nolli, poi guarda la Marchesa ed infine si guarda l’abito addosso.) Eh, bellissima la combinazione…Due coppie…Benissimo, benissimo, dottore: per un pazzo… (Accenna appena con la mano al Belcredi.) A lui sembra ora una carnevalata fuori di tempo, eh? (Si volta a guardarlo.) Via, ormai, anche questo mio abito da mascherato! Per venirmene con te, è vero?
BELCREDI: Con me! Con noi!
ENRICO IV: Dove, al circolo? In marsina e cravatta bianca? O a casa, tutti e due insieme, della Marchesa?
BELCREDI: Ma dove vuoi! Vorresti rimanere qua ancora, scusa, a perpetuare – solo – quello che fu lo scherzo disgraziato d’un giorno di carnevale? È veramente incredibile, incredibile come tu l’abbia potuto fare, liberato dalla disgrazia che t’era capitata!
ENRICO IV: Già. Ma vedi? È che, cadendo da cavallo e battendo la testa, fui pazzo per davvero, io, non so per quanto tempo…
DOTTORE: Ah, ecco, ecco! E durò a lungo?
ENRICO IV: (rapidissimo, al dottore). Sì, dottore, a lungo: circa dodici anni. (E subito, tornando a parlare al Belcredi) E non vedere più nulla, caro, di tutto ciò che dopo quel giorno di carnevale avvenne, per voi e non per me; le cose, come si mutarono; gli amici, come mi tradirono; il posto preso da altri, per esempio… che so! Ma supponi nel cuore della donna che tu amavi; e chi era morto; e chi era scomparso… tutto questo, sai? non è stata mica una burla per me, come a te pare!
BELCREDI: Ma no, io non dico questo, scusa! Io dico dopo!
ENRICO IV: Ah sì? Dopo? Un giorno… (Si arresta e si volge al dottore.) Caso interessantissimo, dottore! Studiatemi, studiatemi bene! (Vibra tutto, parlando) Da sé, chi sa come, un giorno, il guasto qua… si tocca la fronte che so… si sanò. Riapro gli occhi a poco a poco, e non so in prima se sia sonno o veglia, ma sì, sono sveglio; tocco questa cosa e quella: torno a vedere chiaramente…Ah! – come lui dice – (accenna a Belcredi) via, via allora, quest’abito da mascherato! questo incubo! Apriamo le finestre: respiriamo la vita! Via, via, corriamo fuori! Arrestando d’un tratto la foga: Dove? a far che cosa? a farmi mostrare a dito da tutti, di nascosto, come Enrico IV, non più così, ma a braccetto con te, tra i cari amici della vita?
BELCREDI: Ma no! Che dici? Perché?
DONNA MATILDE: Chi potrebbe più…? Ma neanche a pensarlo! Se fu una disgrazia!
ENRICO IV: Ma se già mi chiamavano pazzo, prima, tutti! (A Belcredi) E tu lo sai! Tu che più di tutti ti accanivi contro chi tentava difendermi!
BELCREDI: Oh, via, per ischerzo!
ENRICO IV: E guardami qua i capelli! (Gli mostra i capelli sulla nuca.)
BELCREDI: Ma li ho grigi anch’io!
ENRICO IV: Sì, con questa differenza: che li ho fatti grigi qua, io, da Enrico IV, capisci? E non me n’ero mica accorto! Me n’accorsi in un giorno solo, tutt’a un tratto, riaprendo gli occhi, e fu uno spavento, perché capii subito che non solo i capelli, ma doveva esser diventato grigio tutto così, e tutto crollato, tutto finito: e che sarei arrivato con una fame da lupo a un banchetto già bell’e sparecchiato.
BELCREDI: Eh, ma gli altri, scusa…
ENRICO IV: (subito) Lo so, non potevano stare ad aspettare ch’io guarissi, nemmeno quelli che, dietro a me, punsero a sangue il mio cavallo bardato…
DI NOLLI: (impressionato) Come, come?
ENRICO IV: Sì, a tradimento, per farlo springare e farmi cadere!
DONNA MATILDE: (subito, con orrore) Ma questo lo so adesso, io!
ENRICO IV: Sarà stato anche questo per uno scherzo!
DONNA MATILDE: Ma chi fu? Chi stava dietro alla nostra coppia?

Marcello Mastroianni nella versione filmica dell’Enrico IV (1984)
ENRICO IV: Non importa saperlo! Tutti quelli che seguitarono a banchettare e che ormai mi avrebbero fatto trovare i loro avanzi, Marchesa, di magra o molle pietà, o nel piatto insudiciato qualche lisca di rimorso, attaccata. Grazie! (Voltandosi di scatto al Dottore) E allora, dottore, vedete se il caso non è veramente nuovo negli annali della pazzia! – preferii restar pazzo – trovando qua tutto pronto e disposto per questa delizia di nuovo genere: viverla – con la più lucida coscienza – la mia pazzia e vendicarmi così della brutalità d’un sasso che m’aveva ammaccato la testa! La solitudine – questa – così squallida e vuota come m’apparve riaprendo gli occhi – rivestirmela subito, meglio, di tutti i colori e gli splendori di quel lontano giorno di carnevale, quando voi (guarda Donna Matilde e le indica Frida) eccovi là, Marchesa, trionfaste! – e obbligar tutti quelli che si presentavano a me, a seguitarla, perdio, per il mio spasso, ora, quell’antica famosa mascherata che era stata – per voi e non per me – la burla di un giorno! Fare che diventasse per sempre – non più una burla, no; ma una realtà, la realtà di una vera pazzia: qua, tutti mascherati, e la sala del trono, e questi quattro miei consiglieri segreti, e – s’intende – traditori! Si volta subito verso di loro. Vorrei sapere che ci avete guadagnato, svelando che ero guarito! – Se sono guarito, non c’è più bisogno di voi, e sarete licenziati! – Confidarsi con qualcuno, questo sì, è veramente da pazzo! – Ah, ma vi accuso io, ora, a mia volta! – Sapete? – Credevano di potersi mettere a farla anche loro adesso la burla, con me, alle vostre spalle. (Scoppia a ridere. Ridono ma sconcertati, anche gli altri, meno Donna Matilde.)
BELCREDI: (al Di Nolli) Ah, senti… non c’è male…
DI NOLLI: (ai quattro giovani) Voi?
ENRICO IV: Bisogna perdonarli! Questo, (si scuote l’abito addosso) questo che è per me la caricatura, evidente e volontaria, di quest’altra mascherata, continua, d’ogni minuto, di cui siamo i pagliacci involontarii (indica Belcredi) quando senza saperlo ci mascheriamo di ciò che ci par d’essere – l’abito, il loro abito, perdonateli, ancora non lo vedono come la loro stessa persona. (Voltandosi di nuovo a Belcredi) Sai? Ci si assuefà facilmente. E si passeggia come niente, così, da tragico personaggio – eseguisce – in una sala come questa! – Guardate, dottore! – Ricordo un prete – certamente irlandese – bello – che dormiva al sole, un giorno di novembre, appoggiato col braccio alla spalliera del sedile, in un pubblico giardino: annegato nella dorata delizia di quel tepore, che per lui doveva essere quasi estivo. Si può star sicuri che in quel momento non sapeva più d’esser prete, né dove fosse. Sognava! E chi sa che sognava! – Passò un monello, che aveva strappato con tutto il gambo un fiore. Passando, lo vellicò, qua al collo. – Gli vidi aprir gli occhi ridenti; e tutta la bocca ridergli del riso beato del suo sogno; immemore: ma subito vi so dire che si ricompose rigido nel suo abito da prete e che gli ritornò negli occhi la stessa serietà che voi avete già veduta nei miei; perché i preti irlandesi difendono la serietà della loro fede cattolica con lo stesso zelo con cui io i diritti sacrosanti della monarchia ereditaria. – Sono guarito, signori: perché so perfettamente di fare il pazzo, qua; e lo faccio, quieto! -Il guajo è per voi che la vivete agitatamente, senza saperla e senza vederla la vostra pazzia.
BELCREDI: Siamo arrivati, guarda! alla conclusione, che i pazzi adesso siamo noi!
ENRICO IV (con uno scatto che pur si sforza di contenere): Ma se non foste pazzi, tu e lei insieme, (indica la Marchesa) sareste venuti da me?
BELCREDI: Io, veramente, sono venuto credendo che il pazzo fossi tu.
ENRICO IV: (subito forte, indicando la Marchesa) E lei?
BELCREDI: Ah lei, non so…Vedo che è come incantata da quello che tu dici… affascinata da codesta tua «cosciente» pazzia! (Si volge a lei) Parata come già siete, dico, potreste anche restare qua a viverla, Marchesa…
DONNA MATILDA: Voi siete un insolente!
ENRICO IV: (subito, placandola) Non ve ne curate! Non ve ne curate! Seguita a cimentare. Eppure il dottore glie l’ha avvertito, di non cimentare. (Voltandosi a Belcredi) Ma che vuoi che m’agiti più ciò che avvenne tra noi; la parte che avesti nelle mie disgrazie con lei (indica la Marchesa e si rivolge ora a lei indicandole il Belcredi) la parte che lui adesso ha per voi! – La mia vita è questa! Non è la vostra! – La vostra, in cui siete invecchiati, io non l’ho vissuta! – (A Donna Matilde) Mi volevate dir questo, dimostrar questo, con vostro sacrificio, parata così per consiglio del dottore? Oh, fatto benissimo, ve l’ho detto, dottore: – «Quelli che eravamo allora, eh? e come siamo adesso?» – Ma io non sono un pazzo a modo vostro, dottore! Io so bene che quello (indica il Di Nolli) non può esser me, perché Enrico IV sono io: io, qua, da venti anni, capite? Fisso in questa eternità di maschera! Li ha vissuti lei (indica la Marchesa) se li è goduti lei, questi venti anni, per diventare – eccola là – come io non posso riconoscerla più: perché io la conosco così indica Frida e le si accosta – per me, è questa sempre… Mi sembrate tanti bambini, che io possa spaventare. (A Frida) E ti sei spaventata davvero tu, bambina, dello scherzo che ti avevano persuaso a fare, senza intendere che per me non poteva essere lo scherzo che loro credevano; ma questo terribile prodigio: il sogno che si fa vivo in te, più che mai! Eri lì un’immagine; ti hanno fatta persona viva – sei mia! sei mia! mia! di diritto mia! (La cinge con le braccia, ridendo come un pazzo, mentre tutti gridano atterriti; ma come accorrono per strappargli Frida dalle braccia, si fa terribile, e grida ai suoi quattro giovani) Tratteneteli! Tratteneteli! Vi ordino di trattenerli! (I quattro giovani, nello stordimento, quasi affascinati, si provano a trattenere automaticamente il Di Nolli, il dottore, il Belcredi.)
BELCREDI: (si libera subito e si avventa su Enrico IV) Lasciala! Lasciala! Tu non sei pazzo!
ENRICO IV: (fulmineamente, cavando la spada dal fianco di Landolfo che gli sta presso). Non sono pazzo? Eccoti! (E lo ferisce al ventre. È un urlo d’orrore. Tutti accorrono a sorreggere il Belcredi, esclamando in tumulto)
DI NOLLI: T’ha ferito?
BERTOLDO: L’ha ferito! L’ha ferito!
DOTTORE: Lo dicevo io!
FRIDA: Oh Dio!
DI NOLLI: Frida, qua!
DONNA MATILDE: È pazzo! È pazzo!
DI NOLLI: Tenetelo!
BELCREDI (mentre lo trasportano di là, per l’uscio a sinistra protesta ferocemente): No! Non sei pazzo! Non è pazzo! Non è pazzo!
Escono per l’uscio a sinistra, gridando, e seguitano di là a gridare finché sugli altri gridi se ne sente uno più acuto di Donna Matilde, a cui segue un silenzio.
ENRICO IV: (rimasto sulla scena tra Landolfo, Arialdo e Ordulfo, con gli occhi sbarrati, esterrefatto dalla vita della sua stessa finzione che in un momento lo ha forzato al delitto) Ora sì… per forza… li chiama attorno a sé, come a ripararsi, qua insieme, qua insieme… e per sempre!
Il tema, fondamentale della pièce è il labile confine che vi è tra “pazzia” e “normalità”. D’altra parte tale tema è più volte rappresentato nella scrittura pirandelliana (si pensi a Vitangelo Moscarda) ma ogni volta Pirandello traccia su di essa una labile linea che più che definire contribuisce, invece, a confondere, oserei dire, mescolare i piani.
Dal passo emerge, in primo luogo, la nostalgia per la giovinezza perduta nella pausa vitale della pazzia: non è quindi quest’ultima a tormentarlo, ma il non aver vissuto mentre gli altri (prendendosi beffe di lui) continuavano la loro esistenza.
Quando rinsavisce si spacca il velo d’ipocrisia della vita cosiddetta “normalità”: è più pazzo lui che finge di esserlo e loro che per “compiacerlo” si mascherano da pazzi? Se in lui, fermandosi il tempo, ha potuto, per un attimo, vivere senza apparenza o forma che lo determinasse, la finzione che gli altri hanno vissuto fingendosi pazzi, li ha resi ancora più pazzi, costretti a prendere una forma. Allora la pazzia di Enrico IV diventa elemento straniante per leggere la realtà e vederla nella sua apparenza, negatrice, quindi, della vita.

Tom Stoppard nella versione americana dell’Enrico IV
- Il teatro dei miti: è l’ultima fase, quella forse maggiormente influenzata dall’esperienza surrealista. Fanno parte di questa fase tre opere La nuova colonia (1928), Lazzaro (1929) e I giganti della montagna (incompleto e pubblicato postumo nel 1937). E’ proprio quest’ultimo, sebbene non terminato, a destare la maggiore attenzione a livello critico:

Locandina
Una compagnia di attori girovaghi, guidata dalla contessa Ilse, avendo deciso di recitare La favola del figlio cambiato (una opera altamente drammatica dello stesso Pirandello) e non trovando accoglienza nei comuni teatri, giunge ad una villa che sembra abbandonata. Gli strani e misteriosi abitanti della villa, il mago Cotrone e gli Scalognati, cercano dapprima di allontanarli con tuoni, fulmini, apparizioni di fantasmi e altro, infine, poiché i commedianti non si lasciano intimorire, li accolgono, e Cotrone cerca di convincere la contessa a recitare per gli ospiti della villa il suo dramma, una storia scritta per lei da un giovane poeta che, innamorato e da lei respinto, si è ucciso.
LA MAGIA DI CROTONE
COTRONE: La Contessa ha una voce che incanta… Io credo che, se volesse entrare un po’ nella villa, si sentirebbe subito riconfortata.
IL CONTE: Su, Ilse, su, cara, ti riposerai almeno un poco.
COTRONE: Manca forse il necessario, ma di tutto il superfluo abbiamo una tale abbondanza… Stiano a vedere. Anche di fuori. Il muro di questa facciata. Basta ch’io dia un grido… (Si pone le mani attorno alla bocca e grida) Olà! (Subito al grido la facciata della villa s’illumina d’una fantastica luce d’aurora) E i muri mandano luce!
ILSE: (incantata, come una bambina) Oh bello!
IL CONTE: Come ha fatto?
COTRONE: Mi chiamano il mago Cotrone. Vivo modestamente di questi incantesimi. Li creo. E ora, stiano a vedere. (Si rimette le mani attorno alla bocca e grida Nero! (Si rifà il tenue barlume lunare di prima, spenta la luce della facciata) Questo nero la notte pare lo faccia per le lucciole, che volando – non s’indovina dove – ora qua ora là vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Ebbene, guardino: … là … là … là…
Appena dice e indica col dito in tre punti diversi, dove indica, s’aprono per un momento, fin laggiù in fondo alle falde della montagna, tre apparizioni verdi, come di larve evanescenti.)
ILSE: Oh, Dio, com’è?
IL CONTE: Che sono?
COTRONE: Lucciole! Le mie. Di mago. Siamo qua come agli orli della vita, Contessa. Gli orli, a un comando, si distaccano; entra l’invisibile: vaporano i fantasmi. È cosa naturale. Avviene, ciò che di solito nel sogno. Io lo faccio avvenire anche nella veglia. Ecco tutto. I sogni, la musica, la preghiera, l’amore… tutto l’infinito ch’è negli uomini, lei lo troverà dentro e intorno a questa villa.
(…)
COTRONE: (…) Non bisogna più ragionare. Qua si vive di questo. Privi di tutto, ma con tutto il tempo per noi: ricchezza indecifrabile, ebullizione di chimere. Le cose che ci stanno attorno parlano e hanno senso soltanto nell’arbitrario in cui per disperazione ci viene di cangiarle. Disperazione a modo nostro, badiamo! Siamo piuttosto placidi e pigri; seduti, concepiamo enormità, come potrei dire? mitologiche; naturalissime, dato il genere della nostra esistenza. Non si può campare di niente; e allora è una continua sborniatura celeste. Respiriamo aria favolosa. Gli angeli possono come niente calare in mezzo a noi; e tutte le cose che ci nascono dentro sono per noi stessi uno stupore. Udiamo voci, risa; vediamo sorgere incanti figurati da ogni gomito d’ombra, creati dai colori che ci restano scomposti negli occhi abbacinati dal troppo sole della nostra isola. Sordità d’ombra non possiamo soffrirne. Le figure non sono inventate da noi; sono un desiderio dei nostri stessi occhi
 Simone Cecchetti nella parte di Cotroneo (2016)
Simone Cecchetti nella parte di Cotroneo (2016)
L’ULTIMA SCENA
COTRONE: A tempo! E hanno detto a tempo ciò che dovevano dire; non vi basta? Tutto il resto, come siano apparse e se siano vere o no, non ha nessuna importanza! Io le ho voluto dare un saggio, Contessa, che la sua Favola può vivere soltanto qua; ma lei vuol seguitare a portarla in mezzo agli uomini, e sia! Fuori di qua io però non ho più potere di valermi in suo servizio altro che dei miei compagni, e li metto con me stesso a sua disposizione.
Si ode, a questo punto, potentissimo da fuori, il frastuono della cavalcata dei Giganti della Montagna che scendono al paese per la celebrazione delle nozze di Uma di Dòrnio e Lopardo d’Arcifa, con musiche e grida quasi selvagge. Ne tremano i muri della villa. Irrompono sulla scena eccitatissimi Quaquèo, Doccia, MaraMara, La Sgricia, Milordino, Maddalena.
QUAQUÈO: Ecco i giganti! Ecco i giganti!
MILORDINO: Scendono dalla montagna!
MARA-MARA: Tutti a cavallo! Parati a festa!
QUAQUÈO: Sentite? Sentite? Pajono i re del mondo!
MILORDINO: Vanno alla chiesa per la consacrazione delle nozze!
DIAMANTE: Andiamo, andiamo a vedere!
COTRONE: (arrestando con voce imperiosa e potente tutti gli accorrenti dietro l’invito di Diamante) No! Nessuno si muova! Nessuno si faccia vedere, se dobbiamo andar su a proporre la recita! Restiamo qua tutti a concertare la prova!
IL CONTE: (tirandosi a parte la Contessa) Ma tu non hai paura, Ilse? Li senti?
SPIZZI: (atterrito, accostandosi) Tremano i muri!
CROMO: (accostandosi anche lui atterrito) Pare la cavalcata d’un’orda di selvaggi!
DIAMANTE: Io ho paura! ho paura!
Tutti restano ad ascoltare con l’animo sospeso dallo sgomento, mentre le musiche e il frastuono si vanno allontanando.
 I giganti della montagna con la compagnia di Gabriele Lavia (2019)
I giganti della montagna con la compagnia di Gabriele Lavia (2019)
Con l’ultima opera che, pur lavorandoci sino alla fine dei suoi giorni, pur non riuscendo a portarla a termine, Pirandello mette fine ad ogni finzione di tipo realistico:
- tale dramma non ha né tempo né spazio;
- i personaggi assumono un aspetto simbolico.
Forse i Giganti raffigurano l’aspetto della civiltà moderna, potenti grazie al progresso, ma rozzi ed insensibili; dall’altra parte Crotone, con i suoi Scalognati (che vivono nella sua villa), dediti soltanto a vivere nella fantasia dell’arte ed infine gli attori che vogliono far uscire l’arte dall’isolamento e portarla in mezzo al popolo. Ma è veramente arduo tentare una lettura esaustiva, nonostante le indicazioni date al figlio Stefano. Ma forse la forza de I giganti della montagna è proprio nella non voluta ambiguità.
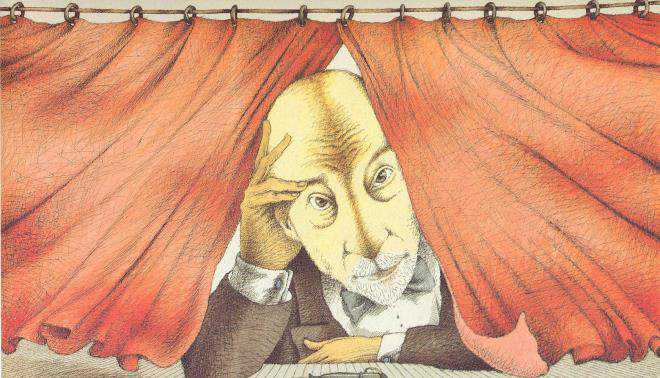
Pirandello in un disegno di Tullio Pericoli






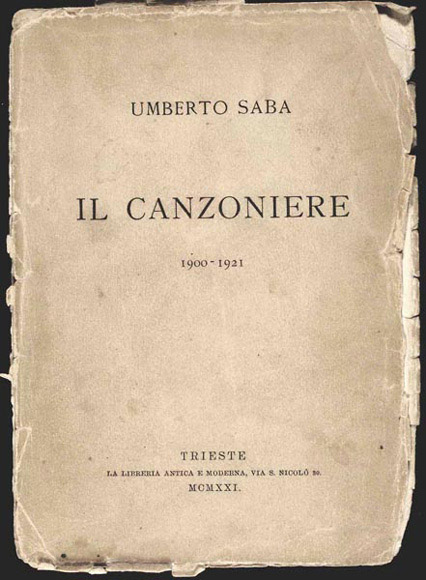




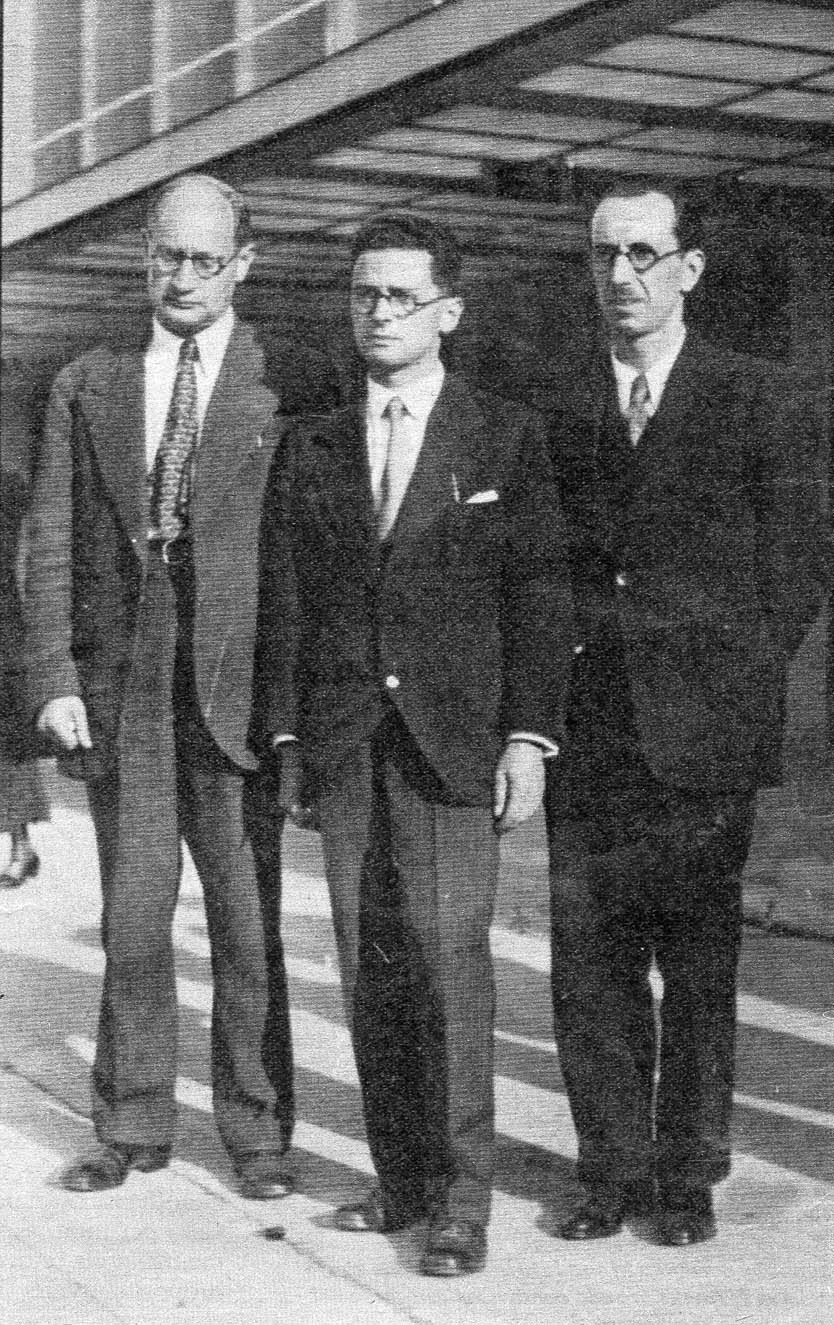




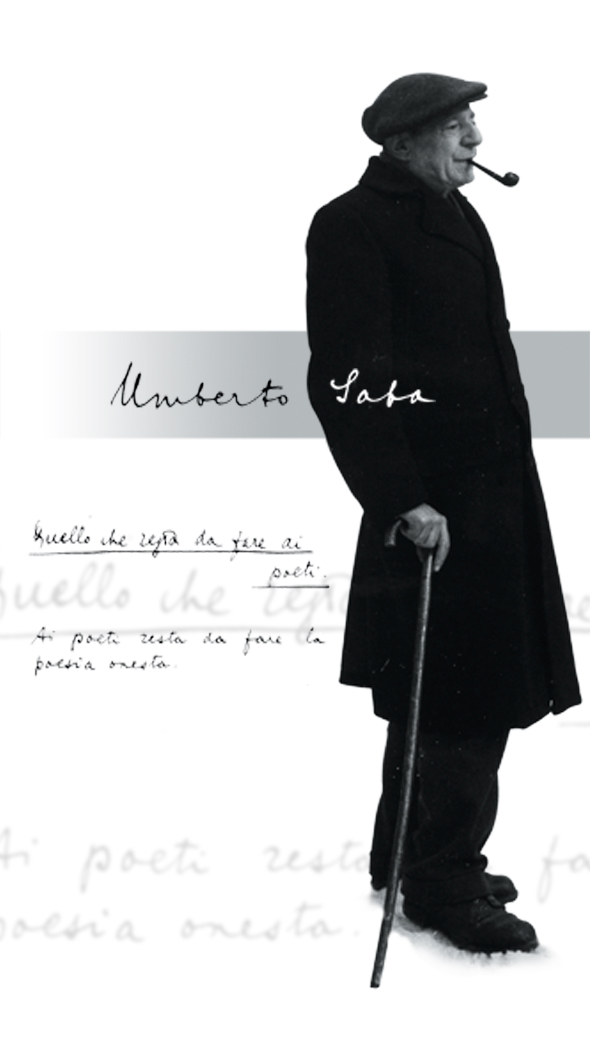

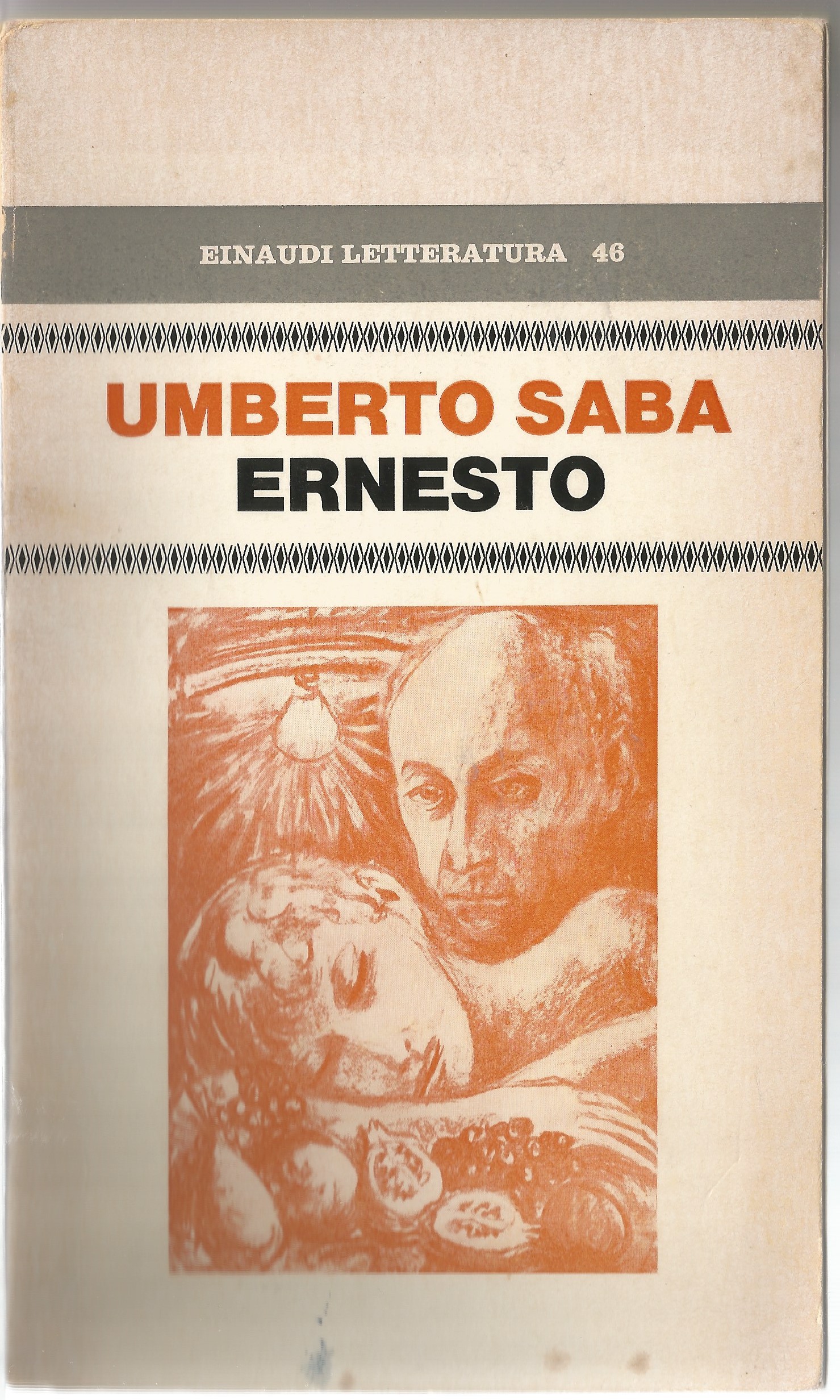
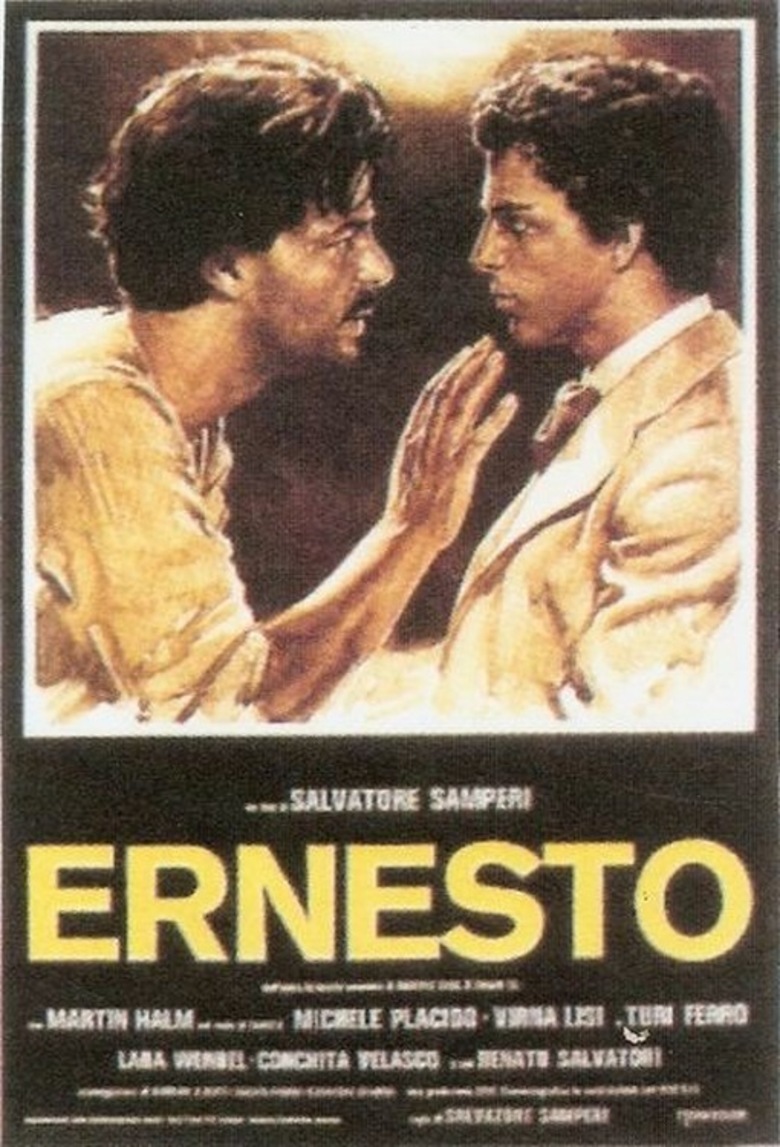

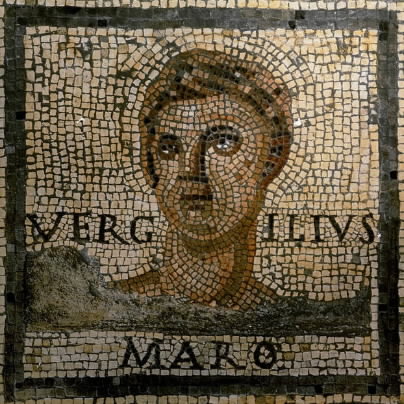
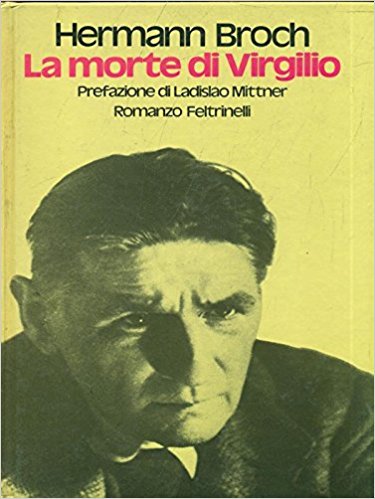





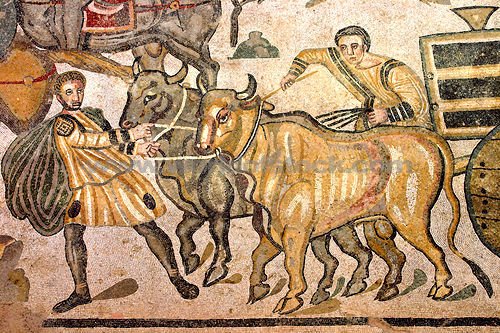









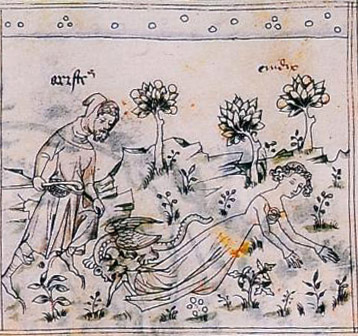



















 Intanto, mandati avanti dal borgo latino, ché altro / esercito, pronto, resta in attesa nel piano, / cavalieri venivano, e a Turno re risposte portavano; / trecento, tutti armati di scudi, e Volcente era il capo. / E già si avvicinavano al campo e alle mura arrivavano, / quando lontano, costoro vedon girare a sinistra, / e l’elmo, nell’ombre della notte lunare, tradì / l’immemore Eurialo, colpito dai raggi splendette. / Non impunemente fu visto. / Volcente gridò alla schiera: «Fermi, uomini, che cosa vi muove? chi siete in armi? / dove siete diretti?». Essi nulla rispondono, / ma rapidi fuggono al bosco e alla notte si affidano. / I cavalieri si lanciano ai passaggi ben noti / di qua, di là, tutti i bivii con guardie coronano. / La selva era vasta, di macchie e d’elci nerastri / foltissima, e densi spineti per tutto l’empivano: / radi sentieri lucevano fra intrichi nascosti. / Eurialo, l’ombra dei rami, la preda onerosa / impaccia, l’inganna l’orrore nel tentare la via. / Niso andava: già senza accorgersene ha passato i nemici, / e i boschi sacri, che poi dal nome d’Alba si dissero / Albani (allora il re Latino, pascoli folti, li aveva): / come ristette, e invano a cercar l’amico si volse, e non c’era: / «Eurialo infelice, dove mai t’ho lasciato? dove ti cerco / tutto facendo di nuovo il confuso cammino / dell’ingannevole selva?» E scruta all’indietro / le impronte recenti e le segue, s’aggira tra mute boscaglie. / Ecco, ode cavalli, strepito ode, e gli inseguitori, e i richiami: / e molto non passa, che un urlo agli orecchi / gli arriva, e vede Eurialo; già tutta la schiera / (colpa della notte e del luogo) con subito confuso tumulto / lo raggiunge, lo tiene, che tutto invano pur tenta. / Che fare? con quale forza, con quali armi oserà / strappar loro il fanciullo? o è meglio gettarsi a morire, / su quelle spade, affrettare la bella morte nel sangue? / Rapidamente flettendo il braccio palleggia l’astile, / e in alto, alla Luna rivolto, la prega così: / «Tu, dea, tu valido aiuto, soccorri il nostro pericolo, / o bellezza degli astri, o dei boschi Latonia custode. / Se mai per me sui tuoi altari il padre mio Irtaco / portò doni, se anch’io con le mie cacce ne aggiunsi, / e ne appesi alla cupola, e ai sacri fastigi ne affissi, / fammi sconvolgere tu quella folla, reggi l’arma per aria». / Disse, e con tutto il corpo tendendosi il ferro / lanciò. L’asta volando straccia l’ombra notturna, / e vien nella schiena a Sulmone, voltato, e lì stesso / s’infrange, ma passa col legno rotto i precordi. / Rotola quello, dal petto un caldo fiume versando; / già freddo, gli ultimi aneliti con lunghi singulti dà ancora. / di qua, di là guardano. E Niso, più ardente, / ancora scoccava dall’orecchio una picca: / stavan quelli confusi, e l’asta passò a Tago le tempie / stridendo, restò a intiepidirsi nel cervello trafitto. / Volcente infuria, feroce: non riesce a vedere l’autore / del colpo, né dove possa pieno di rabbia scagliarsi. / «Tu intanto, però, col sangue vendetta / mi pagherai per entrambi», gridò e col ferro sguainato / piombava su Eurialo. Allora folle, sconvolto, / Niso scoppia a gridare, non può più nel buio nascondersi, / non può sopportare così orrendo dolore. / «Me, me! qui son io che ho colpito, su me il ferro volgete / o Rutuli! Mio è tutto l’inganno, nulla osò questo, / nè avrebbe potuto: il cielo lo attesti e, consce, le stelle. Soltanto, amò troppo il suo misero amico». / Queste parole gridava, ma spinta a forza la spada / tagliò le costole, il candido petto sfondò. / S’accasciò Eurialo morto, per il bel corpo / scorreva il sangue, cadde la testa sulla spalla, pesante: / così purpureo fiore, che l’aratro ha tagliato, / languisce morendo, o chinano il capo i papaveri / sul collo stanco, quando la pioggia li grava. / Ma Niso si butta nel mezzo, solo fra tutti / Volcente ricerca, Volcente solo egli vuole. / Intorno i nemici si stringono / di qua di là tentano / di ributtarlo: e nondimeno resiste, e ruota la spada / fulminea, finché al Rutulo urlante la cacciò nella gola / e tolse, morendo, al suo nemico la vita. / Allora si buttò in terra, sull’amico già esamine, / e lì, trafitto, trovò in placida morte riposo.
Intanto, mandati avanti dal borgo latino, ché altro / esercito, pronto, resta in attesa nel piano, / cavalieri venivano, e a Turno re risposte portavano; / trecento, tutti armati di scudi, e Volcente era il capo. / E già si avvicinavano al campo e alle mura arrivavano, / quando lontano, costoro vedon girare a sinistra, / e l’elmo, nell’ombre della notte lunare, tradì / l’immemore Eurialo, colpito dai raggi splendette. / Non impunemente fu visto. / Volcente gridò alla schiera: «Fermi, uomini, che cosa vi muove? chi siete in armi? / dove siete diretti?». Essi nulla rispondono, / ma rapidi fuggono al bosco e alla notte si affidano. / I cavalieri si lanciano ai passaggi ben noti / di qua, di là, tutti i bivii con guardie coronano. / La selva era vasta, di macchie e d’elci nerastri / foltissima, e densi spineti per tutto l’empivano: / radi sentieri lucevano fra intrichi nascosti. / Eurialo, l’ombra dei rami, la preda onerosa / impaccia, l’inganna l’orrore nel tentare la via. / Niso andava: già senza accorgersene ha passato i nemici, / e i boschi sacri, che poi dal nome d’Alba si dissero / Albani (allora il re Latino, pascoli folti, li aveva): / come ristette, e invano a cercar l’amico si volse, e non c’era: / «Eurialo infelice, dove mai t’ho lasciato? dove ti cerco / tutto facendo di nuovo il confuso cammino / dell’ingannevole selva?» E scruta all’indietro / le impronte recenti e le segue, s’aggira tra mute boscaglie. / Ecco, ode cavalli, strepito ode, e gli inseguitori, e i richiami: / e molto non passa, che un urlo agli orecchi / gli arriva, e vede Eurialo; già tutta la schiera / (colpa della notte e del luogo) con subito confuso tumulto / lo raggiunge, lo tiene, che tutto invano pur tenta. / Che fare? con quale forza, con quali armi oserà / strappar loro il fanciullo? o è meglio gettarsi a morire, / su quelle spade, affrettare la bella morte nel sangue? / Rapidamente flettendo il braccio palleggia l’astile, / e in alto, alla Luna rivolto, la prega così: / «Tu, dea, tu valido aiuto, soccorri il nostro pericolo, / o bellezza degli astri, o dei boschi Latonia custode. / Se mai per me sui tuoi altari il padre mio Irtaco / portò doni, se anch’io con le mie cacce ne aggiunsi, / e ne appesi alla cupola, e ai sacri fastigi ne affissi, / fammi sconvolgere tu quella folla, reggi l’arma per aria». / Disse, e con tutto il corpo tendendosi il ferro / lanciò. L’asta volando straccia l’ombra notturna, / e vien nella schiena a Sulmone, voltato, e lì stesso / s’infrange, ma passa col legno rotto i precordi. / Rotola quello, dal petto un caldo fiume versando; / già freddo, gli ultimi aneliti con lunghi singulti dà ancora. / di qua, di là guardano. E Niso, più ardente, / ancora scoccava dall’orecchio una picca: / stavan quelli confusi, e l’asta passò a Tago le tempie / stridendo, restò a intiepidirsi nel cervello trafitto. / Volcente infuria, feroce: non riesce a vedere l’autore / del colpo, né dove possa pieno di rabbia scagliarsi. / «Tu intanto, però, col sangue vendetta / mi pagherai per entrambi», gridò e col ferro sguainato / piombava su Eurialo. Allora folle, sconvolto, / Niso scoppia a gridare, non può più nel buio nascondersi, / non può sopportare così orrendo dolore. / «Me, me! qui son io che ho colpito, su me il ferro volgete / o Rutuli! Mio è tutto l’inganno, nulla osò questo, / nè avrebbe potuto: il cielo lo attesti e, consce, le stelle. Soltanto, amò troppo il suo misero amico». / Queste parole gridava, ma spinta a forza la spada / tagliò le costole, il candido petto sfondò. / S’accasciò Eurialo morto, per il bel corpo / scorreva il sangue, cadde la testa sulla spalla, pesante: / così purpureo fiore, che l’aratro ha tagliato, / languisce morendo, o chinano il capo i papaveri / sul collo stanco, quando la pioggia li grava. / Ma Niso si butta nel mezzo, solo fra tutti / Volcente ricerca, Volcente solo egli vuole. / Intorno i nemici si stringono / di qua di là tentano / di ributtarlo: e nondimeno resiste, e ruota la spada / fulminea, finché al Rutulo urlante la cacciò nella gola / e tolse, morendo, al suo nemico la vita. / Allora si buttò in terra, sull’amico già esamine, / e lì, trafitto, trovò in placida morte riposo. Preparandosi all’assalto, i cavalieri portano sulle lance le teste dei due giovani, così che della loro morte viene a sapere la povera madre di Eurialo. S’accende la battaglia, morti da ambedue le parti. Turno, circondato dai nemici, fugge, gettandosi nel Tevere.
Preparandosi all’assalto, i cavalieri portano sulle lance le teste dei due giovani, così che della loro morte viene a sapere la povera madre di Eurialo. S’accende la battaglia, morti da ambedue le parti. Turno, circondato dai nemici, fugge, gettandosi nel Tevere.


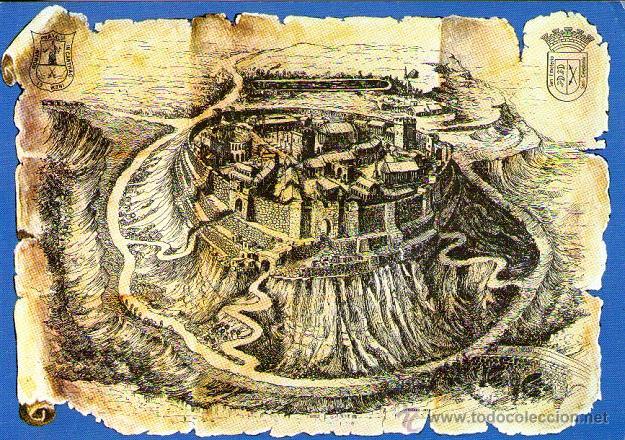
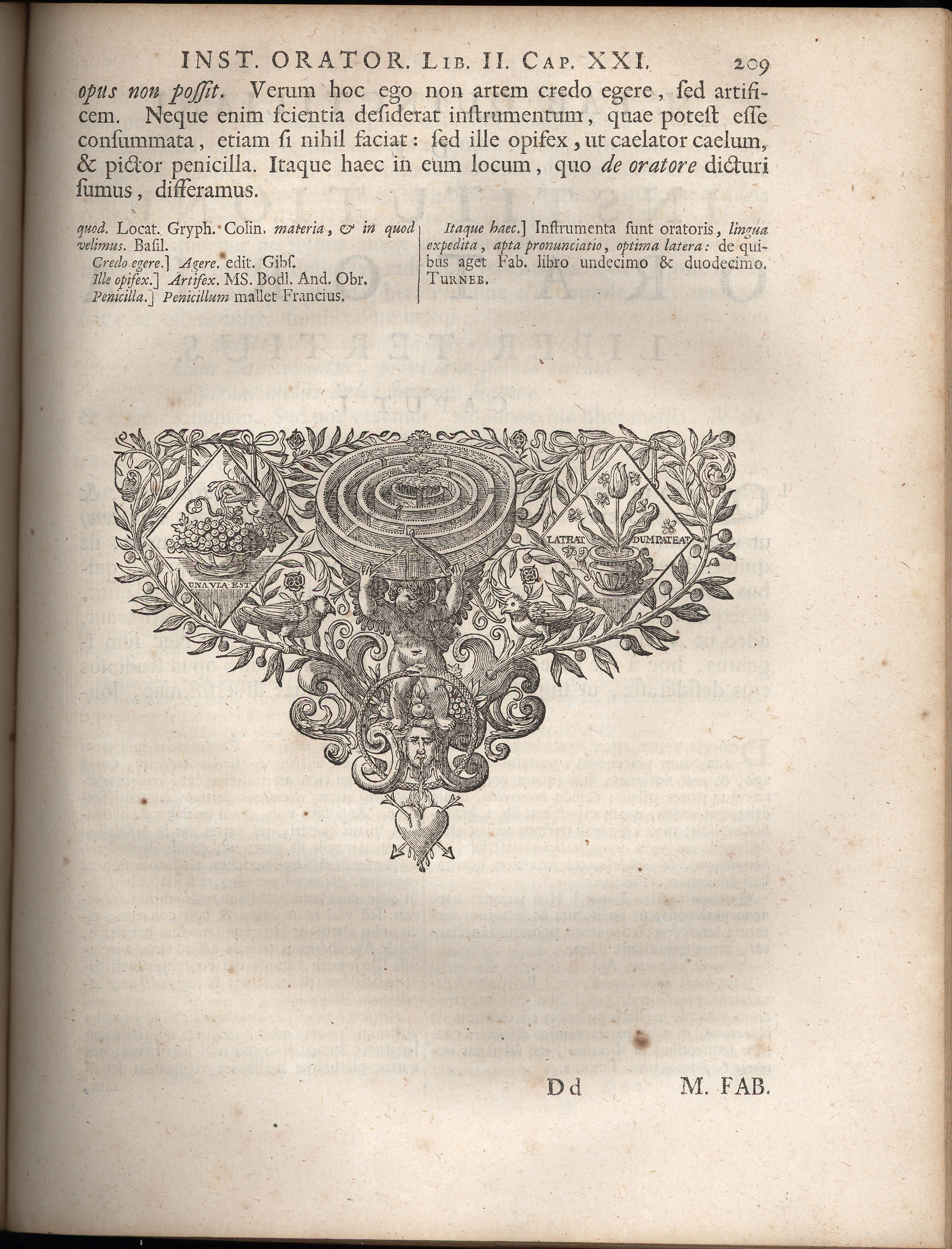

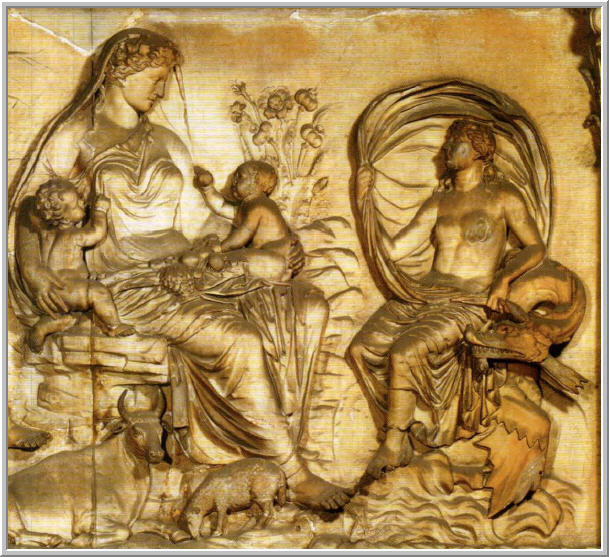



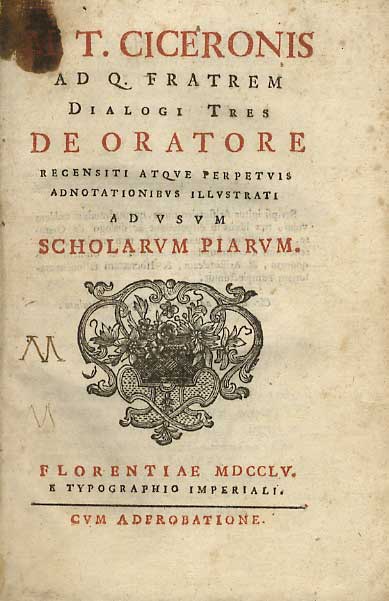






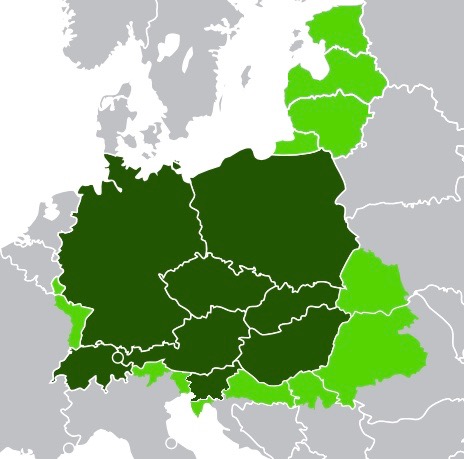

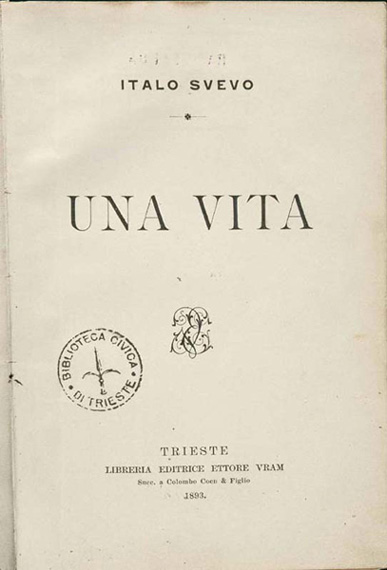

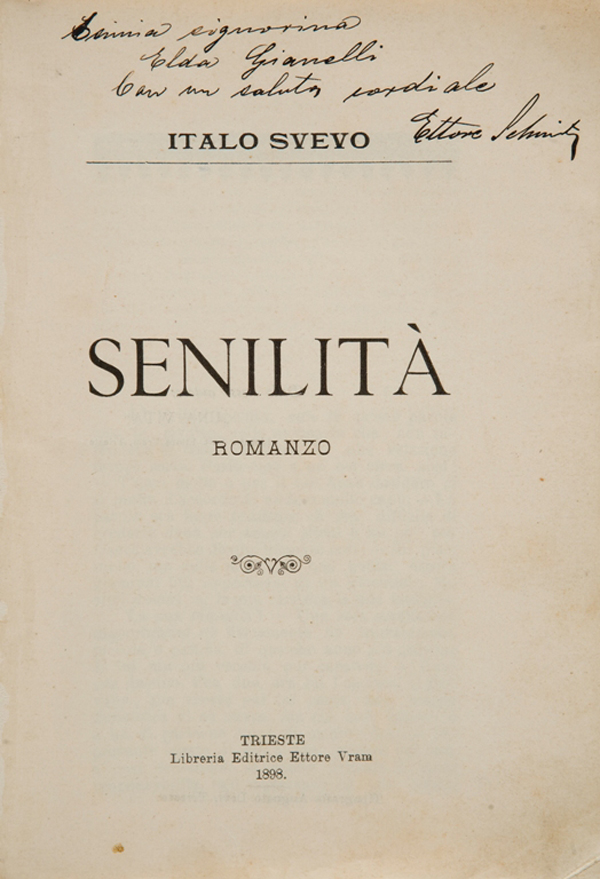
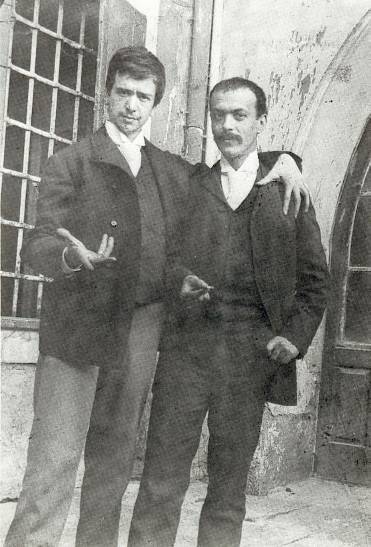






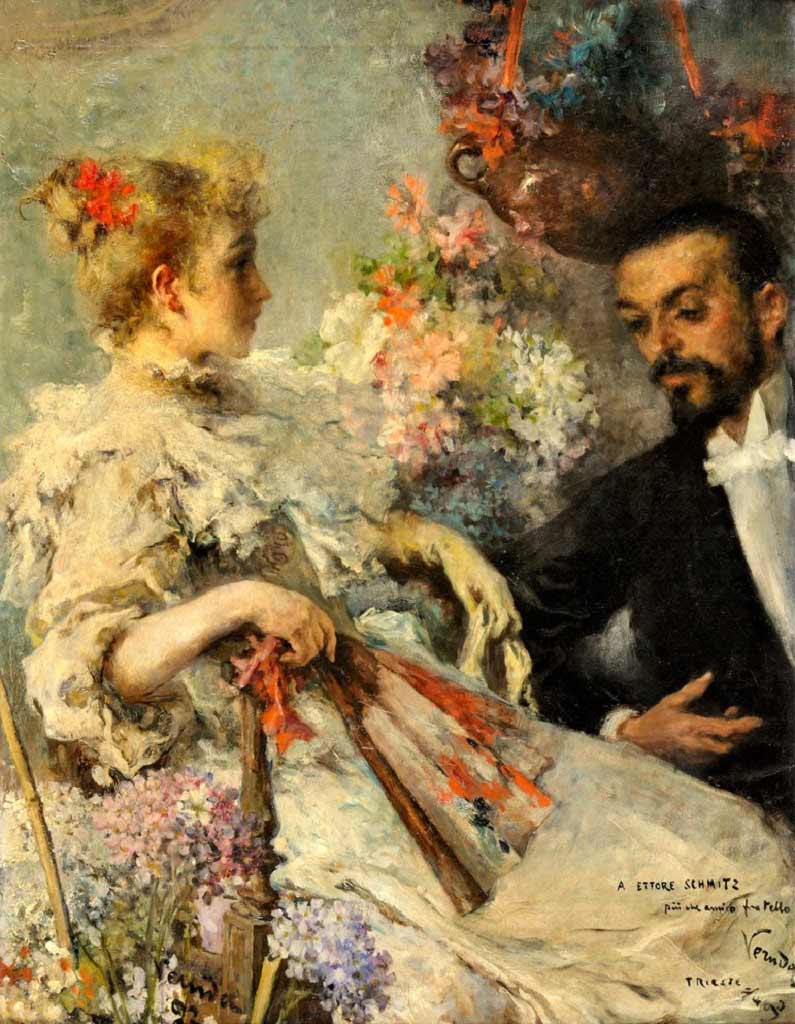















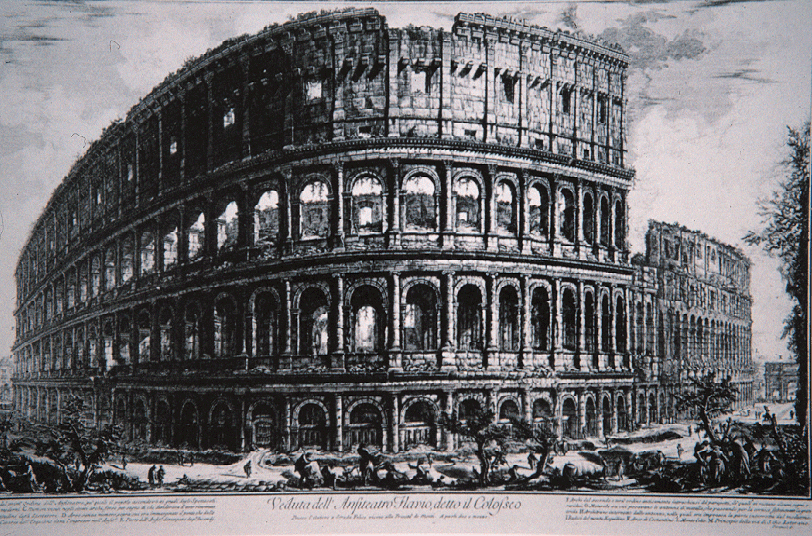


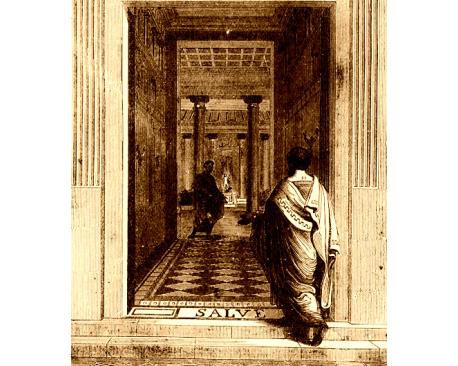










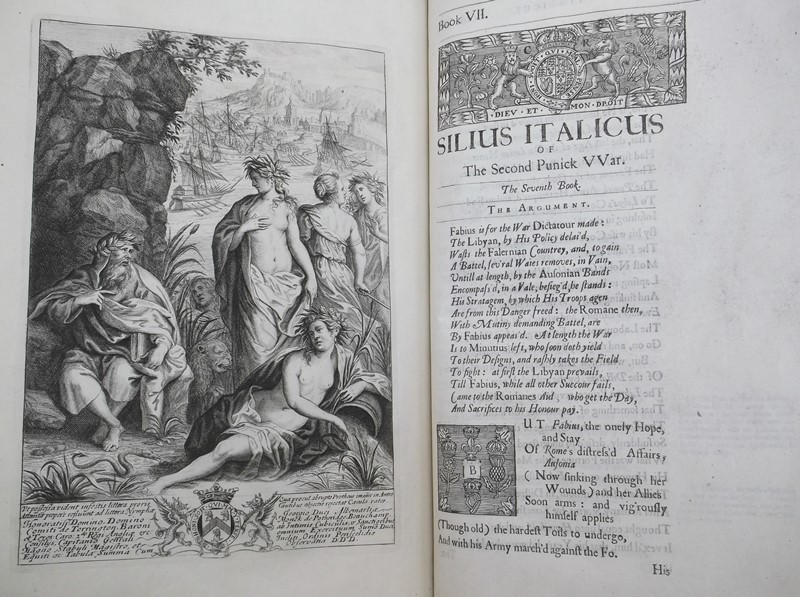


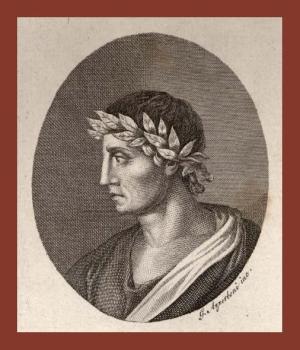
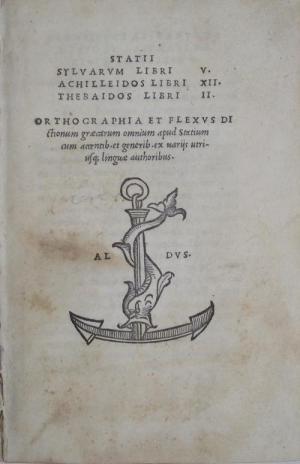


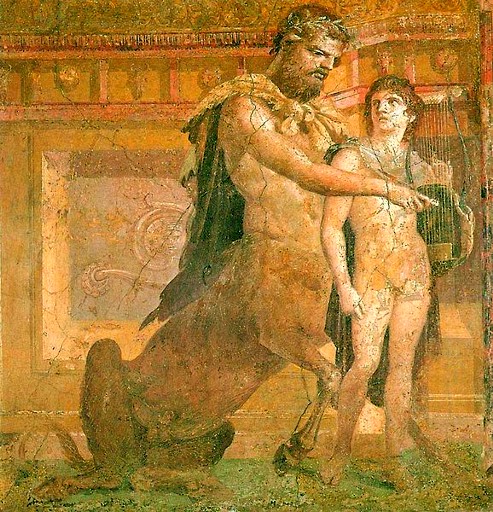
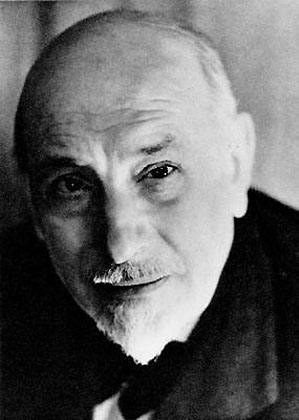
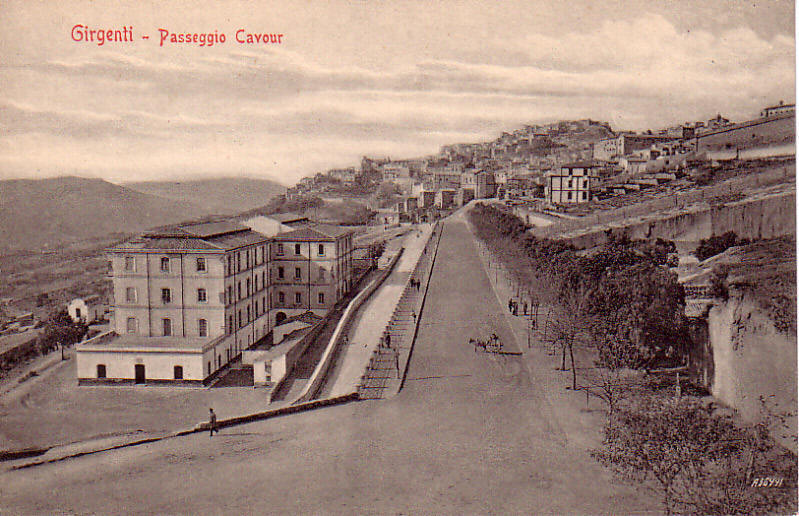








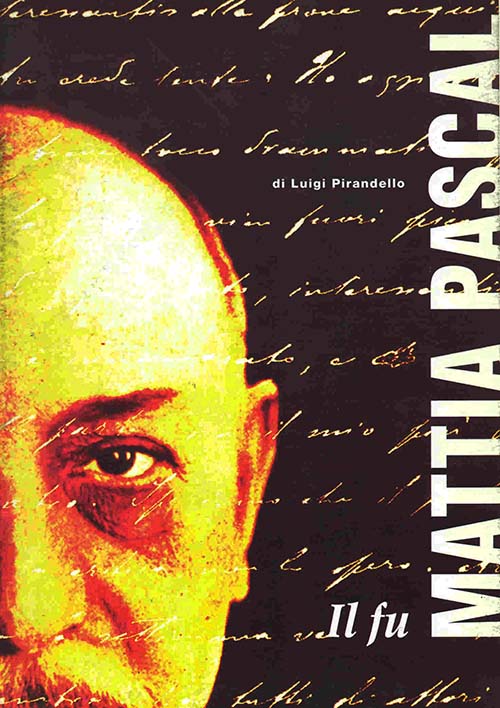

















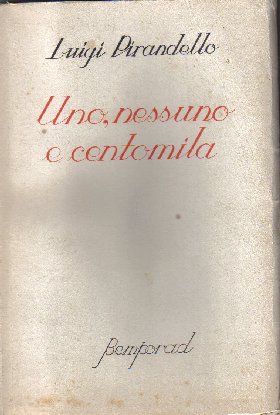









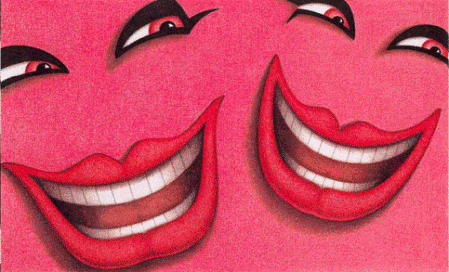

















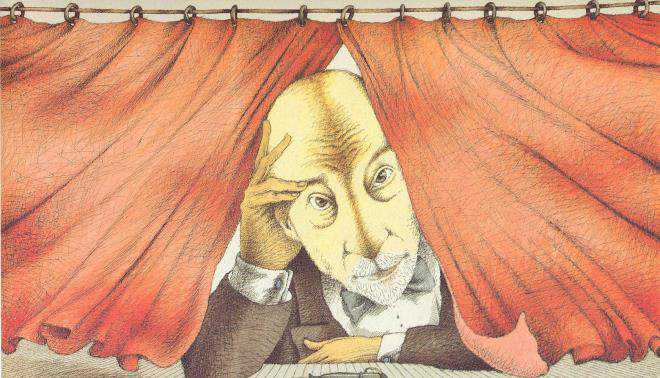

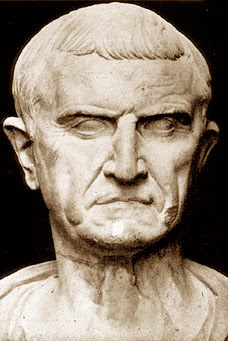






















![Francesco Petrarca[4].jpg](https://erprofessor.com/wp-content/uploads/2017/03/francesco-petrarca4.jpg)










